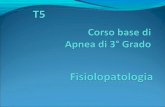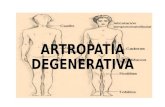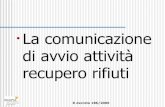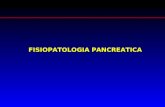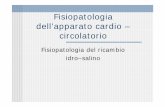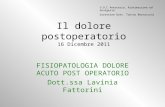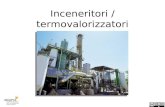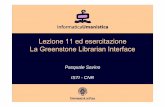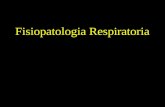Lezione 18 (11-05-07) Fisiopatologia
-
Upload
manuela-orani -
Category
Documents
-
view
611 -
download
0
Transcript of Lezione 18 (11-05-07) Fisiopatologia

FISIOPATOLOGIA LEZ. del giorno 11/05/2007 del prof. Sandro Muntoni Laura Matta
LA GOTTAOggi parliamo, in un'ora, della gotta, quindi, iniziamo bene, metabolismo purinico (suppongo avesse intenzione di ironizzare...). Allora, cos'è la gotta? E' un disordine del metabolismo purinico, riguardante pertanto le basi puriniche, ed è caratterizzata da aumento dell'acido urico ematico, quindi dell'uricemia, quindi iperuricemia, e, soprattutto, da precipitazioni di urato monosodico. L'iperuricemia si riflette perciò con dei precipitati localizzati preferenzialmente nelle articolazioni, per cui parleremo di artrite acuta cronica, nei tessuti periarticolari, dove alla lunga portano alla formazione dei tofi, e nel rene. Nel rene riscontriamo tre quadri clinici: nefrolitiasi, nefropatia da urati e nefropatia da acido urico. Per quanto riguarda la patogenesi della gotta, è chiaro che è strettamente connessa a tutti i fattori che determinano iperuricemia, i quali a lungo andare tendono a provocare attacchi di gotta. Il livello dell'acido urico ematico è determinato dall'equilibrio tra produzione ed eliminazione dell'acido urico, quindi l'iperuricemia può dipendere da un'aumentata produzione di acido urico, da una ridotta escrezione a livello renale o, come vedremo, da entrambi i fattori. Cercate di ricordare, vi servirà quando sarete medici, che la concentrazione ematica di acido urico non deve superare i 7 mg/dL. Questo è il valore che, in generale, non deve essere superato, deve mantenersi entro i 7 mg/dL, poi se uno ha 7,1 mg/dL, pazienza... Si dice che nelle donne esso debba essere ancora più basso, intorno ai 6 mg/dL, diciamo però che 7 mg/dL è il cut off da ricordare. Quando vi troverete nella pratica clinica una persona con la sindrome plurimetabolica, che presenta anche iperuricemia, con 9 mg/dL di uricemia, bisognerà somministrarle dei farmaci che inibiscono la produzione di acido urico. 9 mg/dL di uricemia è un valore troppo alto: il rene, alla lunga, ne risente; comincia una leggera insufficienza renale, la creatininemia inizia a salire, così come l'azotemia, ed è interessante notare come, ripristinando il valore normale di uricemia con qualche mese di terapia, rientrino nella norma anche i valori di creatininemia ed azotemia. L'iperuricemia diventa un freno proprio per la funzione renale, va indubbiamente trattata. Nei bambini i valori sono più bassi, ma per voi questo ha una minore importanza. Mostra una diapositiva sul metabolismo purinico. Vedete in basso, sulla destra, la formazione dell'acido urico, il quale deriva dal catabolismo delle basi puriniche. Abbiamo (sono cose che rifarete sicuramente più avanti, le avrete fatte in biochimica...) il metabolismo delle basi puriniche: la formazione delle basi avviene con una via ex novo e una via cosiddetta di recupero (con il catabolismo si forma ipoxantina che può nuovamente essere riconvertita a base purinica attraverso, appunto, questa via). Se non avviene il recupero, si forma la xantina, dalla quale deriverà l'acido urico, prodotto del catabolismo. Come vedete, sono coinvolte alcune vie enzimatiche importanti: partendo dall'alto, il ribosio- 5-fosfato viene convertito in 5-fosforibosil-1-pirofosfato (PRPP), che nella via ex novo, tramite l'enzima PRPP amido- transferasi (che lui chiama APRT, amido - fosforibosiltransferasi), porta alla formazione di 5-fosforibosilamina, da cui si forma IMP (acido inosinico), che viene poi trasformato in AMP e GMP. Nella via di recupero, la formazione di basi puriniche è catalizzata da dall'ipoxantina - guanina - fosforibosiltransferasi (HGPRT). Il professore si mantiene abbastanza vago e non commenta le varie tappe metaboliche; ho inserito qualche informazione in più perché altrimenti sembra citare enzimi a caso che non si sa dove collocare. Comunque, a voi interessa sapere che esistono due vie, la via ex novo e la via di recupero, per la formazione di basi puriniche e che dal catabolismo delle sole basi puriniche deriva l'acido urico, del quale una diminuita escrezione o un'iperproduzione, dovute a difetti di vario tipo, possono provocare iperuricemia.Consideriamo la classificazione della gotta. Il 90% circa dei casi è la gotta cosiddetta primaria,la cui eziologia non è ben definita, nel senso che si tratta di una patologia intrinseca che determina iperuricemia. A questa si contrappone la gotta secondaria, così chiamata perché determinata da altre patologie, per esempio un'aumentata produzione di acido urico con aumento dell'escrezione urinaria che si ritrova in malattie linfoproliferative, dove c'è un turnover accelerato di basi puriniche (soprattutto neoplasie, leucemie) con aumentata produzione di acido urico, oppure malattie renali croniche, in cui si ha ridotta escrezione dell'acido urico in presenza di una normale produzione, quindi si ha un rallentamento dell'eliminazione dell'acido urico. Quindi, nel 90% dei casi è primaria o idiopatica, mentre nel 10% dei casi è secondaria. Nella forma primaria possono verificarsi diverse possibilità: aumentata produzione di acido urico, ridotta escrezione di acido urico o entrambe. Per quanto riguarda le secondarie, esistono anche sindromi genetiche ben precise, tipo la sindrome di Lesch - Nyhan nella quale per un difetto genico si ha iperproduzione di acido urico.
Iperuricemia da iperproduzione: spesso è di tipo idiopatico. Significative sono le sindromi di tipo linfoproliferativo, le neoplasie, in cui si ha un'iperproduzione di cellule, per esempio la policitemia, o in corso di psoriasi, di obesità (nella sindrome plurimetabolica spesso è presente anche iperuricemia), anche l'abuso di alcol può determinare la stimolazione della produzione di acido urico, o classiche malattie da

accumulo derivanti da difetti del metabolismo del glucosio (certe glicogenosi), malattie emolitiche, o difetti enzimatici di alcune vie legate alla produzione o al catabolismo delle basi puriniche. Anche una dieta ricca di purine può favorire un'aumentata produzione di acido urico. I livelli ematici di acido urico sono dovuti ad un equilibrio tra produzione ed eliminazione.Iperuricemia da ridotta escrezione: soprattutto l'insufficienza renale. Trovare iperuricemia in un individuo in stato di apparente benessere può essere spia o del fatto che lui tenda primitivamente ad avere un'uricemia elevata, oppure tenda a manifestare insufficienza renale. Tipicamente, in corso di insufficienza renale, creatininemia, azotemia e uricemia salgono. Vi ricordo che talvolta l'iperuricemia può essere primitiva e determinare un sovraccarico per il rene, e quindi secondariamente si ha un aumento della creatininemia e dell'azotemia. Queste cose si possono capire con un pò di pratica clinica. Poi c'è la malattia del rene policistico, patologia non rara, in cui il rene presenta delle cisti sierose. E' relativamente frequente; il paziente va a fare un'ecografia perché ha dolori all'altezza dei lombi e gli trovano il rene policistico. Sono cisti di tipo sieroso nel parenchima renale che possono gradualmente crescere. Non sono lesioni precancerose, non c'è rischio di cancro, però crescono, il liquido citrino tende ad accumularsi e in certi casi bisogna aspirarlo; si fa ecograficamente, per ridurre la grandezza di queste cisti. Spesso la malattia del rene policistico si associa a cisti in altri organi, per esempio nel fegato, può quindi rientrare in quadro di cisti sierose multiple in vari organi. C'è una certa ricorrenza anche familiare. Poi c'è il diabete insipido, che non ha nulla a che fare con il diabete mellito, ma è dovuto al fatto che si è incapaci di concentrare le urine, perché l'ADH viene a mancare o, se è un diabete insipido di tipo nefrogenico, l'ADH viene prodotto ma non funziona a livello periferico, a livello renale. Vi ricordo che l'ADH è deputato ad evitare la troppa diuresi, inibisce la diuresi e questo ne giustifica il nome; è una forma di risparmio d'acqua. Se l'individuo tende a disidratarsi, si libera molto ormone antidiuretico che favorisce il riassorbimento d'acqua a livello renale, quindi anche la concentrazione delle urine. Vi dissi anche che un test molto banale e semplice è il "test alla sete", effettuato per vedere se c'è un diabete insipido, si lascia l'individuo per ore senza bere acqua e poi si va a controllare le urine. Se il peso specifico delle urine rimane uguale perché l'individuo non è in grado di concentrare le urine, nonostante non beva acqua e pertanto sia disidratato, questa può essere una prova che l'individuo presenti il diabete insipido, caratterizzato da poliuria, perché l'individuo urina molto non essendo capace di concentrare le urine, e polidipsia, beve molto, perchè ovviamente deve compensare la perdita d'acqua. Nel diabete insipido spesso c'è un'iperuricemia da ridotta escrezione, che si può riscontrare, anche se non sempre, anche nell'ipertensione arteriosa. L'iperparatiroidismo è una patologia in cui il paratormone tende a favorire l'osteoporosi, la farete sicuramente più avanti (!). Poi ci sono tutta una serie di farmaci: ciclosporina, levodopa, alcuni diuretici che possono ridurre l'escrezione di acido urico.
Forme in cui iperproduzione e ridotta escrezione di acido urico coesistono: in corso d'abuso d'alcol, ma sono forme rare. Ci possono essere deficit enzimatici, come difetti della glucosio-6-fosfatasi (che non è la glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, sono cose diverse), o di fruttosio-1-fosfato-aldolasi.Ricapitolando e considerando la questione da un'altra ottica, esistono fattori genetici e non genetici. Fattori genetici, come per esempio qualche sindrome genetica dovuta ad un difetto di una certa via enzimatica del metabolismo delle purine. Fattori non genetici, tra cui quelli alimentari: torniamo al problema dell'alimentazione, al discorso che se si facesse prevenzione si potrebbe prevenire una barca di malattie, tra cui gli attacchi di gotta. L'elevato consumo di carne è, ancora una volta, fattore di rischio, in questo caso per l'uricemia. Oltre alle carni, vi ricordo anche la forte assunzione di bottarga, per chi se la può permettere, senz'altro molto buona ma, siccome sono uova, quindi hanno il nucleo, una forte assunzione può favorire l'iperuricemia. Abbiamo già detto il forte consumo d'alcol, il diabete, perchè l'insulino - resistenza, soprattutto nel diabete di tipo II, tende ad aumentare il riassorbimento renale di urati. Notate come certe cose ritornino. Poi ci sono alcuni farmaci che possono favorire il riassorbimento di acido urico. Anche prima abbiamo parlato di obesità: a volte è associata ad insulino - resistenza da diabete di tipo II, quindi spesso le due cose vanno a braccetto. Allora, cosa succede? Abbiamo un'iperuricemia, qualunque ne sia la causa: se l'acido urico è troppo elevato, c'è una precipitazione di cristalli nelle articolazioni, prima di tutto, e allora abbiamo tutti i fenomeni legati alla flogosi. Intanto questi cristalli di urato, che precipitano, vengono fagocitati dai monociti/macrofagi, la fagocitosi a sua volta attiva tutta una serie di contromisure, per cui chemiotassi di neutrofili, rilascio di citochine, abbassamento del pH che favorisce a sua volta la precipitazione dei cristalli. Si può avere una lisi dei fagociti, ma anche dei neutrofili che intervengono, l'autolisi comporta la liberazione di enzimi lisosomiali, praticamente, diciamo, la cascata dell'infiammazione acuta, che, se i cristalli persistono, diventa infiammazione cronica. Quindi danno tissutale e infiammazione. Quali sono i fattori favorenti il precipitare dei cristalli di urato monosodico nelle articolazioni? Nella fattispecie sono due: uno è la temperatura, in genere i precipitati tendono a formarsi alla periferia del corpo, nell'alluce per esempio, perchè la temperatura è più bassa. Riducendosi la temperatura, la solubilità dei cristalli è minore: al contrario, più sale la temperatura, più il cristallo è solubile. Il secondo

fattore, fondamentale, è il cambiamento di pH: se il pH si abbassa per via dell'acidità, e quando c'è infiammazione tende ad abbassarsi, ci può essere una precipitazione dei cristalli di urato. Prevalentemente sono questi i fattori che favoriscono l'attacco acuto di gotta. Adesso concentriamoci sui quadri clinici. Questi sono importanti. Abbiamo l'iperuricemia asintomatica, che significa? Vuol dire che uno va a farsi le analisi del sangue, e si trova 8 mg/dL di uricemia. Sta benissimo, non ha nessun disturbo, però un'uricemia tanto elevata può portare alla lunga a rallentamento della funzione renale, che può regredire se l'uricemia torna alla norma, e scatenare in futuro, negli anni, attacchi di gotta. Possiamo avere un'artrite gottosa acuta, una gotta intercritica, un'artrite tofacea cronica, una nefropatia gottosa. Anche in questo caso, non è mai sbagliato tenersi ben idratati. La disidratazione favorisce, dove ci siano dei soluti che possono precipitare, in genere, ovviamente la precipitazione: questo vale per la calcolosi renale, per la calcolosi biliare, in generale insomma. Vale anche in questo caso. I farmaci ad azione uricosurica??? li saltiamo, magari li vedrete più avanti.Mostra una fotografia. Questi sono i classici tofi, accumulo cronico di cristalli di acido urico, di sali di acido urico. Guardate come diventano le mani, oramai non si vedono quasi più. Questa è la sezione di un alluce amputato in cui sono appunto evidenti formazioni tofacee, sia nelle articolazioni che nei tessuti molli. Alla lunga determinano decisamente un quadro invalidante. Sulla destra vedete un tofo gottoso, ci sono sottili cristalli di urato circondati da reazione di fibroblasti e cellule giganti perché anche in questo caso, siccome diventa un evento cronico, avremo formazione di cellule giganti o comunque cellule che tendono ad inglobare, a fagocitare questi cristalli. L'organismo ha il problema di cercare di eliminare questi cristalli, non ci riesce, allora li ingloba; ricordate che la fagocitosi di tutte queste sostanze è una caratteristica costante dell'infiammazione cronica (che avete fatto con me, mi pare), quindi macrofagi che tendono a fondersi con altri e a diventare cellule giganti, le cellule di Langhans poi. Anche in questo caso abbiamo cellule giganti che tendono a fagocitare i cristalli. Quali sono i markers, in generale, ematici che possono un pò aiutare? Intanto l'uricemia, però ricordatevi, ragazzi, che l'uricemia, a volte, in corso di attacco gottoso acuto, può essere normale, perchè magari l'acido urico è andato a precipitare molto nell'articolazione e per una qualche ragione l'uricemia in fase acuta si può trovare normale. Il fatto di trovare l'uricemia normale non è detto escluda l'attacco acuto di gotta, in questo caso anche la clinica aiuta, non è solo l'esame dell'uricemia, a volte naturalmente si trova anche l'uricemia molto alta, però non è detto che si trovi necessariamente uricemia elevata in fase acuta. E' chiaro che se la trovate alta bisogna trattarla: non se è 7,1 - 7,3 mg/dL ma 8 - 9 mg/dL. La VES, la velocità di eritrosedimentazione, è una SPIA SUL CRUSCOTTO che vi dice che c'è infiammazione, non vi dice dove l'infiammazione sia localizzata, ma vi dice che c'è. La formula leucocitaria: l'aumento dei globuli bianchi è un altro indice indiretto, perchè sapete che le cause di aumento dei globuli bianchi sono tantissime, ci può essere un aumento dei leucociti per le più svariate affezioni, in corso di appendicite acuta, si fa un prelievo, aumentano i bianchi, soprattutto neutrofili, la formula si sposta in neutrofilia, quella è una causa completamente differente di aumento dei globuli bianchi. Anche in corso di gotta possiamo avere un aumento dei leucociti; pensate che l'incremento dei globuli bianchi molti l'hanno considerato come marker importante per la valutazione del rischio cardiovascolare; in pratica, in presenza di flogosi, questa può essere un fattore precipitante, per esempio, una coronaropatia. Alcuni clinici tendono, giustamente, quando si fa il pannello della valutazione del rischio cardiovascolare, a prendere in considerazione non solo il colesterolo, la proteina C reattiva, che è diventato un esame eseguito di routine, anche la formula leucocitaria per l'aumento dei bianchi. Quando c'è una proteina C reattiva elevata, un colesterolo elevato, un aumento dei bianchi significativo (oltre i 10000) l'individuo ha un rischio acuto, non trascurabile, il clinico vedrà cosa fare, potrà somministrare la cardioaspirina, prescrivere le statine per abbassare il colesterolo. E', diciamo, un dato in più. I bianchi tendono ad aumentare anche in corso di gotta. Poi abbiamo le proteine della fase acuta. In corso di infiammazione acuta abbiamo alcune proteine che inequivocabilmente aumentano, ad esempio il fibrinogeno, proteina della coagulazione che quando c'è una flogosi acuta in atto aumenta. Un bambino con una tonsillite importante può avere fibrinogeno e piastrine molto alte perchè sono indirettamente dei fattori che tendono ad aumentare in corso di infiammazione acuta. Certamente le piastrine non sono proteine della fase acuta, però anche loro possono aumentare. Le proteine della fase acuta migrano con l'elettroforesi in . Abbiamo albumina, e. Il picco delle durante l'infiammazione aumenta molto. Quindi in corso di infiammazione troviamo una VES alta, il picco delle elevato, ci possono essere proteina C reattiva e fibrinogeno elevati, per esempio, ci sono quelle che chiamiamo appunto proteine della fase acuta che tendono ad aumentare, soprattutto la proteina C reattiva. In genere l'artrite gottosa acuta si caratterizza per un attacco che provoca un dolore fortissimo, quando io ho studiato la gotta il libro proponeva questo esempio: "Al paziente fa male poggiare il lenzuolo sull'alluce", mi era sembrato esagerato, poi ho incontrato i pazienti che hanno confermato, e ho pensato "Quello che si studia è vero, a volte...". Non tutto quello che si studia è sempre vero, perciò dico così, bisogna essere sempre critici e avere la possibilità di confrontare le cose che si studiano su più testi . L'attacco di gotta acuta è un evento veramente dolorosissimo, in genere colpisce l'alluce, zona distale

dove la temperatura del corpo è un pò più bassa, c'è gonfiore, eritema, calore, talvolta febbre. La cute della zona interessata può andare incontro a desquamazione dopo la risoluzione dell'attacco di gotta acuta. Abbiamo già detto che interessa prevalentemente le articolazioni periferiche, in genere estremità inferiori, però può colpire anche altri siti, come per esempio l'inserzione del tendine d'Achille. Nel 50% dei casi è coinvolta la prima articolazione metatarsofalangea, ma questo ci interessa meno. La gotta si può sviluppare ogni volta che il liquido sinoviale sia ipersaturo di urati, è evidente: c'è una tale saturazione del liquido sinoviale da parte degli urati che precipitano e danno l'attacco di gotta. A volte l'uricemia non è elevata in corso di attacco di gotta acuto, perché c'è qualche fattore che lo abbassa, magari il fatto stesso che precipiti può essere una concausa.Quanto dura l'intervallo tra il primo e un eventuale secondo attacco di gotta (non è detto che il paziente debba avere sempre attacchi di gotta, ne può avere uno, e a volte se inizia a curarsi poi non ne avrà più)? A volte passano anche decenni, tra il primo e il secondo attacco di gotta. L'intervallo completamente asintomatico tra il primo e il secondo attacco di gotta viene chiamato gotta intercritica.L'artrite gottosa cronica invece si ha quando questi periodi intercritici si riducono perché attacchi alle articolazioni si verificano più frequentemente. E' tipica del paziente che non si è curato o non ha avuto modo di curarsi. L'artrite che cronicizza alla lunga porta alla formazione di aggregati di cristalli di urato di sodio chiamati tofi, circondati da cellule giganti. I tofi sono chiaramente una caratteristica della forma cronica, non della forma acuta, ci vuole tempo perché tali fenomeni avvengano. Quando io vi chiederò all'esame cosa i tofi caratterizzino, voi mi dovrete rispondere:- La forma cronica. l'artrite gottosa cronica. I tofi si trovano prevalentemente sulle strutture articolari, ma anche su strutture extraarticolari; danno un fenomeno di osteolisi: l'osso, nella porzione adiacente al tofo, va in osteolisi, e questo si può notare facendo una lastra. In genere trascorrono dieci anni dal primo attacco di gotta acuta al secondo, poi magari curata male porta alla formazione dei tofi, evento cronico, lento. Dunque, l'artrite gottosa si manifesta solo nell'1% dei casi di insufficienza renale nonostante ci sia iperuricemia, quindi l'insufficienza renale è una causa di gotta ma meno frequentemente di quanto si pensi. L'artrite gottosa è più frequente nella malattia del rene policistico, e anche qui la funzione renale può un pò zoppicare. A volte un individuo che ha 1,4 mg/dL di creatininemia si sottopone ad un'ecografia dietro suggerimento del medico e scopre di avere rene policistico. La malattia del rene policistico è un fattore predisponente per l'iperuricemia e per attacco di gotta. L'aumento a livello renale dell'acido urico causa nefrolitiasi, nefropatia da urati e nefropatia da acido urico, queste ultime molto simili. La nefrolitiasi è un analogo della calcolosi renale: ci sono individui che hanno calcolosi renale che possono successivamente manifestare un attacco acuto di gotta. C'è una buona corrispondenza tra calcolosi renale da acido urico e iperuricemia, c'è una discreta correlazione. Vi ricordo comunque che in Sardegna la prevalenza di calcolosi renale è elevata per varie ragioni; questi fenomeni calcolosi sono più frequenti nelle zone più calde. La nefropatia da urati è diversa, perché in questo caso abbiamo deposizione di cristalli nell'interstizio midollare del rene (piramidi renali), non nelle vie di escrezione. Questo è un guaio: un conto è la calcolosi renale, dolorosa, c'è la colica renale vista prima, ma la deposizione di cristalli nell'interstizio porta a lungo andare all'insufficienza renale cronica, che a volte affiora con tutti i segni caratteristici, tra cui l'ipertensione arteriosa.La nefropatia da acido urico è leggermente diversa ma sono quadri clinici molto simili, questa è dovuta alla deposizione di cristalli di acido urico nei tubuli renali e nei collettori, con l'ostruzione del flusso urinario.Il problema è che queste sindromi si presentano a volte come complicanze di patologie neoplastiche, per esempio un linfoma. Le neoplasie talvolta si complicano con problemi di tipo renale, nefropatia da acido urico, per esempio. Due brevi parole sulla sindrome di Lesch - Nyhan, una malattia ereditaria legata al cromosoma X. Come in tutte le patologie legate all'X, verrà colpito il maschio emizigote, le femmine in genere trasmettono la malattia, difficilmente la donna sarà omozigote (è una malattia abbastanza rara). Di norma le femmine sono eterozigoti. C'è un difetto nella via enzimatica di HGPRT (ipoxantina-guanina- ribosiltransferasi) e colpisce 1/100000 nati, è rara ma non rarissima. Qual è il problema? Questi individui hanno una serie di patologie legate al ritardo mentale, tendenza all'aggressività, all'automutilazione, disturbi neurologici. Si verifica un aumento dell'acido urico.Le altre magari ve le controllate, per avere giusto un'idea. Esistono anche altre sindromi genetiche legate a difetti del metabolismo dell'acido urico. Per esempio abbiamo la xantinuria, malattia abbastanza conosciuta dovuta a deficit della xantina ossidasi, proprio nella via finale del catabolismo delle purine che porta a formazione di acido urico, patologia recessiva che determina tutta una serie di problemi.