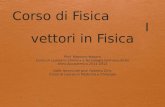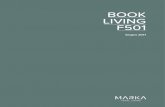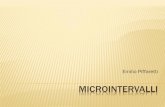LETTERA DEL PRESIDENTE APPROFONDIMENTI FOCUS ... 2016/2 CT...Roberta Povoleri, Elena Rastello, Paola...
Transcript of LETTERA DEL PRESIDENTE APPROFONDIMENTI FOCUS ... 2016/2 CT...Roberta Povoleri, Elena Rastello, Paola...

luglio-settembre 2016 – juvenilia 1
■ LETTERA DEL PRESIDENTENon c’è partita se non si lavora sulla compatibilità fra giocatori
■ PGSITALIA INTERVISTAQuanto ci lasciamo fare dal carisma salesiano a fi anco dei giovani?
■ APPROFONDIMENTIEssere per i giovaniportatori di futuro
Misurarsi con la paurache rende violenti i ragazzi
Sviluppare l’attenzione per migliorare le prestazioni
■ FOCUS 2016IMMAGINARE NEI DIVERSI TERRITORI IL FUTURO DEL NOSTRO SPORTLA SFIDA DELL’INTRAPRENDENZAIL CARISMA SALESIANO COME ENERGIAIL VOLONTARIATO “BENE DI COMUNITÀ”IL RADICAMENTO IN TERRITORI FRAGILILA FORZA PROPULSIVA DENTRO I TERRITORI
22016
Post
e It
alia
ne S
.p.A
. Spe
dizi
one
in a
bbon
amen
to p
osta
le -
70%
Rom
a A
ut. n
. C/R
M/0
78/2
010

Fondata da Don Gino Borgogno
Anno LVI - n. 2 - 2016 RIVISTA
DELLE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANEVia Nomentana, 175 - 00161 Roma
[email protected] - www.pgsitalia.org
DIREZIONE E REDAZIONEFrancesca Barbanera, Luca Baracco,
Luca Caruso (vicedirettore), Francesco D’Ambrosio, Enrico Delmastro,
Franco Floris (direttore responsabile), Angelo Isella, Franco Longo,
Michele Marmo, Michele Portincasa, Roberta Povoleri, Elena Rastello, Paola Scalari
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 297/2010 del 22/06/2010
IMPAGINAZIONE E STAMPATipolitografia Istituto Salesiano Pio XI
Via Umbertide, 11 - 00181 Roma Tel. 06 7827819 • [email protected]
Finito di stampare: Novembre 2016
Som
mario
3 LETTERA DEL PRESIDENTE
30 DAL TERRITORIORoma | Allenamenti estivi verso legami durevoliper il futuro della ginnastica ..........................................................................30
Monica Malabotta
Reggio Calabria| La risposta a chi amaun sport sano ed economico .................................................................................30
Sergio Notaro
Alassio | Cosa c’è di meglio di tre giorni di mare e sport? .............................................................................................................................31
Cristina Bollini
Roma: Un corso nazionale di aggiornamentoper vecchi e nuovi alleducatori ................................................................................31
Sr Francesca Barbanera
ENTRANEL “FOCUS”DI QUESTONUMERO
Dietro al Focus emerge l’idea che non si possa inoltrarsi nella “stagione elettora-
le”, se non ci sono momenti di dialogo anche serrato nei diversi e variegati
territori. Come ricorda suor Anna Razionale nell’intervista in aper-
tura di questo numero, da noi tutti attendono risposte chiare e pragmatiche alle loro attese, ma queste non sono delineabili senza un
alto tasso di pensiero sul fare.Ragionare a livello locale o pro-
vinciale su alcune pagine di questo Focus e/o di quello contenuto nello
scorso numero di Juvenilia, soffer-mandosi anche solo su una delle cinque
scelte fondanti dello Statuto, è affermare che il futuro delle PGS chiede l’apporto del
pensiero di tutti.segue a pag. 19➔
28 VITA ASSOCIATIVAUn’estate di Olimpiadi che rilancia lo sportforza educativa ........................................................................................................................28
Elena Rastello
4 PGSITALIA INTERVISTAQuanto ci lasciamo fare dal carisma Salesiano a fianco dei giovani? ...........................4
Intervista a Suor Anna Razionale a cura di Juvenilia
7 PASTORALE GIOVANILELa nostra impronta nello sport per fare uno spazio di realizzazione dei giovani ..............7
Sr. Francesca Barbanera
9 APPROFONDIMENTII principi cardine della relazione nel lavoro di animazione che fa perno sugli interessi giovanili .......9
Mario Pollo
Allenatori e dirigenti che si misurano con la paurache rende violenti i ragazzi ...............................................................................13
Paola Scalari
Comprendere i meccanismi del processo attentivo migliora le prestazioni sportive .................................................................16
Francesco D’Ambrosio
19 FOCUS Immaginare nei diversi territoriil futuro prossimo del nostro sportI molti appuntamenti di uno sport che vuole giocare la carta dell’intraprendere ..................19
A cura di un gruppo di PGS del Veneto
La fede nel futuro passa dal quotidiano esserci e co-evolverci sul campo e a bordocampo ..................................21
A cura di un gruppo di PGS della Liguria
La gratuità del volontariato la si vede nello stilecon cui sta in mezzo ai ragazzi ......................................................................22
A cura di un gruppo di PGS della Sicilia
Se le fragilità non vengono da noi è ora che il nostro sport si incammini verso di loro ....................................................................24
A cura di un gruppo di PGS della Lombardia
Lavorare per orientare insieme le linee delle politiche sportive dentro le comunità territoriali ...........................................26
A cura di un gruppo di PGS del Piemonte

luglio-settembre 2016 – juvenilia 3
Lettera del Presidente
NON C’È PARTITA SE NON SI LAVORA SULLA COMPATIBILITÀ FRA GIOCATORI
sappiano bene che un buon allenatore è chi, trovandosi di fronte a giocatori diver-si per capacità atletiche e
relazionali, cerca anzitutto la compati-bilità tra tutti, valorizzando le positività e contenendo le spigolosità di ognuno. Solo così, come si dice, si può fare spo-gliatoio fra tutti, stare in partita, giocare e possibilmente vincere.
A ben vedere, quello della compa-tibilità è un problema diffuso a molti li-velli: da una squadra a un’associazione, da un paese a una nazione.
Lo è perché, in un tempo di confu-sione e incertezza, siamo tutti alla ri-cerca della nostra identità di persona, di gruppo, di associazione, pronti a difenderla da chi sembra minacciarla. Proprio a causa dell’incertezza, più di
Tutto questo, direi, ci riguarda pro-fondamente come associazione, sia se volgiamo lo sguardo al nostro interno, sia se lo volgiamo verso l’esterno.
La nostra identità associativa può lievitare oggi percorrendo l’Italia in lungo e in largo, riconoscendo le ric-chezze dei nostri mondi associativi, anche la diversità di sguardi e di stili di azione, facendo in modo che queste ricchezze vengano comprese e condi-vise, scandagliate e “gustate”, trasfor-mate in spinta forte a metterci a servi-zio di questa generazione di ragazzi e adolescenti nell’inventarsi anche loro “buoni cristiani e onesti cittadini” attra-verso lo sport.
Ma lo sguardo lo dobbiamo volge-re anche fuori, senza chiuderci in ciò che già siamo, per aprirci a ciò che potremmo essere se valorizziamo il nostro stile nel fare sport, immergen-doci nelle nuove periferie umane, ma anche interagendo e collaborando con altri mondi associativi sportivi, intravedendo nella cooperazione e nella contaminazione una possibilità di arricchimento per tutti.
Sono convinto che oggi sono mol-ti i mondi sportivi attratti dalla nostra storia con i quali entrare in contatto, non usando la nostra fede sportiva per distinguerci, separarci, opporci, ma ap-punto per incontrarci, accoglierci e col-laborare in vista del compito comune dell’educare nel fare sport. Chiuderci è impoverente per tutti, rende statica la nostra identità, a volte la rende in-sipida. Aprirci e cercare dei minimi denominatori comuni è la strada che rigenera tutti perché i riconoscimenti, gli scambi, gli apprendimenti reciproci insaporiscono il lavoro di tutti. In nome della possibilità di misurarsi insieme con la grande partita del far giocare a tutti la loro storia di vita, magari in pa-lestra o in piscina o in campi di calcio a cui fin’ora non abbiamo mai pensato, insaporendola con il sale del carisma salesiano. È tempo per allenare e al-lenarci a inaspettate compatibilità. ■
Lo
Gianni Gallo
ieri tutti difendono, purtroppo anche con le armi, la loro identità etnica, re-ligiosa, culturale, associativa. In gioco, si dice, ci sono le nostre caratteristiche irrinunciabili.
In realtà tutti sappiamo che un’iden-tità non è qualcosa di fisso o stabile, ma qualcosa che si evolve nel tempo, man mano che i contesti in cui si vive si mo-dificano, anzi convivendo con gli altri soggetti sociali con cui abitiamo. E tutti noi abbiamo chiari due rischi.
Il primo è chiuderci in noi stessi, isolarci, non comunicare, stare in difesa, proclamarci autosufficienti. L’esito è lo spreco, se non la dispersione della no-stra storia personale, di gruppo, di as-sociazione. L’alternativa appassionante è aprirci senza paura ma anche senza ingenuità, comunicare e “scambiare”, senza per questo venir meno alle no-stre radici.
L’apertura verso gli altri non è facile perché essi possono farci male, impa-dronirsi di noi, fagocitarci. Ma se ci ar-rocchiamo in un sistema chiuso viene meno la spinta a evolverci, interrogati, messi in discussione e sfidati, ma anche arricchiti dalla presenza degli altri, al punto che possiamo scrivere un nuovo capitolo della nostra storia, della no-stra identità. C’è dunque futuro dove diverse storie si incontrano, dialogano, rigenerano attraverso il riconoscimen-to reciproco, l’ascolto curioso e inten-so, l’apprendimento gli uni dagli altri, sapendo di avere un compito comune: dare dignità a ogni vita umana, senza esclusione.
Si pensi alla scelta di papa Fran-cesco di entrare in contatto con altre chiese e con altre fedi, non per imporre la propria fede, ma piuttosto per arric-chirsi gli uni gli altri in nome del bene dell’umanità tutta. Dalle sue parole, ma prima ancora dal suo sguardo, traspare un interesse incondizionato per l’altro e la convinzione che solo nel dialogo franco e costruttivo ognuno comprende a fondo la sua fede e consolida la sua missione nel mondo a servizio dell’uo-mo che Dio ama.

“
4 juvenilia – luglio-settembre 2016
PGSITALIA INTERVISTA
QUANTO CI LASCIAMO FAREDAL CARISMA SALESIANO A FIANCO DEI GIOVANI?Intervista a suor Anna Razionale a cura di Juvenilia
intervista a suor Anna Ra-zionale, presidente nazio-nale del CIOFS, va collo-cata dentro il cammino che
sta portando le PGS alla nuova stagione elettorale 2016-2017, con la pretesa che sia, come abbiamo detto spesso sulla rivista, “una stagione di convivialità, di dialogo, di nuove leadership”. Una sta-gione che come rivista accompagnia-mo con delle interviste (si veda quella a don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, sull’ultimo numero di Juvenilia rilancia la sfida a cammina-re con i giovani più poveri nello sport e nella vita. E accompagniamo anche con i Focus intorno alle cinque scelte fondanti dello sport PGS secondo lo Statuto. In questa prospettiva si veda il Focus di questo numero con le riflessio-ni maturate da cinque gruppi di lavoro in diverse Regioni.
Il punto di partenza dell’intervista va ricercato nel messaggio della Ma-dre generale suor Yvonne Reungoat, ai giovani sportivi riuniti a Torino nella primavera del 2015 per i Giochi inter-nazionali PGS, quando ha scritto:
Carissimi giovani, vi voglio bene; tutte le Figlie di Maria
Ausiliatrice credono. come ci insegnato don Bosco, che nel vostro cuore, nel-la vostra vita ci sono ideali grandi che devono essere riconosciuti, apprezzati, messi in movimento senza timidezza, ma con intraprendenza come sapete fare voi.
Insieme, siete capaci di trasformare l’attività sportiva in un mezzo effi cace per andare verso le “periferie” e provare
L’
la gioia di donare il meglio di voi stessi a chi attende amicizia, accoglienza, una stretta di mano con sincerità, un sorriso che comunica ottimismo.
Un pressante invito ai giovani sportivi quello di suor Yvonne a mettersi in movi-mento, essere intraprendenti, non chiu-dersi in se stessi, per andare nelle “perife-rie”. Un messaggio in realtà sfi dante per quanti adulti e giovani guardano insieme al futuro delle PGS, senza chiudersi nella nostalgia del passato o nel lamento dif-fuso verso il presente, per fare invece del carisma salesiano un insieme di micro-e-sperimenti signifi cativi a livello locale e insieme nazionale (e internazionale) che aprono varchi di futuro per tutti.
Di fronte all’insorgere di domande “tremende” da parte della società, in particolare da parte degli adole-scenti, cosa ha da offrire, da met-tere in gioco, il carisma salesiano?
Ogni tempo, ogni società gene-ra le sue “tremende domande”, così come genera le risposte attraverso i carismi, quei doni che lo Spirito fa a uomini e donne non perché hanno presentato un curriculum d’eccezio-ne o sponsorizzati da qualcuno im-portante, ma perché forse meglio di altri sono entrati nella dinamica della gratuità, tipica dell’agire di Dio.
Sicuramente i giorni che stiamo vivendo non sono facili per nessu-no, né per i giovani, né per gli adulti, ma noi che ci sentiamo portatori di un carisma educativo abbiamo for-se bisogno di rompere quella sorta di “incantesimo” che non permette alla parola “carisma” di sprigionare quell’energia, quel fascino, quella bellezza che rende poi pieni di ener-gia, fascino e bellezza anche le per-sone che vivono di quel carisma... cioè noi!
Di don Bosco si diceva che “edu-cava amando, attraendo, conquistan-do e trasformando... avvolgeva tutti quanti, interamente, in un’indicibile atmosfera di allegrezza e di felicità”. Diremmo oggi, con un lessico un po’ più laico, era una “persona carisma-tica”, così noi che non ci sentiamo tali prendiamo una certa distanza dal carisma impedendo ad esso di di-ventare carne e sangue con la nostra persona.
E, allora, la domanda non è più cosa il carisma ha da offrire, da met-tere in gioco di fronte alle domande dei giovani e della società, quanto p
ato un curriculum d’eccezio-onsorizzati da qualcuno im-
e, ma perché forse meglio di no entrati nella dinamica gratuità, tipicare di Dio.

luglio-settembre 2016 – juvenilia 5
➔
piuttosto cosa abbiamo da of-frire noi, in che misura ci met-tiamo in gioco, ci lasciamo fare dal carisma.
I giovani alla fine hanno bi-sogno proprio di questo, non di super eroi, ma di adulti, di educatori capaci di coinvolgersi con passione nelle cose che fan-no, nelle situazioni, nelle relazio-ni, nella storia... Non un coinvol-gimento solo di testa o di anima, ma anche di cuore e di mani.
Cosa è stato Don Bosco se non un adulto così? Certo, non pensava di essere quel santo che poi è stato, il fondatore di un’o-pera grande quanto il mondo... Lui ha semplicemente – con tutto quello che ha comportato in ter-mini di fatica – lasciato che lo Spi-rito agisse in lui, mettendosi a sua disposizione, non in maniera passiva ma con capacità di iniziativa. E così la paura è diventata fede, la sfiducia speranza e l’esperienza di orfanità un cuore aperto e ospitale per ogni giovane.
La sfida è dare risposte chiare e pragmatichealle attese del tempoIn una cultura del fare come l’at-tuale, cosa è intraprendere alla don Bosco?
Piero Bairati, storico dell’impren-ditoria moderna, quando si è imbattu-to nella figura di Don Bosco durante i suoi studi sulla storia di Torino e della Fiat scrisse così: “La storia delle sue opere nasce da una propensione ai comportamenti decisionali, una carat-teristica che fa di lui un Santo con la stoffa da manager”. Seppe, cioè dare risposte chiare e pragmatiche ai pro-blemi posti dal nascente processo di industrializzazione di una società in profonda trasformazione.
Da questa considerazione deriva il fatto che Don Bosco non è stato un intellettuale, non un solitario medi-tabondo, è stato un pragmatico, ma non senza pensiero. La scelta dei suoi obiettivi non era il frutto di lunghe e mai concluse elucubrazioni, ma di quella sua frase poco citata: “Voglia-mo intrometterci... dappertutto”.
La sua azione come educatore, come uomo attento ai cambiamenti sociali, come gestore di un’organiz-
zazione (parola che a noi oggi infa-stidisce, ma con cui quotidianamente dobbiamo fare i conti) che stava cre-scendo e sviluppando, nasce allora da quello slancio vitale, dall’ascolto e dall’esercizio di una vocazione spe-ciale per la comunicazione e per la leadership. Per cui possiamo dire che essere intraprendenti alla Don Bosco significa tutto questo.
Verso dove intraprendere come PGS oggi? Lungo quali piste incammi-narci, guardando in avanti?
Di don Bosco sappiamo che ha avuto anche una grande abilità a cre-arsi, a formarsi una squadra di colla-boratori, a mettere al centro dell’at-tenzione pubblica il tema educativo o,
meglio, i ragazzi con le loro reali esigenze. In questo è stato molto abile nell’intraprendere relazioni con chiunque potesse aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo: la salvezza di tutto il giovane. E noi FMA, raccogliendo questa sua eredità, abbiamo gli strumenti per poter continuare a sviluppa-re questo obiettivo carismatico; abbiamo lo strumento associati-vo che ci permette, nel migliore dei casi di formarci collabora-tori laici e di arrivare ai giova-ni valorizzando i loro interessi, per esempio l’intramontabile interesse per lo sport che vede ancora oggi la possibilità di aggregare ragazzi e ragazze.
Per fare sport oggi ci vuole anzitutto un pensiero sul fareQuali attenzioni favoriscono uno slancio intraprendente nel tempo libero a fianco delle ragazze e dei ragazzi?Il problema, per la PGS come per le altre Associazioni, sta nel superare quella cultura diffusa del “fare per il fare” e riposizionarsi come Asso-ciazione sul “fare sport”, ma con un “pensiero sul fare” che aiuti a cerca-re le modalità organizzative più ade-guate per coniugare professionalità nel servizio e capacità di allargare la proposta sportiva ed educativa a tutti; a rendere più consapevoli i diri-genti del compito di animazione che svolgono oltre che tecnico; a rende-re sempre più l’Associazione, grazie
f-et-re
bi-on di rsi
an-zio-vol-ma,
se non che n’o-do... tutto ter-Spi-
a suapassiva
meglesigeabilecon raggsalveFMAeredper re qabbvo cdeitorni vperintanag
Poggi canzitu

6 juvenilia – gennaio-giugno 2016
INTERVISTE a...
alla sua ricchezza di gesti, riti e lin-guaggi, un luogo di ricomposizione dei legami tra atleti, con le famiglie, con il territorio in generale.
Pensiamo per esempio al grande potenziale di scambio e di confronto con la diversità culturale che le tra-sferte, gli eventi di festa portano al loro interno! Questo però richiede una capacità dirigenziale capace di creare le condizioni organizzative e relazionali che tutto ciò comporta.
Dal momento che fare sport in maniera diversa significa in qualche modo produrre e mettere in circolo cultura, la strada dell’associazioni-smo – e quindi anche la PGS – può dare in questo il suo più bel contri-buto. Per esempio, pensiamo a come maschile e femminile possono arric-chirsi nel fare sport!
Una palestraper apprendere il grande gioco della cooperazioneCome possono arricchirsi maschi-le e femminile nel fare sport?
Se il potenziale educativo dello sport non viene soffocato da altro, pensiamo a come si potrebbe lavo-rare a livello formativo, sul versante degli stereotipi di genere, i compor-tamenti cioè che ci si aspetta da un ragazzo e da una ragazza nella linea della condivisione del gruppo; il rap-porto con il proprio corpo e quello dell’altro, come potrebbe rafforzarsi la capacità alla cooperazione e alla creazione della leadership in vista della formazione di futuri dirigen-ti pensato come un ruolo di grande responsabilità sociale per entrambi i sessi.
Lo sport diventerebbe davvero un luogo di pari opportunità, di crescita integrale, di apprendimento del cosa vuol dire “mettersi in gioco” nella vita.
Sono di stimolo in questo senso alcune parole di Papa Francesco che riprendo volentieri perché sono un testo prezioso per lo sport PGS: “Pro-prio perché siete sportivi, vi invito non solo a giocare, come già fate, ma c’è qualcosa di più: a mettervi in gioco nella vita come nello sport. Mettervi in gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed entusiasmo”. ■
METTERSI IN GIOCO METTERSI IN GIOCO NELLA VITA NELLA VITA COME NELLO SPORTCOME NELLO SPORTPapa Francesco
Riprendiamo volentieri i passaggi principali della rifl essione di Papa Francesco ha offerto al mondo sportivo, come ci ricordato suor Anna Razionale nell’intervista qui a fi anco.
Lo sport solo se rimane un gioco fa bene al corpo e allo spirito. E proprio perché siete sportivi, vi invito non solo a giocare, come già fate, ma c’è qualcosa di più: a mettervi in gioco nella vita come nello sport. Mettervi in gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed entusiasmo. Mettervi in gioco con gli altri e con Dio; non accontentarsi di un
“pareggio” mediocre, dare il meglio di sé stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre. Non accontentarsi di queste vite tiepide, vite “mediocremente pareggiate”: no, no! Andare avanti, cercando la vittoria sempre! Vi auguro anche disentire il gusto, la bellezza del gioco di squadra, che è molto importante per la vita. No all’individualismo! No a fare il gioco per se stessi. Nella mia terra, quando un giocatore fa questo, gli diciamo: “Ma questo vuole mangiarsi il pallone per se stesso!”. No, questo è individualismo: non mangiatevi il pallone, fate gioco di squadra, di équipe. Appartenere a una società sportiva vuol dire respingere ogni forma di egoismo e di isolamento, è l’occasione per incontrare e stare con gli altri, per aiutarsi a vicenda, per gareggiare nella stima reciproca e crescere nella fraternità.Nelle società sportive si impara ad accogliere. Si accoglie ogni atleta che desidera farne parte e ci si accoglie gli uni gli altri, con semplicità e simpatia. Invito tutti i dirigenti e gli allenatori ad essere anzitutto persone accoglienti, capaci di tenere aperta la porta per dare a ciascuno, soprattutto ai meno fortunati, un’opportunità per esprimersi.
(7 giugno 2014)
LogispspgqgsMrecMa7 giugno 2014.
Le società sportive con Papa Francesco

“
luglio-settembre 2016 – juvenilia 7
PASTORALE GIOVANILE
Francesca Barbanera
2016-2017: UN ANNO PER DONARE A RAGAZZI E RAGAZZE IL CORAGGIO DI ALZARE LO SGUARDO VERSO L’ALTO
ello scegliere lo slogan pastorale per l’anno 2016-2017, si è voluto partire dalle provocazioni molto
incisive e concrete che Papa Francesco ha lanciato ai giovani nel corso della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia dello scorso luglio. In modo particolare una parte del di-scorso della Veglia, vuole stimolare non solo l’impegno dei giovani, ma anche di ciascuno di noi, a lasciare un’impronta significativa nel mondo dello sport nel quale operiamo. L’im-pronta del nostro essere per i giova-ni, l’impronta di uno sport che vuole essere strumento di realizzazione dei giovani, un’impronta che vuole supe-rare l’emarginazione, l’impronta della trasparenza e rettitudine, l’impronta della comunione, l’impronta della pre-ventività e quindi della salesianità.
Papa Francesco infatti, in quella not-te di Cracovia, si è rivolto ai giovani di tutto il mondo con queste parole:
Cari giovani, non siamo venuti al mondo
per “vegetare”, per passarcela comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti; al contrario, siamo venuti per un’al-tra cosa, per lasciare un’impron-ta. È molto triste passare nella vita senza lasciare un’impronta. Ma quando scegliamo la como-dità, confondendo felicità con consumare, allora il prezzo che paghiamo è molto ma molto caro: perdiamo la libertà”. Questo è il prezzo. E c’è tanta gente che vuole che i giovani non siano li-beri; c’è tanta gente che non vi vuole bene, che vi vuole intontiti, imbambolati, addormentati, ma mai liberi. No, questo no! Dobbia-mo difendere la nostra libertà!
Educatori che suscitanodomande
Anche la proposta di pastorale gio-vanile che a livello Italiano in ambito salesiano è stata offerta a tutti gli am-bienti, invita i giovani a riflettere su un punto essenziale per l’esistenza di ogni uomo: “Con o senza te non è la stessa cosa”. A questo titolo/slogan se ne ag-giunge un altro: “Maestro dove abiti?”.
Il titolo di per sé è già una rispo-sta affermativa a una domanda di senso ma poi con la richiesta di scoprire dove abita il Maestro, indica la fatica di una ricerca che non è affatto scontata. Ma an-cora di più noi educatori, non possiamo dare per scontato che i nostri gio-vani atleti si pongano le domande di fondo.
E qui, ecco profilarsi
l’espressione più evidente della “liqui-dità” del nostro substrato sociale: un mondo che si ferma alla porta della Via, Verità e Vita, che è l’Uomo Gesù, senza oltrepassarla mai.
Nell’antichità si sosteneva che solo alcuni “privilegiati” potessero avere la capacità di filosofare, di pensare; che la maggior parte delle persone inseguis-sero l’opinione, il “fanno tutti così” (così lo potremmo tradurre oggi), mentre solo i pochi, ricercavano la vera scien-
za, il sapere, la conoscenza. Forse in questo contesto sociale e contemporaneo, più che mai, il ruolo di un vero educatore che si metta a fianco dei giova-ni, deve essere quello di colui che insegue la Ve-rità: un “suscitatore di do-manda”. E proprio come nel mondo classico, chi compie questa missio-ne, è certamente una
N
La nostra impronta nello sport per farne uno spazio di realizzazione dei giovani
➔

“
8 juvenilia – luglio-settembre 2016
PASTORALE GIOVANILE
Sr. Francesca Barbanera è referente nazionale PGS: [email protected]
minoranza, che può assumere anche un grande valore se viene considerata quale minoranza “evangelica”. Di con-seguenza, non saranno neanche molti, i giovani che davvero cerchino il Mae-stro e questo non ci deve spaventare.
Non basta un divanocontro il dolore e contro ogni timore
Sempre nel corso della Veglia di Cracovia Papa Francesco ha utilizzato una metafora molto esplicita e plasti-ca con la quale rappresentare ciò che spesso è il nostro mondo, e ciò che vivono i nostri giovani:
Nella vita c’è un’altra paralisipericolosa e spesso diffi cile
da identifi care, e che ci costa molto riconoscere. Mi piace chia-marla la paralisi che nasce quan-do si confonde la felicità con un un divano! Sì, credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. Un divano che ci aiuti a stare comodi, tranquilli, ben sicuri. Un divano, come quel-li che ci sono adesso, moderni, con massaggi per dormire inclusi, che ci garantiscano ore di tran-quillità per trasferirci nel mon-do dei videogiochi e passare ore di fronte al computer. Un divano contro ogni tipo di dolore e timo-re. Un divano che ci faccia stare chiusi in casa senza affaticarci né preoccuparci. La “divano-felicità” è probabil-mente la paralisi silenziosa che ci può rovinare di più, che può rovi-nare di più la gioventù. “E perché succede questo, Pa-dre?”. Perché a poco a poco, senza rendercene conto, ci tro-viamo addormentati, ci troviamo imbambolati e intontiti. L’altro ieri, parlavo dei giovani che van-no in pensione a 20 anni; oggi
parlo dei giovani addormentati, imbambolati, intontiti, mentre altri – forse i più vivi, ma non i più buoni – decidono il futuro per noi. Sicuramente, per molti è più facile e vantaggioso avere dei giovani imbambolati e intontiti che confondono la felicità con un divano; per molti questo risulta più conveniente che avere giova-ni svegli, desiderosi di risponde-re, di rispondere al sogno di Dio e a tutte le aspirazioni del cuore.Proprio qui c’è una grande pa-ralisi, quando cominciamo a pen-sare che felicità è sinonimo di comodità, che essere felice è camminare nella vita addormen-tato o narcotizzato, che l’unico modo di essere felice è stare come intontito. È certo che la droga fa male, ma ci sono molte altre droghe socialmente accet-tate che fi niscono per renderci molto o comunque più schiavi. Le une e le altre ci spogliano del nostro bene più grande: la liber-tà. Ci spogliano della libertà.
L’umanità di Cristo spesso abita l’umanità ferita
Le provocazioni del Papa proseguo-no con l’affermazione che Gesù non è il Signore del comfort, della sicurezza e della comodità. E il luogo dove incon-trare il Maestro sicuramente può esse-re presentato ai nostri ragazzi come il luogo dell’umanità di Cristo che spes-so è l’umanità ferita: cioè dell’affama-to, dell’assetato, del nudo, nel malato, dell’amico che è finito male, del dete-nuto, del profugo e del migrante.
Ma anche il luogo dell’umanità di Gesù che crede e tiene fortemente all’amicizia, che piange per la morte dell’amico Lazzaro, che ama la bellez-za e i bambini, che sa sfamare le folle
di cui ha compassione, che dona la vita per amore.
E le domande di senso possono na-scere solo proprio a partire da tutte le esperienze che coinvolgono ogni parte di noi, dei nostri sensi, del corpo, del-le emozioni. Cercare dove abita il Ma-estro in questa prospettiva può essere davvero stimolante per i nostri giovani perché ci si trova di fronte a un Dio in-carnato. Dice a questo proposito il filo-sofo Eugen Fink: “La domanda, il pro-blema e lo stupore ci strappano da ogni porto e da ogni sicurezza per condurci in mare aperto”.
Il passo che dobbiamo aiutare a fare ai nostri giovani è quello del coraggio di iniziare, del mollare gli ormeggi e di partire. La partenza e il lasciare il molo è il momento più difficile. Ma per que-sto ancora una volta lasciamo la parola a Papa Francesco che si rivolge ai gio-vani proprio con delle immagini del mondo dello sport e quindi per noi fa-cilmente comprensibili:
Il tempo che oggi stiamo vivendo non ha bisogno di giovani-divano, ma di giovani con le scarpe, meglio anco-ra, con gli scarponcini calzati. Questo tempo accetta solo giocatori titolari in campo, non c’è posto per riserve. Per questo, amici, oggi Gesù ti invita, ti chiama a lasciare la tua impronta nel-la vita, un’impronta che segni la sto-ria, che segni la tua storia e la storia di tanti.
Consegniamoci in questo anno e soprattutto consegniamo ai nostri ra-gazzi, il cammino verso il vero senso della vita che passa attraverso la ri-cerca, la bellezza, la preghiera, la so-lidarietà. Doniamo loro il coraggio di alzare lo sguardo per prendere forza e benedizione dall’Alto per richiamarlo poi sul mondo come dono gratuito e presenza fraterna. ■

luglio-settembre 2016 – juvenilia 9
APPROFONDIMENTI
Farsi adulto educatore/3ESSERE PER GLI ATLETI PORTATORE DI FUTURO
Mario Pollo
I principi cardine della relazione nel lavoro di animazioneche fa perno sugli interessi giovanili
Oggi più di ieri il rischio è il tentativo degli adulti di abolire la distanza generazionale. A ben vedere, invece, la distanza non va abolita o esasperata ma, piuttosto, valorizzata. La valorizzazione passa da una comunicazione dialogica, in grado di rendere prossima la diversità generazionale, sapendo che ogni comunicazione richiede che i comunicanti siano simili e diversi allo stesso tempo. Da questo punto di vista da una parte giovani e adulti, pur diversi tra loro, hanno molte domande e aspirazioni in comune sul vivere oggi, e possono pertanto farsi co-ricercatori di un futuro sensato. Dall’altra la distanza stessa permette loro di dare un apporto diverso. Adulti e giovani sono nella condizione ottimale per comunicare, in quanto abbastanza simili e abbastanza diversi.
el precedente articolo si è individuata come una delle caratteristiche fondanti del-la relazione adulta dell’ani-
matore con il mondo giovanile quella dell’amore per il giovane e il suo mon-do, espresso attraverso l’accoglienza e la fiducia incondizionata finalizzate alla trasformazione creativa del presente, in nome del sogno del futuro condiviso dall’adulto e dal giovane. Nello stesso articolo sono stati delineati i caratteri di questa accoglienza rinviando a questo articolo, invece, le indicazioni sulle mo-dalità della sua realizzazione concreta.
Un’accoglienza intessuta di materno e paterno
Questa espressione un po’ ermeti-ca indica che l’adulto (educatore, ani-matore, allenatore) promuove una re-lazione con il giovane che deve essere un delicato equilibrio tra l’accoglienza incondizionata (modalità relazionale materna) e l’accoglienza subordinata all’effettuazione di alcune prestazioni
da parte dello stesso giovane (moda-lità paterna). In altre parole, questo significa che l’adulto educatore deve far sentire al giovane sia che è amato come persona e sia che deve impe-gnarsi nel fornire alcune prestazioni, se vuole rispondere alle attese che l’a-dulto educatore ha nei suoi confronti.
Occorre ricordare, però, che l’ac-coglienza incondizionata, per potersi realizzare, richiede per prima cosa una sorta di conversione dell’adulto educa-tore/animatore; nel senso che questi deve maturare in se stesso la capacità di cogliere in ogni persona la diversità e l’unicità che la rendono irripetibile.
Si è parlato di conversione, perché questa capacità non è, e non può esser-lo, il frutto di una competenza tecnica, bensì di uno sguardo d’amore. Infatti, è solo l’amore che riesce a far cogliere la diversità irripetibile di una persona che, allo sguardo privo di amore, se-gnato dalla passività delle abitudini, delle categorie interpretative consoli-date e dei pregiudizi personali, appare un anonimo – e per questo omologo – abitante dell’indistinto a cui viene dato il nome, un po’ fisico peraltro, di massa.
L’espressione “accoglienza” signifi-ca, infatti, nel metodo dell’animazione, per prima cosa la messa in valore della originalità e della dignità umana per-sonale dei giovani con cui l’educatore/animatore compie l’itinerario formativo.
N
➔

APPROFONDIMENTI
Come si è detto prima, però, l’acco-glienza incondizionata (materna) deve essere accompagnata da quell’acco-glienza richiedente (paterna) che, tra l’altro, consente all’educatore/anima-tore di non accondiscendere, in modo acritico e permissivo, agli stili di vita, ai valori e ai bisogni di cui i giovani con cui opera sono portatori. Infatti, si può riconoscere dignità all’originalità umana dell’altro, pur rifiutando e cri-ticando i suoi stili di vita, i suoi com-portamenti, le idee e i valori di cui è portatore.
Una coscienza limpida è una vera empatia
La capacità di valorizzare l’umanità particolare dell’altro, senza rinunciare a essere per lui uno stimolo critico o essendo, addirittura, l’esigente richie-dente di un cambiamento profondo, domanda all’adulto, oltre alla capacità di amare i giovani, una coscienza limpi-da di sé e una vera empatia, e la capa-cità di essere per il giovane portatore di futuro.
La coscienza limpida di sé, l’adulto la conquista solo se opera continua-mente per migliorare la conoscenza di se stesso, delle proprie potenziali-tà e dei propri limiti e utilizza la rela-zione educativa anche a questo fine. Uno degli elementi della conoscenza di sé che l’adulto educatore deve ne-cessariamente sviluppare riguarda la
congruenza tra le categorie mentali che egli utilizza
per interpretare la realtà e la stessa realtà. Infatti, la conoscenza di sé com-prende non solo le dimensioni affetti-ve, emotive, volitive, morali e cognitive ma anche i presupposti mentali che sono alla base dei processi attraverso cui l’adulto decodifica la realtà.
Questo tipo di conoscenza di sé è frutto di un lungo lavoro, sia interiore che di confronto con gli altri e la real-tà in generale. Per quanto riguarda la conoscenza del proprio sé psichico, l’introspezione, la revisione di vita, la correzione fraterna che deriva dai rap-porti interpersonali autentici e dalla vita in un gruppo di formazione umana e cristiana sono le vie maestre per po-terla raggiungere.
L’adulto, se vuole avere una co-scienza di sé limpida e profonda, deve, come si è detto, essere in grado di comprendere il suo modo di dare sen-so esistenziale alle cose che costellano la sua vita.
La persona impegnata a realizzare questo tipo particolare di conoscenza di sé è, indubbiamente, una perso-na che può realmente mettersi in un rapporto di vera disponibilità all’ac-coglienza e, quindi, alla conoscenza dell’altro, in quanto ricerca un’autenti-ca accoglienza di sé. Infatti, solo chi è in grado di accogliere autenticamente se stesso, e tenta di decifrare il proprio modo personale di rapportarsi alla re-altà, è in grado di riconoscere l’irripe-tibile originalità dell’altro, guardando ad essa con minori pregiudizi.
Una fiduciache restituisce al protagonismo
Complementare all’accoglienza di terzo educativo è la fiducia che è la disponibilità e la capacità dell’adul-to educatore/animatore a credere e a scommettere che il giovane possiede in sé, magari solo a livello potenziale, tutte le risorse necessarie a realizzare un progetto di vita che liberi piena-mente la sua umanità, in coerenza con il progetto d’uomo che motiva l’adulto alla sua azione educativa.
La fiducia, per essere un fatto educativamente efficace, non può rimanere nascosta nel cuore dell’a-dulto, ma, al contrario, richiede una sua forte manifestazione all’interno della relazione educativa. Richiede, ad esempio, il far capire al giovane, più che con parole con gesti concreti, che la sua vita, le scelte che egli com-pie, sono importanti per l’adulto a tal punto che questi è disposto a giocare parte della propria vita perché il gio-vane possa liberare la pienezza della sua condizione esistenziale.
Come si vede, la fiducia è null’altro che un volto dell’amore dell’adulto per il giovane e la sua vita ed è, tra l’altro, la forma moderna del principio educati-vo di Don Bosco, secondo cui «non solo è importante che i giovani siano amati ma che sappiano di esserlo».
Il modo più concreto di dare fiducia ai giovani, oggi, è quello di restituire loro quel protagonismo che la vita so-ciale nega loro. Il protagonismo può essere definito come un modo globale, da parte del giovane, di rapportarsi al gruppo educativo che gli consente di scoprire sia la sua identità personale, e quindi la sua unicità individuale, sia la responsabilità del suo agire sociale. Infatti, quando si parla di protagonismo del giovane, si fa riferimento essenzial-mente a due dimensioni: quella indivi-duale e quella sociale.
Il protagonismo individuale riguar-da, in modo particolare, la possibilità da parte del giovane di percepire il gruppo come luogo della propria auto-realizzazione e della connessa scoper-ta di essere una persona originale ed irripetibile.
Il protagonismo sociale riguarda, invece, la partecipazione alla vita del gruppo segnata dalla assunzione di responsabilità, oltre che nei confron-
cessariamente sviluppare riguarda la congruenza tra le categorie
mentali che egli utilizza
tibile originalità dell altro, guardando ad essa con minori pregiudizi.
ai gioloro qciale esserda pagruppscopre quila resInfattdel gmentduale
Ilda, inda pgrupprealizta di irripe
Ilinvecgrupprespo

luglio-settembre 2016 – juvenilia 11
ti della propria crescita, anche verso quella dei propri coetanei.
Abilitare il giovane al protagonismo è il modo concreto che l’adulto ha a di-sposizione per manifestare la fiducia e, nello stesso tempo, per combattere quel disagio subdolo e nascosto che affligge molti giovani e che è, come dimostrano le analisi sociologiche, ge-nerato dall’assenza di protagonismo degli stessi giovani nella vita sociale.
La dignità educativa degli interessi giovaniliL’accoglienza, da parte dell’adulto edu-catore/animatore, del mondo giovanile si manifesta, oltre che nella relazione esistenzialmente autentica, anche nel riconoscimento, e quindi nella loro ac-coglienza, della dignità educativa degli interessi di cui il giovane è portatore. Questo principio consiste semplice-mente nella disponibilità dell’adulto a partire, nel cammino educativo dai concreti interessi del giovane, siano essi ricreativi, del semplice stare insie-me, sportivi, culturali o religiosi.
Questo significa che, per l’anima-zione non vi sono interessi giovanili di serie A, che possono essere accol-ti, ed altri di serie B che debbono es-sere rifiutati, in quanto ogni interesse, anche il più banale o marginale, ha in sé una qualità educativa che può esse-re fatta emergere e che può fornire il fondamento al percorso formativo del gruppo. Ogni interesse del giovane deve perciò essere accolto come un potenziale tema generatore del proces-so educativo dell’animazione.
Infatti, uno dei cardini dell’anima-zione è, appunto, la consapevolezza che è possibile educare tutta la per-sona del giovane a partire da un fram-mento della sua esistenza. Come la parte è influenzata dal tutto, così la par-
te può influenzare e modificare il tutto, in quella circolarità ermeneutica che caratterizza la concezione dell’uomo come sistema.
Se si opera con questa convinzione e, naturalmente, con abilità e efficacia, si vedrà che è possibile senza partico-lari forzature far nascere nel giovane altri interessi, più evoluti, che forniran-no nuovi inneschi all’attività dell’edu-cazione/animazione.
La libertà e la complessità del giovane
Un’altra caratteristica della rela-zione dell’adulto educatore/animato-re con il giovane, che manifesta oltre all’accoglienza anche la fiducia, è co-stituito dal riconoscimento della liber-tà del giovane. Questo riconoscimento significa semplicemente che l’adulto è consapevole che ogni giovane ha un modo diverso, personale, di reagire alle stimolazioni che l’attività educativa del gruppo gli propone.
Per questo motivo, ogni azione edu-cativa ha un ampio margine di impre-vedibilità e deve perciò rifuggire da quel determinismo che si manifesta nelle “formule prefabbricate”, che rendono l’educazione la stanca e no-iosa celebrazione di un rito e che non permettono di riconoscere l’originalità e la diversità di ogni persona e di ogni gruppo umano.
Il riconoscimento della libertà del giovane comporta, quindi, da un lato, la progettazione di interventi originali, ovvero che rispondano puntualmente e creativamente alle particolarità dei giovani a cui si rivolgono e a quel-le dell’ambiente in cui avvengono, e, dall’altro, una continua verifica degli effetti reali che l’azione dell’educazio-ne/animazione produce.
Questo significa che il metodo
dell’animazione culturale è lontano mille miglia da quella concezione di lavoro sui gruppi giovanili basa-ta sull’uso monotono e ripetitivo di determinate tecniche di animazione. Nello stesso tempo, il metodo dell’a-nimazione, per rispettare la libertà del giovane, deve proporre continue verifiche al fine di valutare l’aderen-za tra l’intenzionalità educativa e gli effettivi risultati che il lavoro educati-vo dell’animazione produce.
Al riconoscimento della libertà va affiancato quello della complessità del giovane. Il termine “complessità” indi-ca il pensare al giovane come a un si-stema in cui si intrecciano varie dimen-sioni e che non è riducibile a modelli interpretativi semplici. L’accettazione della complessità consente di supera-re alcuni dei vizi ideologici che hanno afflitto l’educazione, e anche alcune forme di animazione, in questo ultimo ventennio.
Il riconoscimentodella complessitadel giovane
L’educazione ha sofferto, infatti, di due paradigmi ideologici che hanno provocato concezioni riduttive del processo educativo e della persona che lo vive.
Il primo di questi paradigmi era ed è costituito dal pensare al giovane come a una sorta di monade totalmente isolata dall’ambiente sociale e naturale in cui vive. Questo tipo di ideologia ha provocato un iperindividualismo edu-cativo, che ha prodotto o riflessi negati-vi sull’adattamento sociale del giovane, oppure il fallimento dell’intenzionalità educativa, in quanto l’azione sull’indi-viduo veniva vanificata dai condiziona-menti dell’ambiente sociale.
Il secondo paradigma, al contrario, pensa al giovane come a una sorta di prodotto degli influssi e delle pressioni dell’ambiente sociale e naturale. L’azio-ne dell’animazione che si ispira a que-sta ideologia trascura l’individuo a favo-re dell’azione sull’ambiente sociale, in quanto si ritiene che il coinvolgimento del giovane nell’agire sociale sia di per sé un fatto educativo, oltre naturalmente che la modificazione dell’ambiente so-ciale produce delle modificazioni nelle persone che lo abitano.
Accettare la complessità significa operare, simultaneamente, sull’indivi-dualità del giovane e sull’ambiente so-➔

APPROFONDIMENTI
che l’adulto debba porsi in modo sim-metrico rispetto al giovane, annullan-do la differenza di responsabilità, di esperienza e di ruolo che segna le due differenti generazioni.
Tutt’altro! L’adulto, infatti, per svol-gere efficacemente il suo ruolo edu-cativo deve valorizzare al massi mo la distanza generazionale che lo separa dal giovane.
Questa affermazione può sembra-re paradossale, visto che la maggior parte dei problemi della comunicazio-ne tra adulti e giovani sono imputati, di solito, a questa distanza generazionale e molti educatori si ingegnano, elabo-rando più o meno sofisticate strategie, per ridurla o, addirittura, annullarla.
In realtà la distanza generaziona-le diventa un problema che nasce dal tentativo di risolverlo. Nella vita socia-le e individuale degli esseri umani, si presentano molti problemi che sono risolvibili semplicemente con inter-venti di contrasto. Ad esempio, se una casa è fredda è sufficiente riscaldarla per risolvere il problema, oppure se una persona è isolata, si opera per in-serirla in una rete di relazioni umane.
Ci sono, invece, altri problemi in cui il tentativo di contrastarli non fa al-tro che aggravarli. Uno di questi casi tipici è costituito dal problema della distanza generazionale.
La stagnazionedi tipoconservatore
Per comprendere quanto detto è ne-cessario considerare che questo tipo di problema è presente in tutte le epoche della storia umana. In una nota del libro Change di Watzlawick, si può leggere, ad esempio, questo testo contenuto in una tavoletta babilonese di argilla di al-cune migliaia di anni fa: «La gioventù di oggi è corrotta nell’anima, è malvagia, empia, infingarda. Non potrà mai esse-re ciò che era la gioventù di una volta e
non potrà mai conservare la nostra cultura».
La constatazione che il pro-blema della distanza genera-
zionale attraversi, anche se con accenti e importanza diversi, la storia umana do-vrebbe aiutare a compren-dere che esso è fisiologico e va accettato, come del resto hanno fatto le civiltà prece-denti la nostra.
Infatti, molto probabilmente, la di-stanza generazionale non è altro che un meccanismo attraverso cui si svolge il processo evolutivo della civiltà umana, ovvero delle culture umane che la co-stituiscono. Se venisse meno la distanza generazionale, le varie culture vivreb-bero una stagnazione di tipo conserva-tore che, oltre a impedirne l’evoluzione, ne provocherebbe l’involuzione e, quin-di, la degenerazione progressiva.
Se si accetta questo approccio al problema della distanza generazionale, si vede che la sua soluzione non è affatto nella sua abolizione, ma nella sua valo-rizzazione ai fini educativi.
Questa valorizzazione avviene però solo se, tra l’adulto e il giovane, si instau-ra una comunicazione di tipo dialogico, in grado cioè di rendere prossima la diversità generazionale senza abolirla. Ora, occorre tenere presente che ogni comunicazione interpersonale, per svi-lupparsi, richiede che i comunicanti siano da, un lato, simili e, dall’altro, di-versi. Infatti, la comunicazione tra due comunicanti perfettamente identici è inutile, così come quella tra comunicanti completamente diversi è impossibile. In fondo un adulto e un giovane sono nella condizione ottimale per comunicare, in quanto sono abbastanza simili e abba-stanza diversi.
Ancora una notazione sulla distanza, sulla differenza generazionale. La diffe-renza tra le persone, quando può con-tare su un nucleo di similarità, è sempre produttrice di vita. La vita nello spazio tempo del mondo si nutre infatti della differenza, come già notava all’origine del pensiero filosofico occidentale Era-clito, e come in tempi più recenti sugge-risce il secondo principio della termo-dinamica. L’uguaglianza, con il suo volto dell’omogeneità, produce solo morte se non evolve continuamente nella dif-ferenziazione. Questo non significa che essa non sia faticosa da gestire, scomo-da e a volte disperante. Tuttavia, ogni evoluzione della condizione umana è sempre frutto di una fatica a cui nessuno può sottrarsi e tanto meno l’adulto edu-catore/animatore.
Come utilizzare la differenza gene-razionale nella relazione adulto-giovane sarà oggetto del prossimo articolo. ■
Mario Pollo è esperto di teoria e metodo dell’animazione culturale e insegna pedago-gia generale all’Università LUMSA di Roma:[email protected]
ciale in cui egli vive, attivando il gruppo giovanile nella direzione del lavoro per la trasformazione dell’ambiente.
Tuttavia, il riconoscimento della com-plessità del giovane va oltre il supera-mento dei vizi ideologici prima descritti, in quanto mette al centro del processo educativo non solo i processi cognitivi ma anche l’affettività, la corporeità e la spiri-tualità del giovane che va, infatti, consi-derato un sistema in cui simultaneamente convivono, influenzandosi reciprocamen-te, soggettività, oggettività, razionalità, emotività, corporeità e spiritualità.
La relazione dell’animazione tiene perciò conto della multidimensionalità in cui si gioca ed è attenta, oltre che al contenuto, alla affettività, alla espressività corporea, al suo significato sociale ed al suo senso esistenziale e religioso.
Come si è visto nella rassegna dei principi cardine della relazione di ani-mazione, questa prima di essere un fatto tecnico, è un modo esistenziale di intes-sere la relazione adulto – giovane che ri-cerca l’autenticità e che vuole rendere il giovane protagonista del suo farsi uomo. Da questo punto di vista, la relazione che l’adulto offre ai giovani è quello della compagnia fiduciosa e sapiente di chi ren-de disponibile la sua esperienza esisten-ziale e culturale al disegno del progetto personale del giovane. Solo dopo aver accettato questa filosofia della relazione educativa, l’adulto educatore/animatore può pensare ai termini tecnici del suo agire. Tuttavia, è bene ricordare ancora una volta che questa relazione, per na-scere, ha bisogno di una profonda “con-versione dell’adulto”.
La valorizzazione della distanza generazionale
Il modo di concepire la relazione educativa ed esistenziale dell’adulto con il giovane, attraverso la reciprocità, l’accoglienza incondizionata e la fidu-cia or ora descritta non significa affatto

“
luglio-settembre 2016 – juvenilia 13
Allenatori e dirigenti che si misurano con la paura che rende violenti i ragazziPaola Scalari
Cattivi ragazzi/3DIETRO RAGAZZI CATTIVI CI SONO CATTIVI EDUCATORI
Tu sei l’arco che lancia i figli verso il domani. (Khalil Gibran)
Con passo risoluto il padre di Lorenzo, uomocalvo e possente, si allontana dalla piccola
e disadorna sala dove l’allenatore del fi glio lo ha convocato. L’uomo sbatte con un colpo sec-co la porta della palestra e, salito in auto, parte facendo stridere sull’asfalto traslucido le ruote della sua “Giulietta”. In macchina rievoca la scena appena accaduta. Ritornano, come in un ritor-nello, le parole con le quali gli è stato notifi cato l’allontanamento del fi glio dal campo sportivo. “Lorenzo non potrà più giocare con le promesse del Chies. Mai più”. Espulso, indesiderato, perché soggetto troppo cattivo. Il sogno di vederlo in serie A, svanito. La speranza di saperlo ricco, dis-solta. La certezza di osservarlo ammirato e cor-teggiato da giovani e bellissime donne, sparita. E tutto questo disastro per una monelleria.
Certo le parole dell’allenatore l’avevano defi -nita diversamente, ma solo per via dell’antipatia che questi nutre – da sempre – per Lorenzo. I fat-ti sono semplici. Avevano tenuto in spogliatoio il suo ragazzo perché aveva detto una sequela di parolacce contro l’allenatore. – Ma quale adole-scente non le dice? – commenta tra sé e sé l’uo-mo sorpassando due autobus in un colpo solo.
Suo fi glio si era mortalmente annoiato. In-
dispettito, ma a ragione poiché non venivano valorizzate le sue capacità, aveva allagato lo spogliatoio e distrutto così ogni oggetto, vestito, suppellettile dei suoi compagni.
Al rientro della squadra, di fronte alle in-vettive dei suoi coetanei e allo sbraitare del suo allenatore, aveva scaraventato le bottigliette dell’acqua, come fossero bombe a mano, addos-so a tutti. Immobilizzato da due adulti accorsi
per via dei rumori assordanti e delle urla sempre più acute li aveva morsicati, presi a calci e feri-ti con le unghie. “Una vera belva” aveva detto il presidente dei giovani del Chies, facendo eco alle rimostranze dell’allenatore. “Due incapaci” riteneva senza ombra di dubbio lui che, in quan-to padre, conosceva il suo ragazzo.
Nel frattempo l’ingorgo della tangenziale lo fa rallentare. La fi la di auto è scomposta e gli permette dei zig zag per avanzare di qual-che posto tra suoni di clacson e qualche gesto poco edifi cante. L’uomo pensa che sono tutti dei pusillanimi e che chi, come lui e suo fi glio, si fa valere non viene apprezzato.
Mentre queste frasi si formulano nella sua mente la volante della polizia stradale lo ferma. Richiesti e controllati i documenti lo invita a comportamenti più corretti. L’uomo tace e ripar-te mentre, in un vortice incessante, gli tornano a galla le prediche della sua ex moglie. Lucia lo ha sempre rimproverato di dare troppa corda a Lo-renzo, di fargliele passare tutte lisce, di trattarlo come fosse già grande.
“La sempre corrugata Lucia, donna depres-sa, rigida, moralistica, bacchettone che può ca-pire della virilità maschile?” si chiede mentre si
I ragazzi più si sentono soli, senza guida, senza regole, senza stop più sentono crescere dentro di loro l’impossibilità di contenere i sentimenti negativi. In realtà, più o meno consapevolmente, essi cercano chi svolga questa funzione di contenimento e, spesso, “provocano” proprio affinché chi è adulto dica: “Adesso basta!”. Per essere di aiuto quel confine, però, deve essere posto senza furia, senza mortificazioni, senza brutalità, poiché deve rappresentare l’interesse amorevole verso i ragazzi. Ma bisogna intervenire prima che il tiro sia così alto che quanti comunicano con i ragazzi – a scuola, in famiglia, nello sport… – perdano la testa e alla violenza rispondano con violenza.
➔

14 juvenilia – luglio-settembre 2016
infi la tra due possenti camion richiedendo al tir con rimorchio che sorpassa una veloce e stri-dente frenata. Un guizzo di paura gli fa strin-gere il volante. Ma poi riprende a pensare che Lorenzo a quattordici anni ha deciso di andare a vivere con lui preferendolo alla madre.
“I ragazzi hanno bisogno di libertà, di fi -ducia, di sperimentarsi. Non si può tenerli al guinzaglio e sparare loro addosso se non ti ob-bediscono. Non si può eliminarli come ha fatto l’allenatore con quell’aria di “so tutto io” e il pre-sidente Matteucci con quel ghigno di rimpro-vero dipinto in faccia, sentenzia a voce alta nel piccolo abitacolo.
La coda intanto si smaltisce. La viabilità diventa scorrevole e l’uomo si ritrova davanti a casa. Spera non ci sia Lorenzo perché non sa-prebbe come dargli la notizia. Si guarda intorno, frastornato. Constata, con un respiro di sollievo, che il motorino del fi glio non c’è, segno che il giovane è fuori casa. Entra in cucina prende una birra fresca e passa in salotto sprofondando nel divano. La tracanna per allentare la tensione, si dice. Per nascondere la paura di affrontare il fi glio e di perdere il vantaggio che ha ottenuto rispetto alla madre, gli suggerisce una vocina interiore. Magari, pensa, potrebbe regalargli la cinepresa che tanto desiderava per compen-sarlo della brutta botta che prenderà sapendosi espulso dalla squadra.
Il cellulare intanto squilla. Lo estrae dalla tasca lentamente per-ché riconosce le note della marcia nuziale con cui ha connotato le telefonate della sua ex moglie. È infatti Lucia. Con voce metallica gli comunica che Lorenzo è a casa sua. L’uomo, sudando copiosa-mente, chiede notizie. Lucia, con un fare da bollettino meteorologi-co, gli dice che il ragazzo è distrutto per la follia che ha combinato quel mattino in palestra e che è dispera-to per il male che ha fatto agli ami-ci, all’allenatore, al fi sioterapista e al papà di Achille che lo volevano bloc-
care. L’uomo la incalza: “Ma come sta?”. La donna con fare amareggiato sentenzia: “Piange e urla che non l’ha fatto apposta, che non era in sé, che adesso si ammaz-za”. Poi infastidita aggiunge: “Ho cercato di consolarlo, ma inutilmente. Anzi. Ogni mia parola pronunciata per sollevarlo dai sensi di colpa lo getta nello sconforto più nero”.
L’uomo inveisce contro l’inettitu-dine della donna, dell’allenatore, della
squadra di calcio, della direzione sportiva. L’ex moglie, fi ngendo di non sentire, ribadisce che non riesce a persuadere Lorenzo che, in qualche modo, si potrà rimediare e tutto tor-nerà a posto. L’uomo sentenzia che bisogna portarlo via da Cesena affi nché non si senta umiliato. La donna decreta che intanto lo porta al Pronto soccorso.
Nel frattempo dal microfono giunge il rumore di vetri rotti segno della furia che sta scuotendo il corpo di Lorenzo. Si urla addosso male parole e cerca conferma del suo essere un individuo spregevole. Lui non vale nulla è il tetro ritornello con cui accompagna testate sul muro e pugni sulle credenze di casa. La madre interrompe la chiamata all’ex marito affer-mando che non si può lasciare Lorenzo solo con i suoi demoni e che lo porta all’ospe-dale. L’uomo corre a rimettersi le scarpe, cerca affannosamente le chiavi dell’auto fi nite per terra, si asciuga il sudore che gli imperla la fron-te, butta giù in un sol sorso una seconda birretta imprecando contro chi ha fatto del male al suo Lorenzo, grande promessa del calcio nazionale.
Nessuno nasce arrabbiato con il mondo
Dietro a ragazzi cattivi ci sono cat-tivi educatori. Nessun essere umano nasce arrabbiato con il mondo, ma
l’assenza di appropriate cure genito-riali, la mancanza di un legame bene-volo tra madre e padre, la visione di-storta del concetto di educazione da parte dei formatori, possono rendere un giovane incapace di comportarsi in modo adeguato.
L’aggressività, la prepotenza, il bisogno di predominare, l’assoluto egocentrismo del bambino vengono infatti mitigati, rimodellati, educati dal mondo familiare e dal mondo so-ciale attraverso le funzione di cura e di contenimento.
Sono i ragazzi che hanno ricevu-to in maniera insufficiente queste at-tenzioni, non solo quelli che possono assumere atteggiamenti meno idonei nel mantenimento di rispettose rela-zioni, ma anche quelli che hanno bi-sogno di educatori, allenatori, istrut-tori, sacerdoti e professionisti capaci di assorbire odio e generare amore.
Le funzioni genitoriali non sono infatti una questione biologica, ben-sì una capacità psichica. Qualsiasi adulto che voglia educare un minore deve poter dunque sviluppare que-ste competenze mentali. I ragazzi non possono infatti educarsi da soli.
Quando i loro genitori sono fragi-li, confusi o incompetenti è dunque necessario che altri adulti educatori sappiano prendersi cura di loro con pazienza, saggezza, forza d’animo.
Una mancanza di attenzioni ge-nitoriali, infatti, genera nel ragazzo un senso di vuoto, angoscia e paura. Ogni inquietudine vissuta da un ado-lescente, allora, è dovuta al terrore che si genera dentro di lui a causa della mancanza di punti di riferimen-to. Il giovane, senza qualcuno che ac-colga i suoi moti aggressivi, non può
trasformare la paura di es-sere solo al mondo nel de-siderio di crescere, essere apprezzato, venir ammira-to da chi gli sta accanto.
È dunque il sentirsi senza appoggio, abban-donato, rifiutato, incom-preso che fa insorgere nel minore l’angoscia abban-donica. Con il crescere di un’opprimente paura cresce la sua incapacità di contenere le emozioni che invadono il suo cor-po. È come se il mondo interiore fosse pieno di
cad“Pczd
s
sL’ex mo
APPROFONDIMENTI
b 2016
aa-n -o el a-i-al c-
trasesiapto
sedpmddcdcpi

luglio-settembre 2016 – juvenilia 15
Paola Scalari, psicoterapeuta di Venezia, la-vora sulla gruppalità dei ragazzi come degli adulti, e prima ancora, sulla gruppalità fami-liare: [email protected]
UN LIBROPER SAPERNE DI PIÙ
CONTATTOCONTATTOLa consulenza educativa ai genitorila Meridiana, Molfetta 2010
Francesco Berto, psicopedagogista, e Paola Scalari, psico-loga e psicoterapeuta, offrono ai lettori un testo scorrevole, seppur denso di concetti, di suggestioni e di spunti tratti dalla loro vasta esperienza, per rifl ettere sul diffi cile compito di educare i fi gli nella società attuale. Società in cui i rapporti intergenera-zionali sembrano essere inesistenti o tali, da impedire sia la scelta e la condivisione di modelli educativi adeguati, sia il supporto alla crescita dei fi gli. Anche i servizi e le istituzioni, che dovrebbero aiutare mamme e papà a sviluppare le competenze educative, hanno spesso sedi diffi cili da raggiungere e orari rigidi da rispettare; tendono inoltre a fornire soluzioni precostituite che fanno sentire i geni-tori inadeguati e poco competenti. Così padri e madri, chiusi nel loro involucro nar-cisistico, esercitano in solitudine e con notevole sofferenza la funzione genitoriale. Solo con fatica e in situazioni di emergenza cercano l’aiuto di esperti. Ma in emer-genza il tempo è vincolante sia per i genitori che per i professionisti. (Pia M. Sigismondi, psicoterapeuta)
“oggetti cattivi” che premono come duri e pungenti macigni. Il ragazzo sente allora la necessità di liberar-si di questo gravoso peso interiore. Scaraventa quindi fuori l’odio che dà forma a questi dolorosi “calcoli men-tali”. Lo espelle e lo deposita in chi gli sta attorno. Lo proietta ed evacua su chiunque gli si avvicini. Il mondo esterno si popola così di “gente catti-va”. E il vissuto paranoico diventa via via sempre più incontenibile in un’a-mara spirale che genera aggressività, rabbia, violenza.
Più nella mente di un adolescente albergano “pensieri cattivi” derivanti da rappresentazioni di persone o di parti di esse che sono assenti, molli, distratte, insicure, sadiche, coercitive, abusanti, più egli esplode in modo prepotente, brutale e crudele.
La violenza del vuoto educativo e la violenza del ricatto relazionale, dunque, generano la sua disumanità.
Allenatori e dirigentiche curano i pensieri cattivi
La cattiveria di un ragazzo è dun-que l’espressione delle distorte at-tenzioni familiari e della fragilità educativa dei suoi educatori di rife-rimento che, invece di supplire alle cure che gli sono mancate, lo con-dannano per non averle ricevute.
La priorità anche in palestra, nel campo sportivo, nel ring, nel rettan-golo di terra rossa, nello stadio, quan-do si ha a che fare con un minorenne, sarebbe invece sempre quella edu-cativa. Anche perché nessun campio-
ne diventa tale se non ha la capacità di stare al mondo con gli altri, di ri-spettare le regole della convivenza, di comprendere il valore del rispet-to e di apprezzare il gioco collettivo.
Un atleta irresponsabile può ap-parire a tratti geniale, ma prima o poi si distrugge e distrugge l’ambiente in cui gioca. Ma per ogni allenatore, animatore, istruttore e adulto, fino alla maturità del giovane, c’è la possibili-tà di educare!
Senza l’amorevolezza di almeno un adulto competente, dunque, l’o-dio per un mondo che viene sentito come ostile non trova pace.
E anche nel campo sportivo si tratta di offrire ai ragazzi la presenza di persone carismatiche, ammirabi-li, umanamente competenti. Persone che abbiano lo statuto di adulto e non siano perciò arroccate in visioni nar-cisistiche, che portano a dare più va-lore alla vittoria che ai giovani che la devono perseguire.
A nulla perciò serve colpevolizzare madri e padri incapaci, a molto inve-ce serve assumere quelle funzioni che loro non hanno saputo svolgere.
I genitori, alle volte, per un’amara storia generazionale, non sono proprio in grado di assorbire la rabbia del bambino senza fuggirvi lontano o senza recipro-carla come tale. Mamme e papà possono non possedere le capacità psichiche per elaborare i sentimenti dei figli. Posso-no cioè non essere capaci di bonificare, attraverso il loro più maturo senso della realtà, le emozioni dei loro ragazzi. Re-altà che comprende il fatto che nessuno può avere e fare ciò che vuole, ma che
la negoziazione e la mediazione tra desideri propri e altrui diventa la via maestra per coltivare buoni rapporti con sé, con il prossimo e con il mondo. Madri e padriquesta funzione educativa la svolgono contenendo i desideri dei figli in modo che il limite non solo funzioni da linea di confine tra sé e gli altri, ma anche da esperienza che lo alleni a tolle-rare il fatto di non averla sempre vinta.
Senza furia,senza mortificazioni,senza brutalità
Un ragazzo più si sente lasciato da solo, senza guida, senza regole, senza stop più sente accrescere dentro di sé l’impossibilità di contenere i suoi sentimenti negativi. Egli allora cerca chi svolga questa funzione di conte-nimento educativo e, spesso, provoca proprio affinché chi è adulto gli dica “Adesso basta!”. Quel confine inva-licabile però deve essere posto sen-za furia, senza mortificazioni, senza brutalità poiché deve rappresentare il segno dell’interesse amorevole verso il ragazzo. Se non sa contenersi da solo l’adulto lo tiene al suo posto affinché impari ad autoregolarsi.
Bisogna allora intervenire prima che il tiro sia così alto che tutti quelli che circondano il ragazzo perdono la testa e alla violenza del giovane rispondono con violenza. Spesso ri-nunciando a educare attraverso la sospensione, l’espulsione, l’allonta-namento.
Ma chi darà a questi ragazzi l’op-portunità di crescere? ■
e ri ucenm
loé i i
e padricativa ndo i
modo o funzioni

16 juvenilia – luglio-settembre 2016
APPROFONDIMENTI
Comprendere i meccanismi del processo attentivo migliora le prestazioni sportiveFrancesco D’Ambrosio
Pensare l’allenamento/8L’ATTENZIONE NELL’ATLETA PERMETTE DI INDIVIDUARE PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE
La capacità di attenzione oggi più che mai è decisiva nello sport, più in generale in tempo che ci inonda di stimoli, proposte, messaggi spesso contraddittori. Senza attenzione critica ci si impoverisce o si ci disperde. Da questo punto di vista nello sport e nella vita in generale l’attenzione è un importante presupposto corporeo, emotivo e mentale per essere padroni di se stessi e delle proprie azioni e prestazioni, individuali ma soprattutto sociali. Allenare l’attenzione nello sport è allora di grande importanza per vedere, riconoscere, selezionare, riorganizzare gli stimoli ambientali e decidere velocemente le risposte che possono essere più adeguate.
o
attenzione, in generale, in-dica l’atto con cui la mente, in forma chiara e vivida, si rivolge a un oggetto. È un
processo selettivo innato che progredi-sce insieme al progredire delle attività cognitive e percettive. In quanto pro-cesso di selezione dell’informazione, è un processo multiforme che può essere considerato un’at-tività soprattutto cognitiva, che ci permette di filtrare dall’immensa mole di in-formazioni disponibili quegli aspetti che sono per noi rilevanti.
L’attenzione: alcuni principi fondamentali
Nel linguaggio quotidiano il termine attenzione viene utilizzato per descrive-re esperienze e situazioni di vario gene-re, in particolare:
la capacità di selezionare parte di uno stimolo per l’elaborazione;
è sinonimo di concentrazione; il concetto è legato alla vigilanza,
come vedremo più avanti.Si tratta di una funzione mentale
posta a livello conscio, per questo si dice che esiste una relazione com-plessa con la coscienza; può essere diretta volontariamente da parte del soggetto, o richiamata in modo auto-matico dalle caratteristiche dello sti-molo, ma in entrambi i casi si tratta di un fenomeno del quale siamo consa-pevoli. Essa, inoltre, ha due importan-ti effetti: mettere in evidenza alcune informazioni ed escludere dalla co-scienza le altre.
Tuttavia, la funzione attentiva è con-nessa a una varietà di processi psicolo-gici diversi tra loro (cognitivi, emotivi,
affettivi, motivazionali). Tali processi, a loro volta, sono attivati da complessi si-stemi neurofisiologici (vedi Fig. 1).
Come si è detto sopra, l’atten-zione è una funzione selettiva che si correla con il livello di attivazione (o arousal, cioè la prontezza generaliz-zata che rende capaci di percepire, analizzare e rispondere agli stimoli; cfr. al riguardo anche Juvenilia nr. 1 del 2013), senza però coincidere con questo.
I due concetti sono strettamente connessi perché il grado di attenzio-ne dipende dal livello di attivazione del soggetto. Quest’ultimo rimanda a sua volta alle condizioni interne o esterne ad esso. Possiamo quindi rias-sumere dicendo che l’attenzione è l’in-sieme dei dispositivi e meccanismi che consentono di concentrare e focalizzare le proprie risorse mentali su alcune in-formazioni piuttosto che su altre.
Le quattro componenti dell’attenzione
L’attenzione in ambito sportivo vie-ne generalmente considerata un im-portante presupposto mentale della prestazione. Ad esempio, negli sport di squadra (pallacanestro, calcio, hockey,
L’

luglio-settembre 2016 – juvenilia 17
ecc.), gli atleti sono colpiti da un flusso di informazioni che non riescono a uti-lizzare completamente a causa della loro limitata capacità di elaborazione. Per poter riuscire ad agire in modo ef-ficace devono infatti tener conto di quali siano, possibilmente, le informazioni at-tuali più importanti o più rilevanti per il loro problema di gioco. A questo punto risulta chiaro che ogni persona possiede un filtro o meccanismo di selezione che separa le informazioni rilevanti da quelle irrilevanti per poi sceglierle.
Tenuto conto di quanto accennato, nella pratica sportiva, le componen-ti attentive individuate dagli studiosi dello sport e riportate in letteratura sono: attenzione selettiva, attenzione divisa, attenzione sostenuta e attenzio-ne visiva spaziale.
L’attenzione selettivaCome si è detto, l’attività primaria
svolta dall’attenzione è quella di sele-zione delle informazioni in base alla loro rilevanza biologica e psicologica. In tal senso, l’attenzione selettiva consiste nel-la capacità di selezionare uno o più sti-moli, interni o esterni, presenti in un dato momento utili, appunto, per l’organismo.
L’attenzione selettiva ha due scopi: evitare il sovraccarico di infor-
mazioni (dato che le risorse attentive sono limitate);
consentire comportamenti coerenti, flessibili e sensibili ai cambiamenti.
Si può dire che l’attenzione selet-tiva può riguardare diversi fenomeni e il criterio di rilevanza può essere riferito a diversi fattori: in particolare, la selezione interessa tutte le modali-tà sensoriali (visiva, uditiva, olfattiva, ecc.), determinate zone dell’informa-zione o del campo visivo (in questo
caso, si parla più avanti di attenzione visiva spaziale). Inoltre, un particolare oggetto (chiamata attenzione basata sugli oggetti) e alcune caratteristiche dell’oggetto (forma, colore, ecc.).
L’attenzione divisaL’attenzione divisa pone l’accento
sulla capacità del soggetto di prestare attenzione a più stimoli individuando nell’automatizzazione esecutiva di un compito che deriva dalla pratica, un primo fattore di focalizzazione, o focus attentivo. Vale a dire, a capacità di distri-buire l’attenzione contemporaneamen-te su diverse attività o su più categorie di stimoli, e quindi di mettersi in grado di svolgere più compiti in un ambiente complesso.
A tale proposito, recenti studi hanno dimostrato che per gli atleti dei vari gio-chi di squadra è impossibile recepire tut-to l’insieme delle informazioni su ciò che avviene durante il gioco. Questo spiega come, in questi caso, il ruolo dell’allena-tore è quello di aiutare i suoi atleti a co-struire atteggiamenti di aspettativa che dirigano l’attenzione verso elementi della situazione più ricchi di informazioni; in altri ter-mini, che il focus attenti-vo degli atleti sia diretto su determinati aspetti della situazione in modo da essere elaborata co-scientemente.
Diversamente, si va incontro al fenomeno della “cecità attentiva” o “cecità della disatten-zione”. Un esempio che ben chiarisce questo fe-nomeno è il seguente: nei giochi sportivi spesso
allenatore e compagni rimproverano a un giocatore che era in possesso di palla di non avere visto un giocatore completa-mente libero e di non avergli passato il pallone, sebbene si trovasse direttamente nel suo campo visivo. Di conseguenza, il giocatore incolpato respinge ogni accusa e dichiara di non aver visto il giocatore in posizione favorevole.
L’attenzione sostenuta L’attenzione sostenuta è l’abilità nel
resistere agli elementi “distrattori” e nel mantenere la concentrazione per un lungo periodo su uno stimolo spe-cifico, su un’attività o su un determinato compito. In sostanza, tale processo sot-tolinea gli aspetti relativi alla variazio-ne della prestazione a un compito in funzione del tempo; ciò è rappresenta-to dal tentativo di comprendere la fun-zione base della vigilanza. La vigilanza è, dunque, la capacità di controllare nel tempo le risorse attentive su eventi con bassa frequenza di accadimento.
L’attenzione visiva spazialeL’attenzione visiva spaziale, come ve-
dremo meglio nel paragrafo successivo, è una delle componenti dell’attenzione selettiva più studiata. Rappresenta l’abilità di un osservatore di selezionare particola-ri porzioni nell’ambiente esterno. L’atten-zione può essere orientata verso queste porzioni di ambiente sia in modo volon-tario (endogeno) sia in modo involontario (esogeno). In pratica, secondo tale con-cezione, le due principali dimensioni che costituiscono questo tipo di attenzione sono l’orientamento spaziale o nel campo visivo e la focalizzazione (focus attentivo).
Per quanto riguardo l’orientamento esso può essere:
esplicito, dove è presente una mag-giore acuità visiva (movimento degli oc-
Fig. 1 - I processi psicologici e neurofisiologici connessi all’attenzione
Percezione Memoria
Coscienza Attenzione
Controllo motorio Attivazione fi siologia
Emozioni e stress
llu lgliio-sette bmbre 2016 – jjuvenilia 6 1177
di --oti o o-
va no a” n-he e-te: so
➔

18 juvenilia – luglio-settembre 2016
APPROFONDIMENTI
Francesco D’Ambrosio, psicologo e psico-terapeuta, è docente all’Università di Tor Vergata Roma e formatore PGS: [email protected]
chi, del capo e del corpo, sguardo fisso sull’area di interesse);
implicito, quando la visione è perife-rica (guardare con la coda dell’occhio).
A questo proposito, gli studi sperimen-tali sull’attenzione implicita hanno messo in evidenza che quando l’attenzione è orientata nella zona di probabile compar-sa dello stimolo, la risposta è più veloce.
Una delle caratteristiche della focaliz-zazione e che l’attenzione può essere sia diffusa (in questo caso le risorse attentive sono distribuite in modo uniforme su tut-to il campo visivo), sia focalizzata (ossia si concentra solo su una regione o posizio-ne spaziale). In tutto ciò, il focus attentivo è considerato metaforicamente come un “fascio di luce” o “fuoco di una lente”.
Come vedremo nel paragrafo suc-cessivo, le ricerche hanno dimostrato che le dimensioni del focus sono variabili, cambiano a seconda delle richieste del compito e si può esercitare un controllo volontario sulla forma che esso assume. A questo punto del lavoro descriviamo in maniera dettagliata l’utilizzo dell’atten-zione spaziale nella prestazione sportiva.
La percezione consapevoledegli stimoli
Come abbiamo visto, l’attenzione in generale favorisce la prestazione. Per studiare le modalità in cui questo feno-meno si realizza sono stati creati dei pa-radigmi sperimentali per indagare come i processi attentivi possano influenzare la percezione consapevole di stimoli o di eventi. Tuttavia, una delle aree di ricerca più indagate in ambito sportivo rappre-senta l’attenzione visiva spaziale. Essa è considerata una componente fondamen-tale della prestazione sportiva.
In pratica, il processo dell’attenzio-ne spaziale serve a spostare l’attenzio-ne stessa su stimoli particolarmente rilevanti o su una parte saliente dello stimolo. Inoltre, individuare i processi cognitivi coinvolti nelle abilità percetti-vo-motorie degli atleti e costruire stru-menti operativi sport-specifici per il mi-
glioramento della prestazione sportiva.A tale proposito, uno studio speri-
mentale svolto in laboratorio, ha osser-vato negli atleti le singole operazioni mentali legate all’attenzione. Da tale studio ne deriva che l’assunto di base è che le operazioni mentali richiedono tempo e lo strumento utilizzato per ri-levare e misurare questa componente dell’attenzione è stata la metodologia dei tempi di reazione (misurazione dei processi cognitivi in laboratorio). In tale senso, il tempo di reazione (TR) è il tem-po che intercorre tra la presentazione di uno stimolo e l’emissione della risposta, con quel che chiede di flessibilità e di orientamento dell’attenzione nell’atleta.
Gli stessi autori hanno postulato il controllo della dimensione e della for-ma del focus attentivo in discipline open skill vs. closed skill (vedi Tab. 1).
Va notato che nello sport closed skill, ad esempio nel tiro con l’arco, gli arcie-ri hanno mostrato tempi di reazione più veloci; infatti sono addestrati a tirare ra-pidamente le loro frecce una sola volta in risposta al raggiungimento della massima trazione. È stato osservato che gli atleti esperti rispetto ai non-atleti ottengono tempo di reazione più rapidi nella prova invalida, dimostrando di orientare l’atten-zione in maniera più efficace. Resta co-munque il fatto che negli sport open skill (ad esempio, la boxe) questa capacità è più sviluppata in quanto tali discipline ri-chiedono un’elevata flessibilità per effet-tuare rapide e corrette anticipazioni (risul-tati simili si sono ottenuti nella pallavolo) (vedi Tab. 1).
L’allenamento a due meccanismi attentivi
I risultati hanno dimostrato inoltre che in uno sport di precisione come il tiro a volo, gli atleti devono mostrare un’atten-zione strategicamente focalizzata nel-la quale ogni sforzo effettuato, al fine di controllore la distribuzione delle risorse attentive all’interno del campo visivo, pro-duce un vantaggio in termini di velocità e accuratezza della risposta.
In quest’ultimo caso, gli atleti di tiro a volo (closed skill), nell’eseguire un com-pito con elevata difficoltà (compito di di-scriminazione), impiegano strategie di controllo del fuoco attentivo più efficaci rispetto ad atleti di rugby (open skill).
Quanto esposto indica come tali stra-tegie attentive potrebbero essere state sviluppate attraverso l’allenamento e la pratica sportiva. In effetti, si ottengono prestazioni migliori con quelle indicazio-ni in cui l’attenzione da parte dell’atleta è diretta su un certo punto nel quale appare lo stimolo atteso. È opportuno sottolinea-re che, se si tiene conto di questi risultati, sembra plausibile che le istruzioni dell’al-lenatore producano lo stesso effetto e che l’atleta ne ricavi un vantaggio attentivo in quelle situazioni di gioco che sono attese e uno svantaggio in quelle inattese.
Per concludere, riteniamo che l’inten-sa attività fisica e le istruzioni durante l’al-lenamento possano produrre due reazioni differenti sui meccanismi attentivi: favorire i processi automatici (come l’orientamen-to spaziale) e mobilitare i processi volon-tari (come la focalizzazione attentiva). Ne risulta quindi che l’indagine effettuata sulle diverse componenti dell’attenzione nell’atleta, potrebbe avere importanti ri-cadute pratiche, in quanto permetterebbe di individuare percorsi strategici per il mi-glioramento della prestazione sportiva. ■
Tab. 1 - Discipline sportive, dimensione e forma del focus attentivo
chi, del capo e del corpo, sguardo fisso sull’area di interesse);
glio
Tab
Tipo di disciplina sportiva Tipo attenzioneSport open skill
(boxe, tennis, scherma, giochi di squadra)
Sport closed skill(tiro a volo, tiro con l’arco)
Attenzione diffusa (analisi globale e rapida di cambiamenti nel campo visivo)
Continui cambiameniPresenza del feedback interattivo
Attenzione focalizzata (restringimento del raggio attentivo, analisi di specifi che aree
del campo visivoCondizioni ambientali costantiAssenza di feedback interattivo

luglio-settembre 2016 – juvenilia 19
FOCUS
I MOLTI APPUNTAMENTIDI UNO SPORT CHE VUOLE GIOCARELA CARTA DELL’INTRAPRENDERE
FOCUS / PRIMA SCELTA FONDANTELa scelta di uno sport intraprendente a fianco dei giovani
Come nello scorso numero di Juvenilia, dedichiamo il Focus all’approfondimento – il più possibile partecipato da allenatori e dirigenti, giovani e famiglie, cittadini e amministratori – delle “cinque scelte fondanti” alla base del nostro Statuto per alimentare un dialogo a più voci sul futuro delle PGS. Ma mentre nel Focus precedente la riflessione andava, come dire, “dall’alto” verso il basso con l’aiuto di personaggi esterni ma attenti al mondo PGS, in queste pagine gli spunti per un dialogo ripartono “dal basso”, attraverso un’attualizzazione delle scelte fondanti affidate a cinque gruppi di allenatori e dirigenti di Regioni diverse, che si sono messi in gioco per avvicinare al quotidiano lavoro l’immaginazionee la costruzione del futuro delle PGS.
Focus 2016: una stagione di convivialità, dialogo, nuove leadership
A cura di cinque gruppi di allenatori e dirigentidi Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto
FocusImmaginare nei diversi territoriil futuro prossimodel nostro sport
A cura di un gruppo di PGS del Veneto
iamo cresciuti nelle PGS con uno spirito attivo, con l’idea che “quando non ci sono gare, bisogna inven-
tarsele”; oggi ciò non è più così vero, l’impegno non è più così totalizzante e ci sono molti altri stimoli e sempre più cose da fare in tutti i campi. Tra i dirigenti serve almeno recuperare una qualità di presenza nel poco tem-po disponibile.
Nei Comitati provinciali ci stiamo chiedendo che senso hanno i nostri
organismi, dove stiamo andando e perché viviamo i territori come più distanti.
Bisognerebbe tornare a essere dirigenti che stanno nelle palestre a contatto con i ragazzi e non ingab-biati negli uffici per le incombenze burocratiche. Dirigenti presenti, che sanno stare nelle relazioni e suppor-tare in vari modi le giovani genera-zioni di allenatori e dirigenti.
Sono molte le strade dell’intra-prendere che si aprono.
Intraprendenti nel tessere insiemeun nuovo linguaggio
Serve anzitutto una “micro-pe-dagogia” delle relazioni quotidiane, diffusa in tutta l’organizzazione e ne-gli stili di lavoro dei dirigenti per im-parare non solo a pianificare a lungo termine, ma anche a esserci nel qui e ora delle situazioni.
Ci si chiede se questo non debba essere uno dei principali elementi di distinzione dalle altre offerte sportive
S
➔

20 juvenilia – luglio-settembre 2016
FOCUS
del territorio che sono più strutturate e forti, in grado spesso di garantire un sistema di servizi molto più ricco e organizzato.
C’è stato, in tutto questo, un salto di generazioni e il gap è difficile da colmare; la secolarizzazione in gene-rale e la laicizzazione delle risorse interne rendono sempre più sfidante la capacità di far sperimentare l’ispi-razione pedagogica, umanistica ed evangelica che caratterizza la nostra storia. Occorre quindi ricostruire un linguaggio comune tra noi. La stes-sa dimensione religiosa chiede di essere diversamente riscoperta e di emergere da un intreccio maggiore tra vissuti e narrazioni di senso che rigenerino intraprendenze feconde.
Intraprendenti con i ragazzi dando responsabilità
Ciò che caratterizza positivamen-te la storia di molti dirigenti e allena-tori delle PGS è il fatto di avere alle spalle esperienze in cui ci si è sen-titi accolti e coinvolti attivamente da quelli sono stati gli educatori di un tempo. Ciò che colpisce nei ricordi è la fiducia data a ragazzi che non si sarebbero mai aspettati di essere in grado di assumersi impegni e in-carichi: “mi sono sentita scelta”, “mi sono sentita amata”, “credevano in me”, “mi dicevano: vieni a darci una mano”.
Questo è uno stile da non dimen-ticare e da sviluppare nelle relazioni con le giovani generazioni che, ancor più oggi, hanno bisogno di essere incalzate, sollecitate, chiamate a re-sponsabilità. Il rischio diffuso è di sostituirsi; occorre, invece, una nuo-
va capacità di ascolto e un costante aiuto a rileggere e reinterpretare ciò che stanno vivendo.
Non si tratta tanto di trasmettere, e tanto meno di prescrivere, piutto-sto serve un’arte maieutica che aiuti a scoprire e sperimentare le proprie risorse tra ragazzi che sembrano af-faticati e travolte dai nuovi strumen-ti di comunicazione che sembrano frenare lo sviluppo di una “socialità corporea”.
Ciò su cui è importante continua-re a insistere è la creazione di spazi di confronto, l’attenzione allo scam-bio, al “far parlare i ragazzi” prima e durante gli allenamenti e le com-petizioni, interessarsi a loro, a come stanno, a quello che stanno vivendo, ritagliando il tempo prezioso delle “quattro chiacchere”.
Oggi i ragazzi sono oppressi da un eccesso di offerte e di stimoli, ciò non solo rischia di spegnere l’en-tusiasmo, ma di passivizzare la loro fruizione dello sport e il loro stare in famiglia. Per questo motivo è impor-tante perseguire dimensioni espres-sive e creative, favorire esperienze gruppali e di convivialità tra i ragazzi e le famiglie, inventando dispositivi capaci di responsabilizzare giovani e adulti su piccoli impegni e compiti da sviluppare sul piano progettuale e operativo.
Intraprendenticon le famiglie chiuse nella fatica
Le società sportive oggi incontra-no famiglie che sono spesso fragili, a volte “bloccate”, in difficoltà nella gestione dei figli e degli aspetti edu-cativi e proprio per questa fragilità
più difficili da gestire; in alcuni casi si tratta anche di problemi di natura economica, aspetti che le nostre re-altà devono tenere in considerazione, muovendosi con delicatezza e con forme di prossimità.
Serve un lavoro di sensibilizza-zione delle famiglie alle dimensio-ni educative e sociali dello sport, servono forme di avvicinamento e confronto non solo per condividere obiettivi, ma spesso per supportare disorientamenti e comportamenti contraddittori. Dobbiamo monitora-re questa sfida che alcuni anni fa ci siamo posti come prioritaria, pena il rischio di evitamenti sistematici dei genitori, di incomprensioni e con-trapposizioni dolorose e contropro-ducenti.
Intraprendenti nel riconoscere le culture altre
Vi è una crescita di ragazzi stra-nieri sul territorio che tuttavia riman-gono esclusi dalle pratiche sportive; vi è un diffuso problema di non inte-grazione delle famiglie di altre cultu-re, provenienze e religioni che ricade sui figli e sull’opportunità che possa-no prendere parte a una disciplina sportiva.
In alcuni casi servono anche solo piccole attenzioni, per esempio nei confronti delle ragazze e delle loro tradizioni culturali e religiose, in al-tri casi serve un percorso di avvici-namento più complesso e condiviso con il territorio.
Intraprendenti nel tessere reti nei mondi fragili
La proposta di uno sport più ama-toriale incontra sicuramente una domanda molto diffusa in una gene-razione di ragazzi che spesso nella logica delle prestazioni agonistiche rimangono automaticamente esclusi: non ci si avvicina allo sport per timi-dezza, fragilità affettiva, impedimenti economici, piccole disabilità come le dislessie, che possono essere perce-pite come ostacoli, oppure diventare invece una ricchezza se accolte, com-prese e sostenute. Per creare squadre e tornei serve un’alleanza più stretta con altri soggetti, come le scuole, gli oratori, i comuni, le ASL, le associa-zioni e i gruppi informali dei ragazzi.

Intraprendenti nell’educazionealle diversità
C’è un bisogno diffuso di educa-zione alle diversità, di incontro con l’altro, di riconoscimento di come le storie marginali e le fatiche possano rappresentare uno stimolo educativo e occasione di crescita preziosissima per i gruppi di ragazzi. Si tratta di es-sere più consapevoli di questo poten-ziale che sappiamo valorizzare per esempio nei campi residenziali, dove possiamo toccare con mano l’evolu-zione sorprendente che molti ragazzi
compiono nel corso di un’esperienza intensa e unica, che ci caratterizza e di cui dobbiamo andare fieri.
Intraprendenti nell’aprirsi alle nuove tecnologie
Il fenomeno è sotto gli occhi di tutti, così come si sta prendendo co-scienza dei rischi di un uso inconsa-pevole, indiscriminato e non mediato delle nuove tecnologie digitali. Tut-tavia opporsi aprioristicamente vor-rebbe dire non assumere i linguaggi e gli stili di comunicazione come una
sfida educativa e di nuove forme di socialità. Anche su questi aspetti ser-vono patti formativi allargati alle al-tre agenzie educative; occorre offrire criteri e strumenti di discernimento per perseguire ciò che è buono,non abbruttisce e rende la vita bella. ■
LA FEDE NEL FUTURO PASSA DAL QUOTIDIANO ESSERCI E CO-EVOLVERCISUL CAMPO E A BORDOCAMPO
FOCUS / SECONDA SCELTA FONDANTELa scelta del carisma salesiano come energia di fede nel futuro
A cura di un gruppo di PGS della Liguria
➔
iamo convinti che la sa-lesianità non la si spiega a nessuno a tavolino o in un’aula. Passa piuttosto dal
quotidiano incontrarsi e “perdere tem-po” – tra adulti e giovani, tra religiose/i e laici, tra chi è credente e chi è in ricer-ca di una fede – dove possono nascere parole di fede nel futuro. Una fede che passa dagli sguardi, dalle piccole atten-zioni, dal non aver paura di arrendersi, dal “fare cose insieme” nello sport e in-tanto dialogare, dal non farsi complici ma essere esigenti nel chiedere conto della vita.
Detto questo ci limitiamo ad alcune annotazioni pensando al futuro che ci attende come PGS.
Una stagione per riconoscersi tra mondi salesiani
Partiamo con un’annotazione espe-rienziale. Tutti i giorni costatiamo che il legame con le FMA ha un alto valore evocativo e simbolico, rigenerativo di motivazioni, intuizioni, potenzialità che altrimenti rimarrebbero inespresse. Una presenza quotidiana e un esserci che fa cultura salesiana, dentro il gran-de alveo della famiglia salesiana dove scorrono anche le PGS, fianco a fianco
con altre espressioni del carisma sale-siano.
Perché negare che spesso ci man-ca, non solo fisicamente, una presen-za dei salesiani? E dunque perché non creare nuovi reticoli di riconoscimento e scambio in nome del comune spirito di don Bosco e del suo amore profon-do per i giovani? Nate con don Gino e tanti altri salesiani e suore, come PGS riteniamo indispensabile lavorare per nuove forme di collaborazione e di in-vestimento reciproco, senza paura di ri-conoscere gli errori che non sono man-cati in questi anni. Che senso avrebbe vantarci del carisma salesiano senza condividerlo tra mondi salesiani, in una logica di investimento reciproco?
La salesianità come forza per animare i territori
Nel dire questo è utile distin-guere tra Ente PGS nazionale e associazioni locali ai diver-si livelli. Non c’è salesianità se non la si vive nei territori, dentro e tra associazioni per sentirsi “movimen-to dal basso” ancorato a don Bosco. Se sfuggiamo a questo compito e tenia-
mo tra le realtà locali solo uno scambio organizzativo e tecnico... Ora proprio in questo compito abbiamo un inedito bisogno di animatori e animatrici delle due grandi congregazioni salesiane.
Troppi dirigenti e allenatori si sono incuriositi allo “stile salesiano, ma non hanno fatto esperienze in cui intreccia-re le attese di don Bosco con le loro atte-se di vita e di servizio nelle PGS. Senza di questo la loro premura umanizzante e credente finisce per atrofizzarsi sotto il peso delle cose da rincorrere.
Non si tratta di fare corsi di forma-zione dall’alto verso il basso, di inse-
S
➔he senso avrebbe a salesiano senza
ndi salesiani, in una to reciproco?
à er ritori
è utile distin-nazionale ai diver-esianità erritori, iazioniimen-rato a giamo
tenia-
zione dall’alto verso il basso, di inse-

22 juvenilia – luglio-settembre 2016
FOCUS
gnare lo spirito salesiano, ma di fare “esperienze oratoriane”, esperienze partecipate, pensose, festose, convivia-li in cui ci si scambia quel carisma sale-siano di cui ognuno è portatore, spesso inconsapevole.
Un progetto che prende forma giorno dopo giorno
In una società liquida i ragazzi fati-cano a maturare progetti di vita che in-travvedano una prospettiva, un traguar-do. Ma da questa loro (e nostra) fatica non si può che uscirne insieme, incar-nando nel nostro tempo un carisma e un progetto originale e fecondo, come raccontano 150 anni di storia salesiana e oltre 50 anni di storia PGS. Un proget-to, semplice ma impegnativo, che passa dal dedicare tempo, molto tempo, per fare dello sport uno spazio in cui emer-gono attese, si tessono quotidiane re-lazioni, maturano motivazioni, nascono associazioni e gruppi, si allenano com-petenze, si organizzano attività. Al pun-to che i ragazzi non solo sono amati ma percepiscono di essere amati.
Ci occorre più coraggio nel gioca-re una proposta da credenti nella vita, come don Bosco, condividendo un’im-magine di Dio fonte di letizia, felicità, passione per la vita degli altri. Un Dio è che non è indifferente burocrate e controllore, ma interessato alla vita di ognuno, qui e ora. Un Dio che ammette l’errore, anche grande, ma perdona, ha misericordia, dona speranza, come ci ricorda Papa Francesco.
Ma è nel quotidiano esserci e co-e-volverci tra adulti e giovani, sul campo e a bordo campo, nello spogliatoio a festeggiare le vittorie o reagire alle sconfitte, che siamo chiamati a mettere in gioco una “fede nel futuro”, attenti alle possibilità dei contesti, ma soprat-tutto alle risorse nascenti delle nuove generazioni.
La cura di eventi fortemente simbolici e generativi
Tutto questo vale anche per le ma-nifestazioni nazionali e per i vari campi scuola o altri appuntamenti formativi dove riscontriamo poca convivialità e festosità, poca ritualità collettiva che faccia toccare con mano significati sa-lesiani nutrienti e motivanti. Che dire se non che la stessa messa a volte è solo un appuntamento da sbrigare, non un
evento generativo, un gioco collettivo dove possono emergere speranze. La co-costruzione del clima da messa... vale una messa, ma anche il dopo in cui sciogliersi convivialmente, festosa-mente, creativamente.
Da questo punto di vista è da ripen-sare il compito dei campi scuola re-gionali e degli appuntamenti simili nei territori, in modo da sfuggire al mordi e fuggi.
La crisi e l’incuria dei campi scuola regionali rappresenta una grave perdi-ta per lo spirito PGS. Pur conoscendo da vicino i problemi che stanno dietro la crisi, perché non ripartire dai campi regionali per intrecciare reti, scambi, forme di aiuto e insieme senso di ap-partenenza a un’associazione, più che a una palestra? Non è facile creare tes-suti leganti, sentimenti partecipati se non si esce, almeno un poco, dalla pro-pria palestra per trovare spazi e tempi dove si possa mettere al centro le molte sperimentazioni in atto per leggerle in profondità (senza paura di ammettere errori), cogliere le intuizioni feconde e in tal modo tratteggiare sentieri da per-correre.
La condivisione intensa delle scelte fondanti del nostro Statuto
Più da vicino occorre ripartire dal-le “scelte fondanti” del nostro Statuto e sollecitare tutti a conoscerle e appro-fondirle, ad assaporarne la fecondità educativa rispetto alle loro attese e a quelle dei ragazzi. Al punto da inserir-le consapevolmente nei singoli Statuti delle associazioni locali. Non può esse-re certo un’imposizione, ma una meta sensata per tutti, quella da cui può di-pendere la contaminazione tra mondi, che nascono ormai da storie molteplici, come nuova strada per poter produrre beni comuni per tutti praticando uno sport alla don Bosco.
Certo arrivare a questo chiede che qualcuno sui territori frequenti le asso-
ciazioni, attivi piccole o grandi collabo-razioni fra mondi diversi dentro le quali possono crescere inedite connessioni. Si tratta di vivere a quel punto momenti trasversali contaminanti su alcuni nodi che rimandano al come “nuotare” in una società liquida, al come attraversa-re il vivere oggi. Con un atteggiamento non di marketing, conquista o imposi-zione, ma quello di chi sa che abbiamo molte domande in comune facendo sport e che le risposte spesso si intrav-vedono solo contaminandosi fra mondi PGS.
La capacità di intraprendenza dei mondi associativi
Infine, in un tempo di scarse risorse, è urgente farci carico dell’attivazione di inedite risorse. Lo stile salesiano è con-tagioso e il contagio don Bosco lo pas-sava ai preti, ai giovani, agli artigiani, ai banchieri e agli stessi politici. Svilup-pare “alleanze impossibili” a favore dei giovani era il suo intento continuo.
Anche il reperire risorse finanzia-rie ci rimanda oggi a don Bosco e alla sua intraprendenza, alla sua capacità di chiedere aiuto, contare sugli altri, rac-cogliere soldi. Un problema oggi forte-mente sentito dalle associazioni locali, perché le istituzioni pubbliche si sono impoverite o mirano ad altro, ma non è vero che non ci sono potenziali risorse finanziarie nei territori.
Ci attende una stagione di nuo-va imprenditività salesiana intrisa di sempre nuove invenzioni che oggi chiedono nuove forme di coordina-mento territoriale e regionale, non meno che nazionale. La raccolta fondi è un’arte raffinata e competitiva. Chi dona deve chiaro il senso di speran-za di cui è intriso il lavoro salesiano dentro lo sport, il nostro conoscere per immersione i mondi dei ragazzi e dei giovani, lo stare insieme e il cam-minare non solo con i ragazzi ma con i quartieri e i paesi. ■
eveevenenenentototoooo gggenneeneratatattivivivivivvooooo,oo,, uuuun n n gigigiiigiococo o o cocoolllllllletttititivovo ciiazazioio inini,, attattitit vi pppiiccolle o gggraandnddddiii ii cocooolllllllababababboo-ooo-oi i f i i i i

luglio-settembre 2016 – juvenilia 23
LA GRATUITÀ DEL VOLONTARIATOLA SI VEDE NELLO STILE CON CUI STA IN MEZZO AI RAGAZZI
FOCUS / TERZA SCELTA FONDANTELa scelta del volontariato per uno sport “bene di comunità”
A cura di un gruppo di PGS della Sicilia
rima di offrire una rifles-sione sulla scelta del vo-lontariato nel mondo PGS, mi permetto di richiama-
re che tra le scelte fondamentali che troviamo nello Statuto ci sono l’edu-cazione e il volontariato. Direi che es-sere volontari è sposare fino in fondo la causa dell’educare facendo sport, dentro lo sport e non a fianco.
Nell’articolo 2, infatti, si afferma che il cortile è “luogo privilegiato di educazione” e che “come educatori collaboriamo con i giovani per svi-luppare le loro capacità e attitudini fino alla piena maturità”. In altre pa-role, si afferma che intendiamo “con-correre alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi e dei giovani valorizzando la loro doman-da educativa e la prassi umanizzante dello sport”.
All’articolo 5 dello Statuto, poi, si legge che l’associazione PGS si impegna nella “promozione del vo-lontariato nel servizio educativo/sportivo”, da una parte “riconoscen-done la validità nella formazione del-la persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti del territorio”, dall’altra “curandone la professiona-lità, lo stile educativo dell’animazio-ne, la spiritualità giovanile come mo-tivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco”.
Che cos’è il volontariato educativo?
Da ciò scaturisce la preoccupa-zione dell’Associazione per formare tecnici e dirigenti che sposino la sfi-da dell’educazione dei ragazzi e pro-muovano il volontariato nella prassi sportiva. Tanta strada è stata percor-sa, abbiamo formato nei nostri campi scuola numerosi “alleducatori”, ma oggi a cosa siamo chiamati? E cosa
significa collaborare con “questi” giovani, attraverso lo sport, per svi-luppare le loro attitudini e concor-rere alla formazione integrale della persona?
Reputo che queste scelte siano ancora attualissime. Lo sport possie-de la capacità di valorizzare varie caratteristiche (non solo fisiche) del-le persone che lo praticano e suscita attitudini valoriali e umane racchiuse in ogni individuo.
«Molte persone, specie i più gio-vani, vivono oggi una crisi di identità che porta insicurezza, fragilità e vul-nerabilità. In questo contesto la risor-sa più contesa è la visibilità sociale, un appello al “guardami, guardami” più che mai vivo anche nello sport». Così scrive un medico sportivo.
Il volontariato chiede una rigorosa preparazione
Il ruolo dell’educatore sportivo diventa così molto più importante e richiede una specifica formazione per fare emergere – educere, appun-to – la persona oltre che l’atleta.
L’allenatore diventa sempre più spesso, dopo la famiglia e la scuola, la terza figura di accompagnamento
nella crescita dei bambini, dei gio-vani, trovandosi ad assolvere molti ruoli nello stesso tempo: istruttore, insegnante, modello, animatore. Gli obiettivi educativi vanno così oltre la preparazione fisica e l’allenamento: guidare lo sviluppo corretto dell’au-tostima, la giusta percezione di sé, l’educazione al fair play.
Per una piena assunzione del ruo-lo è necessaria una preparazione ri-gorosa: nel campo educativo non si può improvvisare. Oggi dagli opera-tori sportivi (dirigenti, tecnici, alle-natori) si esige preparazione seria e competenza nei loro ruoli.
Un quotidiano mettere in gioco, senza risparmiarsi
I nostri alleducatori sono chiama-ti a scelte intelligenti, passando dal sapere al saper fare, quindi: saper osservare i ragazzi, saper comunica-re, saper ascoltare, saper interveni-re, saper utilizzare metodi adeguati, saper individuare mezzi e strumenti adatti…
Più da vicino, cosa dunque deve essere un alleducatore? Direi un per-sonaggio complesso, articolato in monte sfaccettature.
P
➔

24 juvenilia – luglio-settembre 2016
FOCUS
SE LE FRAGILITÀ NON VENGONO DA NOI È ORA CHE IL NOSTRO SPORT SI INCAMMINI VERSO DI LORO
FOCUS / QUARTA SCELTA FONDANTELa scelta del radicamento dello sport in territori fragili
A cura di un gruppo di PGS della Lombardia
territorio è lo spazio dove abbiamo risorse e volontà per agire: diventerà tanto più esteso quanto intensa
diventa la nostra volontà di abitarlo e influenzarlo.
Ma cosa intendiamo con il termi-ne territorio fragile? La risposta non è cosi scontata perché è profonda-mente legata ai nostri obiettivi come PGS, alle nostre forze e risorse, non solo economiche.
Il problema del territorio è pro-fondamente legato anche a fragilità
interne, quindi di società, associazio-ni e talvolta personali, che rendono le nostre strutture incapaci e inadatte a operare là dove c’è più bisogno, di solito in zone periferiche spesso iso-late e diventate quartieri dormitorio privi di strutture ricreative, educative e di aggregazione.
Eravamo come oasi nel deserto
In passato le nostre società pote-vano essere viste quasi come oasi nel
Il
Anzitutto è un istruttore, cioè buon conoscitore dello sport che insegna.
E poi un dimostratore, in quanto buon conoscitore della tecnica.
Un insegnante, pertanto, con spe-cifiche competenze metodologiche e didattiche.
E ancora, un animatore che sa coin-volgere tutti, bravi e meno bravi, timidi e spavaldi, sicuri e insicuri.
Un modello o meglio un punto di riferimento autorevole, un esempio per l’acquisizione di atteggiamenti radicati nella gratuità e nello spirito di servizio. Un educatore, in fondo, in quanto riesce a far emergere le potenzialità di ciascu-no per il raggiungimento dei massimi livelli di sviluppo possibile per ogni ra-gazzo e ragazza.
Prima ancora, tuttavia, un osservato-re acuto dei comportamenti, dei gesti, delle scelte degli atleti. Un ascoltatore attento, infine, che valorizza e scommet-te sulle intuizioni degli allievi.
Il risultato sportivo, non agonistico
Un buon alleducatore PGS pone al vertice scelte educative per cui nelle gare è importante il risultato sportivo e non quello agonistico. Cosa vuol dire questa scelta nel lavoro quotidiano?
Anteporre la persona allo spor-tivo, anziché anteporre lo sportivo alla persona. Proprio per questo, far giocare tutti (sport per tutti), invece di far giocare solo i più forti (lo sport per pochi).
Se vero poi che tutti i giocatori hanno diritti e doveri, è anche vero che i talenti non hanno più diritti che doveri. Di conseguenza, se tutti im-parano a rispettare le regole (“nulla è dovuto”), a maggior ragione de-vono imparare a rispettarle i talenti (al contrario del “tutto è dovuto”). In questo senso, si educa al lavoro fisi-co-atletico (e non si esaspera quello fisico-atletico), così come si educa al lavoro tecnico-strategico (e non si esaspera quello tattico-strategico).
In caso di insuccesso si cerca la causa in se stessi, mentre in caso di
mancata vittoria non si ricerca mai un capro espiatorio. Si educa alla sporti-vità, alla lealtà, all’onestà, mentre non si educa a essere furbi, sleali, disone-sti per ottenere la vittoria.
Chi vuole spendere tempo per gli altri?
Dietro e dentro a tutto la gratuità, il dono più bello che possa esistere nel mondo dello “sport promoziona-le”. Ogni atleta, infatti, ha diritto di fare sport, anche chi non ha un fisico di atleta e non viene accettato nelle squadre a finalità agonistiche.
È anche vero che oggi non sem-pre facile trovare giovani disponibili a spendere del proprio tempo per gli altri nel campo dello sport amatoria-le. Ci sono degli organismi nazionali e internazionali che hanno come sco-po il volontariato. Nel campo sportivo molto meno, perché si guarda sem-pre allo sport agonistico.
Oggi, grazie alla legge sul servi-zio civile, lo Stato ormai incoraggia tanti giovani a prestare un servizio nelle agenzie educative, quindi an-che nei nostri oratori e nelle PGS. Forse è questa la strada che gli Enti di promozione dovrebbero intra-prendere. ■

luglio-settembre 2016 – juvenilia 25
deserto: attiravano persone, talvolta anche da lontano, facendo sì che i problemi delle periferie ci “raggiun-gessero” e la nostra attività e pre-senza costante riuscisse a mitigare i problemi di zone delle nostre città, spesso nascoste ma non così lontane.
Purtroppo l’oasi, per sua stessa natura, da sola non è in grado di in-fluenzare e cambiare il deserto. ma svolge la sua funzione sperando che il deserto non la soffochi.
Un’idea differente è un’oasi che cerca di portare acqua creando ca-nali o inviando le proprie carovane, cercando di trasformare il deserto trovando territori fertili e semi pronti a germogliare.
È una strada innovativa e difficile che potrebbe mettere alla prova la forza e le capacità organizzative ed educative degli alleducatori e delle PGS.
Una strada già tracciata, ad esem-pio, da giovani operatori del Gruppo Abele di Torino, come ha raccontato Michele Gagliardo che nel Focus del numero scorso di Juvenilia, aveva offerto le sue provocazioni: da alcu-ni anni ogni giorno, con un furgone carico di poche attrezzature sportive, degli educatori e un mediatore cul-turale, partono per portare nella pe-riferia torinese lo sport amatoriale e auto organizzato in luoghi dove non vi sono strutture, ma la richiesta di stimoli da parte dei giovani è ancora più forte, seppur inespressa.
Perchéparlare ancora di deserto?
Un lavoro che diventa molto più difficile di quello in cui siamo abi-tuati nelle nostre ASD, dove spes-so veniamo cercati da chi è seguito da famiglia ed educatori e ha già la possibilità di avvicinarsi a un’attività sportiva.
Qui si tratta di portare lo sport e valori come il rispetto delle regole, la capacità di aggregazione, il met-tersi in gioco in variegate forme di autogestione, in zone delle nostre città dove non ci sono servizi e op-portunità e i giovani “cittadini” con le famiglie spesso non conoscono le realtà e le offerte nei dintorni di quelle periferie dove vivono e lavo-rano. Ancora una volta ci troviamo a parlare di “deserto”, ma con questa
attività il Gruppo Abele contribuisce a rivitalizzare giovani e famiglie nel-le periferie, perché uno dei pericoli del “deserto” è che la sua aridità ci contagi, rendendoci incapaci di far germogliare le capacità che abbia-mo dentro.
Attività ludica in associazionilibere e inclusive
Un altro esempio di questo ap-proccio al territorio è dato da “Blu Volley” che, con l’ausilio di Comune, oratori ed educatori di strada, propo-ne in Valcuvia nel varesotto un per-corso educativo formativo dedicato ai giovani che le prime settimane di giugno culmina nella festa sportiva del Green Volley, dove tornei amato-riali si alternano a momenti di festa, gioco libero, musica e stand gastro-nomici, per favorire l’aggregazione di giovani e famiglie in un territorio dove le offerte non sono quelle di una grande città.
Altrettanto significativa è l’espe-rienza del progetto “3on3” attuato in Calabria da Domenico Geria in col-laborazione con PGS Italia (si veda l’ultimo numero di Juvenilia, a p. 27). Con il solo ausilio di due canestri smontabili, il cortile – luogo predilet-to di don Bosco - è diventato il luogo spontaneo di aggregazione e gioco di ragazzi che, richiamati dalla pre-senza di questo campo improvvisato e cercati dagli educatori, hanno spe-rimentato il gioco “puro”, con regole create lì per lì condividendole all’i-stante, e godendo della gioia che na-sce dal gioco in sé, senza guardare al risultato e al punteggio ma allo stare insieme.
Ovviamente, in entrambi i casi si
esula da un discorso organizzativo di enti di promozione, numero di tes-serati, lavoro tecnico e organizzazio-ne di campionati, ma ci si concentra su eventi e attività più inclusive che competitive.
È un lavoro, questo, che poco si preoccupa delle “fragilità“ interne di qualsiasi Ente di promozione sporti-va, ossia la necessità di fare numeri, attraverso le tessere e le attività orga-nizzate.
Ma è un lavoro maggiormente le-gato alla figura di don Bosco e ai va-lori salesiani, rispetto a quel che sia-mo chiamati a svolgere nella nostra normale attività.
Polisportività. È uno degli aspetti fondamentali. Non si tratta di creare atleti e specialisti, ma di organizzare un’attività ludica e associativa libera come ai tempi del “cortile” della no-stra infanzia e di quella di ragazze e ragazzi che ancora oggi lo frequen-tano ogni giorno. Senza bisogno di strutture costose, con gli alberi come mura e il cielo come tetto.
Giovanili. Attraverso questo tipo di attività si entra in contattano con giovani – e le loro famiglie - di etnie, strati sociali e religioni differenti, se lo sport sarà solo la prima delle do-mande cui potremmo essere chia-mati a rispondere, tamponando altre carenze della società oltre a quelle sportive.
Salesiani. Attraverso il carisma salesiano e la figura di educatore di don Bosco cercare di trasformare i territori e I ragazzi con cui ci trovere-mo a rapportarci: altri semi per crea-re altre oasi, se il territorio è fertile, per cercare di rendere il deserto un po’ più verde e magari, col tempo, trasformarlo in giardino. ➔

26 juvenilia – luglio-settembre 2016
FOCUS
FOCUS / QUINTA SCELTA FONDANTELa scelta di una politica che persegue uno sport per tutti
LAVORARE PER ORIENTARE LE LINEE DELLE POLITICHE SPORTIVEDENTRO LE COMUNITÀ TERRITORIALIA cura di un gruppo di PGS del Piemonte
rapporto tra “sport per tut-ti” e istituzioni pubbliche locali è, da anni, un nodo per molti versi irrisolto
nella nostra associazione, anche per la timidezza o forse l’inadeguatezza, del-la stessa PGS a farsi protagonista nelle politiche locali e territoriali, lasciando – a volte forse per questioni di como-do, altre per paura di spezzare fragili equilibri nei rapporti – che siano altre organizzazioni a gestire e dettare le li-nee delle politiche sportive.
Sul territorioper mettere in gioco l’educativo salesiano
Così facendo, si rischia di dimenti-care quel che scriveva don Gino Borgo-gno nel 1986:
In un momento nel quale tutto lo sport di base sembra essere omologato ai criteri dello “sport per tutti” – parola grossa che riempie la bocca di Enti locali, Federazioni ed Enti di promozio-ne sportiva che sino a pochi anni fa si occupavano solo dello sport di alto livello – noi siamo chiamati a essere testimoni e rappresen-tanti di un progetto originale di educazione attraverso lo sport, nato non da quaranta o cinquanta anni, ma da oltre 150 anni fa nel-la mente di Don Bosco, quando sin dalla più tenera età intratteneva
i coetanei e i ragazzi più grandi con i giochi per presentare loro quanto aveva di più caro in cuo-re: la via della loro salvezza.A questo siamo ancora oggi chia-mati dal nostro essere “all-e-ducatori” e “dir-educatori” nella PGS. Il tratto è chiaro e richiama le responsabilità di ognuno di noi, nessuno escluso, a non perdere il contatto con le origini, con le radici della PGS, in breve a “non perdere l’identità”, a “non farsi scippare l’educativo nello sport”.
Ed è proprio quest’ultimo aspetto quello sul quale la PGS rischia di per-dere, anche se il risultato in alcune si-tuazioni territoriali è già compromesso, la sua partita più importante: non esse-re più il riferimento e l’associazione che da sempre si è distinta nell’educazione e nella crescita armoniosa dei giovani
attraverso lo sport. Con il rischio di la-sciarsi trascinare dalle mode e da quel-le che sembrano essere diventate paro-le guida, un po’ modaiole, che parlano dello sport per tutti come “inclusione”, “superamento delle barriere culturali”, “razzismo”, perdendosi in un variega-to mélange di parole che nel concetto PGS e salesiano di sport per tutti erano e sono già incluse.
Luoghi dove resistere alle frustrazioni
Ma quel che appare più evidente è che nel giocare il “cruciverba” dei termini politicamente corretti con al-tri Enti e Federazioni le PGS stiamo perdendo i giovani, non sapendo più dove siano, non raggiungendo i luo-ghi del ritrovo spontaneo. Una volta (ma è passato almeno un decennio dagli ultimi avvistamenti spontanei
Quali rispostea un problemaforse spinoso
Ma qui il problema può farsi spi-noso: le PGS, i gruppi mini, i Comitati provinciali hanno abbastanza risorse e volontari per cercare di occuparsi di altre situazioni critiche, oppure i pochi educatori sono a malapena suf-
ficienti per coprire le esigenze delle nostre società e parrocchie?
Vedo sempre gli stessi visi duran-te le riunioni e le attività, sempre col sorriso a rimboccarsi le maniche, ma sempre con qualche ruga in più e con spalle un po’ più curve.
Per conquistare il “deserto” la vo-lontà è utile, ma non basta. Servono
progetti coordinati con Comuni ed educatori di strada, con gli alleduca-tori delle società in prima linea, ma anche con Enti organizzati alle spalle che con bandi, segreterie mezzi e or-ganizzazione aiutino organizzino l’at-tività, altrimenti possiamo solo con le nostre forze curare il nostro giardino mentre tutto intorno si inaridisce. ■
Il

luglio-settembre 2016 – juvenilia 27
di giovani nei cortili) l’oratorio era il polo di attrazione e tutto era più semplice.
Oggi i luoghi dei giovani sono i centri commerciali, i giardini, i luo-ghi anche un po’ “periferici” (fab-briche abbandonate – improbabi-li giardini – scalinate e tetti delle case) dove ci si può muovere libe-ramente senza controllo per svolge-re le attività “sportive” di maggior attrazione e più adrenaliniche.
Se si pensa allo skateboard, rol-lerblade o al più estremo parkour si pensa solo ad attività marginale o socializzante. Ma in questo “feno-meno” si dovrebbe leggere anche una voglia di confronto e compe-tizione, una di voglia di scoprire i propri limiti, quei limiti che sin troppo spesso uno sbagliato con-cetto di sport per tutti ha frustrato e annichilito.
Fare politica sportiva non è, quindi, solo fare inclusio-ne, ma è avere un proget-to ben delineato. E nulla è più semplice di questo per l’associazione PGS. racchiuso da tempo in un libretto di don Bosco di sedici pagine – Il sistema preventivo – che si avvia al suo 140° anniversario dalla pubblicazione.
Un progetto dove i giovani sonoattori e non comparse
Ecco allora che il rapporto con la politica locale e territoriale si fa più semplice. Non entra nelle alchimie dei rapporti, ma si fa portatore di un progetto, sempre moderno, che pone i giovani al centro quali attori e non “comparse” utili a un altro fine.
Per fare un esempio, in Piemonte, alla fine degli anni ’90, si aprì un vero e proprio “laboratorio” che poteva essere anche punto di riferimento, di studio e di supporto per l’intera associazione. Un progetto al quale don Gino ha dedicato i suoi ultimi anni di associazione. Il suo desiderio di lasciare un ultimo “dono” era più forte di lui e il tutto senza ricercare remunerazione alcuna se non vedere l’associazione crescere. Sulla base di quel progetto i numeri dell’associa-zione in Piemonte lievitarono sino a essere il 25% del dato nazionale (per
numero di società e per nu-mero di tesserati) e questo grazie anche a un approccio discusso e con-diviso con la Regione Piemonte e con gli Enti Locali, quali Province e Co-muni, attraverso i responsabili locali, appropriatamente formati.
La fedeltà al progettopuò aprire sui territorispazi di futuro
Oggi, ovviamen-te, molte cose sono cambiate. Se vent’an-ni fa il servizio assi-stenziale e supple-tivo che svolgevano le associazioni era, parzialmente, remu-nerato dagli Enti lo-cali e dalla Regione con contributi anche sostanziosi, in un pe-riodo di risorse scar-se, se non assenti del
tutto, i pochi contributi diventano un miraggio cui si può dare sostanza e materialità solo attraverso progetti che sappiano diversificarsi dal gran numero di pretendenti (Federazioni, Enti e CONI stesso).
E lo stesso principio vale, forse di più, per i giovani da avvicina-re: se tutti i progetti e le proposte sono uguali e conformate (omo-geneizzazione della proposta) e si distinguono solo per l’uso di una palestra piuttosto che un’altra o di un “logo” più o meno accattivante e pubblicizzato, e per i costi a volte da vero e proprio dumping – tanto gli istruttori si pagano poco e han-no bisogno di quei quattro denari – è ovvio che per la PGS c’è poca strada da percorrere in futuro. Ma se la PGS si fa protagonista dello sport per tutti, riportando l’aspetto educativo e sportivo al centro del
progetto, allora si apriranno inediti spazi in futuro.
La risposta alle richieste di accoglienza
Chiudendo queste brevi riflessioni su come ricollocarci sul territorio non possiamo non ritornare a citare don Gino:
L’associazione PGS è respon-sabile non solo di soddisfare lo sviluppo equilibrato dell’uomo in tutte le sue dimensioni ai suoi soci, ma anche di offrire ad al-tri gruppi sportivi giovanili nei diversi territori questa propo-sta, in risposta a esplicite o im-plicite domande e invocazioni... Molti gruppi sportivi, sempre più, chiedono di essere accolti nel nostro “ambiente”, di fare con noi questa “esperienza”, di condividere convivendo sporti-vamente nelle attività. Questo convivere, dialogare, confrontarsi aiuta ognuno a crescere come PGS, senza ar-roccarsi in chiusure autonomi-stiche anticonciliari e non sa-lesiane. E aiuta gli altri a revi-sionare, migliorare accogliendo un messaggio di liberazione e di crescita, umana e forse cri-stiana. Il problema non è: riti-riamoci da questo servizio che implica un confronto e quindi un rischio; ma qualifi chiamoci per essere capaci di offrire un servizio che sia messaggio e proposta per essere un po’ più “missionari dei giovani”». ■
numero di società e per nu-mero di tesserati) e questo grazie anche a un approccio discusso e con-diviso con la Regione Piemonte e congli Enti Locali quali Province e Co
.n i a l a
o
tecanisttilepnccsrs
t tt i hi

28 juvenilia – luglio-settembre 2016
VITA ASSOCIATIVA
Elena Rastello
Un’estate di Olimpiadiche rilancia lo sportforza educativa
è ormai abbassato il sipario olimpico di Rio e del Brasile: attività sportive, iniziative ed eventi attraversati dall’inesauribile energia di atleti da tutto il mondo e siamo ancora lì a rivede-
re giornate coloratissime, vivaci e ricche di sport, vita ed esuberanza. Olimpiadi e Paralimpiadi: atleti, allenatori, di-rigenti, tifosi, volontari... sfilate, premiazioni, spettacolo e competizione, rappresentative da più di 170 Paesi.
Mesi e anni di palestre e allenamenti
Ammiriamo ancora le loro gesta e, forse, ci commuo-viamo per le loro vittorie. Tanti di loro sono capaci di prestazioni che fanno emozionare e lasciano sorpresi. Esprimono al meglio le capacità umane: forza di volon-tà, perfezionismo dei gesti, forza muscolare, armonia, destrezza, autocontrollo. Si nota in tanti atleti una tenacia esemplare che sostiene l’agonismo estremo di alcune gare. Lo sport può educare, può plasmare la personalità dei giovani atleti, il loro presente, il loro futuro, per esse-re ‘campioni nella vita’: per chi abbia praticato un po’ di sport è naturale pensare alle ore di palestra, di piscina, di campo sportivo trascorse per arrivare a certe prestazioni sempre più elevate, al valore del costante allenamento, del finalizzare tanto impegno quotidiano verso la meta di un record, di un successo, di una vittoria.
Gesti atletici di solidarietà e giustizia
Abbiamo negli occhi la bat-teria olimpica dei 5000 metri
quando la gara stava volgen-do al termine: la neoze-
landese Nikki cade come l’america-
na Abbey, che mette male il piede e si procura una distor-
sione al ginocchio ma, invece di maledire il momento e lamentarsi del dolore, si volta e aiuta Nikki a rialzarsi. In-sieme ricominciano a correre sorreggendosi l’una l’altra. Abbey cade altre due volte e tocca a Nikki sorreggerla. Tagliano il traguardo insieme. Ultime, ma in realtà vin-centi. Applausi, ammesse di diritto dal Comitato olim-pico alla finale per spirito sportivo. Esiste un gesto più sportivo dell’aiutare un avversario? Non si conoscevano e ora hanno un legame unico: gesti che non si improvvi-sano in una gara!
Abbiamo visto sfilare – per la prima volta nella sto-ria dei Giochi – le squadre dei rifugiati, la cui parte-cipazione era stata fortemente voluta dai Comitati internazionali olimpico e paralimpico per esprimere solidarietà ai rifugiati di tutto il mondo. Giovani ac-colti calorosamente e che – resilienti e audaci – espri-mono in semplicità le loro capacità atletiche per dire che è possibile un ‘altro mondo’, di pace e giustizia tra i popoli.
La corsa, al pari di altri sport, sembra talvolta capa-ce di risvegliare le coscienze. È ciò che ha espresso il maratoneta etiope secondo arrivato che, al traguardo, ha portato le braccia sopra la testa, incrociate ai polsi e con i pugni chiusi, gesto di protesta nei confronti del Governo del suo Paese, colpevole di perseguitare una certa popolazione. Lilesa sapeva bene che avrebbe do-vuto, per quel gesto, trasferirsi in un altro Paese, ma nel giorno della medaglia che vale gli sforzi individuali di una vita, egli è voluto arrivare al traguardo ricordan-do al mondo la lotta e la fatica di un popolo che vuole difendere la sua terra.
Le molte ambiguitàche deturpano il bello dello sport
Abbiamo anche letto delle spese faraoniche, sostenu-te dal Brasile per questa edizione delle Olimpiadi e da altri Paesi nel passato, per affrontare i magnifici eventi olimpici, spese che suscitano perplessità: è davvero tutto un grande business? L’Olimpiade è solo un grande mer-cato dei media e delle multinazionali? E poi il problema del doping, tra atleti squalificati e riammessi, tra lotte alle lobbies farmaceutiche e silenzi su una piaga che deturpa la bellezza della pratica sportiva.
Poi pensiamo alle popolazioni “spinte altrove” dal-le città, dove si sono svolti i Giochi olimpici negli ultimi trent’anni, per lasciar spazio a impianti sportivi, che tal-volta sono scarsamente utilizzati negli anni successivi: lo scarto di popoli ‘senza voce’ e lo spreco di risorse.
Si

luglio-settembre 2016 – juvenilia 29
Il coraggio di sognarenonostante tutto
Il tema della cerimonia iniziale dei Giochi paralimpici è stato “Ogni corpo ha un cuore”, racconto di disabilità come completezza del vivere quotidiano: la sfilata delle squadre na-zionali nelle manifestazioni olimpiche ha quasi lo scopo di sor-prendere e provocare, con atleti che sono immagini universali, con le loro storie, le loro emozioni, la loro vita. Uno straordi-nario movimento: da un’utopia a un progetto, da una speran-za a una realtà. Atleti che, con le loro prestazioni, invitano le giovani generazioni a sognare, a gareggiare, a stabilire rela-zioni umane di amicizia fra singoli e popoli: che interessante il secondo posto del nuotatore di Singapore dietro al campione statunitense che qualche anno fa aveva incontrato come idolo da emulare! Che bella l’anziana tedofora brasiliana, campio-nessa paralimpica nel 1984, che incespica, cade e si rialza con le sue forze per continuare a portare la torcia nel tripudio del pubblico presente allo stadio.
Che incoraggiante vedere la delegazione italiana ai Giochi paralimpici che ha sfilato mostrando un cartello in cui sono sta-te ricordate le vittime del terremoto in Centro Italia del 24 ago-sto: un gesto apprezzato e applaudito dagli ottantamila presen-ti che hanno già messo al collo degli atleti italiani la medaglia d’oro della solidarietà. Che gioia il murales della pace che gli oltre 5mila atleti paralimpici stanno firmando, voluto dal Co-mitato paralimpico Internazionale: un’opera d’arte collettiva che vuole cambiare una mentalità. Poi abbiamo anche visto la delegazione paralimpica bielorussa che porta la bandiera della Russia, la cui squadra è stata esclusa dalla manifestazione per lo scandalo del doping di Stato. Oppure, la pena grande dell’atleta israeliano che dà la mano a fine gara all’atleta egi-ziano che, invece, gliela nega, forse non solo perché incapace di perdere, ma anche per razzismo.
La rifondazione dello sporta partire dal gioco
Gli enti sportivi, le associazioni, gli ambienti oratoriani che promuovono sport educativo tra i giovani in tanti Paesi possono trarre da questi eventi mondiali molte suggestioni a operare con coraggio e creatività: i progetti sociali che favoriscono la pratica sportiva e l’integrazione di ragazzi in situazioni di vulnerabilità, migranti, con qualche disabi-lità, tra passione e divertimento. Accompagnare giovani atleti ad affrontare la sfida di migliorarsi progressivamen-te, a spostare il limite un poco più in là, a sfidare se stessi e i propri risultati non accontentandosi, affrontare le difficol-tà e le sconfitte quali parti integranti dello sport: progetti educativi integrali che formano alla lealtà e verità di sé,
che orientano l’energia della vita e la gioia nell’equilibrio tra mente e corpo, tra speranza del risultato e senso di re-sponsabilità.
In tanti abbiamo avuto la sensazione che i Giochi olimpici debbano essere ‘rifondati’, una rifondazione sociale ed eti-ca, innanzitutto, che vada oltre lo sport-business, la crescente spettacolarizzazione degli eventi sportivi, la deformazione che ha imposto il mercato capitalistico allo sport odierno. Rifon-dare i Giochi olimpici ripartendo dallo scopo e dalla ragione d’essere della pratica sportiva e, da qui, dalla motivazione de-gli sportivi, quelli in attività e ancora di più dei futuri campioni. Rifondare i Giochi dal gioco e dai movimenti sportivi che sono humus e vivaio dove i giovani trovano l’ambiente – non le scor-ciatoie – per diventare atleti in tutti gli sport.
L’invenzione quotidianadel legame vincente
Rifondare i Giochi ripartendo dagli atleti, dagli alleducato-ri, da dirigenti che:
non misurino l’eccellenza sportiva in base alle vittorie, bensì sulla fedeltà ai valori e ai principi dello sport, con l’at-tenzione agli atleti eccellenti, anche quando non sono vincenti, poiché il risultato non è il primo indicatore d’eccellenza di un atleta o di una squadra sportiva;
considerino la virtù come l’eccellenza del “sistema sport”, capace di generare imitazione, innovazione, migliori presta-zioni e record;
non considerino il vincere come il fine dello sport, bensì le medaglie e i trofei come premio, segno che riconosce e raffor-za la virtù-eccellenza di un atleta, di una squadra, e che inco-raggia l’emulazione virtuosa;
considerino vincitori non tanto coloro che rincasano con una medaglia, ma coloro che, dopo un impegno sportivo, sco-prono e dimostrano nel quotidiano di esserne usciti più umani;
siano convinti che la vita assomiglia a una partita, una gara da dividere i tre parti, la prima da correre con la testa, la secon-da con la personalità, la terza con il cuore.
Crediamo che l’azione di tanti sportivi in oratori-centri gio-vanili, scuole e altri ambienti salesiani sia una pratica intrisa di impegno per interventi che trasformano la realtà: un proget-to che richiede novità di vita, di saggezza, di discernimento, di testimonianza, di professionalità educativa e pastorale, un progetto PGS di proposta formativa, culturale e propositiva, che deve essere aggiornato costantemente per adeguarsi alle nuove domande e situazioni. ■
Elena Rastello, salesiana, lavora al dicastero di pastorale giovanile presso alla Casa generalizia FMA a Roma: [email protected]
h i

30 juvenilia – luglio-settembre 2016
DAL TERRITORIO
Allenamenti estivi verso legami durevoli per il futuro della ginnastica
ROMA
La ginnastica, anche nel campio-nato PGS, sta cambiando durante la pausa estiva.
In passato si chiudevano i cor-si con il tradizionale saggio di fine anno ai primi di giugno per ritorna-
re in palestra ai primi di ottobre o al massimo con la ripresa della scuola.
Negli ultimi anni sempre più so-cietà, sia di ritmica che di artistica, approfittano dello stop dalle gare dei mesi estivi per intensificare la preparazione fisica e provare qual-che difficoltà nuova in vista dei cam-pionati.
E per andare incontro alle ne-cessità delle famiglie che lavorando hanno bisogno di un posto per i pro-pri figli in ormai tante realtà sono nati i centri estivi sportivi.
Al mattino allenamento, pausa pranzo, compiti delle vacanze, pisci-na e di nuovo allenamento.
In questo modo il gruppo e la squadra rafforzano i rapporti sen-za perdere di vista la preparazione sportiva che vede ormai il lavoro di ogni allenatore migliorare di anno in anno sempre più verso il perfe-zionamento del gesto atletico, anche dove non ci sono grandi possibilità per diventare campioni, ma con la consapevolezza che quello che si impara è tecnicamente corretto e che la crescita psicofisica della sin-gola atleta viene potenziata.
Un breve stop nel mese di ago-sto e poi via di nuovo tutte in pa-lestra per ricominciare con rinno-vato entusiasmo. Troppo? Forse. Ma sono convinta che, nella società in
cui viviamo, l’adolescente sta meglio in un ambiente sano come la palestra con coetanee con le quali condi-videre interessi e obiettivi e che questo potrà contribui-re a renderle adulti migliori. Disponibili anche, una volta abbandonate le gare, a resta-re nelle società per mettersi a servizio delle nuove leve. Solo allora sai di aver fatto un buon lavoro. ■
Monica Malabotta, coordinatrice nazionale ginnastica
REGGIO CALABRIA
C’era anche Gianni Gallo, presidente nazionale delle PGS, all’Assemblea dei dirigenti quadri delle PGS calabresi il 2 ottobre a Lamezia Terme (Catanzaro) per presentare alle associazioni, ai diri-genti, agli alleducatori, al settore arbitri e agli organi di stampa le attività sporti-ve, ricreative e formative messe in cam-po dal Comitato regionale in vista della stagione 2016/2017.
«Si sono riaccesi i motori in vista del nuovo anno – ha spiegato il presidente delle PGS Calabria, Demetrio Rosace – all’insegna di una proposta sportiva che abbraccia tutto il territorio regionale e che va incontro alle esigenze di chi ‘ama’ fare sport sano e ‘vuole’ praticarlo senza ingenti sforzi economici che troppo spes-so risultano insostenibili”.
“Grazie alla cultura del volontariato – ha aggiunto Rosace – che portiamo avanti da tempo puntiamo, nel nostro piccolo, a garantire uno sport di qualità fatto su mi-sura per i nostri giovani, inseriti purtrop-po in un contesto che manifesta diverse difficoltà sociali ed economiche. Da qui il nostro progetto per la nuova stagione, dai campionati ai concentramenti sportivi, dal piano formativo al grande evento delle Pi-giessiadi di fine stagione che si svolgerà ancora una volta nella splendida cornice di Sibari dal 1 al 4 giugno 2017».
Per informazioni sui campionati, per prendere parte ai tornei e alle attività sportive e per conoscere più da vicino le iniziative delle PGS, è possibile visitare il sito del www.pgscalabria.it e consultare la pagina facebook “PGS Calabria”. ■
Sergio Notaro, addetto stampa PGS Calabria
La risposta a chi ama un sport sano ed economico
30 juvenilia – luglio-settembmbmbmbmbmbmbmbbbmbmbbmbmbmbmmbmbbbbbmmmmmmbbmbbbbbbbbreeereeeeeeeeeeeeeeeeeeerereeereerererrrrreereeeeeeerrrrrrererererrrrrrrrre 2222222201010101010100010100011101010101101110011101010100010001666666666666 6666666
che questo potrà contribuire a renderle adulti migliori. Disponibili anche, una volta abbandonate le gare, a resta-re nelle società per mettersia servizio delle nuove leve. Solo allora sai di aver fatto un buon lavoro. ■
Monica Malabotta,coordinatrice nazionale ginnastica
ha ada tegarasurapo indifficnostrcamppiangiessancodi Si
Pprensporinizisitola pa

luglio-settembre 2016 – juvenilia 31
Cosa c’è di meglio di tre giornidi mare e sport?
ALASSIO
Cosa ci può essere di me-glio che trascorrere tre giorni di mare e di sport, con persone provenienti da più parti d’Italia che condividono le tue stesse pas-sioni, alternando un torneo di palla-volo, bagni al mare, risate sotto l’om-brellone e quant’altro?
La risposta è molto semplice: il 15° Volley e Mare Memorial Don Gino Borgogno di Alassio.
E la squadra capitanata, come sempre, da Paolo Neri che è il pro-motore e l’anima della manifestazio-ne, con il supporto del Comitato pro-vinciale PGS di Savona, della sempre presente Cinzia Molle, che ci ha mes-so a disposizione il palazzetto dello sport di Alassio, in cui tra vittorie e sconfitte, gioie e amarezze è sempre prevalsa la voglia di stare insieme e di fare festa, anche sognando un ba-gno al mare.
Questo è quello che tra l’8 e il 10 luglio ci ha offerto la PGS rappresen-tata da Carlo Grancelli, vice presi-dente nazionale, e da Angelo Isella, anche lui vice presidente nazionale. Le sei squadre partecipanti ASD Pa-rona Pavia, sempre presente dalla prima edizione, Amiche Volley Tori-no, Primavera Life Reggio Emilia che per l’occasione riunisce le proprie giocatrici da Roma e Trento, Rebus di
un mix tra ragazze di Reggio Emilia e Busto Arsizio, Gruppo Vacanze Pavia e Speranza Primule Milano.
Rivali in campo, le squadre hanno però alloggiato insieme all’Ostello Don Bosco con una sveglia mattutina
rappresentata dal “dol-ce” suono dei gabbiani sul tetto. Poi via al pa-lazzetto, dove le squa-dre si riuniscono al rit-
mo di schiacciate e difese in un clima di divertimento e allo
stesso tempo di agonismo. Alla sera, terminate le gare, tutti e tutte
a visitare Alassio tra lungomare, classico budello, gelaterie e bar.
Dopo tre giorni in cui si alternano gare e mare,
si conclude il torneo con le premiazioni in
spiaggia. Vince Spe-ranza Primule di Milano
che festeggia così nel mi-gliore dei modi l’ultima gara del pro-prio capitano e si aggiudica anche il premio come migliore difensore.(Va-lentina Broggi) e la migliore alzatrice (Agata Giannoccari).
Migliore schiacciatrice, come lo scorso anno, risulta Erica Steccanella di Rebus mentre la migliore giocatri-ce (anche per lei non è la prima vol-ta) si dimostra Silvia Grecchi di ASD Parona Pavia.
Migliore alleducatore, premio vo-luto da Don Gino in tutte le Don Bo-sco Cup, è stato assegnato a Mauro Porracchio di Primavera Life Reggio Emilia.
Ci ritroveremo qui ad Alassio nel luglio 2017 per la 16° edizione di “Volley e mare” con la Libera fem-minile e raddoppieremo con la pre-sentazione della categoria Under 16 femminile a giugno a Rimini. ■
Cristina Bollini ([email protected])
Un corso nazionaledi aggiornamento per vecchi e nuovi alleducatori
ROMA
In questo anno giubilare si è scelta proprio Roma quale location per l’appun-tamento organizzato dal Nazionale PGS e rivolto a tutti gli allenatori già con espe-rienza e senza limiti di età, quale aggior-namento tecnico, salesiano e spirituale. Infatti le giornate che si sono susseguite dal 22 al 25 settembre, hanno visto i cor-sisti impegnati in diverse attività teoriche in aula, una giornata intera sui campi per le lezioni teorico/pratiche, momenti di distensione nello stile di famiglia salesia-no, il momento intenso del pellegrinag-gio e giubileo vissuti attraversando tutta via della Conciliazione in un clima di raccoglimento e di preghiera, e la Porta santa della Basilica vaticana.
Ciò che ci possiamo portare dentro al termine di questa esperienza e tornando sui nostri luoghi di provenienza da tutta Ita-lia è che le nostre PGS ancora hanno in sé il desiderio di crescere insieme: i più giovani accogliendo l’esperienza di coloro che da più anni vivono in questa realtà, i più grandi arricchendosi dell’entusiasmo che le PGS possano ancora avere un bel futuro.
Il gruppo di 42 corsisti ci fa ricordare che l’impegno della formazione lo dob-biamo portare avanti come un’eredità preziosa senza la quale perdiamo la no-stra identità. E la certezza che abbiamo potuto cogliere sta proprio nel fatto che il senso di appartenenza originario e ge-nuino, è l’unica nostra forza vincente per poter continuare a proporre sport nel nome di Don Bosco. ■
Sr Francesca Barbanera([email protected])
no, Primavera Life Reggio Emilia che pep r l’occasione riunisce le prp opprie giigigiigigiiiggiiggigigigigiiigigigiiigigigigigggggggggggggggggggggggggggg occocccocccocococococccococccoccccccococococccattattaaaatatatataaaaaaatattttatataatatatata riiriririiiriririrririrrirrriiiriririrriciiiiiiiciciiciciciicccccciicciiciciciciiciccicccccciiicicciicicicciccccc ddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaa aaaaa a aaaaaa a RoRRRoRRRoRoRRoRRRoRRoRoRoRRRRoRoRoRoRooRoooRRRoRoRRoRoRoRoRoRooRoRoRooooooomammamamamamaammammamamammmmmamamamamamamammmamammmmamamamamamamamamaamammam eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTrrrreeeeerrerererererereeerereerererererererererrereererererrerereerrereeeeenntntntntntntntnnnntntntntntntnnttnttntntnttntntntntntntntnnnnntntntntntnnnntnnnnnntoooooooo,oooooo,oooo,oooo,o,o,o,o,o,o,,ooo,o,ooooooooooo RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRebebbebbebebbebbbebebebebebebebbbebebebbebebeebebebebebbebbebeebbebeebebebbebbebeeebusuususuuususuusuuusususuuuusuususususususususussusuusussuuuusuuuusss dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii
femminile a giugno a Rimini. ■Cristina Bollini
(c(c(cririristststinininaa.a.boooooooooobooooooooooooooboooooolllllllllininini@i@@@i@@@@@feeeeeeefefeeeeeeeffeeeeninnininiiniiniiinininnnninnninniniiiiiiniininnnninikskskskskskkskskskssssssssssssssssssss iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i.i.i.i.i.i.ii.iit)t)t)t)t)t)))t))t)tt)t)t)ttt)t)t))t)t)t)t)t)t)t)t)t))tt)t)))))))
ere di me-tre giorni
on persone parti d’Italia tue stesse pas-torneo di palla-
risate sotto l’om-o?olto semplice: il
un mix tra ragazze di ReggioBusto Arsizio, Gruppo Vacane Speranza Primule Milano.
Rivali in campo, le squadrperò alloggiato insieme alDon Bosco con una sveglia m
rappresentata dce” suono dei gsul tetto. Poi vlazzetto, dovedre si riuniscon
mo di schiacciate in un clima di divertimen
stesso tempo di agonismsera, terminate le gare, tutt
a visitare Alassio tra lunclassico budello, gelater
Dopo tre giorni inalternano gare e
si conclude ilcon le premia
spiaggia. Vincranza Primule d

32 juvenilia – luglio-settembre 2016
NEWSRICONSEGNATO AL QUIRINALE IL TRICOLORE DI RIO 2016“Abbiamo conquistato 67 medaglie scrivendo pagine indelebili di storia. Abbiamo portato sul podio 100 atleti dimostrando che siamo un Paese che quando vuole sa fare squadra confer-mandoci nella top ten mondiale. Ab-biamo qui atleti che hanno mostrato storie splendenti, ci hanno fatto sogna-re ed emozionare portando nel mondo il nome dell’Italia”. Con queste parole il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha presentato al presidente della Repubblica Mattarel-la i medagliati olimpici e paralimpici ai Giochi di Rio, nel corso della cerimonia
vimento sportivo italiano, con il vostro impegno e con la vostra capacità, con-tribuendo a diffondere il messaggio olimpico”. “Voglio sottolineare come questa esperienza vi abbia fatto cresce-re, anche sotto il profi lo umano. Rag-giungere un obiettivo non vuole dire essere felici: la felicità bisogna averla dentro per raggiungere i traguardi. La pratica sportiva ci insegna a superare i nostri limiti, a migliorarci. E voi avete fatto gioire ed emozionare il nostro Pa-ese. Voi stessi siete stati la nostra ban-diera in Brasile” ha concluso Mattarella.
di riconsegna della bandiera italiana al Quirinale il 28 settembre. “Per la pri-ma volta sono presenti anche i quarti classifi cati, perché lo sport non è solo vittorie, anche loro fanno parte dell’I-talia che vince – ha proseguito Malagò –. Siamo davanti a campioni di vita e fuoriclasse sul campo, che insegnano come ogni obiettivo sia possibile: sono lo spot più effi cace di un’Italia fi era che non ha timore di nuove sfi de da affron-tare con lungimiranza”.Al Quirinale erano presenti 83 azzurri protagonisti a Rio. “Avete fatto onore – ha riconosciuto Mattarella – al mo-
Si è svolta in Vaticano dal 5 al 7 ottobre la conferenza globale su fede e sport “Sport at the service of humanity”, promossa dal Pontifi cio consi-glio della cultura, alla presenza di Papa Francesco, del segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon e del presidente del CIO Thomas Bach.“Lo sport, come la musica – ha osser-vato il cardinale Gianfranco Ravasi, è un linguaggio universale, una categoria fondamentale della persona umana. È una manifestazione di creatività, fanta-sia e potenzialità. Questa nobile attività può degenerare attraverso ben noti ele-
menti devastanti. Ma lo sport, dalle sue origini fi no al giorno
d’oggi, è parte della paideia, quel processo di crescita ed evoluzione
educativa che può portare all’eurit-mia tra corpo e anima”. Ma, ha pro-
seguito Ravasi, “c’è bisogno di tornare a un principio di moralità e anche di senso religioso che nell’autentica attività spor-tiva è insito”.Obiettivo della conferenza è stato creare uno spazio nel quale leader appartenen-ti a diverse religioni e fedi, responsabili dello sport e delle aziende, del mondo accademico e dei media si sono in-contrati per discutere di come attuare
una sinergia tra fede e sport a servizio dell’umanità. Il Papa ha chiesto con for-za a sportivi e sponsor di tenere lo sport lontano da manipolazioni, sfruttamento commerciale e corruzione. Perché “sa-rebbe triste se la gente non riuscisse più a confi dare nella verità dei risultati spor-tivi, o se il cinismo e il disincanto pren-dessero il sopravvento sull’entusiasmo e sulla partecipazione gioiosa e disinteres-sata”. “Lo sport non ci dà risposte sul signifi -cato dell’esistenza umana, sulla vita, la morte, l’aldilà. Solo la fede può farlo” e insieme “possono creare una potente al-leanza”, ha affermato Thomas Bach.
FEDE E SPORT, TRE GIORNI DI RIFLESSIONE IN VATICANO
COMPIE 50 ANNI LA SCUOLA DELLO SPORT DEL CONINel corso dei suoi cinquant’anni di vita, la Scuola dello sport ha alimentato la vocazione allo studio, alla ricerca, alla rifl essione e alla trasmissione del sapere sportivo, creando le premesse per una tradizione che è divenuta un esempio nel mondo. Il presidente del CONI Onesti, convinto che lo sviluppo dello sport italiano potesse realizzarsi solo at-traverso la formazione e la cultura, creò la Scuola perché provvedesse a formare i Maestri di sport e, negli anni successivi, alla specializzazione e all’aggiornamen-to dei tecnici e di numerose fi gure pro-
di studi e ricerche con l’obiettivo di uti-lizzare nel campo dello sport i risultati di varie discipline scientifi che. Numerosi, in questi cinquant’anni, gli atleti che hanno frequentato e fre-quentano la Scuola in qualità di allievi o docenti, come pure gli allenatori, i ricercatori, gli scienziati, i professionisti, i formatori, gli uomini di cultura che hanno contribuito alla crescita di questa istituzione, perseguendo un modello di eccellenza sportiva.
Luca Caruso ([email protected])
fessionali che operano nel mondo spor-tivo, promuovendo anche il progresso
vimento sportivo italiano, con il vostro a al pri-
dieducativi t
Vaticano dala conferene sport “Sof humaniPontifi cio
ll
enti devae sue origgi, è parteesso di cresva che pu
TRE Gal nza port ity”, consi-
medalle
d’oggproce
educativ
T