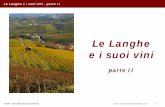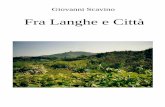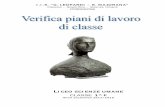LE LANGHE E LA RESISTENZA PAVESE E FENOGLIO · • La “fuga”: conclude il romanzo e serve ......
Transcript of LE LANGHE E LA RESISTENZA PAVESE E FENOGLIO · • La “fuga”: conclude il romanzo e serve ......
LA RESISTENZA La Resistenza italiana fu l'insieme dei movimenti politici e militari che in Italia dopo l'armistizio di Cassibile si opposero al nazifascismo nell'ambito della guerra di liberazione italiana.
Il movimento della Resistenza – inquadrabile storicamente nel più ampio fenomeno europeo della resistenza all'occupazione nazifascista– fu caratterizzato in Italia dall'impegno unitario di molteplici e talora opposti orientamenti politici, in maggioranza riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), i cui partiti componenti avrebbero più tardi costituito insieme i primi governi del dopoguerra.
BEPPE FENOGLIO Beppe Fenoglio era un intellettuale esperto di letteratura inglese e americana. Dopo aver partecipato alla Resistenza nelle Langhe, pubblicò i suoi primi lavori di impronta neorealista negli anni ’50.
A Beppe Fenoglio dobbiamo, oltre ad un vivido ritratto dell'umanità contadina di Langa, il racconto della Resistenza partigiana, una narrazione epica e priva di retorica della guerriglia sulle colline e delle inquietudini di una generazione.
UNA QUESTIONE PRIVATA
• Tra le opere di Fenoglio ricordiamo Una questione privata
• Italo Calvino definirà l’opera «Un romanzo di follia amorosa e di cavallereschi inseguimenti»
• «Una questione privata è costruito con la geometrica tensione d'un romanzo di follia proprio com'era, di dentro e di fuori, vera amorosa e cavallereschi inseguimenti come l'Orlando furioso, e nello stesso tempo c'è la Resistenza come mai era stata scritta, serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele, e con tutti i valori morali, tanto più forti quanto più impliciti, e la commozione, e la furia. Ed è un libro di paesaggi, ed è un libro di figure rapide e tutte vive, ed è un libro di parole precise e vere. Ed è un libro assurdo, misterioso, in cui ciò che si insegue, si insegue per inseguire altro, e quest'altro per inseguire altro ancora e non si arriva al vero perché».
Pubblicato postumo nel 1963, a due mesi dalla morte dell’autore, questo romanzo breve consegna ai lettori un’immagine intensa di quella che fu, per Fenoglio, la Resistenza partigiana, fatta di ipocrisie e contraddizioni, ma anche di un’umanità nobile e autentica.
Fenoglio definì questo racconto
“Un intreccio romantico non sullo sfondo della storia, ma nel fitto della guerra: la liricità del nucleo centrale è esaltata dallo sfondo epico, e l’alternarsi delle vicende reali con quelle solo rievocate e sognate è elemento determinante del romanzo.”
TRAMA Nelle Langhe, durante la guerra partigiana, Milton è un giovane studente universitario, ex ufficiale che milita nelle formazioni autonome. Eroe solitario, durante un'azione militare rivede la villa dove aveva abitato Fulvia, una ragazza che egli aveva amato e che ancora ama. Mentre visita i luoghi del suo amore, rievocandone le vicende, viene a sapere che Fulvia si è innamorata di un suo amico, Giorgio: tormentato dalla gelosia, Milton tenta di rintracciare il rivale. È da qui che parte la ricerca: vuole trovare Giorgio per sapere la verità, per comprendere definitivamente l’impossibilità del suo amore per Fulvia e l’inconsistenza dell’amicizia tra lui e Giorgio. Ma la ricerca non si rivelerà affatto semplice. Il suo viaggio si scontrerà con la violenza della Storia.
Dopo un lungo viaggio Milton scopre che Giorgio è stato fatto prigioniero dai fascisti. Ostinato nella sua ricerca, Milton decide di fare a sua volta prigioniero un fascista per scambiarlo con Giorgio, così da poter parlare con lui e finalmente sapere. Milton riesce a catturare un ufficiale nemico per scambiarlo con Giorgio, ma questo impaurito tenta la fuga in un momento di distrazione del partigiano, che è costretto a sparargli. Il fallimento della temeraria impresa non riduce però la volontà di Milton di trovare una soluzione al suo problema. Ossessionato dal ricordo di Fulvia, Milton decide di tornare alla villa della ragazza. Sorpreso da un rastrellamento, il protagonista si dà ad una fuga disperata, che termina all’ingresso del bosco, quando Milton crolla a terra «…Come entrò sotto gli alberi, questi parvero serrare e far muro e a un metro da quel muro crollò».
LUOGHI Le vicende si svolgono sulle Langhe piemontesi in un territorio collinare delimitato da tre paesini: Treiso, sede della divisione partigiana di Milton, Mango, dove invece prestava servizio Giorgio, e Canelli dove si trovava la divisione fascista di S. Marco. Emerge la conoscenza dei luoghi e delle loro caratteristiche: sono infatti questi luoghi natali dell’autore, paesaggi che Fenoglio amava molto e conosceva fin nel minimo dettaglio grazie anche alla sua stessa esperienza partigiana vissuta proprio in quei posti.
TEMI La Resistenza che vive intorno a lui. Fenoglio si sente indifeso e inerme davanti alla guerra, alla quale è costretto a partecipare forzato dagli eventi e dalla brutalità del fascismo. Lo scrittore quindi cerca di liberare la sua narrazione da ogni intento moraleggiante e didattico, non modifica la realtà ma cerca di presentarla così come era. I partigiani appaiono nel loro coraggio ma anche in tutti i loro limiti e nelle loro divisioni interne, senza inutili tentativi di idealizzare la realtà. Il viaggio riferito all’evolversi della mentalità del personaggio e alla sua formazione. Il cammino continuo di Milton è soprattutto quello che avviene nella mente del personaggio, che pensa, ricorda momenti, compie un viaggio a ritroso nel tempo. La ricerca. Una questione privata è anzitutto ricerca, ricerca di conferme, di un amico, di una donna, di una felicità forse impossibile.
GENERE Dal primo punto di vista il romanzo assume le caratteristiche di un romanzo di carattere, basato sull’analisi del personaggio. Se poniamo attenzione sull’ambiente che circonda Milton, il racconto, corredato da numerosi flash-back e pause narrative, diventa quasi un romanzo storico, un quadro della guerra partigiana nelle Langhe . Se poi poniamo la nostra attenzione all’evolversi delle vicende in relazione alla mentalità di Milton, l’opera assume l’aspetto di un romanzo di formazione, il personaggio cerca di liberarsi dai vincoli che la sua mente di intellettuale gli aveva imposto.
CONTESTO Il contesto è quello della guerra partigiana combattuta sulle Langhe che Fenoglio conosceva molto bene per avervi partecipato in prima persona. Il romanzo è quindi per questo aspetto autobiografico, l’autore rivive quei momenti della sua vita. La Resistenza è rappresentata essenzialmente da tre punti di vista: Milton, i partigiani ed i contadini.
CESARE PAVESE Cesare Pavese è stato uno scritto re, po eta, saggista e
tradutto re italiano .
Scritto re dall’esistenza amara e to rmentata, aprì nuo vi o rizzo nti culturali nella letteratura italiana del ‘900, pur mantenendo sempre un legame co l mo ndo primigenio e autentico della Langa della sua infanzia.
LA CASA IN COLLINA Tra le opere di Pavese ricordiamo La casa in collina.
Il romanzo è il simbolo dell’impegno politico e del disagio esistenziale di un’intera generazione.
La casa in collina indaga le conseguenze psicologiche e sociali del secondo conflitto mondiale e della Resistenza, cui Pavese stesso non partecipa, rifugiandosi, come il protagonista, in collina. La narrazione è dunque fortemente intrisa di elementi autobiografici, che fanno trasparire alcune costanti della poetica di Pavese:
• il legame disarmonico tra l’intellettuale e la realtà
• il rapporto complesso con il mondo rurale delle Langhe contrapposto a quello della città
• il ruolo della memoria individuale.
LA FIGURA DI CORRADO
Ne La Casa in collina Pavese tratta il dissidio tra la solitudine contemplativa dell’intellettuale e la presa di posizione storica ed ideologica che gli eventi richiederebbero. Pavese avverte profondamente questo dissidio per motivi autobiografici e lo traspone, attraverso la scelta della narrazione in prima persona, nella figura di Corrado.
Corrado: è un professore di scienze sulla quarantina, insegna a Torino, ma vive a pensione sulle colline circostanti. La sua indole è schiva e la guerra accentuerà una simile predisposizione alla solitudine: egli stesso dichiara come il cane Belbo sia il suo unico «confidente sincero». Al suo carattere acuto e riflessivo non sfugge come rimanere in disparte sia già una connivenza con il fascismo. Ma egli, rifiutata la via dell’impegno diretto, si sforza di mettere da parte la propria logica e di non incedere nei rimpianti sulle numerose occasioni perdute.
TEMATICHE AFFRONTATE
• La “solitudine”: come condizione umana che, se da una parte permette all’uomo di riflettere e ragionare nella propria individualità, dall’altra denuncia drammaticamente la propria impotenza di fronte all’impegno civile.
• Le parole-tema indicate nel titolo, «casa» e «collina», servono come collegamento per inquadrare l'intera vicenda.
• La “fuga”: conclude il romanzo e serve a denunciare i rimorsi che il protagonista non potrà mai allontanare.
• • La “collina” e la “casa”: Sullo sfondo della
"collina", che all'inizio del romanzo viene presentata come il luogo ideale per escludere gli avvenimenti della guerra che invece colpiscono la città, vi è il tema complementare della "casa" con i suoi ristretti valori di sicurezza e di chiusura verso il prossimo.
• La “città”: in contrapposizione con la collina, la
città rappresenta il luogo dove avvengono eventi cruenti che segneranno profondamente la vita di tutti i personaggi del romanzo.
LA CONCLUSIONE DEL ROMANZO
Le riflessioni di Corrado e il senso che esse danno a tutta La casa in collina diventano particolarmente significative nell’ultimo capitolo, quando Corrado è ormai solo e ha perduto gran parte dei propri punti di riferimento nelle altre figure della narrazione. I pensieri del protagonista vanno con insistenza al significato della violenza e della guerra:
«È qui che la guerra mi ha preso, e mi prende ogni giorno. [...] non è che non veda come la guerra non è un gioco, quella guerra che è giunta fin qui, che prende alla gola anche il nostro passato. [...] Ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini. Sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha paura di scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce, giustificare chi l’ha sparso».
La conclusione appare così un esame di coscienza del protagonista, che, da intellettuale e letterato, osserva l’insensata sofferenza della guerra, senza prenderne parte attivamente e senza trovare una giustificazione alle morti che il conflitto sta causando. Corrado da un lato comprende la dolorosa condizione umana, ma dall’altro si rammarica della propria impotenza e dell’impossibilità di fermare la sofferenza collettiva.
STILE
Narratore e punto di vista: Il narratore del romanzo è interno, in quanto assume il discorso in prima persona ed è presente nel racconto come personaggio principale. Il punto di vista del narratore infatti è a focalizzazione interna, perché coincide con quella di un personaggio. Il narratore non coincide con l’autore, sebbene siano presenti numerosi tratti autobiografici, che permettono di accostare la figura di Corrado a Cesare Pavese.
La storia di una solitudine individuale di fronte all’impegno civile, la contraddizione da risolvere tra vita in campagna e vita in città nel caos della guerra, il superamento dell’egoismo attraverso la scoperta che ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione appartengono sia al pensiero del protagonista del romanzo sia all’autore.
In quest’opera, Cesare Pavese adotta uno stile maturo, utilizzando una scrittura ritmata, quasi colloquiale, con frasi corte ma parecchio incisive.
In Corrado, il protagonista, Pavese si identifica e attraverso di lui, che vive nel tempo presente, egli ricorda la vita trascorsa sulle colline piemontesi che appaiono subito il luogo preferito e che servono per rievocare con l'immaginazione la vita passata che viene narrata in prima persona dall' io narrante, «esplicitando così i contenuti interiori, endocettuali».















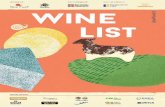


![GAL Langhe Roero Leader - presentazione dei risultati 2007-2013 [modalità compatibilità]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5598e2fd1a28aba57d8b46a2/gal-langhe-roero-leader-presentazione-dei-risultati-2007-2013-modalita-compatibilita.jpg)