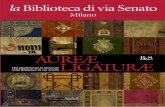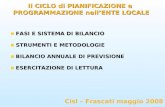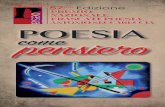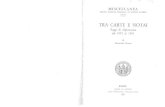LASFIDADELLASALUTE OGGI E PER LE FUTURE GENERAZIONI · g L'edizione 2012 di Venezia in Salute al...
Transcript of LASFIDADELLASALUTE OGGI E PER LE FUTURE GENERAZIONI · g L'edizione 2012 di Venezia in Salute al...

LA SFIDA DELLA SALUTE OGGI E PER LE FUTURE GENERAZIONI
Movimento Difesa della Sanità Pubblica.La riorganizzazione dei servizi territoriali
ALL’INTERNO
DICEMBRE 2012 / GENNAIO 2013 - NUMERO 5
èèV E N E Z I A I N S A L U T E

2
sommario
P R I M O P I A N O
g Registro Regionale Malattie Rare. La sfida della diagnosi e della presa in carico complessiva dei pazienti; a cura di Monica Mazzucato e Paola Facchin,Coordinamento del Registro Regionale Malattie Rare
F O C U S U L S S 1 2
g Tumore alla vescica, la diagnosi precoce salva la vita. Intervista a Carlo Pianon,primario di Urologia dell'ospedale dell'Angelo
g Distretto Socio sanitario n. 2 dell'azienda Ulss 12. I servizi territoriali nella Venezia insulare. Un intervento di Danilo Corrà, direttore del Distretto 2 dell'Ulss 12
P R E V E N Z I O N E E S T I L I D I V I T A
g Diabete, ridurre complicanze e costi sanitari.Intervista a Diego Turchetto, medico di medicina generale
g Una guida per i pazienti cardiopatici. L'assunzione dei farmaci fondamento della prevenzione secondaria; a cura di Franco Del Piccolo, responsabile Unità di Riabilitazione Cardiologica della Casa di Cura Policlinico San Marco
S P E C I A L E
g L'esposizione al carico complessivo di inquinanti e il rischio per le future generazioni.Un intervento di Ernesto Burgio, presidente del Comitato Scientifico ISDE (International Society of Doctors for Environment)
L ’ I N I Z I A T I V A
g L'edizione 2012 di Venezia in Salute al parco di san Giuliano; a cura di Angelo Frascati,medico di medicina generale
A T T I V I T À
g Azienda Ames, farmacie comunali e ristorazione scolastica.Intervista a Giampiero Marchese, amministratore delegato di Ames
g Collegio Infermieri. Il ruolo dell'infermiere per la prevenzione delle cadute in ospedale.L’esperienza della Casa di Cura Policlinico San Marco; a cura di Renata Casarin,Responsabile Ufficio Formazione Casa di Cura Policlinico san Marco
P U N T I D I V I S T A
g La riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali. Tutelare e migliorare l'assistenza ai cittadini; a cura di Salvatore Lihard, Movimento per la Difesa della Sanità pubblica
g Telefoni mobili e tumori alla testa. Una sentenza di condanna della Cassazione; a cura di Laura Masiero, presidente associazione A.P.P.L.E.

3
primo pianoMalattie rare, la sfida della diagnosie della presa in carico complessivadei pazienti
Le malattie rare sono condizioni estremamenteeterogenee tra loro, diverse per eziologia, meccanismipatogenetici e manifestazioni cliniche, accomunate dalfatto di avere una bassa prevalenza nella popolazione.Tale minor frequenza si accompagna spesso ad unaminor conoscenza.Il fatto di raggruppare queste patologie, seppur diversetra loro, all'interno di uno stesso gruppo, con lacaratteristica comune di avere una bassa diffusione in popolazione, risiede nel fatto che esse presentanoproblematiche assistenziali simili.
a cura di Monica Mazzucato e Paola Facchin,Coordinamento Registro Regionale Malattie Rare
La specificitàLa peculiarità delle malattie rare sta nel fatto cherichiedono un’assistenza specialistica e acarattere continuativo di dimensioni tali da nonpoter essere supportata senza un importanteintervento pubblico. Nel tempo, sotto la spinta ditali considerazioni, si è iniziato a destinarerisorse, sempre più rilevanti, da una parte allaricerca su tali patologie e, dall’altra, all'assistenzaalle persone colpite da queste malattie.
L'impatto complessivo sulla salute della popolazioneQuesto processo si è verificato a partire dagliStati Uniti negli anni Ottanta, per poi coinvolgeremolti Paesi europei, tra i quali l’Italia. Negli ultimianni si è infatti assistito al progressivo affermarsidella necessità di considerare le malattie rare nelloro complesso, prescindendo dalle singoleparticolarità, unico approccio utile per stimare illoro impatto complessivo sulla salute della

4
popolazione. Nel tempo si è osservato unampliamento degli obiettivi da perseguire,dall’emanazione di leggi specificatamenteorientate a sostenere lo sviluppo di farmaci perqueste condizioni, alla pianificazione di interventia carattere assistenziale mirati, finoall’implementazione di vere e proprie politichesanitarie a favore delle persone con malattie rare.
ENTITÀ DEL PROBLEMAUna delle questioni fondamentali quando siaffronta il tema delle malattie rare è risponderealla domanda: quanti e quali sono i malatiinteressati da queste condizioni?La sensazione basata sull’esperienza personaledel medico difficilmente coglie l’entitàcomplessiva del fenomeno. Di molte malattie rareun medico può vedere solo un caso o anchenessuno nella sua vita professionale.Malattie più o meno frequenti, seppur rareÈ comunque riconoscibile un gradiente di “rarità”:per esempio, esistono malattie rare “piùfrequenti” che colpiscono qualche migliaio dipazienti in Italia, tra queste la sclerosi lateraleamiotrofica, le distrofie muscolari, l’emofilia, percitare qualche esempio. Per altre si può stimareche i pazienti affetti siano qualche centinaio. Peraltre ancora non esistono studi di prevalenza, masolo descrizioni in letteratura di singoli casi: è ilcaso di molte sindromi genetiche o sequenzemalformative complesse.In generale si può affermare che queste malattie,pur potendo essere singolarmente pocofrequenti, non sono rare, se considerate nel lorocomplesso. Il numero dei malati, pur non essendocosì rilevante rispetto ad altre condizioni con lequali il medico di medicina generale o il pediatraquotidianamente si confronta, è comunqueglobalmente consistente.Complessivamente tra 5mila e 7mila tipidiversi di malattie rare e soglia di raritàBasti pensare che si stima che il numerocomplessivo delle malattie rare oscilli tra 5.000 e 7.000. A livello europeo una malattia èconsiderata rara se colpisce meno di 5 personesu 10.000 abitanti.
L'IMPATTO Oltre al numero non trascurabile di personemalate, bisogna considerare l’impatto di questepatologie, determinato dalla sommatoria di moltielementi diversi. Elemento comune a moltemalattie rare è la complessità della gestioneassistenziale, fattore che può determinarecontinui accessi a diversi servizi della retesanitaria e sociale.Impatto rilevante per il malato e per il sistemaassistenzialeL’impatto, da una parte sulla persona malata,dall’altra sull’intero sistema assistenziale, risulta
in entrambi i casi molto rilevante. Complessitàassistenziale, costi sociali ed umani tendono adeterminare un danno , che, moltiplicato per ilnumero dei malati e di famiglie coinvolte,complessivamente elevato, produce un impattorilevante sulla salute della comunità e giustifical’attenzione che deve essere riservata allemalattie rare secondo un approccio di sanitàpubblica.
LE POLITICHE PER LE MALATTIE RARE INEUROPALaddove la scarsità di conoscenze e il numerolimitato di persone affette rappresentanoelementi peculiari, il contesto sovra-nazionaleappare il più adeguato per intraprendereinterventi e stabilire principi di programmazionesanitaria. In questo senso le malattie rarerappresentano un esempio paradigmatico diambito di salute pubblica in cui le azioni, sesupportate a livello di Unione Europea, possonoassumere un valore aggiunto considerevole.Gli interventi dell'Unione EuropeaSulla scia di questo orientamento, sono statiintrapresi ad oggi diversi interventi a livelloeuropeo, ferma restando comunque l’autonomiadecisionale in materia sanitaria dei singoli StatiMembri.Le malattie rare sono state identificate come unapriorità nell’ambito dei Programmi d’azionecomunitaria di Sanità Pubblica relativi agli anni1999-2003, 2003-2008 e 2008-2013. Nelnovembre 2008 è stata ufficialmente adottatauna Comunicazione della Commissione Europeaal Parlamento Europeo, al Consiglio, al ComitatoEconomico e Sociale Europeo e al Comitato delleRegioni denominata “Le malattie rare: una sfidaper l’Europa”.Tale comunicazione ha preceduto l’adozione diuna Raccomandazione del Consiglio Europeo suun’azione nel settore delle Malattie Rare. Tuttequeste azioni sono testimonianza del rilevanteinteresse che le malattie rare suscitano a livelloeuropeo, motore di diverse possibili azioni daintraprendere a livello dei singoli Stati Membri.Le azioni: www.orpha.net e www.eucerd.euIl contributo dell’Unione Europea si è tradottoinizialmente nella promozione di azioni che hannocome obiettivi primari l’ampliamento delleconoscenze sulle malattie rare ed ilmiglioramento dell’accessibilità alle informazionieffettivamente disponibili. In tale ambito è statocreato Orphanet, il più noto portale informativomultilingue sulle malattie rare e i farmaci orfani,sviluppato per rispondere alle esigenzeinformative di pazienti, medici e ricercatori.(Per accedere al portale: www.orpha.net).Per avere una fotografia dello stato dell’arte dellepolitiche e delle azioni condotte a livello europeoed internazionale sulle malattie rare è possibile

5
consultare il sito della Commissione Europeariportante le attività di EUCERD, il Comitato diesperti sulle malattie rare, istituito nel 2011:www.eucerd.eu/.
LE POLITICHE PER LE MALATTIE RARE IN ITALIALe politiche a favore delle persone con malattiarara hanno preso avvio in Italia con l’emanazionedel Decreto Ministeriale n. 279/2001. La norma ècaratterizzata da un approccio innovativo inquanto affronta il problema delle malattie rare intermini di programmazione sanitaria ed affida alleRegioni il compito di programmare e implementarele attività individuate dalla normativa nazionalecome prioritarie.Gli obiettivi del decreto n. 279I punti strategici contenuti nel decreto sopracitatosono:• la stesura di un elenco di malattie rare e,
quindi, di malati portatori di particolari diritti;• l’esigibilità di tali benefici solo all’interno
di una rete regionale o interregionale di Centri accreditati per la diagnosi e la cura di queste specifiche forme di malattia;
• la disciplina dell’attività di tali Centri all’interno di protocolli esplicitati, basati sulle più aggiornate evidenze scientifiche e monitorate nella loro attuazione ed efficacia;
• il legame tra attività dei Centri accreditati,erogazione dei benefici ai pazienti e monitoraggio del fenomeno attraverso la costituzione di registri di malattie rare su base regionale/interregionale;
• il coinvolgimento formale delle associazioni dei pazienti nei processi decisionali e di monitoraggio e la necessità di supportare le famiglie dei pazienti e i professionisti del Sistema Sanitario Nazionale con azioni di informazione e formazione mirate.
LA RETE PER LE MALATTIE RARE DELLA REGIONE VENETOLa Regione Veneto ha intrapreso specifichepolitiche sanitarie per costituire un sistemaregionale dedicato all’assistenza alle persone con malattie rare già a partire dal 1999. Da allorasi sono succeduti numerosi provvedimenti chehanno portato all’individuazione della reteregionale dei presidi accreditati per l’assistenza ai malati rari, all’attivazione del sistemainformatizzato per la presa in carico assistenzialedei malati, fino a provvedimenti specifici diintegrazione ai livelli essenziali di assistenza per i cittadini residenti in Veneto.I centri regionali di assistenza specializzatinelle varie patologie rareFin dall’inizio obiettivo prioritario a livelloregionale è stato quello di costituire, comestabilito dalla normativa nazionale, una rete di assistenza per i pazienti affetti da malattie
rare. Tale rete è stata individuata a partire dallestrutture costituenti il sistema regionale diassistenza. I centri sono stati individuati sullabase di criteri trasparenti: casistica seguita,esperienza clinica, elevato potenziale di ricerca ecollegamenti con altre strutture di eccellenza. Lalogica seguita è quella di garantire la possibilitàper i pazienti di accedere davvero al meglio dellecure disponibili per la loro condizione. CiascunCentro individuato è dedicato ad uno specificosottogruppo di patologie e di fascia dipopolazione. In base al numero di malati presentinel Veneto, per ciascun gruppo di patologiapresente nell’elenco del DM 279/2001 (adesempio malattie infettive rare, tumori rari,malattie metaboliche ereditarie, malformazionicongenite, ecc.) sono stati individuati uno o piùCentri, fino a un massimo di 4 Centri per i gruppidi patologie più numerosi, ciascuno costituito dauna o più Unità operative.
LO SVILUPPO DELLA RETE INTERREGIONALELe intese tra le Regioni e Province Autonome delNordest che perseguano l’obiettivo di individuaree implementare strategie d’azione per lo sviluppoe l’innovazione comuni trovano nell’area dellasanità, e nel campo delle malattie rare inparticolare, un ambito paradigmatico diimplementazione.Un accordo tra Regione Veneto, Friuli VeneziaGiulia e Province Autonome di Trento e BolzanoPer raggiungere tali obiettivi strategici,nell'ottobre 2004 è stato siglato un accordo traRegione Veneto, Regione Friuli-Venezia Giulia,Provincia Autonoma di Bolzano e ProvinciaAutonoma di Trento per creare un ambitoterritoriale omogeneo per l'assistenza allepersone con malattie rare, basato su uno stessosistema informativo, al fine di omogeneizzareapprocci assistenziali, modalità di accesso aibenefici e percorsi dei pazienti, eliminandodisparità e disuguaglianze tra i malati presentinell'area. Una delle aree principali oggettodell’Accordo riguardava la condivisione di criteri emetodi per la definizione dei Centri di riferimentocomuni da accreditare per specifici gruppi dipatologie rare all'interno dell'Area Vasta.Riconosciuti 19 presidiSono stati così riconosciuti, con Delibere diGiunta congiuntamente emanate dalle 4Amministrazioni costituenti l’Area Vasta, i Centridi riferimento comuni per l’assistenza allepersone con malattie rare. Complessivamentesono stati individuati 19 presidi di riferimentocosì distribuiti: 12 in Regione Veneto, uno in Provincia Autonoma di Trento, uno in ProvinciaAutonoma di Bolzano e 5 in Regione FriuliVenezia Giulia.In Veneto presidi accreditati a Padova, Verona,Belluno, Vicenza, Conegliano, Castelfranco

6
Veneto, Treviso, Venezia, Mestre,Camposampiero, RovigoPer la Regione Veneto i Centri di riferimentoindividuati fanno capo ai seguenti presidiospedalieri/aziende ospedaliere: AziendaOspedaliera di Padova, Ospedale S. Antonio di Padova, Azienda Ospedaliera di Verona,Ospedali di Belluno, Vicenza, Conegliano,Castelfranco Veneto, Treviso, Venezia, Mestre,Camposampiero, Rovigo.
LA PROGRAMMAZIONE E IL MONITORAGGIODELLA RETE DI ASSISTENZA. OBIETTIVI E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO E DEL COORDINAMENTO MALATTIE RARE Il Coordinamento e il Registro delle Malattie Raredella Regione Veneto hanno come obiettivo quellodi definire e rendere operative delle politiche diprogrammazione sanitaria utili alla costituzione diun sistema regionale per l’assistenza a favoredelle persone con malattie rare.Individuazione della rete dei Centri di riferimento e sistema informativo basato su una cartella clinica informatizzataLe attività intraprese sono state l’individuazionedella rete dei Centri di riferimento per la diagnosie la cura dei malati rari e l’attivazione di unsistema informativo centrato su un’unica cartellaclinica informatizzata, a cui accedono tutte lestrutture e i servizi attivi nel territorio regionale,comprendente i dati anagrafici del paziente, ladiagnosi di malattia rara, la prescrizione,distribuzione e somministrazione di farmaci,parafarmaci, galenici, prodotti dietetici, ausili,protesi, etc, cioè quanto necessario per la cura ela presa in carico della persona, i controlli clinici ela definizione delle condizioni di salute, funzioni eautonomia del malato.I protocolli assistenzialiIn conformità a quanto definito nella cartellaclinica informatizzata e a quanto predisposto daspecifici protocolli diagnostici-terapeutici epercorsi assistenziali, le persone con malattiarara accedono direttamente ai benefici specificiper la loro condizione, senza necessità di ulterioripassaggi amministrativi e aggravi burocratici. Taliprotocolli assistenziali sono specifici per gruppodi patologie e nascono dall’integrazione deicontenuti desunti dalle evidenze disponibili inletteratura e dell’esperienza dei Centri diriferimento. L’obiettivo è di favorire untrasferimento rapido nella pratica clinica diquanto disponibile in letteratura e, grazieall’organizzazione che supporta il lavoro in retedei vari professionisti, la disponibilità deitrattamenti più innovativi, ma essenziali, vicini alluogo di vita della persona.Il modello veneto adottato anche in altre regioniLo stesso sistema è stato progressivamenteadottato dalle Provincie Autonome di Bolzano e di
Trento, nell’ambito dell’Accordo di Area Vasta per lemalattie rare e da altre Regioni italiane: RegioneEmilia-Romagna, Regione Liguria e piùrecentemente anche Regione Campania e RegionePuglia. Ad oggi, il sistema governa l’assistenza di50.000 persone con malattie rare, seguiti dai Centriper le malattie rare delle Regioni sopracitate.La raccolta dati e l'accesso all'informazioneGli utenti che complessivamente accedono alsistema informativo sono 3.484 professionistioperanti presso i Centri di riferimento, gli altriospedali della rete regionale, le farmacieospedaliere, i distretti socio-sanitari, i servizifarmaceutici territoriali ed i coordinamentiregionali. Nell’architettura del sistema,l’informazione è il collante che unisce i vari nodidella rete assistenziale, con il fine di promuovereuna presa in carico modellata su percorsi definitie multidisciplinari, vera sfida assistenzialequando si parla di malattie rare.Contemporaneamente, lo stesso sistemaraccoglie dati che permettono, da un lato, dimonitorare le attività dei servizi, i costi sostenuti,i percorsi assistenziali seguiti dai pazienti,evidenziando eventuali disfunzioni della rete,dall’altro, di ricostruire le storie naturali dellemalattie e un notevole patrimonio di conoscenzeutilizzabili anche per la ricerca clinica.
MALATTIE RARE IN CIFRE NELLA REGIONEVENETO Per stabilire quanti siano realmente i malatibisogna disporre di un monitoraggio esaustivo,attivo per un periodo sufficientemente lungo inun’area territoriale omogenea. I Registri regionaliistituiti in attuazione alla norma nazionalecostituiscono una preziosa opportunità, offrendouna fotografia del fenomeno malattie rare.In Veneto oltre 21 mila pazientiAl 30 giugno 2012 i pazienti iscritti nelRegistro sono 21.770. Non si riconosce unadifferenza significativa per quanto riguarda ladistribuzione per sesso dei pazienti certificati.Il 32 per cento dei pazienti è in età pediatricaPer quanto riguarda la distribuzione per età, ipazienti in cui viene posta diagnosi di unamalattia rara in età pediatrica rappresentano il 32% del totale dei pazienti registrati.Le malattie più frequenti sono le malformazionicongeniteConsiderando i pazienti di tutte le classi di età, igruppi di patologie a più elevata numerosità sonole malformazioni congenite (18%), seguite damalattie dell’apparato visivo (17%) e da malattiedel sangue e degli organi ematopoietici (12.5%).Le patologie rare che mostrano maggioreincidenzaUn altro gruppo relativamente numeroso è quellocostituito dai pazienti affetti da malattie rareneurologiche, considerando sia le malattie del

7
sistema nervoso periferico che centrale (12,5%).Tra le malattie più frequentemente diagnosticatevi sono le anomalie cromosomiche, leneurofibromatosi, le distrofie retiniche ereditarie,l’emocromatosi, i difetti ereditari dellacoagulazione, le anemie ereditarie, i disturbi delmetabolismo e del trasporto degli aminoacidi,la sclerosi laterale amiotrofica, la corea diHuntington e via via altre malattie più rare.In età pediatrica, al primo posto le malformazioni congenite, poi le malattie delsangue e le patologie metaboliche ereditarieSe si considera in particolare l’età pediatrica e ladistribuzione dei pazienti per gruppi dipatologie,le malformazioni congenite diventanodi gran lunga il gruppo più numeroso (43%),seguite dalle malattie ematologiche (15%) e dalle malattie metaboliche ereditarie (8%).In aumento la sopravvivenza in età adultaDa sottolineare è l’aumentata sopravvivenzanell’età adulta di pazienti con malformazionicongenite e malattie metaboliche ereditarie, iquali costituiscono attualmente una parte nontrascurabile dei pazienti adulti. Tale dato deveguidare lo sviluppo di percorsi che mirino adevitare la frattura assistenziale che i pazientipossono sperimentare nel delicato passaggio traetà pediatrica ed adulta.Il paziente al centro della reteQuesto rappresenta solo un esempio di come i datiraccolti dal Registro non solo permettono dirispondere alla domanda “quanti e quali sono ipazienti con malattia rara”, ma consentono diindividuare sottogruppi con bisogni specifici,attorno ai quali organizzare le reti di presa in carico.Il Registro così strutturato rappresenta non solouno strumento di monitoraggio utile per laprogrammazione sanitaria, ma la base di unsistema in cui il paziente è al centro e l’informazioneraccolta va ad alimentare l’offerta di servizi.Tale sistema è inoltre lo strumento che permette diconnettere strettamente sia la rete verticale basatasul meccanismo dell'accreditamento, e quindi sullaselezione di eccellenze clinico-assistenziali, sia larete orizzontale dei servizi, centrata sul luogo di vitadella persona, collegante tutte le professionalità e leistituzioni che concorrono a realizzare un percorsomultidimensionale complesso di presa in caricoglobale del malato e della sua famiglia.
L’INFORMAZIONE Disporre di informazioni facilmente accessibilisulla malattia e sull’organizzazione delle reti diassistenza rappresenta un prerequisito essenzialeper realizzare una presa in carico adeguata dellepersone con malattia rara.Favorire una diagnosi tempestivaIl nodo dell’informazione è cruciale, soprattuttoquando si parla di malattie rare. Molto spesso ipazienti affetti da malattie rare e i loro familiari
incontrano notevoli difficoltà nell'ottenereinformazioni su queste condizioni e spessofaticano a trovare i percorsi esistenti loro dedicatiall'interno della rete dei servizi sanitari. Ciòcomporta un peso ulteriore sui malati e le lorofamiglie, spesso già assai gravate, oltre che unamaggior probabilità di ritardo nella formulazionedi diagnosi corrette e, quindi, nell’accesso aitrattamenti disponibili. Inoltre, tali aspetticontribuiscono spesso ad accentuare nei malatila sensazione di isolamento.Una linea telefonica per malati e familiari (tel. 049-8215700) e l'indirizzo [email protected] far fronte a tali problemi il Registro Malattie Raredella Regione Veneto ha attivato, a partire dal 2002,un centro di informazione e documentazione per ipazienti e gli operatori dei servizi socio-sanitari(help-line malattie rare). Il servizio è realizzatoattraverso una linea telefonica dedicata attivatutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00alle ore 17.00 con turni di risposta programmati(tel. 049-8215700). Il servizio ha lo scopo rifornireconsulenza in tempo reale, sia a pazienti e lorofamiliari sia ai professionisti dei Centri di riferimentoche della rete territoriale dei servizi. Tale servizio èpensato per rispondere a quesiti riguardantil’organizzazione della rete di assistenza per i pazienticon malattie rare, i diritti previsti dalla normativa, sianella fase di accertamento diagnostico sia dopo ladiagnosi di malattia. Svolge inoltre, in risposta arichieste pervenute, ricerche specifiche riguardantiparticolari aspetti inerenti le malattie rare, adesempio possibilità terapeutiche innovative, storianaturale della malattia, etc. Gli utenti del serviziosono pazienti o loro familiari, associazioni di utenza,medici dei Centri di riferimento costituenti la reteregionale, professionisti dei Distretti socio-sanitari,medici di medicina generale e pediatri di liberascelta. Il servizio dispone inoltre di un indirizzo diposta elettronica dedicato:[email protected].
LA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONICHE SI OCCUPANO DI MALATTIE RAREIl ruolo delle associazioni d’utenza acquisiscesempre più visibilità istituzionale ed una progressivavalorizzazione nella programmazione e nellavalutazione dei servizi. l’attività delle associazioni di utenza risulta fondamentale per il lavoro dimediazione tra i servizi pubblici ed i cittadini, perl’ampliamento della rete delle risorse del territoriooltreché per la capacità di far emergere unadomanda aderente ai bisogni dei cittadini.Fondamentale il processo di empowermentdi pazienti e familiariIn particolare, i pazienti con malattia rara e leassociazioni che li rappresentano, possonosicuramente essere definiti pionieri del processodi empowerment, dal momento che sono

8
attivamente coinvolti a livello europeo, nazionalee regionale nell’esprimere il loro punto di vistarispetto alle politiche sanitarie da intraprendere. Illoro ruolo di supporto a pazienti e familiari èfondamentale, soprattutto in questo ambito, datoche il senso di isolamento conseguente alricevere una diagnosi di patologia rara o all’esseresenza una diagnosi è assolutamente amplificato.Il coordinamento malattie rare: oltre 126 associazioniTra i compiti istituzionali del Coordinamentomalattie rare vi è quello di raccogliere informazionisulle associazioni attive nel campo delle malattierare. Si sono censite 126 associazioni, aventisede legale o operativa in Regione Veneto, chesi occupano specificamente di malattie rare.Ancor più numerose sono le Associazioni che sioccupano di malattie rare contestualmente adaltre problematiche, ad esempio disabilità, cecità,etc. Per ognuna delle Associazioni sono stateraccolte informazioni circa: organizzazione interna,natura dell’Associazione, gli iscritti, attivitàpromosse, riferimenti. I contatti con leAssociazioni sono continui, al fine di raccogliereindicazioni e pareri preliminarmente a ogniintervento che si va a realizzare.UNIAMO comprende oltre 100 associazioni per 600 patologie rappresentateDa segnalare è il fatto che UNIAMO, laFederazione Italiana di associazioni che sioccupano di malattie rare, ha la sua sedeoperativa a Venezia. UNIAMO, nata nel 1999,conta ad oggi più di 100 associazioni federatedi malati rari e loro familiari, per oltre 600patologie rare rappresentate. UNIAMO,promuove e coordina in Italia, in sintonia conEURORDIS, la Federazione europea, le iniziativecollegate alla giornata mondiale delle malattie rare,che si celebra ogni anno l’ultimo giorno di febbraio (per maggiori informazioni: www.uniamo.org;www.rarediseaseday.org).
LE PROSPETTIVE: MIGLIORAMENTODELL'ASSISTENZA E AUMENTODELL'INNOVAZIONELo sviluppo futuro della rete di assistenza per lepersone con malattia rara in Regione Venetointende seguire principalmente due obiettivi.Miglioramento dell'assistenzaIl primo obiettivo è quello del miglioramento dellepossibilità di assistenza per questi malati, siapotenziando le attività dei servizi già orapienamente coinvolti nella rete per le malattierare, sia allargando la rete stessa a nuovi soggettie a nuove parti del Sistema Sanitario regionale,venendolo progressivamente a coinvolgere intutta la sua interezza.Aumento dell'innovazioneIl secondo obiettivo è quello di aumentarefortemente il tasso di innovazione della rete di
assistenza stessa, caratterizzandola proprio nelcostituire un modello di sperimentazione diinterventi, organizzazioni, attività eprogrammazioni estendibili poi ad altri contesti di cura e ad altre organizzazioni di servizi.Coinvolgimento della società a tanti e diversi livelliConsiderati l’enorme numero e la variabilità delletipologie di patologie definibili come rare e laestrema diversità di problemi assistenziali,decorsi e prognosi che esse comportano, si puòaffermare che l’assistenza a questi malatidetermina il coinvolgimento di pressoché tutti iservizi socio-sanitari, oltre che l’interazione con lealtre dimensioni della società come quella dellascuola, del lavoro, dell’attività sportiva e deltempo libero, ecc.È quindi strategico che alla rete per le malattierare, così come è stata fino ad ora disegnata,siano progressivamente aggiunti altri partner,definiti da servizi e ambiti del sistema sanitarioregionale per il momento non facenti parte delsistema malattie rare.Priorità attuali: la collaborazione con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta Questo progressivo allargamento del sistema devetener conto di alcune priorità evidenziate dallestesse Associazioni d’utenza, e quindi dai pazientiche esse rappresentano. Tra queste appareprioritario il miglioramento del sistema diriferimento dei malati e di loro successiva presa incarico, anche attraverso un pieno coinvolgimentodei medici di medicina generale e dei pediatri dilibera scelta. Infatti, sia i medici di medicinagenerale che i pediatri di libera scelta hanno unruolo strategico nel sistema di cure ai malati rari.Da un lato, infatti costituiscono una parteimportante del sistema di riferimento, il qualedeve essere sufficientemente sensibile nelsospettare la presenza di una malattia rara esaper precocemente inviare il paziente allospecifico Centro di riferimento competente.Dall’altro, sono attivamente coinvolti nel processodi presa in carico, che deve accompagnare lapersona in tutte le diverse fasi della malattia. È dasottolineare perciò che lo sviluppo di reti di cureprimarie capaci di rispondere ai bisognicomplessi di questi malati rappresenterebbeun’opportunità di crescita professionale e dimiglioramento dello standard di cure offerte amoltissimi potenziali fruitori, malati rari e non.
Per informazioniCoordinamento Malattie Rare Regione del VenetoRegistro Malattie Rare – Regione del VenetoResponsabile: Prof.ssa Paola FacchinTel. +39 049 8215700 / Fax. +39 049 8215701Sito web: malattierare.regione.veneto.it/e-mail: [email protected]

9
Cosa sono e quali sono le malattie rare?Le malattie rare sono condizioni estremamenteeterogenee tra loro, accomunate da una bassadiffusione nella popolazione e da aspetti dicomplessità assistenziale. Una malattia èconsiderata rara se colpisce meno di 5 personesu 10.000. Alcune sono relativamente “piùfrequenti”, ad esempio la sclerosi lateraleamiotrofica, l’emofilia, le distrofie muscolari, altresono rarissime, come molte sindromi genetiche omalformazioni complesse.Le politiche a favore delle persone con malattiarara hanno preso avvio in Italia con l’emanazionedel Decreto Ministeriale n. 279/2001, il quale hadefinito un elenco di malattie rare e quindi dimalati portatori di particolari diritti. Per un elencodettagliato delle malattie incluse nel Decreto èpossibile consultare la paginahttp://malattierare.regione.veneto.it/ alla voce“Cerca”.
Quanti malati rari mediamente segue unmedico di medicina generale nel Veneto?In Veneto i malati rari sono circa 20.000. Le malattiarare non sono solo pediatriche, per due terzicolpiscono adulti ed anziani. In media un medico dimedicina generale ha tra i suoi pazienti almeno 8persone con una diagnosi di malattia rara.
Quando si deve sospettare una malattia rara?È sicuramente difficile riconoscere patologieinfrequenti. Poche sono le malattie rare che sipresentano con segni clinici caratteristici. Più spessoi segni ed i sintomi di presentazione sonorelativamente comuni, ma quello che è suggestivo èla loro associazione. In altri casi quello che èpeculiare è l’andamento temporale di segni esintomi o una mancata risposta alla terapia. Nel sitohttp://malattierare.regione.veneto.it/cerca è
presente una funzione di ricerca per segni e sintomi,che può aiutare il medico nella fase di formulazionedel sospetto diagnostico di malattia rara.
Nel caso di sospetto di una malattia rara,cosa fare?Il paziente va indirizzato alla rete dei Centri diriferimento per le malattie rare, ufficialmenteidentificati a livello regionale/interregionale, aiquali spetta la presa in carico dei malati, ladefinizione dei protocolli diagnostico-terapeuticie dei percorsi assistenziali. È importante sapereche le prestazioni finalizzate alla diagnosi dimalattia rara possono essere eseguite inesenzione nei Centri di riferimento, se prescritteda un medico specialista del Servizio SanitarioNazionale. L’elenco dei Centri di riferimento èconsultabile alla paginahttp://malattierare.regione.veneto.it/pagine_statiche/index.htm, dove è anche disponibile unafunzione di ricerca per singola patologia.
A quale assistenza hanno diritto i malati rari? L’esenzione riguarda tutte le prestazioni efficacied appropriate per il trattamento ed ilmonitoraggio della malattia rara accertata e perla prevenzione degli ulteriori aggravamenti,incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e previste dai protocolli, ove esistenti, definiti daiCentri di riferimento.
Cosa bisogna fare per ottenere i benefici?In caso di diagnosi di malattia rara, il Centro diriferimento competente rilascia una certificazioneal paziente attraverso un sistema informatizzato.In tempo reale, il Distretto socio-sanitario di residenza visualizza e consegna al pazientel’attestato di esenzione, base per ottenere i benefici previsti per legge.
TIPOLOGIA MALATTIE PERCENTUALE INCIDENZA
MALFORMAZIONI CONGENITE 18,3MALATTIE DELL'APPARATO VISIVO 17,1MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO 12,5MALATTIE EMATOLOGICHE 12,5MALATTIE DEL METABOLISMO 9,3MALATTIE DELL'APPARATO OSTEOMUSCOLARE 7,0MALATTIE DELLE GHIANDOLE ENDOCRINE 5,1TUMORI 4,6MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO 4,2MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE 3,3MALATTIE DERMATOLOGICHE 3,2MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO 3,1MALATTIE DELL'APPARATO GENITO-URINARIO 0,5MALATTIE INFETTIVE 0,1ALTRE 0,1
Distribuzione dei
pazienti certificati
per gruppo
nosologico di
malattie rare ex DM
79/2001 (N=21.770)
VADEMECUM DELLE MALATTIE RARE

focus ulss 12
Tumore alla vescica,la diagnosi precoce salva la vita.Intervista a Carlo Pianon,primario di Urologia all’Ospedale dell’Angelo
Urologia
Nella zona di Porto Marghera si registra un eccesso di mortalità per tumori alla vescica. Lo testimonia lo studio nazionale SENTIERIche ha analizzato i tassi di mortalità nei siti più inquinati d'Italia (una sintesi della ricerca è stata pubblicata nel 2010 sulla rivista“Epidemiologia e prevenzione”; vedi numero 0 del 2012 di VIS).Il tumore alla vescica è correlato a cattivi stili di vita come il fumo e all'esposizione a vari tipi di sostanze tossiche e cancerogenemaggiormente presenti nei luoghi in cui sono state e sono ancoraattivi importanti siti industriali.“Il dato che va sottolineato però – spiega Carlo Pianon, primario di Urologia all'ospedale dell'Angelo di Mestre – è che la diagnosiprecoce, per questo tipo di patologia, è molto efficace e permettenon soltanto che la malattia sia curabile, ma soprattutto guaribile in un numero sempre maggiore di casi”.
10
a cura di Nicoletta Benatelli

Dottor Pianon, il tumore della vescica presentadunque una incidenza maggiore nel veneziano?Quale importanza ha la diagnosi precoce?Posso confermare che il tumore della vescica è inaumento. I casi che riscontriamo vanno crescendo,ma va detto subito che la possibilità di guarigioneè molto alta. L'elemento che fa la differenza è ladiagnosi precoce: prima si scopre la malattia,prima si interviene, e più aumentano le possibilitàconcrete di una guarigione totale. Intervenire al piùpresto permette comunque che la malattia se nonguaribile sia almeno ben curabile.Quando parlo di patologia guaribile, intendo direche la malattia è stata eliminata perché le cellulemaligne erano circoscritte e sono statecompletamente asportate. Quando parlo dipatologia curabile, intendo dire che comunque lasopravvivenza è lunga e permette una buonaqualità di vita.
Quali sono i segnali di allarme che possono farsospettare un tumore alla vescica e che devonoportare ad avviare approfondimenti ulteriori?Il campanello di allarme è sempre la presenza disangue nelle urine. Attenzione però. Va precisatoche spesso questo sintomo non è di fatto correlatoalla presenza di un tumore del rene o della vescica.Spesso si tratta di infezioni più o meno banali, mache vanno sempre curate con attenzione.Soprattutto se il sintomo è ricorrente, cioè siverifica più di una volta, è doveroso escludere chepossa essere correlato ad un tumore dell'apparatourinario ed in particolare della vescica.È importante diffondere l'idea che una visitaurologica o qualche esame non invasivo possanopermettere di fare una diagnosi precoce e quindidi salvare la vita. Le persone che presentanosintomi come il sangue delle urine, non devonopreoccuparsi, ma devono parlarne subito con ilproprio medico di medicina generale edeventualmente anche con l'urologo. I dannimaggiori sono l'esito di una sottovalutazione delsintomo che invece è un elemento che deveindurci a fare tutte le verifiche necessarie perescludere la presenza di un tumore e, se nel caso,intervenire nel modo più rapido ed efficace.
Chi colpisce in prevalenza il tumore alla vescica?Ci sono categorie che possiamo considerare a rischio? Quanti casi trattate ogni anno? Il tumore alla vescica è correlato anche al fumoperciò tutti i fumatori possono essere consideraticategoria a rischio anche per questa patologia.Nel veneziano vediamo poi una incidenzamaggiore soprattutto tra i lavoratori e gli exlavoratori dell'area industriale di Porto Margheraesposti per tempo prolungato a vari tipi disostanze tossiche e cancerogene come leammine aromatiche, ecc.Va detto che queste sostanze sono state anchediffuse nell'ambiente e quindi questo tumore noncolpisce esclusivamente lavoratori ed exlavoratori, ma anche sempre più spesso le donne.Il tumore alla vescica colpisce in genere personeultrasessantenni, ma è presente anche nellapopolazione più giovane di età compresa tra i 35e i 40 anni.In media trattiamo un centinaio di casi l'anno, conuna prevalenza di incidenza tra gli uomini rispettole donne. Su 100 casi, possiamo dire che 60 sonouomini e 40 donne.
La presenza di sangue nelle urine è un sintomoche non va mai trascurato: perché? Con qualiulteriori accertamenti?Il tumore alla vescica si manifesta in genere consangue nelle urine, all'inizio, non persistente, maa spot, presente cioè in modo saltuario. Questosintomo potrebbe già far escludere una infezioneche in genere si manifesta con febbre, bruciore epesantezza nella zona pelvica, con un quadro disintomi coerenti e molteplici.Gocce di sangue intermittenti nelle urine, opeggio un’ematuria franca, devono insospettire.La persona deve rivolgersi subito al medico dimedicina generale o all'urologo. Gli esami da farenell'immediato sono una ecografia dell'apparatourinario che comprenda anche i reni e l'esamecitologico delle urine per verificare se vi sia lapresenza di cellule neoplastiche.Si può poi proseguire con una urotac con contrastoper vedere più dettagliatamente l'apparato urinarionel suo complesso o con una cistoscopia, cioè conl'introduzione di una sonda flessibile dotata di una
11

piccolissima telecamera, che in pochi minutipermette di fare una valutazione della mucosainterna della vescica e, se necessario, di eseguire un prelievo delle aree sospette.È chiaro che si procede per step successivitenendo conto dei sintomi presentati dal pazientee dell'esito dei vari esami.
Spesso le persone hanno paura e preferiscononon fare accertamenti oppure sottovalutano i sintomi...Ripeto: la presenza di sangue nelle urine nellamaggioranza dei casi non è associata ad untumore alla vescica o al rene. Non bisognaspaventarsi. È davvero sbagliato però anchesottovalutare il sintomo che, qualora sia presenteun piccolo tumore, ci permette di intervenireportando il paziente a piena guarigione.Vorrei rivolgere un appello soprattutto alle donne.Di recente abbiamo visto più casi in cui donneche lamentavano ematuria sono state curate perbanali cistiti. Voglio chiarire che l'urologia non vaconfusa con l'andrologia e quindi non riguardasolo i pazienti maschi. Il tumore alla vescica puòcolpire uomini e donne indistintamente.Anche le donne fertili, che hanno ancora lemestruazioni, non possono ritenere normale lapresenza di gocce di sangue nelle urine nei giorniin assenza del ciclo. Occorre che le donneacquisiscano una mentalità diversa ancherispetto a questo sintomo e che includano ancheil tumore alla vescica negli accertamentifinalizzati alla diagnosi precoce, come del restogià avviene per il tumore del seno e dell'utero.Stiamo già da tempo lavorando anche con la LILT(la Lega italiana per la lotta ai tumori) persensibilizzare alla diagnosi precoce dei tumoridell'apparato urinario.
Nel caso si arrivi ad una diagnosi di cancro alla vescica, come si interviene?Dipende dal grado di aggressività cellulare odall'invasività della neoformazione. Ci sonotumori che sono molto superficiali e nonpresentano infiltrazioni; altri che meritano unaattenzione maggiore.I tumori meno pericolosi e meno invasivi vengonoasportati tramite intervento endoscopico. Aseguito della valutazione istologica, si procederàpoi con altre terapie mirate: trattamentilocalizzati come lavaggi con farmacichemioterapici o iniezione del bacillo di CuelmetGuerin (BCG) che provoca una rispostaimmunologica in grado di eliminare le cellulericonosciute come tumorali che possono essereancora presenti in vescica.Una volta eseguiti intervento endoscopico eterapie, viene fatta anche una biopsia di controllodelle mucose della vescica per accertare che tuttele cellule tumorali siano state eliminate. Qui
all'Angelo utilizziamo anche un colorante selettivoche rende visibili, eseguendo una endoscopia conluce a fluorescenza, le zone con cellule ancorapotenzialmente pericolose. Ciò permette dieseguire biopsie di controllo molto mirate.
Quando diventa necessario procedereall'asportazione della vescica?Nei casi in cui il tumore sia particolarmenteaggressivo e o invasivo, è preferibile procedereall'asportazione completa della vescica.L'intervento chirurgico, che dura qualche ora, sichiama cistectomia radicale e prevedel'asportazione, oltre che della vescica, anche dilinfonodi limitrofi e prostata nell'uomo e dilinfonodi limitrofi ed utero nella donna.È proprio per evitare questo intervento radicaleche vogliamo puntare sempre più alla diagnosiprecoce che prevede invece interventi etrattamenti mirati e molto meno invasivi.
Ma come si vive senza vescica?Dobbiamo sottolineare che di solito i pazienti,dopo un breve periodo di adattamento, siadattano alla nuova situazione e possonoriprendere la loro vita normale.La vescica viene ricostruita utilizzando un trattodell'intestino e ricavando da questo l'ampollanecessaria per contenere le urine. Gli ureterivengono collegati dal rene alla nuova vescica perpermettere il fluire del liquido fino all'escrezioneche riprende normalmente, dopo una fase dirieducazione. Il paziente infatti non avverte ilnormale stimolo ad urinare e deve quindiabituarsi ad urinare ad ore fisse per impedire uneccessivo riempimento della nuova vescica.In altri casi di provvede a creare un serbatoiocomunicante con un sacchettino esterno checontiene l'urina.I pazienti comunque si adattano abbastanzabene a queste soluzioni.È evidente che è meglio, se possibile, evitare gliinterventi più radicali e per questo è difondamentale importanza la diagnosi precoce.Invitiamo anche i medici di medicina generale acollaborare con noi ed a inviarci i pazienti chepresentano sintomi sospetti.
L'UNITÀ OPERATIVA DI UROLOGIADELL'OSPEDALE DELL'ANGELOL'Unità Operativa di Urologia dell'ospedaledell'Angelo di Mestre esegue 250 interventichirurgici all'anno per neoplasie vescicali.Di questi una ventina sono cistectomie radicali(asportazione totale di vescica).L'equipe è composta da sette medici e 14 infermieri.
Per informazionisito internet: www.ulss12.ve.it
12

13
focus ulss 12
Lido, Cavallino-Treporti, Pellestrina,Murano, Burano.I servizi socio sanitari sul territorioofferti dal Distretto n. 2
Distretto socio sanitario n. 2
Il Distretto socio sanitario n. 2 dell'Azienda Ulss n. 12comprende il territorio del Lido di Venezia, Cavallino-Treporti (Ca’ Savio), Murano, Burano e Pellestrina.Si tratta perlopiù di isole situate nel cuore della laguna di Venezia e per questo bisognose di servizi sociosanitari decentrati in grado di raccogliere le prioritarierichieste di salute degli abitanti.
NEL 2011 IN TOTALE 149 MILA PRESTAZIONIOFFERTE DAL DISTRETTO N. 2Come è possibile verificare dalla tabella n. 1 –Prestazioni ambulatoriali del Distretto n. 2, dal2007 al 2011 le prestazioni totali svolte su tutto ilterritorio vanno dalle 126mila (anno 2007) alle149mila (anno 2011).In testa per numero di prestazioni offerte è l'areadella riabilitazione che va dalle 35milaprestazioni (anno 2007) alle 49mila prestazioni(anno 2011).Segue l'area diagnostica (esami radiologici;prelievi ed esami di laboratorio) che va dalle41mila prestazioni (anno 2007) alle 46milaprestazioni (anno 2011).Al terzo posto troviamo l'area delle visitespecialistiche che va dalle 28mila prestazioni(anno 2007) alle 31mila prestazioni (anno 2011).
PER LE CURE PRIMARIE, AL PRIMO POSTO LA RIABILITAZIONE ED AL SECONDO LA CARDIOLOGIAIn testa per numero di prestazioni fornite neglianni 2010-2011, come si può evincere dallatabella n. 2 – Prestazioni Cure Primarie, èl'area delle isole di Lido e Pellestrina, che sonoanche le più densamente abitate. Per quantoriguarda la tipologia di prestazioni più richieste,troviamo al primo posto la riabilitazione, seguitadalle visite cardiologiche ed al terzo posto dallevisite nefrologiche.
PER I CONSULTORI, AL PRIMO POSTO LE PRESTAZIONI MATERNO INFANTILINell'area dei Consultori Familiari e Pediatrici, deiServizi per l'età evolutiva e della Salute Mentale, ilmaggior numero di prestazioni riguarda le

prestazioni materno infantili, come si puòevincere dalla tabella n. 3 – Consultori, servizietà evolutiva, salute mentale.
LA PISCINA CON ACQUA DI MARE,140 UTENTI AL GIORNORicordiamo che al Lido è attiva la piscina conacqua di mare che ospita progetti di riabilitazionee varie attività in acqua anche con donne gravidee bambini.L'utenza della piscina è ormai di circa 140presenze giornaliere.
UN RAPPORTO DI DIALOGO TRA SERVIZIDELL'AZIENDA ULSS N. 12 E LA POPOLAZIONEINSULAREAlla particolare geomorfologia del territorioinsulare della laguna di Venezia, si associa lanecessità di tenere vivo, per i servizi distrettualidell'Azienda Ulss n. 12, un rapporto partecipativocon la cittadinanza che miri ad un coinvolgimentodiretto della popolazione nelle scelte e nellagestione dell'offerta di prestazioni.Questo è il tentativo che da qualche anno si stafacendo.L'impegno è anche quello di cercare dirispondere, per quanto possibile, alle richiesteespresse dalla cittadinanza ed ai bisogniemergenti per chi abita in località di fattodisagiate dal punto di vista logistico.
ALCUNE IMPORTANTI ATTIVITÀEcco qui di seguito alcune novità che sono stateintrodotte per andare maggiormente incontro aibisogni dei cittadini:-è stata finalmente aperto il nuovo accesso alDistretto da piazzale Ravà (con conseguentechiusura di quello da lungomare D’Annunzio,ormai inadeguato)-da fine settembre 2012 ha riaperto l'ambulatorio
chirurgico al Lido-a ottobre 2012 ha aperto al Lido l'ambulatorio dichirurgia plastica e piccoli interventi ricostruttivi- a ottobre 2012 ha aperto al Lido l'ambulatoriodi ortodonzia (dentista per bambini) -è stato acquisito in giugno 2012 un nuovocardiologo che completa così l'organico dellaCardiologia al Lido (e consente di garantire lafondamentale riabilitazione cardiologica, attuataanche con sedute in piscina in accordo conl'associazione Amici del Cuore)-da aprile 2012 è entrata in servizio una nuovafisiatra per le visite domiciliari-a settembre 2012 è ripartita l'attività dellapsicomotricista-in programma alla piscina del Lido il nuovocorso di mamme in acqua ed il nuovo corso in acqua per bambini asmatici-in accordo con l'associazione AVAPO è partitoin ottobre 2012 il nuovo corso per volontarianche a Pellestrina-è stato attivato a giugno 2012 (e permane atempo indeterminato) il nuovo servizio diassistenza telefonica 24 ore su 24dell'associazione AVAPO per pazienti malatiterminali (rivolto ai medici curanti, alla guardiamedica ed al punto di Primo Intervento) delterritorio del Distretto n. 2 -a novembre 2012, in collaborazione con AVAPOVenezia, è stato finalmente introdotto ancheper Burano e Pellestrina l’ODO (OspedaleDomiciliare Oncologico) per malati terminali-è stato aperto a settembre 2012 l'ambulatoriodedicato alle visite fisiatriche (e conseguentetempestiva presa in carico fisiochinesiterapica)per post operati-l'arrivo nel 2012 di un medico anestesista haconsentito di intensificare la sostituzione adomicilio (e nelle Case di Riposo) di PEG ecannule tracheostomiche.
14
Tabella n. 1 Prestazioni ambulatoriali del Distretto n. 2,

15
Tabella n. 2Prestazioni Cure Primarie
Tabella n. 3Consultori, servizi età evolutiva, salute mentale

16
focus ulss 12
Etica pubblica e amministrazione,favorire la “partecipazione”
Il caso dell’ex Ospedale al mare al Lido di Venezia
a cura di Danilo Corrà,direttore del Distretto 2

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINOSi è passati in poco più di un ventennio da unsistema di organizzazione della PubblicaAmministrazione fortemente centralistico ad unofondato sul decentramento e sulla promozione delleautonomie locali. Alla tradizionale impersonalità (equindi, fondamentalmente, deresponsabilizzazione)della pubblica amministrazione si è andataprogressivamente sostituendo la trasparenza degliatti e la precisa individuazione di responsabilità. Alpotere invadente ed invasivo della politica, anche esoprattutto negli atti, si è contrapposta lavalorizzazione e responsabilizzazione dell’apparatoburocratico e dirigenziale; alla cultura dellalegittimità si è via via affiancata quella dell’efficaciae dell’efficienza, e così via sino a giungere allerecenti riforme dell’ultimo governo Berlusconipromosse dal ministro Brunetta in materia diinformatizzazione della pubblica amministrazione,di misurazione e valutazione della performancedell’apparato pubblico. Con la riforma Monti, infine,il cerchio si chiude con una visione decisamentediversa rispetto al passato della funzione e del ruolodel dipendente pubblico.
I DIRITTI SOGGETTIVI DEI CITTADINITale imponente mole di riforme ha determinatouna diversa relazione tra pubblicaamministrazione e cittadino: si è infattiprogressivamente passati da un rapportoassolutamente squilibrato in favore del pubblico(retaggio di uno stato borbonico) ad unaconsiderazione del cittadino come utente e, intempi più recenti, al cittadino-cliente, come taletitolare non solo di mere aspettative nei confrontidella pubblica amministrazione ma di forme più omeno intense di “quasi diritti” (vedi la teoriadell’interesse legittimo) sino ad arrivare, ai giorninostri, al riconoscimento in capo al cittadino diveri e propri diritti soggettivi nei confronti dellapubblica amministrazione, la quale sempre piùopera non solo con la potestà propria dell’ente
pubblico, ma anche con attività non autoritativa.
LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICAIn tale nuova ottica di rapporto assumeimportanza cruciale il tema della partecipazionedel cittadino alla cosa pubblica, intesa come libertàdi accesso agli atti (trasparenza della pubblicaamministrazione), ma anche come possibilità dicensurare comportamenti scorretti o impropri(vedi istituzione, presso le diverse amministrazionicentrali e locali, del difensore civico, organoimparziale e ad accesso gratuito di sindacatosull’attività della pubblica amministrazione), dichiedere chiarimenti ed informazioni su prassi nonsempre di immediata intelligibilità (anche grazieagli URP –Uffici Relazioni con il Pubblico – istituitipressoché in tutte le pubbliche amministrazioni) edi partecipare al formarsi ed al manifestarsi dellavolontà della pubblica amministrazione (vedi leggen. 241/1990 sulla partecipazione al procedimentoamministrativo).
IL RAPPORTO CON ASSOCIAZIONI E COMITATIÈ di tutta evidenza come il tema dellapartecipazione incida in modo significativo sullaresponsabilità sociale della pubblicaamministrazione in particolar modo quandoquesta operi in ambiti di forte impatto sociale(sanità, ambiente): una corretta e preventivainformazione ed un coinvolgimento mirato eresponsabile dei cittadini (anche e soprattuttoorganizzati in gruppi, associazioni, comitati)possono infatti risultare determinanti per ilsuccesso di operazioni complesse ad elevatoimpatto su ampi strati della popolazione.
L'ESEMPIO DELLA TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX OSPEDALE AL MARE DEL LIDO DI VENEZIAVogliamo prendere in esame come esempioparadigmatico la complessa operazione ditrasformazione e riqualificazione dell’ex Ospedale al
17

Mare del Lido di Venezia. L’Ospedale al Mare,gestito dall’allora Ulss n. 16 (poi confluita,unitamente all’Ulss n. 11, nell’attuale unica AziendaUlss n. 12 Veneziana), ha funzionato come ospedalea vocazione riabilitativa fino ai primi anni ’90,vivendo (a metà del secolo scorso) momenti di verae propria gloria (per quantità e qualità dei servizi,per numero di addetti, per la forte attrazione anchein termini turistici, tanto da far parlare, per il Lido diVenezia, di bella époque anche in termini sanitari).Successivamente diversi fattori, tra i quali,segnatamente, il progresso della scienza medica edil conseguente abbandono di alcune terapie e nuovistudi epidemiologici che hanno definitivamenteindotto a ritenere non congruo un complessoospedaliero per una popolazione di circa 17.000residenti in isola, hanno progressivamentedeterminato la chiusura dell’Ospedale al Mare e lasua trasformazione in presidio sanitario distrettuale.
IL RIDIMENSIONAMENTO DELLA STRUTTURADi fatto un estesissimo complesso residenzialesanitario si è trovato solo in minima parteoccupato da strutture distrettuali (Poliambulatori,Consultorio Familiare, Piscina riabilitativa, Ufficiamministrativi) e da alcune, residuali, struttureextradistrettuali (punto di Primo Intervento,Centro di Salute Mentale, Emodialisi), mentremolti edifici sono rimasti inutilizzati (tra i quali ilben noto ex Teatro Marinoni).
DOPO LA CHIUSURA, L'ATTIVITÀ DI COMITATIE GRUPPI DI CITTADINIIn occasione della chiusura dell’Ospedale al Marei cittadini lidensi si sono riuniti in diversi comitatia salvaguardia del mantenimento del presidioospedaliero prima, e poi della concentrazione deiservizi distrettuali nel cosiddetto Monoblocco,edificio a vocazione ospedaliera costruito neglianni ’70, sul quale l’Azienda Ulss n. 12 aveva nelfrattempo investito ingenti risorse. Altri comitatisono poi sorti per la salvaguardia ed il ripristinodel Teatro Marinoni, altri ancora per la tuteladell’ambiente (forte era infatti il sospetto, poirivelatosi fondato, che l’area sulla quale insisteval’ex Ospedale al Mare fosse contaminata daresidui da amianto e quindi da bonificare).
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL'ULSS 12A ben vedere, quindi, un terreno di provanotevolissimo per testare la reale capacità dideclinare correttamente ed efficacemente laresponsabilità sociale dell’Azienda Ulss n. 12 (edella pubblica amministrazione in senso piùampio, riguardando la fattispecie anche altrisoggetti pubblici, come si vedrà): sanità,ambiente, cultura sono infatti gli ambitiinteressati dalla vicenda in esame.
LA QUESTIONE POLITICO AMMINISTRATIVALa vicenda politico-amministrativa è nota: con
apposito accordo di programma tra Stato, RegioneVeneto, Azienda Ulss n. 12 e Comune di Venezia siè stabilita l’alienazione del complesso immobiliareal Comune di Venezia, il cambio di destinazioned’uso, la vendita a privati e il reimpiego del ricavatoin parte per la riqualificazione dei servizi sanitaridel Lido di Venezia ed in parte per la costruzionedel nuovo palazzo del cinema.
IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI NEL MONOBLOCCO Nell’ambito di tale complessa (e tutt’altro checonclusa) vicenda interessa evidenziare comel’Azienda Ulss n. 12 abbia gestito la delicata fase del trasferimento e concentrazione dei servizidistrettuali ed extradistrettuali nel cosiddettoMonoblocco. L’iter è stato caratterizzato dalle azioni: • rappresentazione del percorso di riordino e razionalizzazione nelle sedi istituzionaliappropriate e più prossime (Municipalità, Comune)• adeguato e sistematico rapporto con i mediaper una comunicazione veritiera ed efficace• rimotivazione del personale (anche infunzione della comunicazione mediata chequesto poteva garantire sul territorio)• coinvolgimento delle organizzazioni sindacalinelle scelte strategiche e funzionale rapporto coni comitati attraverso una costante attività diinformazione sugli obiettivi e sugli stati diavanzamento del percorso, traendo dagli stessispunti e sollecitazioni utili ad orientare le scelteoperative per una ricaduta efficace sul territorio.
UNA BUONA COLLABORAZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEGLI ABITANTIDi fatto il trasferimento e la concentrazione deiservizi distrettuali ed extradistrettuali nelcosiddetto Monoblocco si è verificata in modoordinato, partecipato ed informato, senza alcunainterruzione di servizio. Un indicatore di efficacia èdato dall’istituzione, dopo il trasferimento, di unacassetta per critiche e suggerimenti (ancheanonimi) installata nell’ingresso della nuova sede:nell’arco dei sei mesi successivi sono pervenutepochissime segnalazioni, e perlopiù sotto forma disuggerimenti minimali e comunque migliorativi,mentre non è stata formulata alcuna critica disistema o comunque di particolare rilievo. Ilcoinvolgimento preventivo e costante dei principalistakeholders (dipendenti, organizzazioni sindacali,istituzioni, comitati) e la loro partecipazione allediverse fasi del trasferimento ha quindi contribuitoa garantire la riuscita dell’operazione.
Per informazioniDistretto socio sanitario n. 2 Azienda Ulss n. 12Padiglione Rossi – MonobloccoPiazzale Ravà 1, Lido di VeneziaTel. 041 5295402/401
18

CENTRO UNICO PRENOTAZIONI041 8897908oppure in sede:Lido dal lunedì al venerdì 9.15-12 (primo piano)Murano martedì 9.00-13.00Burano giovedì 9.30-13.30Pellestrina martedì e mercoledì 9.00-12.00Ca’ Savio lunedì mercoledì venerdì 14.30-16.45
UNITÀ OPERATIVA FAMIGLIA ED ETÀ EVOLUTIVA
041 5295206 fax 041-5295351responsabile: Dott. Francesco Perer Unità operativa Prevenzione e Riabilitazioneper l’Età Evolutiva(Dott.ssa Cristina Bosco)Unità operativa Consultori e Prima Infanzia (Dott.ssa Cristina Bosco)
UNITÀ OPERATIVA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE PER L’ETÀ EVOLUTIVA041 5295326responsabile: Dott.ssa Cristina Bosco Chi ci lavoraPsicologo psicoterapeuta per l’età evolutiva,Neuropsichiatra infantile, Fisiatra, Foniatra,Psichiatra, Assistente sociale, Logopedista,Fisiochinesiterapista Servizi offertiVisite neuropsichiatricheVisite fisiatricheVisite foniatricheValutazione e riabilitazioneLogopedicaFisioterapicaPsicomotoria Consulenze a- singolo, coppia, famiglia.- Scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado- Servizi ospedalieri, sociali, sanitari e del privatosociale.- Colloqui di consulenza psicologica e clinicaindividuali e famigliari.- Valutazione psicodiagnostica e neuropsichiatrica.- Psicoterapia individuale e famigliare.- Consulenze e interventi sociali.- Collaborazione e/o realizzazione di progetti di prevenzione.- Valutazione diagnostica e presa in cura disoggetti disabili e sostegno alle loro famiglie.- Sostegno alla integrazione scolastica di minoridisabili.Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.In cooperazione con- L’ U.O. Riabilitazione vengono attivati corsi diIdroterapia per gruppi di bambini asmatici- Il servizio Tutela Prima Infanzia si effettuano
gruppi con i genitori sullo sviluppo psicomotorio0-12 mesi e sulla prevenzione posturale- L'Autorità Giudiziaria si attuano interventi sucasi di abuso e maltrattamento- Le Direzioni Didattiche si organizzano gruppi diconsulenza psicodinamica rivolta agli insegnanti- L'UOFEE di altri distretti si attuano i follow up perle ADHD e i disturbi generalizzati dello sviluppoApertura servizioIl servizio è gratuito e attivo presso le sedidistrettuali di:Lido 041 5295349/53/50/61/60/62/52Ca’ Savio 041 5300233Burano 041 735580L’accesso avviene su prenotazione tramiteprescrizione del medico curante (pediatra dilibera scelta o medico di medicina generale).Il primo appuntamento può essere fissato tramiteil numero telefonico 041 8897908 (CUP) dalunedì a sabato (mattina) o prenotando dipersona agli sportelli CUP delle sedi distrettuali.Il servizio è operativo da lunedì a venerdì dalle08.30 alle 18.30
CONSULTORI E PRIMA INFANZIA041 5295326fax 041 5295318Responsabile: dott.ssa Cristina Bosco
TUTELA PRIMA INFANZIAChi ci lavoraPediatra, Assistente sanitaria, InfermiereprofessionaleServizi offerti - Prevenzione- Screening ambliopia nelle scuole - Supervisione sanitaria asili nido e scuole obbligo:inserimento, diete speciali, farmaci salvavita,prevenzione malattie infettive diffusive- Collaborazione progetto “Genitori più”- Educazione sanitaria e promozione della salute - Sostegno genitorialità e allattamento al seno- Promozione alimentazione sana e stili di vita sani- Monitoraggio accrescimento primi mesi di vita- Counselling di puericultura (visite domiciliari eincontri consultoriali)- Educazione sanitaria per famiglie e insegnanti- Collaborazione ai corsi di preparazione al parto- Sorveglianza epidemiologica- Sorveglianza della popolazione maternoinfantile del Distretto- Partecipazione alle reti epidemiologiche regionali- Partecipazione stesura piani di zonaApertura servizi Su appuntamento telefonico: Lido, Pellestrina 041 5295137 Ca’ Savio 041 5301556Murano, Burano 041 739853
19
ATTIVITÀ PRINCIPALI DISTRETTO N. 2 ULSS 12

CONSULTORIO FAMILIARE Chi ci lavoraPsicologa, Ginecologa, Ostetrica, Assistentesociale, Consulente legaleServizi offerti (al singolo, alla coppia ed alla famiglia, gratuiti esenza bisogno di impegnativa)- Consulenze e visite ostetrico/ginecologiche- Consulenze e visite ostetrica- Consulenze e visite prevenzione preconcezionale- Consulenze e visite per MST- Consulenze e visite in gravidanza fisiologica,puerperio e allattamento- Consulenze e prelievo per ricerca HPV- Consulenze e visite per contraccezione- Corsi di preparazione alla nascita- Percorso di rilassamento per gravide organizzatoed effettuato in piscina dalla U.O. Riabilitazione- Corsi di sostegno alla genitorialità nel 1° anno divita del bambino- Consulenza e certificazione per IVG- Prevenzione dei tumori femminili anche suprogetto Regionale- Consulenze e visite in menopausa - Consulenze e trattamento Sociale- Consulenze psicologiche - Psicoterapia- Mediazione familiare e sostegno alla genitorialità- Tribunale Ordinario e Minorenni c/o CF Giustinian- Adozioni per entrambi i Distretti n. 1 e n. 2- Consulenze e collaborazioni con Enti e strutturesociali, sanitarie, ospedaliere e del privato socialeApertura ServiziL’accesso è gratuito, non necessita diimpegnativa e avviene su appuntamentotelefonando o presentandosi di persona negliorari di apertura al pubblicoLido 041 5295327/5325Lunedì e il venerdì 9.,30-12.00Cà Savio 041 5304018,Giovedì 9.30-12,30 e 14.30 alle 17.30
CURE PRIMARIE
041 5295207 / fax 041 5295160responsabile Dott.ssa Anna Carnevale MiinoUnità Operativa Specialistica e InfermieristicaUnità Operativa RiabilitazioneUnità Operativa Medicina PenitenziariaUnità Operativa Cure Primarie eroga- Prestazioni medico-specialistiche domiciliari eambulatoriali- Prestazioni infermieristiche domiciliari eambulatoriali- Prestazioni riabilitative e protesiche domiciliarie ambulatorialiInoltre- Gestisce i rapporti e la governance con i Medicidi medicina generale (32) e con i Pediatri di liberascelta (5)- Ha responsabilità tecnico organizzativa dell’
Unità di Valutazione MultiprofessionaleDistrettuale (UVMD) (delega al dottor Zulian)- Gestisce il Coordinamento delle ResidenzeProtette convenzionate sul territorio distrettualee gestisce un reparto territoriale per pazientipost-acuti: la Residenza Sanitaria Distrettuale(delega al dottor Perer)S. Camillo 146 posti (110 primo livello, 36secondo livello)Santa Maria del Mare 105 postiVenezia Sanità (ex Carlo Steeb) 188 posti (141primo livello, 47 secondo)- Fornisce numerose prestazioni di tipoautorizzativo e medico-legalePer accedere a queste autorizzazioni, bisognarivolgersi alla segreteria del distretto 041 5295301Per malattie rarereferente dottoressa Carnevale Miino Anna041 5295207e-mail: [email protected]
UNITÀ OPERATIVA RIABILITAZIONEChi ci lavoraDirigente Medico, Fisiatri, Coordinatore fkt,Fisiochinesiterapisti, Infermieri Professionali,OSS, BagniniServizi offertiNelle sedi del Lido e di Ca’ Savio:- Visite fisiatriche ambulatoriali e domiciliari- Riabilitazione funzionale e neuromotoriaambulatoriale e domiciliare- Ambulatorio di infiltrazioni in capo al Dr Mormile - Valutazione e collaudo ausili ambulatoriale edomiciliareNella sede del Lido:- Tens, ionoforesi, elettroterapie di stimolazione,ultrasuoni, radar, laser, vasche galvaniche eidrochinesiterapia.Apertura ServiziSegreteria: dal lunedì al venerdì 7.30-13.45;Accettazione per la prenotazione delle terapiedal lunedi al mercoledi 9.30-12.30Riabilitazione: dal lunedì al sabato 7.00-15.00sabato fino alle 13Piscina: 7.30-12.30 / 13.30-18.00 sabato fino alle12,30 (salvo modifiche per eventuali corsi: es.“gestanti in acqua” o “attività in acqua perbambini e ragazzi asmatici” o ”amici del cuore”come da cartellonistica di volta in volta esposta).Ufficio protesi: il pubblico si rivolge allo sportellounico integrato (vedi orari più avanti)Modalità di accessoVisita fisiatrica: impegnativa di “visita fisiatrica”con diagnosi di invio, compilata dal medico dibase o da un altro Medico Specialista(ortopedico, neurologo etc.), l’appuntamentoviene prenotato tramite CUP.Visita fisiatrica categorie specifiche: per gliutenti di età pediatrica e per gli utenti post operatiè possibile prenotare su ambulatori specifici, in
20

ufficio accettazione su agenda CUP dedicata.Visita di controllo: impegnativa di visita fisiatricadi controllo (visite praticate per la stessa patologiaper la quale l’utente è già in trattamento; solo dopoche l’utente ha terminato il ciclo di terapie ed entro1 mese dallo stesso) compilata dal fisiatra che hain carico il/la paziente, l’appuntamento vieneprenotato tramite CUP. Dal mese di novembre2010 è possibile prenotare anche in accettazionesu agenda CUP dedicataVisita domiciliare: impegnativa di “visitafisiatrica domiciliare” compilata dal medico dibase, l’appuntamento viene dato dalla segreteria.
UNITÀ OPERATIVA SPECIALISTICAE INFERMIERISTICAChi ci lavoraDirigente Responsabile, Medici SAI, CoordinatoreInfermieristico, Infermieri Professionali, InfermieriGenerici, Operatori socio sanitari, Ausiliari
SERVIZIO INFERMIERISTICO AMBULATORIALEAmbulatorio infermieristico- Terapie iniettive- Medicazioni- Lavaggi CVC- Gestione cateteri vescicali- PEGSi accede senza prenotazione portandoimpegnativa del MMGLido 041 5295201. Aperto tutti i giorni 11.15-12.00Pellestrina Da lunedì a venerdì 11.00-12.00Ca’ Savio Da lunedì a venerdì 10.00-11.30 Burano Aperto da lunedì a venerdì 10.00-11.00Murano non attivo
PUNTO PRELIEVI- Prelievi venosi - Ricezione campioni biologiciLido 041 5295161Aperto dal lunedì al venerdì 7.30-9.00Si accede senza prenotazione, portandoimpegnativa del MMG all’accettazione puntoprelievi al piano terraCa’ Savio 041 5300854lunedì, mercoledì e venerdì 7.00-9.00solo su prenotazione al CUP di Cà Savio da farsi il lunedì, mercoledì, venerdì 14.30-16.45 Burano 041 735580martedì e giovedì 7.45-9.30 solo su prenotazione da farsi dalle 11.00-12.00da lunedì a venerdìMurano 041 739461giovedì 7.30-9.15 solo su prenotazione da farsi da lunedì al venerdì11.00-12.00Pellestrina 041 5295839Martedì, mercoledì e venerdì 7.30-8.15solo su prenotazione da lunedì a venerdì 11.00-12.00
SERVIZIO DI CARDIOLOGIA E RIABILITAZIONE
CARDIOLOGICAServizio Ambulatoriale Cardiologico effettuadiagnostica cardiologica di primo livello.Servizio di Riabilitazione Cardiologia effettua la Riabilitazione del paziente Cardiopatico eesegue il follow-up post Riabilitazione CardiologicaAree interventoTerritorio: espletamento della diagnosticarichiesta dai MMG Ambulatoriali: ECG, ECG con visita / controllocardiologico, (ecocardiogramma / ecocardiodopplermomentaneamente sospeso), test da sforzo alcicloergometro / Treadmill, ECG dinamico sec.Holter e controllo, programmazione del Pace-Makersu prenotazioneAmbulatorio Riabilitativo Cardiologico:riabilitazione Cardiologica del pazientecardiopatico, follow-up periodico programmatodel paziente cardiopaticoModalità di accessoAmbulatorio: richiesta di esame del MMGprenotata a CUP o Ufficio Prenotazioni, richiestadi Consulenza Cardiologica richiesta da PPIAmbulatorio Riabilitativo Cardiologico: richiestadi ciclo di Riabilitazione Cardiologica diCardiologo ULSS
MEDICINA DELLO SPORTDiagnostica finalizzata all’ottenimento idoneitàsportiva agonistica (su prenotazione)Comprende- Spirometria- ECG Basale e sotto sforzo- Esame urine- Visita medico sportiva- Misurazione parametri vitali (peso altezzapressione arteriosa)- Controllo visus
SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE Apertura ServiziDa lunedì a venerdì 7.30-9.00 per i prelievi a domicilio e il resto della mattinata per le altreprestazioniModalità accessoSu prenotazione al servizio infermieristico dipersona o delegato con impegnativa del MMG Lido 041 5295201da lunedì a venerdì 10.30-11.15 Ca’ Savio 041 5300854da lunedì a venerdì 11.30-12.30 Pellestrina 041 5295840da lunedì a venerdì 11.00-12.00Murano 041 739461da lunedì a venerdì 11.00-12.00 Burano 041 735580da lunedì a venerdì 11.00-12.00
SERVIZI SPECIALISTICITutte le visite specialistiche vanno prenotate a CUPcon l’impegnativa compilata dal MMG e PLS. La
21

visita del dentista e ginecologo non necessitano diimpegnativa ma vanno comunque prenotate aCUP. Per la visita di medicina sportiva non serveimpegnativa, ma la richiesta di visita da parte dellasocietà sportiva di appartenenza e poi laprenotazione a CUP.Per informazioni sui giorni delle singole specialitàtelefonare alla segreteria dei poliambulatori dellasede dove si vuole effettuare la visitaIl Poliambulatorio (Lido, 041 5295235)Sono attive:Lido: Cardiologia, Chirurgia, Chirurgia Plastica,Dermatologia, Endocrinologia, Geriatria,ginecologia, Medicina interna, Medicina dellosport, medicina Legale, Neurologia,Odontostomatologia, Ortodonzia, Oculistica,Ortopedia, ORL, Pneumologia, Ecodiagnostica,Reumatologia, UBT, UrologiaPellestrina: OrtopediaCà Savio: Cardiologia, Neurologia, Oculistica,Endocrinologia, Ortopedia, Dermatologia, ORL,Reumatologia, Urologia, Chirurgia (in attivazione)Murano e Burano: Dermatologia, ORL, OrtopediaL’Assistenza specialistica domiciliareLe visite specialistiche domiciliari necessitano diimpegnativa del MMG con specificato visita adomicilio. Vanno prenotate direttamente allasegreteria dei poliambulatori.Sono attive a domicilio: Urologia, Cardiologia,Chirurgia, Pneumologia, Neurologia, Ortopedia,Medicina interna, Dermatologia, ORL, Reumatologia.
UNITÀOPERATIVA AMMINISTRATIVA E TECNICA041 5295201fax 041 5295405Responsabile: Dott. Danilo CorràChi ci lavoraImpiegati amministrativi, Operatori tecnici.Orari di apertura sportelli di anagrafe sanitaria:Lido lunedì, giovedì e venerdì 8.30-11.30mercoledì 14.00-16.00Murano, martedì 9.00-13.00Burano, giovedì 9.30-13.30Pellestrina martedì e mercoledì 9.00-12.00Ca’ Savio lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00
CUP041 8897908oppure in sede:Lido dal lunedì al venerdì 9.15-12.00 (primo piano)Murano martedì 9.00-13.00Burano giovedì 9.00-13.00Pellestrina martedì e mercoledì 9.00-12.00 Ca’ Savio lunedì, mercoledì e venerdì 14.30-16.45
SPORTELLO UNICO INTEGRATO (e-mail: [email protected])Lido 041 5295183, fax 041 5295184da lunedì a sabato 9.00-13.00Pellestrina 0415295924mercoledi 9.00-13.00, venerdi 15.00-17.00
Murano 041 739461martedì e venerdì 9.00-13.00Burano 041 735580lunedi e giovedì 9.00-13.00 Ca’ Savio 041 2909727lunedì, mercoledì e venerdì 10.00-14.00 (ha sede in Piazza Giovanni Paolo II, 3)
UFFICIO PROTESI il pubblico si rivolge allo sportello unico integrato
ATTIVITÀ EXTRADISTRETTUALI DEL MONOBLOCCO DEL LIDO
CENTRO SALUTE MENTALEIl CSM (Centro di Salute Mentale), distaccamentopsichiatrico di Palazzo Boldù, è collocato al pianoterra del Monoblocco, con ingresso autonomo espazi specifici dedicati
SERVIZIO SOCIALE COMUNALELa sede distrettuale del Lido ospita il serviziosociale comunale di Venezia, che attraverso ilproprio personale (assistenti sociali) si occupadelle procedure di ingresso e dimissione instrutture protette, e partecipa ordinariamentealle UVMD secondo un’ottica di integrazione diservizi.
UNITÀ OPERATIVA NEFROLOGIA E DIALISICENTRO ASSISTENZA LIMITATA CAL – LIDOMission: portare un servizio dialitico più prossimoalla residenza, di pazienti clinicamente noncomplicati, in zone territorialmente “difficili”.Il Centro del Lido è collegato per via telematica alCentro di Venezia. In qualsiasi momento, duranteil trattamento, il medico può controllare adistanza parametri come: PAO e frequenzacardiaca, peso corporeo, UF totale e oraria,efficienza del trattamento dialitico chi ci lavoraMedico Nefrologo, Infermieri Professionali,Tecnico di dialisi
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICAPrestazioni specialistiche ambulatoriali- Ambulatorio vaccinale:- Ambulatorio viaggi- Ambulatorio Gruppo C/Malattie TrasmesseSessualmente (MTS)Altre prestazioni igienistiche non ambulatoriali: Controllo e gestione delle malattie infettiveGestione dei soggetti inadempienti allevaccinazioni obbligatorie o non aderenti allevaccinazioni raccomandateGestione Numero Verde per informazioniall’utenza relativamente a: calendario vaccinale,viaggi internazionali, etc.Prestazioni rivolte al territorio- Pareri/Certificazioni igienico-edilizie
22

- Verifica e ispezione per l’attività autorizzativa dicompetenza (LR 22/02)- Promozione della salute ed epidemiologiaregistro e certificazioni delle cause di morte- Altre competenze- Servizio vaccinale per l’infanzia Distretto 2
PUNTO PRIMO INTERVENTO/SUEMServizio di pronto intervento al Lido, Pellestrina e Ca’ Savio (sede principale al Lido)
Nei prossimi numeri della rivista VIS sarannopubblicati approfondimenti anche sugli altriDistretti Socio Sanitari dell’azienda Ulss 12veneziana
23

24
prevenzione e stili di vitaDiabete, ridurre complicanze e costisanitari. Intervista a DiegoTurchetto, medico di medicinagenerale nell’Ulss 12Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il diabete è una emergenzasanitaria mondiale, 19.000 persone ogni 24 ore nel modo ricevono una diagnosidi Diabete mellito, 194 milioni di persone nel mondo oggi hanno il diabete; nel2030 si calcola che saranno 366 milioni, la maggior pandemia che il mondoabbia mai conosciuto.In Italia si stima che il 5-6 per cento della popolazione sia affetta da diabete.Al Sud e nelle isole l'incidenza è più alta rispetto al Nord ed al Centro.Ogni paziente costa al sistema sanitario nazionale 2.589 euro l'anno; si calcolache circa il 5-10% della spesa sanitaria globale nel mondo sia destinata allacura del diabete.Il diabete di tipo 1 insorge più frequentemente durante l’infanzia el’adolescenza, è originato da un processo autoimmune che distrugge le betacellule pancreatiche che producono l’insulina e necessita pertanto dellasomministrazione di insulina. In Italia l'incidenza è di 7 o 8 casi ogni 100milaabitanti, ma in Sardegna si registrano 30 o 40 casi ogni 100mila abitanti.Il diabete tipo 2 rappresenta il 90-95% di tutti i casi di diabete, si manifestasolitamente in età adulta, spesso è associato a obesità e sedentarietà.Il 10 per cento di anziani è affetto da diabete non diagnosticato e un ulteriore10 per cento presenta l'intolleranza al glucosio IGT.Il diabete, se in cattivo controllo, può arrecare danni a occhi, reni, cuore,cervello, arti inferiori, nervi con gravi quadri di disabilità. Pazienti e medicihanno quattro pilastri su cui basare la cura e la prevenzione delle complicanze:dieta corretta, attività fisica, farmaci ipoglicemizzanti orali, insulina.In questo numero di VIS ospitiamo l'intervista a Diego Turchetto, medico dimedicina generale.Nei prossimi numeri della rivista coinvolgeremo anche i servizi Diabetologiciospedalieri.

Dottor Turchetto, come si arriva alla diagnosidi diabete? E una volta riscontrata lapatologia, come si procede?La diagnosi di diabete si basa sulla rilevazioneconsecutiva per due volte di una glicemia pari osuperiore a 125mg/dl o di una glicemia maggioreo uguale a 200 mg/dl dopo 2 ore da un caricoorale di glucosio oppure una emoglobina glicatamaggiore o pari a 6,5 mg/dl. La diagnosi didiabete, in presenza di sintomi tipici, può esserefatta anche in una sola occasione con unaglicemia pari o superiore a 200 mg/dlindipendentemente dall'assunzione di cibo,anche dopo un pasto.Se al momento della diagnosi la glicemia non èeccessivamente elevata, il diabetico viene avviatoad un regime dietetico associato ad attività fisica.La riduzione del peso corporeo e l’attività fisicaproducono benefici in numerose funzioni diorgani ed apparati. Questi benefici vanno benoltre il miglioramento del controllo glicemico.Inoltre aumentano il senso di benessere ed ilgrado di autostima.Il paziente con diabete di tipo 2 dovrebbe attuareun programma di esercizio fisico aerobico delladurata di almeno 30 minuti al giorno per 3 voltela settimana: possono essere svolte attività comemarcia, nuoto, cyclette, ballo.
E quando la modifica dello stile di vita non basta?Quando la modifica dello stile di vita nonraggiunge gli obiettivi desiderati, si imponel'utilizzo di uno o più farmaci antidiabetici orali.La terapia farmacologica va personalizzatasecondo le caratteristiche individuali delpaziente: età, peso, iperglicemia persistente osoltanto postprandiale, o la presenza di altrepatologie concomitanti.Di solito si inizia il trattamento con un solofarmaco per passare poi alla eventualeassociazione di più farmaci.L'insulina è necessaria quando la funzionepancreatica è deficitaria; l'obiettivo della terapiainsulinica è quello di mimare, quanto più possibile,la fisiologia della secrezione insulinica pancreatica,ripristinando secondo la necessità, i picchiinsulinici prandiali e il fabbisogno giornaliero.Il modello di terapia più seguito è quello cheprevede la somministrazione di insulina rapidaprima di ogni pasto e di insulina ritardo la sera,prima di andare a letto.
È importante responsabilizzare il paziente?La cura della malattia diabetica, come per tutte lepatologie croniche, deve avvenire con ilcoinvolgimento diretto ed attivo del paziente. Laterapia si basa sulla collaborazione del paziente;se ciò non avviene, qualsiasi farmaco, anche il piùefficace, costoso e sofisticato non riuscirà adottenere risultati positivi e duraturi nel tempo.Il diabete, sia di tipo 1 sia di tipo 2, ha pesanti
ricadute sulla vita quotidiana: la terapia infattiinterferisce con il modo di alimentarsi, l'attivitàfisica, lo stile di vita, il lavoro, la scuola e più ingenerale le relazioni sociali.
Quali sono i sintomi del diabete che possonoessere interpretati come un campanellod'allarme?Spesso i sintomi iniziali del diabete sono subdoli,possono essere disturbi modesti e cherimandano a differenti patologie. I sintomi classiciastenia, l'urinare spesso e una grande sete simanifestano solo quando i valori della glicemiasono decisamente elevati.Sarebbe opportuno effettuare screening nellapopolazione generale per identificare i pazientiche non sanno di avere il diabete (diabetemisconosciuto) tra le persone con fattori dirischio: familiarità per diabete, soggetti obesi o insovrappeso e/o con scorretti stili di vita, soggettiipertesi e dislipidemici, donne che hanno avutoun diabete gestazionale o che hanno partoritobambini macrosomici.
Cosa significa per un paziente convivere conuna patologia cronica?I considerevoli progressi di ordine tecnologico efarmacologico nel campo della medicinapermettono attualmente di fare una diagnosi edintervenire rapidamente con successo.Nella maggior parte dei casi però le patologie sonocurabili dal punto di vista medico ma non guaribili.Queste malattie rappresentano per coloro che nesono affetti l'ingresso in una condizione cronicacaratterizzata anche da eventuali aggravamenti.Una malattia acuta, anche se grave, rappresentasolo la rottura temporanea dell'equilibrio delsoggetto, mentre la malattia cronica comporta laperdita della condizione di completa saluteprecedente: dal momento della diagnosi,bisognerà accettare la nuova situazione e curarsicostantemente per evitare o posticipare il piùpossibile il peggioramento del proprio stato.
Ma quali sono le strategie che il paziente puòmettere in atto con l'aiuto dei medici di fiducia?La conoscenza della malattia e la capacità digestire la relativa terapia possono rendere piùaccettabile la nuova condizione in cui lapersona, affetta da diabete, viene a trovarsi.Al contrario, la difficoltà ad accettare la malattiapuò ostacolare l'acquisizione della correttagestione della terapia ed indurre negligenze chepossono avere effetti anche gravi.Se si lascia da parte il notevole progressoscientifico e tecnologico di questi ultimi vent'anni, l'innovazione più rilevante nel campo dellecure è stato insegnare ai pazienti come gestire lapropria terapia. È impossibile infatti che medici,infermieri, dietisti, ecc. possano assisterequotidianamente i pazienti nella cura ordinaria
25

26
della loro malattia. I pazienti quindi devonoimparare a curarsi da sé, a monitorare le propriecondizioni e a gestire la terapia.
Possiamo parlare quindi di prevenzionesecondaria e terziaria?A differenza dell'educazione alla salute, che sirivolge al grande pubblico per ridurre il rischio dicomparsa di determinate malattie secondo icriteri definiti di “prevenzione primaria”,l'educazione dei pazienti diabetici concernepersone nelle quali la patologia è già presente el'obiettivo è soprattutto evitare o rallentare ilmanifestarsi di complicanze secondo i criteri di“prevenzione secondaria” o, se queste sono giàpresenti, permettere al paziente di controllarleper evitare invalidità di vario tipo secondo i criteridi “prevenzione terziaria”.
È difficile per i pazienti accettare la malattia?La motivazione dei pazienti ad apprendere lagestione della cura dipende in gran parte dalgrado di accettazione della malattia e dal modoin cui concepiscono la patologia, l'impattoemotivo che essa comporta.Si tratta di acquisire le competenze necessarieper adattare la terapia alle diverse situazioni dellavita quotidiana.L'annuncio della diagnosi provoca nella personareazioni emotive e psicologiche dovute al fatto didover considerare di essere malato in una societàche ha il culto della perfezione, e quindi anchedella salute, assoluta.
Quali sono gli obiettivi che medici e pazientidevono porsi?La malattia conosce variazioni e stadi come ilpassaggio all'insulina o l'insorgenza di diversi tipidi complicanze. Ottenere e mantenere negli anni
valori di glicemia, ma anche di emoglobina glicata,assetto lipidico, pressione arteriosa, normali ocomunque vicini alla normalità e la “condicio sinequa non” per evitare complicanze croniche tipichedel diabete che possono essere anche gravi.Per questo è necessario si instaurare una correttaterapia farmacologica, ma anche sviluppare unagestione integrata della malattia con unaorganizzazione che abbia come attori i servizi diDiabetologia negli ospedali, i medici di medicinagenerale sul territorio e i pazienti .L'educazioneall'autogestione del diabete è fondamentale,possiamo dire indispensabile. Il paziente infattideve saper integrare nella vita di tutti i giorni unacorretta alimentazione, i farmaci, l’attività fisica edeve saperli modificare per mantenere un buoncontrollo glicemico, obiettivo che allontanal'eventualità di complicanze.Se si modifica l'alimentazione e/o l'attività fisica,può essere necessario anche modificare ildosaggio e/o la tipologia dei farmaci.
In questo quadro, quanto conta l'autocontrollodella glicemia?L'autocontrollo della glicemia è un'armastrategica per valutare il compenso metabolico,impostare e realizzare una terapia personalizzata,migliorare l'autogestione della cura e la quantitàdi tempo dedicato alla terapia soprattutto neldiabetico insulino-trattato.La variabilità e l'imprevedibilità della glicemia èampia nei diabetici e anche nello stesso pazientein momenti e situazioni diverse.L'alimentazione, l'attività fisica, gli stress emotivie malattie intercorrenti sono alcune delleprincipali cause di instabilità della glicemia.Diventa perciò indispensabile monitorare econoscere il valore della glicemia, magari tenendoun diario, in qualunque momento della giornata,dosandola con un glucometro, interpretarne ilvalore e comportarsi di conseguenza. In questomodo la malattia viene curata meglio, un buoncontrollo metabolico migliore la qualità della vitaed allontana le complicanze.Va sottolineato anche che la riduzione dellecomplicanze riduce i costi sanitari diretti edindiretti correlati al diabete. Occorre dunquesapere, saper essere e saper fare.
Per informazioniDottor Diego TurchettoMedico di medicina generalecell. 328 3822304email: [email protected] internet www.diabetes.itwww.diabetologia.itwww.novonordisk.itwww.dm1.it

27
prevenzione e stili di vitaUna guida pratica per i pazienti cardiopatici.L’assunzione di farmaci come fondamento allaprevenzione secondaria
a cura di Franco Del Piccolo,responsabile Unità di Riabilitazione Cardiologica
della Casa di Cura Policlinico San Marco
La malattia del cuore necessita spesso di interventi chirurgici o cardiologici salvavita. Nella fase successiva, i farmaci sonoindispensabili per evitare o ridurre il rischio di recidive e complicanze.L’utilizzo corretto e costante dei farmaci prescritti permette al cuore di poter riprendere a funzionare nel miglior modo possibile.Per riprendere la forma ed aiutare il cuore a recuperare dopol’intervento, ci sono i servizi di Riabilitazione Cardiologica che prendonoin carico il paziente nel suo complesso, offrendo oltre allastabilizzazione clinica, anche un percorso di training fisico,ottimizzazione terapeutica, supporto psicologico ed educazionesanitaria ed alimentare per poter ridurre così i fattori di rischio cardio-vascolare modificando gli stili di vita e monitorando la messa in pratica della terapia.Conoscere e capire i farmaci che servono e serviranno per mantenere il livello di funzionalità del cuore e dell'appartato cardiocircolatorio almiglior livello possibile, risulta importate per continuare ad assumerli.Quali sono i farmaci che servono allora per far tornare il sorriso al nostro cuore?Qui di seguito una semplice guida pratica rivolta ai pazienti spiega con parole correnti, in stile divulgativo, l'azione di alcuni tra i piùimportanti farmaci utilizzati dai malati di cuore.

28
GLI ACE-INIBITORIQuesti farmaci sono usati nella cardiopatiaischemica e nell’ipertensione arteriosa e agisconoinibendo un enzima che si chiama ACE (enzimache converte l’angiotensina). Ma che cos’è e comefunziona un enzima? Potremmo considerarlocome una chiave che apre una serratura enormalmente, quando questa serratura è aperta,una sorta di “operaio specializzato” attiva nelnostro organismo un meccanismo di“vasocostrizione” dei nostri vasi dove circola ilsangue (il muscolo che li avvolge, si contrae e ildiametro del vaso si riduce) e per bloccare questo“operaio” che, se troppo attivato fa male al cuore,gli scienziati hanno trovato il modo di bloccarequesta serratura. Con questo farmaco quindi si hacome effetto una vasodilatazione e comeconseguenza la pressione arteriosa scende ed ilcuore in questo modo fa un lavoro minore edessendo meno sollecitato, la sua struttura un po’alla volta si modifica verso la normalità.Gli effetti beneficiGrazie a questi effetti benefici, gli scienziatihanno scoperto che nei pazienti con cardiopatiaischemica (angina pectoris, infarto), chi prendequesti farmaci ha una maggiore probabilità divivere più a lungo e di avere con minor frequenzaepisodi secondari della malattia (angina, infarto).Per questo motivo gli ACE inibitori rientrano neicosiddetti farmaci salva-vita.Possibili effetti collateraliTra gli effetti collaterali di questi farmaci il piùimportante è la tosse (secca, stizzosa, continua):questo perchè il farmaco non blocca solol’enzima dei vasi sanguigni, ma anche un enzimache gli assomiglia e che si trova nell’alberorespiratorio e che, se attivato, provoca la tosse.Inoltre può anche provocare edema delle labbra.Un altro effetto possibile è l'accumulo di potassio(da controllare con gli esami del sangue) e in certicasi può peggiorare la funzionalità del rene sequesto organo è già malato (da controllare con gliesami del sangue).Infine avendo come effetto principalel’abbassamento della pressione arteriosa, questofarmaco non può essere utilizzato da chi ha lapressione troppo bassa.Esempi di molecole: enalapril, ramipril,perindopril, fosinopril, captopril ecc.
I SARTANIVisto che gli ACE-Inibitori possono dare in alcunicasi effetti collaterali come la tosse, i ricercatorihanno pensato che, se invece di bloccare l’enzima(la chiave), bloccavano il recettore (la serratura),si otteneva lo stesso risultato. E così è stato con ilvantaggio che bloccando la “serratura”, non siscatenava la tosse (praticamente quasicompletamente annullata).Anche per i sartani valgono i vantaggi: maggioresopravvivenza e riduzione degli eventi secondaricome per gli ACE-Inibitori.Anche gli effetti collaterali sono simili, tranne perquanto riguarda la tosse.Esempi di molecole: losartan, irbesartan,telmisartan, olmesartan, valsartan ecc.
I BETABLOCCANTIQuesti farmaci hanno più di 30 anni di vita è a tutt'oggi sono tra i più importanti in ambitocardiovascolare.Sono indicati nella cura di cardiopatia ischemica,ipertensione arteriosa, in alcune cardiopatievalvolari, nelle aritmie sopraventricolari eventricolari, nello scompenso cardiaco.Ma perchè si chiamano betabloccanti? Perchèbloccano qualcosa che si chiama beta cioè lafunzione dei recettori beta. Che cos'è allora unrecettore beta? Il recettore beta è una specie di“serratura” posta sulla parete esterna di ciascunacellula del cuore che, in presenza di determinatesostanze circolanti nel sangue – comel'andrenalina, che viene messa in circolo peresempio quando ci si spaventa, ci si arrabbia o siè sotto stress – attiva la porta della cellulaproducendo alcuni effetti specifici all'internodella cellula stessa, che consistono in unaumento della frequenza cardiaca, della forza edella velocità di contrazione, e della velocità diconduzione dello stimolo elettrico cardiaco.Gli effetti benefici Il farmaco betabloccante occupa e blocca ilrecettore beta, impedendo le reazioni sopraelencate e così provoca una riduzione dellafrequenza cardiaca e della pressione arteriosa;riducendo la richiesta di ossigeno da parte delcuore, proteggendolo così dagli attacchi anginosicon una migliore disponibilità di ossigeno da partedelle cellule cardiache.Inoltre l’azione antiscompenso è dipendenteanche dal blocco dell'iperattivazione simpatica(adrenalina) che si instaura nello scompenso eche lo mantiene.La famiglia dei betabloccanti è numerosa perchènon esiste un solo tipo di recettori beta – beta1 ebeta2 sono i principali – e possono essere più omeno selettivi per questi recettori; per le malattiedi cuore si preferiscono i cardio-selettivi.Al cardiologo spetta il compito di scegliere quellopiù adatto alla specifica malattia e allecaratteristiche del paziente.

29
Possibili effetti collateraliTra gli effetti indesiderati dei betabloccantitroviamo: eccessiva riduzione della frequenzacardiaca, abbassamento della pressionearteriosa, possibile peggioramento delladepressione, possibile deficit di erezione e comecontroindicazione assoluta l’asma bronchiale.
LE STATINEAnche per le statine come per i precedentifarmaci il principio d'azione di base è il blocco diun enzima l’”HMG-CoA reduttasi” specializzatonella produzione del colesterolo endogeno, edanche in questo caso bisogna bloccare questo“operaio specializzato” quando c’è troppocolesterolo nel sangue.Gli effetti positiviLe statine appaiono molto efficaci nelle malattiecardio-vascolari proprio perché il loro effetto diriduzione della colesterolemia si realizza sia a caricodel colesterolo totale sia e soprattutto a carico dellafrazione del colesterolo LDL, cioè, come si è detto,riducono il "colesterolo cattivo" a vantaggio di quello"buono" (HDL). Inoltre le statine hanno anche unaltro effetto chiamato “pleiotropico”, cioè unacapacità di ridurre l’infiammazione della placcaateromatosa, stabilizzandola e riducendo così ilrischio di rottura con la conseguente fuoriuscita delcontenuto che porta ad eventi drammatici comel’infarto o all’ictus cerebrale.Possibili effetti collateraliLe statine sono generalmente ben tollerate,tuttavia due sono gli aspetti che meritano unaparticolare attenzione. In primis le statine possonoessere causa di epatotossicità, infatti possonocomportare un incremento dei livelli delletransaminasi. Inoltre le statine sono associate adisturbi muscolari, in particolare alle gambe, chevanno dalla debolezza muscolare e crampi fino allamialgia. Più rare, ma molto più gravi, sono lemiositi e la rabdomiolisi (lesione della cellula
muscolare con aumento del CPK nel sangue). Altrieffetti possibili sono: dispepsia, nausea, cefalea.
ANTIAGGREGANTI PIASTINICI: LA CARDIOASPIRINAL'acido acetilsalicilico o ASA, meglio conosciutocon l'italianizzazione in Aspirina del suo primonome commerciale tedesco di larga diffusione, èun farmaco antinfiammatorio non steroideo(FANS) della famiglia dei salicilati. Inizialmenteusato per abbassare la febbre e come analgesico.Gli effetti positiviÈ un inibitore dell'aggregazione delle piastrine, lacardioaspirina dunque favorisce la fluidificazionedel sangue. Questa proprietà la rende utile perridurre l'incidenza degli infarti.Le sostanze chiamate “trombossani” sonoresponsabili dell'aggregazione delle piastrine,piccole cellule del sangue deputate allacoagulazione, ma che possono formare anchepericolosi coaguli (trombi). Gli attacchi cardiacisono principalmente dovuti all'ostruzione dei vasisanguigni da parte di questi grumi di piastrine el’aspirina, bloccando proprio l’aggregazionepiastrinica previene e contrasta questa evenienza.Possibili effetti collateraliGli effetti collaterali più indesiderati - specialmentead alti dosaggi e per l’assunzione a stomaco vuoto,riguardano il tratto gastrointestinale, dove sipossono avere ulcere ed emorragie.Per tutti i farmaci presi in considerazione vi puòessere la possibilità della reazione allergica nonsempre ponderabile a priori.In conclusione, in particolare nella cardiopatiaischemica, tutti questi farmaci (ce ne sono anchealtri che non abbiamo trattato) vengono chiamatifarmaci salva vita in virtù della loro capacità, seassunti con regolarità, di allungare la vita e diridurre la probabilità di avere un evento acutocome l’angina pectoris e l’infarto del miocardio(prevenzione secondaria).

30
CIBI SCONSIGLIATI• Le farine lavorate e i prodotti che le contengono
come il pane condito, i cracker, i biscotti, i dolci.• I prodotti contenenti lo zucchero raffinato come
i dolci e le caramelle.• La carne lavorata degli hamburger o degli
insaccati (salsicce, salame, mortadella coppa,pancetta, ecc), carne grassa come anatra,costicine e le frattaglie come fegato, rognone e cuore.
• Le combinazioni zuccheri/proteine come nei gelati, milk shake, ecc.
• Uova fritte, formaggi stagionati come gorgonzola, fontina, sottilette, pecorino, grana.
• Latte intero, yogurt alla frutta, panna, burro,strutto.
• Pesce conservato sott’olio (tonno, sgombro),si consiglia un consumo mdoerato di molluschi e crostacei.
CIBI CONSIGLIATI • Tutti i tipi di ortaggi e verdure tra cui asparagi,
zucche, cavoli, pomodori, cavolfiori, carote,rape, patate, sedano, broccoli, lattuga, piselli,germogli.
• Tra le carni sono da preferire: vitello, manzo magro, agnello, pollo, tacchino, pesce.
• Tra i cibi fermentati: i formaggi magri freschi tipo ricotta, mozzarella e crescenza.
• Tutti i tipi di frutta, e succhi vegetali, vanno bene.• Noci e semi oleosi sono preferibili allo stato
crudo e non salati; vanno comunque assunti in moderata quantità.
• Le fibre contenute nella crusca, nel riso, nella farina d'avena, nella pectina.
• Olio d’oliva extravergine, di mais, di soia,sempre in moderata quantità
• Pasta, riso, gnocchi, evitando però condimenti elaborati
LA DIETA CORRETTA, UNA TERAPIA IMPORTANTE Va sottolineato che la terapia farmacologica si deve accompagnare sempre ad una dietoterapia adeguata.
Il reparto di Riabilitazione Cardiologica della Casadi Cura Policlinico San Marco, di cui èresponsabile il dottor Franco Del Piccolo, medicointernista, comprende circa una ventina di postiletto ed anche un Day Hospital-Day Serviceafferenti anche al dottor M. Beggio. Da agosto2011, quando il reparto è stato riorganizzato,sono stati ricoverati in un anno 164 pazienti chenecessitavano della riabilitazione cardiologicaintensiva inviati direttamente delle UnitàOperative di Cardiochirurgia e Cardiologiaospedaliere. La degenza dura in media unaventina di giorni.La Casa di Cura Policlinico san Marco èconvenzionata con la Regione Veneto.In maggioranza si tratta di pazienti che hannosubito un intervento di cardiochirurgia e in parteminore di pazienti che hanno subito interventimeno invasivi come l'angioplastica e che spessopresentano varie patologie associate – comediabete, insufficienza renale, problemi respiratori
cronici o anche l’età avanzata – che li rendonopazienti fragili.Il ricovero rientra nel progetto di presa in carico erieducazione del paziente a seguito di unamalattia cardiaca, che, pure se l'intervento hadato degli ottimi risultati, resta di fatto unapatologia cronica.L'obiettivo è rieducare la funzionalità cardio-respiratoria del paziente, monitorandonel'evoluzione; inoltre vengono fornite informazioniutili per la corretta assunzione dei farmaci, peruno stile di vita e per una dieta più adeguati.La degenza post operatoria permette anche diseguire il paziente in questa delicata fase perevitare o contenere complicanze come aritmie(fibrillazione atriale, ecc.) versamenti pleuro-periardici, infezioni, anemia, ecc.L'équipe riabilitativa è formata anche dallopneumologo e da infermieri riabilitatoriopportunamente formati, psicologo, fisioterapistaed esperto dietista.
L'UNITÀ DI RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA DELLA CASA DI CURAPOLICLINICO SAN MARCO
Per informazioniDottor Franco Del Piccolo, Policlinico San MarcoTel. 041 5071701 – email: [email protected]

31
speciale
Nel 2011 è stato pubblicato il volume “Ambiente eTumori”, edito da AIOM (Associazione Italiana diOncologia Medica), coordinato da Ruggero Ridolfi.Il volume raccoglie articoli che trattano il complessorapporto tra ambiente di vita e sviluppo dei tumori,analizzando in dettaglio quali possano essere leimplicazioni dell’inquinamento ambientale sullasalute umana.In questo numero di VIS, uno degli autori, ErnestoBurgio ha rielaborato per noi i concetti espressi nelsuo capitolo: “ Cancerogenesi transplacentare etrans-generazionale”, sintetizzando il suo saggio e traducendolo in termini divulgativi per un pubblicopiù vasto e composto anche da non addetti ai lavori.Il capitolo originale è comunque consultabile escaricabile gratuitamente dal sito web dell’AIOM:www.aiom.ithttp://www.aiom.it/Attività%E0+Scientifica/Documenti+AIOM/PositionPosition+paper/Progetto+Ambiente+e+Tumori/1,5352,1.
Oncologia Medica
L’incremento dei tumori infantili.L’esposizione al carico complessivo diinquinanti e il rischio per le future generazioni

32
UNO DEI FATTORI CHIAVE: L'ESPOSIZIONEDEI GENITORI O DEL FETO NELLEPRIMISSIME FASI DEL SUO SVILUPPOLa cancerogenesi è un processo lungo ecomplesso: per ciò che concerne l’incremento deitumori infantili, il fattore chiave è probabilmenterappresentato dall’esposizione dei genitori o delfeto nelle primissime fasi dello sviluppo. Leprincipali possibilità che devono esser prese inconsiderazione sono: l’esposizione direttadell’embrione/feto ad agenti fisici o, pertrasmissione transplacentare, ad agenti biologici(virus) o chimici in grado di danneggiaredirettamente il DNA fetale o di indurre alterazioniepigenetiche nei tessuti fetali e la trasmissionetransgenerazionale di vere e proprie firme(“signature”) epigenetiche a carico dei gameti.Riconoscere l’importanza di questi meccanismisignificherebbe, non soltanto riconoscere il ruolo, finqui enormemente sottovalutato, dell’inquinamentoambientale nella genesi e nell’incrementoprogressivo dei casi di cancro, ma anche ipotizzareche la fase di “iniziazione” tumorale rischia diverificarsi sempre più precocemente e che i trend di
incremento del cancro nella primissima infanziarappresentano un segnale di allarme, in relazionealla possibile amplificazione transgenerazionaledelle modifiche (epi)genetiche/programmatiche edelle patologie correlate.
NEGLI ULTIMI 40 ANNI IN TUTTO IL MONDOAUMENTA NEI BAMBINI L'INCIDENZA DITUMORI Troppo spesso ci si dimentica che l’incrementoriguarda tutte le età e, soprattutto, negli ultimidecenni, i tumori infantili. In genere si affermache i tumori infantili sono una patologia rara.Bisogna però intendersi. È opportuno ricordarecome, in termini assoluti, di cancro si ammali unbambino su 5-600 e che oltre 13 mila bambini siammalano di cancro ogni anno nei soli Stati Unitid’America; come nonostante i significativimiglioramenti prognostici degli ultimi decenni ilcancro rappresenti la prima causa di morte permalattia in età pediatrica; come anche in questafascia d’età, da 40 anni a questa parte, si assistain tutto il mondo a un incremento significativo econtinuo della patologia tumorale.
Si pensa generalmente al cancro come ad una malattia degli anziani e si sostiene che il trend continuo di incremento di tumori nel corso del XX secolo in tutti i paesi industrializzati possa essere spiegatomediante la teoria dell’accumulo progressivo di lesioni genetiche ed il miglioramento continuo dellecapacità diagnostiche. Troppo spesso ci si dimentica che l’incremento riguarda tutte le età e, soprattuttonegli ultimi decenni, i tumori infantili. L’obiettivo di questa revisione consiste nel riconsiderare, alla lucedei nuovi modelli di cancerogenesi ambientale e di trasmissione transgenerazionale del cancro, i datiepidemiologici che attestano un incremento significativo dei tumori infantili in tutt’Europa negli anni ’80e ’90, difficilmente interpretabile sulla base del paradigma mutazionale.

33
IN EUROPA GLI STUDI DELLA IARCSULL'INCIDENZA DEL CANCROTRA BAMBINI E ADOLESCENTIIl recente “Surveillance, Epidemiology, and EndResults program data” per il periodo 1992-2004documenta chiaramente questo trend. Se i datidegli Stati Uniti sono preoccupanti, in Europa esoprattutto in Italia la situazione non è migliore,anzi: come risulta chiaramente dal recente progettoACCIS (“Automated Childhood Cancer InformationSystem”) – un ampio monitoraggio condotto dallaIARC (Associazione Internazionale di Ricerca sulCancro) su 63 registri oncologici di 19 paesieuropei, per un totale di oltre 130 mila tumori ditutti i tipi (113 mila pediatrici e 18 mila di etàadolescenziale). Un primo report del progetto,pubblicato su Lancet nel 2004, evidenziò unincremento annuo dell’1-1,5 % per tutte le neoplasie(con aumenti più marcati per alcuni linfomi,sarcomi dei tessuti molli, tumori delle cellulegerminali e del sistema nervoso). Queste cifre, in unprimo tempo accolte con qualche perplessità dallacomunità scientifica internazionale, furonopienamente confermate dalla successiva revisione(la più completa a tutt’oggi) dei dati emersi dallostesso studio, che costituisce il più ampio databaseeuropeo sul cancro, pubblicata due anni dopo, in unnumero monografico, da lo ”European Journal ofCancer”: 18 articoli in tutto, che contengono l’analisidettagliata dei dati sui tassi di incidenza e suitrends di prevalenza e sopravvivenza delle principalineoplasie infantili e adolescenziali.
IL RAPPORTO DELL'AIRTUM DEL 2008: PIÙ TUMORI INFANTILI IN ITALIA RISPETTO A STATI UNITI ED EUROPANon è evidentemente possibile approfondire, inquesta sede, l’argomento. Può esser sufficientesottolineare come in 20 anni (tra il 1978 e il 1997) sisia assistito, in Europa, ad un incremento mediogenerale di neoplasie ad insorgenza in età pediatricadell’1,1% annuo (ma del 2% annuo circa nel primoanno di vita e dell’1,3% in età adolescenziale). Sepossibile ancora peggiori sembrano essere le notizieconcernenti i bambini italiani. I recenti dati del
Rapporto AIRTUM (Associazione Italiana RegistriTumori) 2008 sui tumori infantili, dimostrano infatticome i dati di incidenza e gli andamenti temporalisiano in Italia peggiori che negli altri paesi europei enegli USA (il che, sia detto per inciso, toglie valoreall’ipotetico fattore “miglioramento diagnostico”).Sembra che si stia registrando un leggerorallentamento di questi trend: un dato certamentepositivo, ma che andrà attentamente valutatonell’ambito dei dati summenzionati.
IN AUMENTO LEUCEMIE, TUMORI DELSISTEMA NERVOSO CENTRALE ESOPRATTUTTO LINFOMIForse il modo migliore di inquadrare esintetizzare tali dati consiste nel citare alcunipassi tratti dalla sintesi finale del rapportoAIRTUM: “Il tasso di incidenza per tutti i tumoripediatrici in Italia (175,4 casi per milione/anno nelbambino, 270,3 casi nell’adolescente) è più alto diquello rilevato negli anni novanta negli Stati Uniti(158) e in Europa (140). In Germania è 141, inFrancia è 138… Tra il 1988 e il 2002 si è osservatoun aumento della frequenza (per tutti i tumori)del 2% annuo passando da 146,9 casi nel periodo1988-1992 a 176 casi nel periodo 1998-2002.L’incremento più consistente riguarda i bambinial di sotto di un anno di età (+3,2%), seguiti daquelli di età compresa tra i 10 e i 14 anni (+2,4%).Tutti e tre i tumori più frequenti nei bambini sonoin aumento: le leucemie (+1,6% annuo), i tumoridel sistema nervoso centrale (+2,0% annuo) esoprattutto i linfomi (+4,6% anno)”.
IN AUMENTO SOPRATTUTTO I CASI CHECOLPISCONO BIMBI AL DI SOTTO DI UNANNO DI VITASi tratta evidentemente di dati significativi epreoccupanti: in primis perché, in questo caso,non è possibile proporre quale causa primal’incremento/accumulo nel tempo di lesioniossidative a carico del DNA e/o il progressivoindebolimento dei meccanismi di riparazione delDNA e/o le trasformazioni para-fisiologichelegate all’invecchiamento dei tessuti; ma anche esoprattutto in quanto, come abbiamo giàaccennato e come cercheremo di meglioillustrare, una discreta parte delle neoplasieinfantili (e in particolare quella ad insorgenza nelcorso del primo anno di età, la fascia d’età che haregistrato il maggior incremento) non può cheessere il prodotto di un’esposizione assai precocedel feto, o addirittura dei suoi genitori.
L'ESPOSIZIONE DEI GENITORI E DEL FETO E LA POSSIBILE TRASMISSIONE DEL RISCHIOE DI EVENTUALI DANNI DA UNAGENERAZIONE ALL'ALTRAUn dato particolarmente preoccupante, già rilevatodal report iniziale, e poi confermato tanto dallasuccessiva e più completa analisi, quanto dal

34
rapporto AIRTUM, concerne l’incremento delleneoplasie del primo anno di vita. Due appaiono,come già accennato, gli eventi più probabili, perspiegare questo dato: un’esposizione embrio-fetalediretta a fattori fisici o biologici (virus) e chimici(xenobiotici) per via transplacentare; un eventotransgenerazionale, consistente nella trasmissionedi modifiche epigenetiche o genetiche a carico deigenitori, potenzialmente trasmissibili da unagenerazione all’altra (il che impone di prendere inseria considerazione, anche sul pianoepidemiologico, l’ipotesi di una progressivaamplificazione trans-generazionale del danno).
PIÙ A RISCHIO BAMBINI NATI E CRESCIUTI IN LUOGHI ALTAMENTE INQUINATI O CON MADRI CHE HANNO TRASCORSO LA GRAVIDANZA IN QUESTI CONTESTIDi grande rilievo appaiono, in questo contesto, i datiprovenienti dagli studi dell’epidemiologo ingleseErnest Knox il quale, dopo aver passato in rassegnai luoghi di residenza dei bambini morti di cancro inGran Bretagna tra il 1955 e il 1980, ha mostratocome il rischio aumenti in modo significativo nontanto per i bambini nati e cresciuti vicino a stradetrafficate, pompe di benzina e stazioni di autobus,impianti industriali, quanto per i figli di donneresidenti in tali aree nel periodo della gravidanza. Èevidente che tanto i dati complessivi del progettoACCIS, quanto gli studi di Knox che mettonol’accento sul nesso, ancora incredibilmentecontestato da taluni, tra inquinamento atmosfericoe cancro (secondo Knox un quarto delle neoplasieinfantili avrebbe quest’origine), rappresentano unaconferma della tesi, proposta e sostenuta già trentaanni fa da Lorenzo Tomatis, della possibiletrasmissione transplacentare e/o trans-generazionale di alcune forme di cancro.
L'INCREMENTO DI NEOPLASIE IN ETÀPEDIATRICA: UN DATO SIGNIFICATIVO E INQUIETANTECrediamo che un’attenta riflessione su questidati sia necessaria ed urgente: se l’incremento dipatologie cronico-degenerative e neoplastichesembra essere un indice (anche quantitativo)dell’attuale modello di sviluppo, l’incrementosignificativo delle neoplasie in età pediatricarappresenta un dato particolarmenteinquietante. E questo non soltanto perché neibambini dovrebbero svolgere un ruolo minorel’esposizione ad agenti inquinanti legata allecattive abitudini personali (in primis il fumo disigaretta) e lo stress, ma soprattutto perché nonpotrebbe realizzarsi in così breve tempol’accumulo di lesioni ossidative e, più in generale,di alterazioni genetiche ed epigenetichegeneralmente considerate la causa prima diqualsiasi degenerazione in senso neoplastico.
L'IPOTESI DELL'ORIGINE EMBRIO-FETALEDELLE MALATTIE DELL'ADULTONon bisognerebbe sottovalutare il fatto chel’esposizione dei genitori o dell’embrione e delfeto, in particolari fasi dello sviluppo ontogenetico(finestre di esposizione), a numerose sostanzeinquinanti, può aprire la strada a patologieneoplastiche (oltre che cronico-degenerative,endocrino-metaboliche ecc.) destinate amanifestarsi soltanto in età adulta. Siamo nelcampo (in continuo sviluppo) della cosiddettaIpotesi dell’Origine embrio-fetale delle Malattiedell’Adulto (Developmental Origins of Health andDisease -DOHaD), connessa al programmingfetale dei tessuti. Per quanto concerne latematica della cancerogenesi ambientale, questosignifica che molte neoplasie potrebbero avereinizio in utero o, quantomeno, che la “classica”fase dell’iniziazione neoplastica andrebbe,almeno in una parte dei casi, retrodatata alperiodo prenatale (di programmazioneepigenetica dei tessuti) o addirittura pre-zigotico.
IL POSSIBILE RUOLO DELL'AMBIENTEUTERINO NELLO SVILUPPO DELL'EMBRIONE E DEL FETOAnche la tesi di una possibile origine del cancro daparticolari cellule staminali, dapprima teorizzata,poi confermata in varie forme e localizzazionineoplastiche potrebbe ricollegarsi all’ipotesi diun’origine (epigenetica) embrio-fetale: nel sensoche una parte delle cellule staminali in dotazione aun determinato tessuto potrebbero esser stateepigeneticamente marcate/programmate in uteroin risposta a particolari situazioni nutrizionali(carenziali o comunque poco idonee a un correttosviluppo fetale) o a esposizioni a molecolepotenzialmente (epi)geno-tossiche.Quanto detto fin qui rappresenta un richiamopressante allo studio dei nuovi paradigmicancerogenetici, che propendono per un’originesempre più precoce del processo neoplastico,riconoscendo in esso la conseguenza di unprocesso di sviluppo imperfetto: cioè di un difetto diprogrammazione dei tessuti che avverrebbe in età

35
embrionale o fetale e le cui conseguenze sirivelerebbero dopo (molti) anni. Paradigmi tuttosommato poco noti e fondati su un assunto di baseche sembra assumere sempre di più i caratteri diun paradigma patogenetico “universale” in base alquale le alterazioni del microambiente uterino(legate a carenze nutrizionali, all’inquinamentoprogressivo dell’ambiente e delle catene alimentario ad altre situazioni di stress materno-fetale)sembrerebbero poter indurre alterazioni dellosviluppo ontogenetico e, in particolare, dell’assettoepigenetico di vari tessuti ed organi.
POSSIBILI ORIGINI FETALI E TRASMISSIONETRANSGENERAZIONALE DEL CANCROIl feto è particolarmente vulnerabile ai cambiamentiambientali interni ed esterni, che interagisconoinfluenzando lo sviluppo fetale e hannoconseguenze immediate e a lungo termine. Taliinfluenze sono essenzialmente di naturaepigenetica, in grado cioè di indurre specifichemarcature ed alterazioni ereditarie dell’espressionegenica, senza modificazioni del DNA. Esistonorevisioni sufficientemente approfondite e complete,che prendono in considerazione tanto gli aspetti piùgenerali, che i meccanismi molecolari implicati inquesti nuovi modelli patogenetici, che potrebbero edovrebbero cambiare in modo radicale la nostrarappresentazione delle origini di molte malattie edel cancro.
DATI ALLARMANTI SUL “CARICO CHIMICO”IN DONNE, EMBRIONI, FETI Attualmente molti studi in varie parti del mondostanno valutando il carico chimico (chemicalbody burden) dei nostri organismi, soprattutto indonne, bambini, embrioni e feti, fornendo non dirado risultati allarmanti.Tra i più conosciuti sono gli studi effettuati daricercatori dell’Environmental Working Group(EWG), che hanno documentato la presenza didecine di molecole tossiche, mutagene ecancerogene in sangue, urine, latte materno,cordone ombelicale di quasi tutti i soggettisottoposti ad analisi: particolare preoccupazione,ha suscitato uno studio che documentava lapresenza di sostanze potenzialmente(geno)tossiche e mutagene in tutti i cordoniombelicali testati, a dimostrazione dell’ubiquità eprecocità dell’esposizione fetale.
INQUINANTI AMBIENTALI TRASMISSIBILIALL'EMBRIONE ED AL FETO E POTENZIALMENTE IN GRADO DI INTERFERIRECON LO SVILUPPO DI TESSUTI, ORGANI E FUNZIONI VITALI Il periodo dello sviluppo ontogeneticorappresenta una fase particolarmente critica perciò che concerne la “programmazione” deitessuti: è ormai noto che l’esposizione ainquinanti ambientali per via inalatoria, o
introdotti con il cibo dalla madre durante lagravidanza, può compromettere laprogrammazione epigenetica delle cellule e deitessuti dell’embrione e del feto, interferendo con iprogrammi di differenziazione cellulare e quindicon la pianificazione e lo sviluppo di organi etessuti, aprendo la strada a malattie metaboliche,neuro-endocrine, neurodegenerative eneoplastiche che possono manifestarsi anni odecenni più tardi, in età adulta e persino nellegenerazioni successive.
PIÙ PERICOLOSA L'ESPOSIZIONE FREQUENTEA INQUINANTI, ANCHE IN QUANTITÀ MINIMEÈ utile, a questo proposito, ricordare come sianosufficienti quantità infinitesimali di agenti epi-genotossici, quali metalli pesanti ed interferentiendocrini, per indurre cambiamenti nellaconformazione della cromatina e, di conseguenza,per influire sull’espressione genica. Si tratta di unprocesso lento, che può iniziare nelle prime fasi dellosviluppo fetale o addirittura riguardare i gameti e icui effetti, essenzialmente legati alla particolare fasedi sviluppo dei singoli organi e tessuti interessati,sono destinati a manifestarsi, come detto, dopoanni. E anche in questo senso vale la regola che èl’esposizione frequente a quantità minime arappresentare il maggior problema: è stato infattidimostrato che l’esposizione a inquinanti einterferenti endocrini in precise fasi dello sviluppoontogenetico (finestre di esposizione) può indurreuno stress e specifiche modifiche epigenetiche,acuire la sensibilità agli agenti cancerogeni e influiresulla penetranza di particolari geni.
IL CASO DEL DES: DONNE IN GRAVIDANZATRATTATE CON ESTROGENO ANTIABORTIVO,LE CUI FIGLIE SONO STATE COLPITE DA ADENOCARCINOMA VAGINALESul piano epidemico la prima e più nota confermadi un’origine prenatale e, soprattutto, di unapossibile trasmissione trans-generazionale dialcune forme di cancro risale agli anni 70: ainumerosi casi di adenocarcinoma vaginale inadolescenti le cui madri erano state sottoposte aterapia con il Dietilstilbestrolo (DES), un potenteestrogeno non steroideo di sintesi somministrato afini anti-abortivi. Pur trattandosi di un farmacodestinato unicamente al trattamento di gravidanzea rischio; pur essendo stato dimostrato che la granparte delle donne sottoposte al trattamento nonne aveva alcuna necessità; pur essendone statasegnalata per tempo la scarsa efficacia, si ècalcolato che, tra il 1938 ed il 1971, circa 10 milionidi donne ne fecero uso in gravidanza. E il 15 apriledel 1971 il New England Journal of Medicinepubblicò un report di tre medici del MassachusettsGeneral Hospital che associava l’uso di DES indonne al primo trimestre di gravidanza el’insorgenza nelle loro giovani figlie (di etàcompresa tra i 14 e i 22 anni) di una relativamente

36
rara forma di adenocarcinoma della vagina e/odella cervice uterina.
AL DES SI ASSOCIANO ALTRI TIPI DI MALATTIE CHE COLPISCONO ANCHEFIGLI MASCHI DELLE MADRI ESPOSTE Negli anni successivi si scoprì che le “figlie delDES”, erano anche a rischio di patologieautoimmuni e che il rischio di sviluppare unadenocarcinoma genitale era presente anche inetà più tardiva (30-40 anni); che malformazionigenitali potevano colpire i figli di entrambi i sessi:criptorchidismo, ipoplasia testicolare, ipospadia,anomalie spermatiche nei maschi, infertilità,aborti, parti prematuri e gravidanze ectopichenelle femmine; che all’uso di DES potevaconseguire un carcinoma mammario anche nelledonne che lo avevano assunto.
L'ESPOSIZIONE AL DES ALTERA IN MODOPERMANENTE LA PROGRAMMAZIONE DEI TESSUTI BERSAGLIO Fu ben presto evidente che, essendo il DESrapidamente metabolizzato ed eliminatodall’organismo, le suddette alterazioni persistenti etransgenerazionali che conseguono all’esposizionefetale al farmaco, non possono essere interpretatecome effetti tossici diretti della molecola. E varistudi sperimentali su animali hanno da alloradocumentato gli effetti cancerogeni a lunga-lunghissima scadenza del DES e ne hanno chiarito,almeno in parte, il particolare meccanismopatogenetico e cancerogenetico, riassumibile inquesti termini: l’esposizione al DES durante periodicritici dello sviluppo ontogenetico altera in modopermanente la programmazione (epigenetica) deitessuti-bersaglio degli estrogeni, aprendo la stradaa degenerazioni benigne e maligne dei tessuti (inparticolare per ciò che concerne l’apparatoriproduttivo).
MILIONI DI DONNE TRATTATE CON IL DES: IL FARMACO È STATO SOSPESO GIÀ 30 ANNIFA, MA GLI EFFETTI CONTINUANOL’aspetto più preoccupante dell’intera vicendaconcerne, quindi, il problema della possibiletrasmissione transgenerazionale se non di undanno genetico, almeno delle marcatureepigenetiche, indotte da un agente chimico. Tantopiù che ancora oggi, a distanza di decenni enonostante l’uso del DES sia stato bandito da oltre30 anni, se ne continuano a registrare gli effettinegativi e che è stato dimostrato come anche idiscendenti di prima e seconda generazione deitopi esposti al DES presentino un’alta incidenza ditumori dell’apparato riproduttivo. Si tratta di unproblema di grande rilievo, non soltanto per il fattoche le donne trattate col DES sono state, comedetto, milioni, ma anche e soprattutto per ladocumentata azione pro-cancerogena, in certamisura analoga a quella del DES, di molte molecole
(solo in parte note) disperse in ambiente e catenealimentari, dotate di attività endocrino-mimetica edi potenzialità sinergiche.
LA PREVISIONE DI LORENZO TOMATIS:ALCUNI STUDI DIMOSTRANO CHEL'ESPOSIZIONE A CANCEROGENI IN GRAVIDANZA PUÒ PORTARE EFFETTI NON SOLO NELLA PRIMA, MA ANCHE NELLA SECONDA E TERZA GENERAZIONE Dobbiamo anche ricordare come alcuniricercatori avessero perfettamente descritto ecompreso la portata di questo drammaticoepisodio più di 30 anni fa, quando la componenteepigenetica del nostro genoma era poco più cheun’ipotesi. Lorenzo Tomatis, per oltre 10 annidirettore della IARC, per quasi 20 direttorescientifico di ISDE, aveva infatti lanciato l’allarmegià nel 1979, dalle pagine di una monografia delNational Cancer Institute: sottolineando comefosse ormai assodato che l’esposizione di animaliin stato di gravidanza a sostanze chimichecancerogene può indurre la comparsa di tumorinella prole; portando a sostegno della sua tesiuna copiosa documentazione scientifica,concernente 38 differenti sostanze, appartenentia gruppi chimici diversi; ricordando come nonmancassero, purtroppo, neppure le osservazioniepidemiologiche concernenti esseri umani, vistoche già in quegli anni in decine di “figlie del DES”,si era sviluppato un adenocarcinoma della vagina.Partendo da questi dati Tomatis avevaesplicitamente posto il problema della possibiletrasmissione transgenerazionale del cancro,ricordando come alcuni studi condotti su topi eratti esposti ad agenti cancerogeni durante lagravidanza avessero documentato un’elevataincidenza di tumori non solo nella prole di primagenerazione, ma anche in animali della seconda eterza generazione, non esposti a tali sostanze.
LA POSSIBILE TRASMISSIONE DI UN DANNOEPIGENETICO DA UNA GENERAZIONEALL'ALTRANei successivi trent’anni, pur avendo sia Tomatische altri ricercatori, continuato a indagare a fondo

37
il problema, e definitivamente chiarito la differenzasussistente tra un danno genetico individuale daesposizione transplacentare e la possibiletrasmissione transgenerazionale di un dannoepigenetico; pur essendosi accumulate, grazieanche ai grandi sviluppi della ricerca nel campodell’epigenetica, le evidenze di una possibileorigine fetale del cancro, assai poco si è fatto percorrere ai ripari. Eppure è evidente che riconoscerel’importanza di questi meccanismi significherebbenon soltanto riconoscere il ruolo enormementesottovalutato dell’inquinamento ambientale nellagenesi e nell’incremento progressivo dei casi dicancro, ma anche dimostrare come la fase di“iniziazione” tumorale rischi di verificarsi semprepiù precocemente e come i trend di incremento delcancro nella primissima infanzia rappresentino unsegnale di allarme, in relazione ad una possibileamplificazione transgenerazionale delle modifiche(epi)genetiche/ programmatiche e delle patologieconnesse.
NECESSARIA LA VALUTAZIONEDELL'ESPOSIZIONE A UN “CARICO CHIMICO”COMPOSTO DA DIVERSI TIPI DI INQUINANTI Appare ancora approssimativa la valutazione deipossibili effetti sulla salute umana (e sullegenerazioni future) degli inquinanti immessi inambiente. A questo proposito è importantesottolineare come il problema dell’inquinamentodiffuso (connesso alla dispersione, permanenza eaccumulo degli inquinanti nelle diverse matriciambientali, nei singoli organismi e nelle catenealimentari) sia trascurabile se l’obiettivo è ilcalcolo della quota di inquinamento imputabile auna data fonte, ma rappresenti un problema dienorme rilievo se il fine è la valutazione dei dannisulla salute prodotti dal carico complessivo diinquinamento sulle popolazioni in esame. Equesto non tanto perché se l’obiettivo è stabilirel’impatto di una singola fonte di inquinamento sirischia, paradossalmente, di “dimenticare” che lequote d’inquinamento provenienti dalle diversefonti finiscono comunque col sommarsi tra loro;ma anche e soprattutto perché la crescenteesposizione collettiva agli stessi inquinantidetermina un carico chimico di base (chemicalburden) al quale si aggiungono i nuovi inquinantiprodotti, contribuendo all’induzione di quellostress epigenetico protratto che sembra essere lavera causa dei meccanismi (flogogeni e pro-cancerogeni) che sono all’origine delle patologiecroniche e neoplastiche e del loro incremento.
EFFETTI SINERGICI DI MOLTI INQUINANTISULLA POPOLAZIONE ESPOSTA IN MODOCOSTANTE E RISCHIO CONSEGUENTE DIINSTABILITÀ GENETICASe a questo punto cerchiamo di mettere insiemealcuni dei molti pezzi tuttora incredibilmentemancanti nella rappresentazione dominante - la
crescente dispersione in ambiente di agentiinquinanti; il loro accumulo negli organi e tessutidegli organismi superiori, seguito da un lentorilascio in circolo, che si traduce, di fatto, in unaesposizione quotidiana a quantità minimali diagenti epi-genotossici; la loro bio-magnificazionenelle catene alimentari; gli effetti epi-genotossici(spesso sinergici) di molti di questi agenti efattori ambientali, con conseguente stressgenomico persistente e instabilità genetica; latrasmissione transplacentare di questi stessiagenti, in quantità generalmente insufficiente adeterminare danni genetici e sintomi evidenti, masufficiente a interferire con lo sviluppo del feto econ la programmazione di organi e tessuti; lapossibile trasmissione transgenerazionale delle“marcature epigenetiche” - crediamo che moltiaspetti del puzzle che stiamo cercando diricostruire comincino a chiarirsi.
LA PREVENZIONE PRIMARIA: URGENTE UNARIDUZIONE DRASTICA DELL'ESPOSIZIONECOLLETTIVA A TANTI DIVERSI TIPI DIINQUINANTI SPESSO CANCEROGENI E' perciò evidente che per valutare l’impattoambientale e sanitario (nel medio-lungo termine)di una qualsiasi fonte di inquinamento, sarebbepiù semplice e sensato calcolare la tipologia e laquantità totale delle sostanze tossiche prodotte eimmesse in ambiente.Quanto detto fin qui dovrebbe esser sufficiente aconvincerci dell’urgenza di una drastica riduzionedi tutte le principali fonti di inquinamento chepossano ulteriormente incrementare il toxicchemical burden dei nostri bambini e dellegenerazioni future: a cominciare dal trafficoveicolare nelle nostre città e autostrade e dai moltigrandi impianti non necessari e facilmentesostituibili, che immettono quotidianamente inambiente grandi quantità di agenti cancerogeni epro-cancerogeni. Anche per non trascurare lagrande lezione di Tomatis secondo cui perinvertire il trend di continuo aumento di tumoriesiste una strada obbligata, quella dellaprevenzione primaria (cioè della riduzione delcarico chimico globale) e dell’inclusione tra icancerogeni umani di tutte le sostanze per le qualiesiste una sufficiente evidenza sperimentale neglistudi di cancerogenesi chimica.
Il dottor Ernesto Burgio è medico specialista in Pediatria.ISDE – International Society of Doctors forEnvironment è una ONG che ha avuto sezioniattive in oltre 30 paesi ed è riconosciuta da ONUe OMS. In Italia è rappresentatadall’associazione ISDE Italia – Medici perl’Ambiente e ha sede in Arezzo.
Per informazioniemail ISDE ITALIA: [email protected]

38
l’iniziativaL’edizione 2012 di Venezia in Salute al Parco San Giuliano
a cura di Angelo Frascati,medico di medicina generale
Il 20 e 21 ottobre 2012, al Parco di S. Giuliano di Venezia,si è tenuta la seconda edizione di “VIS – Venezia in Salute”,una manifestazione/laboratorio di idee, rivolta ai cittadini con la presenza di Enti, Associazioni, Aziende Ulss e professionisti della salute.

39
UN LABORATORIO DI IDEEÈ in questa ottica che abbiamo fortemente voluto,anche quest’anno, costruire Venezia in Salute nonun evento casuale, ma un laboratorio di idee, diprogettazione, di coinvolgimento, di crescita civilee democratica; una esperienza che vuole ragionarepartendo da una diversa prospettiva: i nostri doverinei confronti della nostra Salute.
IL TEMA CONDUTTORE DI VIS: PREVENZIONEE CONSERVAZIONE DELLA SALUTE,RALLENTAMENTO DELLA MALATTIAIl tema costituente di VIS è come raggiungere econservare la salute ed il benessere e comeprevenire la comparsa di malattie o rallentarne laprogressione. Tale tema, anche nel 2012, è statosvolto con una visione centrata su:• responsabilità del cittadino nel raggiungere
e mantenere la salute ed il benessere, adottando stili di vita sani.
• responsabilità dei medici, degli operatori sanitari e del sistema sanitario, che devono mettere a disposizione della comunità le loro competenze tecniche e relazionali e i servizi necessari.
• incontro tra queste due visioni responsabili.
“SOTTOTITOLO” DELLA MANIFESTAZIONE: “ILPERCORSO DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO”“Sottotitolo” della manifestazione, è stato “Ilpercorso dell’invecchiamento attivo” in occasionedel “2012, Anno Europeo dell’invecchiamentoattivo e della solidarietà tra le generazioni”.
ORGANIZZATORI, COLLABORATORI E PARTNERVenezia in Salute è stato organizzata dal Comunedi Venezia, dall’Ordine dei Medici ed Odontoiatri edalla Fondazione Ars Medica, che ha avuto il ruolodi partner scientifico e organizzativo. Hannocollaborato alla realizzazione dell’evento l'AziendaUlss 12, la Federazione Nazionale degli Ordini deiMedici ed Odontoiatri, l’Ente Boschi e GrandiParchi di Venezia, e ASD Venicemarathon Club.Media partner è stato Il Gazzettino.
VENEZIA IN SALUTE, UN CALEIDOSCOPIO DI INIZIATIVESi è iniziato sabato 20 ottobre, al mattino, con ilconvegno destinato a medici ed operatorisanitari: L’attività fisica adattata (AFA): dalle lineeguida alla Carta dei Servizi.Il convegno è stato promosso da Comune diVenezia, Ordine Medici e Odontoiatri, FondazioneArs Medica e dall’Azienda.Ulss 12, con il patrociniodi Regione Veneto, Provincia di Venezia eFederazione nazionale Ordine Medici e Odontoiatri.Al Convegno hanno partecipato: Rocco Sciarrone,direttore Dipartimento Prevenzione dell'Ulss 12;Federico Munarin, direttore Distretto 3 Mestrecentro; Giampietro Bonivento, primarioRiabilitazione ospedale Villa Salus; Moreno
Scevola, primario Lungodegenza ospedale diNoale; Giulio Bergamasco, medico di medicinagenerale; Renzo Giacomini, presidenteassociazione medici psicoterapeuti; NicolettaCodato, responsabile Programmazione SanitariaComune di Venezia. Hanno concluso i lavori:Maurizio Scassola, presidente Ordine Medici diVenezia e Bruno Centanini, coadiutore delSindaco per la Sanità.

40
AFA: è un acronimo e sta per Attività FisicaAdattata, un programma specifico di esercizisvolti in gruppo ed appositamente disegnati percittadini con malattie croniche, capaci di migliorarelo stile di vita e di prevenire o limitare la disabilità.Dove è già stato sperimentato, si è dimostrato unvalido strumento per la cura delle sindromi algichee per la prevenzione della non autosufficienza,limitando la disabilità legata spesso all’avanzaredell'età. La pratica di un’attività fisica regolare,infatti, ha determinato nei soggetti adulti e negliover 65 effetti positivi a livello fisico, ma ancheimportanti effetti psicologici, quali la riduzionedella depressione e dell’ansia, che hannoincentivato i rapporti socio-relazionali ed hannoindirizzato l’utente verso una maggiore attenzionesulla ricerca di una migliore qualità di vita.L’Attività Fisica Adattata rientra tra le azioniinnovative del Piano di Zona 2011-2015 areaanziani e area disabilità, approvato dallaConferenza dei Sindaci dell’Ulss 12 con deliberan. 2 del 30/9/2011.
La gestione dell’AFA è extrasanitaria e l’accessoavviene su consiglio del Medico di MedicinaGenerale.Sulla scorta dell’esperienza maturata in altreRegioni Italiane, l’Amministrazione Comunale diVenezia, attraverso le sue strutture centrali edecentrate (Municipalità) intende fornire unsupporto informativo e logistico (Palestre) aisoggetti che opereranno nel territorio perorganizzare l’Attività Fisica Adattata.Il primo obiettivo del convegno è stato quello difornire ai partecipanti conoscenze su cosa è l’AFAe su come vuole essere articolata nel territoriodel Comune di Venezia, su come può esseretrasferita questa esperienza in altri territori dellaRegione Veneto. Un altro obiettivo è farcomprendere, dalle relazioni di docentiappartenenti a diverse aree, della Sanità e delleIstituzioni, come l’AFA nasce e si articola in unprogetto interdisciplinare e può realizzarsi soloapplicando Linee Guida che contemplino talecomplessità.
IL VILLAGGIO DELLA SALUTESabato 20 ottobre al pomeriggio ha aperto ibattenti, nel Parco S. Giuliano, il Villaggio dellaSalute un grande tendone con all’interno decinedi stand ed un Area Meeting dove si sono svoltinumerosi incontri durante le due giornate.
GLI ESPOSITORI: ISTITUZIONI, PROFESSIONISTIDELLA SALUTE, ASSOCIAZIONIDopo l’inaugurazione, e in entrambe le giornate,migliaia di visitatori hanno affollato il Villaggiodella Salute, incontrando gli “espositori” presentinegli stands.
ELENCO DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONIATTIVI NEGLI STANDFondazione ARS MedicaOrdine Medici Chirurghi ed Odontoiatri Provinciadi VeneziaOrdini Medici Chirurghi ed OdontoiatriFederazione NazionaleMedici di Famiglia (FIMMG)Medici dello Sport (FMSI) – AMSD VeneziaAssociazione Medici Psicoterapeuti di Venezia(AMP-Ve)OdontoiatriComune di Venezia:• Osservatorio Politiche Welfare• Programmazione Sanitaria• Assessorato Ambiente• Centro DonnaMunicipalità Mestre e CarpenedoBosco e Grandi Parchi VeneziaOrdine dei Farmacisti della Provincia di VeneziaCoordinamento Professioni Sanitarie VenetoRegione Veneto
Azienda Ulss 12 VenezianaAzienda Ulss 13 MiranoOspedale Villa SalusNordic WalkingAmici del CuorePolisportiva Terraglio(GECA) Associazione giovani e cuore aritmico OnlusSpazio 156 FattiDiTango
EVENTI COLLATERALI• Sabato 20 ottobre, al pomeriggio, si è svoltauna camminata nel Parco S. Giuliano organizzatadai Gruppi di cammino al parco del progettoAllenaMente.• Domenica 21 ottobre, al mattino, c'è statal'esibizione di Pedibus, un “autobus umano” natoper andare e tornare da scuola a piedi, chequesta volta, con alcune scolaresche della scuolaprimaria, ha organizzato una escursione nelparco con tre tappe intermedie: osservazionedella laguna, osservazione naturalistica e storiadel parco; ascolto di fiabe lette ad alta voce.• Al termine dell’escursione i bambini hannodegustato le mele biologiche offerte dall’aziendaagricola Biogrignella di Cavarzere della Coldirettidi Venezia e dell’altro cibo inserito nel ProgettoMerenda Sana (attività motoria e alimentazionesana per prevenire sovrappeso e malattie).• Durante tutto il pomeriggio di domenica 21ottobre, nell’ambito del progetto Nati perLeggere, vi è stato un atelier dedicato ai bambinicon lettura ad alta voce da parte di lettorivolontari, attività creative come disegno,costruzioni di marionette e messinscena dispettacolini creati dai piccoli partecipanti.• Domenica 21 ottobre, al mattino, dalla

41
montagnola del parco, osservazione di Venezia e della laguna guidata da Luciano Pescatori.• Sempre al mattino, dal pergolato del lago dellegarzette, nel Parco, osservazione naturalistica e storia del parco guidata da Valeria Ravara.
• Sabato 20 ottobre e domenica 21 ottobre:dimostrazioni e lezioni di Tai Chi da parte diDavide Francesco Mauro.• Dimostrazioni e lezioni di Nordic Walking conescursioni nel Parco.
RELAZIONI AREA MEETING
Per informazioniSegreteria Coadiutore del Sindaco per la SanitàTel. 041 9655483email: [email protected]
Segreteria Ordine Medici Chirurghi eOdontoiatri di Venezia e Fondazione Ars MedicaTel. 041 989479; 041 989582 email: [email protected]

42
L'azienda Ames è una Spa a totale capitale pubblico di cui è unico azionista il Comune di Venezia.Con 30 milioni di fatturato l'anno e 386 dipendenti, Ames è un'azienda che gestisce servizi prioritari anche per latutela della salute pubblica: 15 farmacie comunali e i servizidi ristorazione scolastica.In tempo di crisi comunque l'amministratore delegatoGiampiero Marchese punta per il 2013 ad allargare le partnership anche ai comuni della città metropolitanacioè a tutti i comuni della provincia di Venezia.Una rivoluzione copernicana per rilanciare l'aziendapubblica, ritarare i servizi e mantenere l'occupazione.
Intervista a Giampiero Marchese amministratore delegato di Ames
Farmacie comunali e ristorazione scolastica
Quali sono nello specifico i principali serviziofferti da Ames alla cittadinanza? Qual è lamission dell'azienda?Ames è una Spa a totale capitale pubblico. Amesgestisce ben 15 farmacie comunali: una aPellestrina, una a Murano ed una a Cavallino.Le altre 12 farmacie sono a Mestre.Per quanto riguarda il settore della ristorazionescolastica, siamo stazione appaltante per lacucina centralizzata delle mense di scuolematerne, elementari e medie. Gestiamo invecedirettamente, con nostro personale, tutte lecucine presenti nei 28 asili nido comunali.
I menu sono decisi dagli esperti di Ulss 12 eComune di Venezia, ma realizzati grazie ai nostrioperatori. I rapporti con i comitati mense dellescuole sono gestiti direttamente dal Comune diVenezia, ma Ames gestisce invece direttamente ibuoni mensa. Per il 2013 vorremmo ancheprocedere alla informatizzazione dei buoni mensa.Infine appartiene ad Ames il personale ausiliarioper pulizie, assistenza, ecc. negli asili nido e nellescuole materne comunali. La mission dell'aziendaè sancita da protocolli in cui il Comune di Veneziastabilisce i compiti di Ames, definisce le attività ela gestione del personale dell'azienda.
AMESattività

43
Quale è il servizio svolto dalle farmaciecomunali? Quale è la caratteristiche principaleche può differenziare le farmacie comunali daquelle private?Le farmacie comunali hanno una sensibilitàmaggiore nel prestarsi alla collaborazione allecampagne di tutela della salute pubblica. Questadovrebbe essere la loro specificità.Il Governo ha promosso una importante riformadelle farmacie come presidio sanitario sulterritorio, ma mancano ancora direttive diattuazione a livello nazionale e regionale.Nel 2013 le farmacie di Ames puntano arealizzare quanto previsto sulla carta, sperandoche siano completati tutti i passaggi normativi.L'obiettivo è fare delle farmacie luoghi dipromozione della salute, potenziando i servizi diautoanalisi della glicemia e di tanti altri parametridel sangue, nonché la misurazione dellapressione arteriosa. Diventando tra l’altro puntodi riferimento per la divulgazione delle campagnedi prevenzione. Nel 2013 servirà anche ripensare inostri spazi per poter svolgere al meglio tutte leattività previste.
Negli ultimi tempi sono state avviateparticolari iniziative socio sanitarie sostenuteanche dalle farmacie comunali? Le farmacie comunali si sono impegnate e siimpegnano a collaborare fattivamente allecampagne di prevenzione promosse dall'Ulss 12veneziana.Aspettiamo comunque le direttive attuative dellariforma, anche a livello regionale, per poteravviare concretamente un nuovo piano di attività.
Quali sono i problemi maggiori che vi trovate adaffrontare in un momento di crisi come questo?Negli ultimi due anni la crisi si è fatta sentire inmodo netto sulla spesa sanitaria. Assistiamo adun contenimento della spesa sanitaria nel settore
del farmaco ed a una contrazione delle vendite.Stiamo comunque elaborando un piano permigliorare i nostri servizi, contenendo anche icosti aziendali. Il nostro piano per il 2013saràvalutato dal Comune di Venezia.Sempre nel 2013 oltre ad una più vasta e variagamma di servizi, vorremmo offrire anche unacarta fedeltà per i cittadini che frequentano lefarmacie comunali.Lo sforzo finora è stato quello di mantenerel'occupazione, malgrado l'incalzare della crisi.Questo resta comunque uno dei nostri obiettiviprincipali.Il progetto di città metropolitana, che comprendetutti i comuni della provincia di Venezia, ci fapensare anche ad un possibile allargamento dellanostra partnership pubblica, che permetterebbedi creare nuove sinergie, diffondendo i servizi erecuperando maggiori risorse. Finora Ames esistesolo nel Comune di Venezia, ma proprio perquesto è possibile pensare ad un ampliamentodella partecipazione alla Spa coinvolgendo tutti icomuni della provincia.
A quanto ammonta il fatturato di Ames? Come vengono ripartiti gli utili?Il fatturato di Ames ammonta a circa 30 milioni dieuro l'anno. Gli utili di Ames sono stati versati inparte al Comune di Venezia ed in parte sonoreinvestiti in attività dell'azienda.La grande sfida è rilanciare l'azienda in unoscenario che, a causa della crisi, muta dicontinuo. Occorre avere nuove idee, fornireservizi sempre più efficaci, avviare sinergie.Questi sono i nostri obiettivi a partire dal 2013.
Per informazionisito internet www.amesvenezia.itindirizzo email [email protected]

44
COS'È LA CADUTAPer caduta si intende un improvviso, nonintenzionale, inaspettato spostamento verso il bassomentre si è in piedi, o seduti oppure coricati a letto.La testimonianza delle cadute è basata sul ricordodel paziente e/o la descrizione della caduta da partedei testimoni. Questa definizione include i pazientiche dormendo sulla sedia cadono per terra, ipazienti trovati sdraiati sul pavimento senza motivoevidente, i pazienti caduti nonostante il supporto.
LA PRIMA AZIONE: IDENTIFICARE I FATTORI DI RISCHIOLa prima azione necessaria per la prevenzione
attivitàAssistenza infermieristica
Le cadute rappresentano un problema di significativa importanza sia a domicilio sia nell’ambito del ricovero in ospedale di soggettiadulti, soprattutto anziani. A seguito dell’evento caduta, oltre ai dannifisici, l’anziano sviluppa un forte senso di insicurezza che lo induce a limitare l’attività fisica compromettendo la propria autonomia e la qualità di vita.Tra le lesioni correlate al fenomeno caduta e che portano al decesso i soggetti anziani, il trauma cranico costituisce la prima causa di mortenel 29% degli uomini e nel 14% delle donne. Le fratture degli artiinferiori sono al secondo posto con il 68% nelle donne rispetto al 29%degli uomini.
Il ruolo dell'infermiere per la prevenzionedelle cadute in ospedale. L’esperienzadella Casa di Cura Policlinico San Marco
a cura di Renata Casarin,Responsabile Ufficio Formazione
Casa di Cura Policlinico san Marco

45
delle cadute in ambito ospedaliero, consistenell’identificare i possibili fattori di rischio, inrelazione alle caratteristiche del paziente ed aquelle dell’ambiente in termini di sicurezza, diorganizzazione e di adeguatezza del processoassistenziale.I fattori responsabili delle cadute possono essererelativi alle condizioni di salute del paziente, (etàavanzata, demenza, deficit visivo, vertigini,patologia motivo di un ricovero e/o presenza dipiù patologie, terapie farmacologiche, ridottamobilità o alterata andatura, precedenti cadute epaura di cadere) o fattori relativi agli aspettiorganizzativi della struttura di degenza (ospedaleo altra struttura assistenziale), allecaratteristiche ambientali ed ergonomiche dellastruttura e dei presidi sanitari impiegati(pavimenti scivolosi o con dislivelli, assenza dicorrimano nei corridoi, ausili per ladeambulazione non adeguati…) .
IL PROGETTO DI PREVENZIONE DELLA CASADI CURA POLICLINICO SAN MARCOAll'interno della Casa di Cura Policlinico SanMarco, che accoglie in prevalenza personeanziane, da anni è stato avviato un progetto diprevenzione delle cadute con l’obiettivo divalutare l’andamento del fenomeno cadute ericercare le azioni preventive idonee emonitorarne nel tempo l’efficacia, in un’ottica dimiglioramento della qualità assistenziale esicurezza della persona ricoverata.
I dati raccolti in sette anni dall’avvio del progetto,sono più che positivi: vi è stata una progressivariduzione non solo nel numero di cadute ma anchenella gravità delle lesioni ad esse conseguenti.Nello scorso anno l’incidenza di cadute è risultatapari al 2,07% (su 6387 ricoveri) e le lesioni graviridotte all’1%.Un contributo notevole nel raggiungimento di talirisultati è senz’altro rappresentatodall’assistenza infermieristica.
INTERVENTI PREVENTIVI ED ASSISTENZIALIATTUATINel corso degli anni la formazione esensibilizzazione del personale alla problematica,ha permesso di definire una serie di interventipreventivi ed assistenziali che sonosistematicamente monitorati nell’applicazione.Tali interventi prevedono:• La definizione e documentazione del
cadute: per ogni paziente che viene ricoverato in struttura, indipendentemente dall’età,l’infermiere calcola il rischio utilizzando un’apposita scala di valutazione.
• In base al punteggio ottenuto, il personale infermieristico sceglie ed attua gli interventi di prevenzione più idonei per il paziente (es.cambio calzature, cintura di sicurezza per la carrozzina, ausili per la postura a letto o durante il cammino…).
• Nel caso in cui si verifichi una caduta, il personale compila una scheda segnalazione dell’evento che

46
invia in Direzione dove vengono monitorati i dati e valutate eventuali altre azioni migliorative.
LA COLLABORAZIONE CON GLI OPERATORI PER LE SEGNALAZIONI SUI FATTORI DI RISCHIOLa collaborazione degli operatori dei vari reparti èstata molto preziosa nell’identificare alcuni fattoridi rischio che sono stati nel tempo modificati edannualmente vengono rivalutati e monitorati.Ad esempio: l’analisi dello stato dellapavimentazione e riparazione anche per minimidissesti sia nelle stanze che nei corridoi, sostituzionegraduale dei letti fissi con letti ad altezza regolabile,acquisto di letti a doppia mezza spondina per lato(che assume quindi scopo preventivo e non dicontenzione), acquisto e manutenzione ausili per lamovimentazione del paziente, affissione di posterinformativi in tutte le stanze.
UN PROTOCOLLO INTERNO PER TUTTO IL PERSONALENel corso degli ultimi mesi, un gruppo di lavorodedicato composto da medici, coordinatori edinfermieri, ha definito un Protocollo interno per laprevenzione e gestione delle cadute, rivolto atutto il personale della struttura.In tale occasione è stata puntualizzatal’importanza di continuare la formazione edaggiornamento del personale al fine di garantirela migliore qualità assistenziale.Identificare il rischio caduta non è sufficiente:occorre conoscere gli interventi di prevenzioneche risultano essere più efficaci ed applicabili,scegliere l’intervento più idoneo per quelpaziente, attuarlo nei tempi e modi prestabiliti.
IL RUOLO DELL'INFERMIERE Multifattoriali sono i fattori di rischio e così puregli interventi preventivi, personalizzati in base al
livello di rischio emerso.L’infermiere valuta la collocazione del pazientenella stanza più idonea, fornisce i supporti piùappropriati per il letto e per la carrozzina, siaccerta della funzionalità del sistema diilluminazione, in particolare di notte. Si occupadel monitoraggio di parametri come la pressionearteriosa e il dolore, della corretta gestione diun’urgenza minzionale o incontinenza, dellapostura e deambulazione dei pazienti, anche coneventuale utilizzo di ausili, valuta la presenza divertigini, oltre ad un regolare ritmo sonno/veglia.Nella prevenzione delle cadute, fondamentale e trasversale è l’educazione al paziente e/o al familiare (care giver), pertanto all’infermiere è richiesta anche una competenza educativo-relazionale che contribuisca a motivare pazientee famiglia alla cooperazione per il raggiungimentodel risultato.All’interno della struttura ogni infermiere cheprende in carico un nuovo paziente, dedica tempoall’educazione, sia all’ingresso che durante ilricovero. Le informazioni fornite durante il colloquiovengono supportate e rinforzate da un opuscoloinformativo che sintetizza i comportamenti piùsicuri per la persona anziana a rischio caduta.
LA COLLABORAZIONE CON I FAMILIARI DEI PAZIENTIImportante è la ricerca della collaborazione attivadei famigliari che sono senz’altro una risorsanell’assistenza all’anziano, in particolare nellafase di dimissione dall’ospedale.La consapevolezza, da parte della famiglia, delrischio cui l’anziano può andare incontro anche alproprio domicilio, è senz’altro il punto di partenzaper rendere più efficace il supporto dell’infermierein termini educativi anche in un’ottica di continuitàdelle cure ospedale-domicilio.
L'articolo qui pubblicato è proposto dal CollegioInfermieri di Venezia per evidenziare l'importanzadel ruolo dell'infermiere professionale all'internodella struttura ospedaliera.La Casa di Cura Policlinico san Marco èconvenzionata con la Regione Veneto.
Per informazioniUfficio FormazioneCasa di Cura Policlinico San Marco Via Zanotto, 40 – 30173 Mestre – Ve 041 5071849; fax 041 0998849email:[email protected]
Collegio Infermieri della provincia di VeneziaP.le Leonardo da Vinci, 8 (scala f) – MestreVenezia041 5055951; fax 041 5040882sito internet: www.ipasvive.it

47
La riorganizzazione deiservizi sanitari territoriali.Tutelare e migliorarel’assistenza ai cittadini
a cura di Salvatore Lihard,Movimento per la Difesa della Sanità pubblica
Movimento per la Difesa della Sanità pubblica
punti di vista
Negli ultimi tempi la mobilitazione di associazioni e comitati di cittadini e del Consiglio comunale si è concentrata sulla difesa e sulla valorizzazionedei due ospedali dell'Ulss 12: l'ospedale civile di Venezia riconosciuto dal nuovo Piano SocioSanitario Regionale come ospedale di rete e l'ospedale dell'Angelo a Mestre riconosciuto dal Piano come ospedale di riferimento provinciale.Mobilitazioni legittime e sacrosante, ma che vannoposte all'interno di un quadro generale che devetenere in seria considerazione l'aspettodell'assistenza territoriale.

48
SUPERARE LA VISIONE OSPEDALOCENTRICAQuante volte abbiamo discusso di dimissioniprotette, ricoveri impropri, intasamento deiPronto Soccorso (soprattutto sabato edomenica), ruolo dei medici di medicina generale(e guardie mediche)?Per tale semplice considerazione, allora, è benevalutare alcune recenti normative (nazionali eregionali), sicuramente positive, ma che ènecessario applicare nella loro completezza.È un'impresa ardua? È possibile usciredefinitivamente dalla cultura “ospedalocentrica”?
IL NUOVO DECRETO LEGGE DEL GOVERNOPER UN’ASSISTENZA SUL TERRITORIO 24ORE SU 24Il 13 settembre 2012, il Governo interviene con undecreto legge, n.158, che reca “disposizioniurgenti per promuovere lo sviluppo del Paesemediante un più alto livello di tutela della salute”.Il provvedimento entrato in vigore il 14 settembre2012, evidenzia che nell'ambitodell'organizzazione distrettuale, bisogna garantirel'attività assistenziale per l'intero arco dellagiornata e per tutti i giorni della settimana.
LE AGGREGAZIONI TERRITORIALI DI SERVIZISecondo il decreto legge occorre mantenereun'offerta integrata delle prestazioni dei medici dimedicina generale, dei pediatri di libera scelta, dellaguardia medica, della medicina dei servizi e deglispecialisti ambulatoriali, adottando formeorganizzative monoprofessionali, denominate:“aggregazioni funzionali territoriali”, checondividono, in forma strutturata, obiettivi epercorsi assistenziali, strumenti di valutazione dellaqualità assistenziale, linee guida, audit e strumentianaloghi. Si citano anche forme organizzativemultiprofessionali, denominate “unità complesse dicure primarie”, in grado di erogare prestazioniassistenziali tramite il coordinamento el'integrazione dei professionisti delle cure primariee del sociale a rilevanza sanitaria.Le Regioni disciplinano le unità complesse di cureprimarie privilegiando la costituzione di reti dipoliambulatori territoriali dotati distrumentazione di base, aperti al pubblico pertutto l'arco della giornata, nonché nei giorniprefestivi e festivi con idonea turnazione, e cheoperano in coordinamento e in collegamentotelematico con le strutture ospedaliere.
IL PATTO TRA REGIONE E MEDICICONVENZIONATIIn Veneto la Giunta Regionale ha emesso duedelibere, la n.41 e la n.1666, nelle quali vieneproposto per la prima volta un “pattoreciprocamente vincolante tra Regione e mediciconvenzionati” legato al raggiungimento di alcuniobiettivi di sistema, finalizzati al miglioramentodel Servizio Socio-Sanitario regionale.
Tali obiettivi riguardano:• lo sviluppo su tutto il territorio regionale di un
modello di una rete assistenziale che veda coinvolti, oltre ai medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, anche i medici di continuità assistenziali (guardia medica) e gli Specialisti ambulatoriali interni, prevedendo una rimodulazione dell'offerta assistenziale (ampliamento degli orari di apertura degli ambulatori) e rispetto di specifici obiettivi di salute (ad esempio: continuità delle cure per i pazienti post-acuti in dimissione dall'ospedale o per i pazienti fragili con patologia cronica stabilizzata);
• l'attuazione della Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT), tramite obiettivi di salute e modalità organizzative del servizio (verso la continuità assistenziale di 12 ore);
• i percorsi di appropriatezza necessari ai fini di migliorare la qualità del servizio e di consentire una nuova dimensione dell'offerta che privilegi l'assistenza territoriale.
LE AZIONI CONSEGUENTI ALLE DELIBEREREGIONALIIn questo contesto, le azioni da avviare riguardano:• la definizione dei Piani Aziendali per il
potenziamento delle cure primarie, in cui assume un ruolo strategico l'appropriatezza nelle seguenti Aree: ricoveri ospedalieri,prestazioni specialistiche e farmaceutiche;
• l'ampliamento percentuale dei Medici di medicina generale aggregati in forme organizzative evolute: Medicine di Gruppo;
• la definizione a livello locale di una rete assistenziale in cui siano ben definiti i nodi,i ruoli, e i percorsi assistenziali;
• il collegamento informativo/informatico sia orizzontale che verticale.
LE PREOCCUPAZIONI PER LE PROSPETTIVEDELLA SANITÀ PUBBLICAPer facilitare la migliore applicazione, la Regioneha predisposto addirittura un “Manualeoperativo” sulle disposizioni. Purtroppo, nellaUlss 12 gli intenti delle due Delibere di GiuntaRegionale qui citate, sono state finora disattese.E ci preoccupano ancora di più gli ultimiprovvedimenti governativi a partire dalla legge di“revisione della spesa”, fino al decreto correttivoultimo che penalizza ulteriormente ilfinanziamento al Servizio Sanitario nazionale.Una “cura dimagrante” insostenibile che porteràad una drastica riduzione dei posti-letto, e ad unadequalificazione dei servizi territoriali.Si registra infine un ritardo della Regione Venetoper rendere operativo il nuovo Piano Socio-Sanitario regionale, varato dopo oltre 15 anni.

49
punti di vistaElettrosmog
I giudici della Sezione Lavorodella Cassazione (Sentenza n. 17438 del 3-12.10.12) hannopienamente e definitivamenteconfermato la Sentenza dellaCorte d’Appello di Bresciariguardante il caso di un malatodi tumore al nervo trigemino a causa dell’intenso uso per lavoro di telefoni mobili(cellulari e cordless).
Telefoni mobili e tumori alla testa.Una sentenza di condanna dellaCassazione
a cura di Laura Masiero,presidente associazione A.P.P.L.E.

50
I PRINCIPI DELLA SENTENZAI Giudici della Cassazione hanno: 1) ribadito la validità dei riferimenti scientificicitati dal consulente tecnico di Brescia e daiconsulenti del ricorrente: l’oncologo che lo avevaseguito e il Prof. Angelo Levis già Ordinario diMutagenesi Ambientale all’Università di Padovacofondatore della Associazione A.P.P.L.E. per laparte epidemiologica;2) nuovamente spiegato la causa delle discrepanzetra gli studi e i giudizi apparentementetranquillizzanti (Progetto Interphone: IARC, CE,ICNIRP, OMS, ma anche Compagnie di telefoniacellulare internazionali e nazionali) e quelli moltoallarmanti del gruppo Hardell;3) recepito ancora una volta il tema dei conflitti diinteresse e dei conseguenti “business bias” cherendono palesemente ininfluenti i risultati deglistudi scientifici che ne sono gravati4) ricordato il principio generale – estensibile atutte le patologie e ed eventuali cause lavorativecorrelate anche se non tabellate dall’INAIL – inbase al quale può essere comunque valutata la“ragionevole certezza” del rapporto causa-effettoche dà luogo a un “rilevante grado di probabilità”.
VERSO IL RICONOSCIMENTO DI ALTREPATOLOGIE CORRELATE ALL'ELETTROSMOGQuesta sentenza facilita il percorso di altre causesu casi di tumore da esposizioni lavorative sia aCEM/ELF (linee elettriche ad alta tensione) che aradiofrequenze (non solo cellulari e cordless, maanche radioemittenti e radar), ma potrebbeaprire la strada per il riconoscimento e il
risarcimento anche di patologie acute di varianatura dovute ad esposizioni a CEM, e persino apatologie imputabili ad altri agenti ambientali“non tabellati” dall’INAIL.
NECESSARIO UN IMPEGNO DEL MINISTEROCONTRO L'USO INDISCRIMINATO DEL CELLULARESe questa sentenza è indubbiamente un passoavanti fondamentale per il riconoscimento deidanni oncologici provocati da esposizione a CEM,bisogna purtroppo constatare che, a distanza diun anno, non c’è segno che sia in fase direalizzazione l’impegno per una “campagna diinformazione indirizzata ad un uso appropriato enon smodato e indiscriminato del telefonocellulare” che il Ministero della Salute per mezzodel Consiglio Superiore di Sanità si eraimpegnato a realizzare col comunicato n. 226 del15.11.2011 pubblicato dopo la trasmissione diReport sull’argomento (27.11.11) e ripreso da varietestate giornalistiche. Impegno ribadito anche direcente in risposta al quesito posto al Ministeroda un Avvocato colpito da tumore al cervellodopo uso intenso e prolungato del cellulare (LaGazzetta del Mezzogiorno del 08.10.12).
Per informazioniAssociazioni A.P.P.L.E.Tel. 049-8750240 indirizzo email: [email protected] internet: www.applelettrosmog.it

Rivista ViS “Venezia in Salute”registrazione al Tribunale di Venezia numero 12 del 31/03/2012numero 5 – dicembre 2012/gennaio 2013
direttrice responsabileNicoletta Benatelli
editoreDirezione Affari Istituzionali del Comune di Venezia
comitato editorialeLuigi Bassettodirettore Affari Istituzionali e vice direttore generale delComune di VeneziaBruno Centaninicoadiutore del Sindaco di Venezia per la Sanità
segreteria tecnica / diffusione della rivistaValentina VerioliSegreteria Coadiutore del Sindaco per la Sanitàsegreteria di redazioneNicoletta Codato, Veronica VentoServizio Programmazione Sanitaria del Comune di VeneziaAnna Zanetti, Cinzia Trevisansegreteria Direzione Affari IstituzionaliGabinetto del Sindaco
inserto speciale FOCUS ULSS 12 in collaborazione con l’azienda Ulss 12comunicazione Maria Grazia Raffele
realizzazione grafica di VisElisabetta Cattaneo Centro Produzione Multimediale del Comune di Venezia
La rivista VIS è solo on line, pubblicata sul sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it,sezione “Mi interessa” e poi sezione “Vivere in salute”ed infine “Venezia in salute”
Per contatti con la [email protected]. 041 9655483
V E N E Z I A I N S A L U T E
èèA.P.P.L.E., ASSOCIAZIONEPER LA PREVENZIONE E LA LOTTAALL’ELETTROSMOG
A.P.P.L.E. è una Associazione di PromozioneSociale, apartitica e senza fini di lucro, iscritta al registro della Regione Veneto. Nata nel 2001 a Padova si occupa di inquinamentoelettromagnetico a livello locale, regionale e nazionale; ha funzione di coordinamento e sportello informativo per cittadini, comitatispontanei e associazioni localmente impegnatesu questo tema.A.P.P.L.E. ha come obiettivi principali: - la divulgazione di informazioni tecniche e scientifiche sulle tecnologie che emettono campielettromagnetici (C.E.M.) e sugli effetti biologici e sanitari conseguenti;- promozione della tutela della salute dell’uomo e dell’integrità dell’ambiente dalle esposizioni ai C.E.M.
Per [email protected] 8750240
Non c'è nessuna strada facile per la libertàNelson Mandela
LA REDAZIONE DI VIS AUGURA A TUTTI UN 2013 DI SALUTE E SERENITÀ!