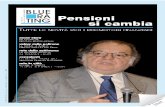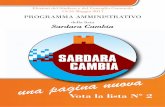Mobile Revolution | Cosa cambia per le persone, cosa cambia per i designer.
LA SCUOLA CHE CAMBIA, Regole di spazio
-
Upload
andrea-pennisi -
Category
Documents
-
view
218 -
download
3
description
Transcript of LA SCUOLA CHE CAMBIA, Regole di spazio
LA SCUOLA CHE CAMBIA
Regole dello spazio
I cambiamenti della società e della tecnologia sono accompagnati da cambiamenti dei modelli di apprendimento e delle forme del sapere, sono e seguiti dal cambiamento dello spazio dell’apprendimento e dell’architettura i.I passaggi storici della trasformazione in Italia passano anche dalla organizzazione degli edifici scolastici e - con una visione più attenta – si possono distinguere anche i segnali della organizzazione della società che verrà.Guardando all’evoluzione della scuola Italiana si possono sintetizzare sei modelli, ogni uno dei quali rappresenta un frammento di contesto culturale, di modello didattico e di soluzioni spaziali, mediamente coerenti fra loro.I passaggi da un modello organizzativo e spaziale all’altro non sono mai lineari e coesistono ancora in buona parte fra loro anche nella scuola di oggi. Essi sono scanditi da alcuni momenti chiave che possono essere rappresentati dalla formazione della scuola dell’obbligo nei primi anni del 900, alla definizione delle linee guida per l’architettura scolastica del 1975 che segna la strada per il progetto della scuola contemporanea italiana, fino alle recenti direttive comunitarie e le linee guida nazionali che definiscono gli obiettivi per il futuro dell’istruzione pubblica.
La scuola dell’alfabetizzazioneLa scuola per l’alfabetizzazione - che in Italia nasce con ritardo rispetto al testo 29/05/2014 document.doc 1
d’Europa all’inizio del 900 – definisce il sapere distinguendo in cultura classica e il sapere tecnico. Con varianti e modifiche è il modello dominante fino agli anno 70. Tale impostazione è il corrispettivo del mondo industriale che sta per delinearsi.Il modello didattico prevalente è il “comportamentismo” in cui la programmazione è per obiettivi e l’insegnamento viene progettato in funzione di traguardi d’apprendimento che sono definiti preventivamente e descritti in modo chiaro e preciso.Il modello di spazio che ne nasce è rappresentato dall’istituto scolastico che è un soggetto architettonico ricorrente nel rinnovo urbanistico ottocentesco e del periodo fascista e che - anche con ampliamenti e modifiche - costituisce l’ossatura portante dei una buona parte del patrimonio di edilizia scolastica del nostro paese.
La scuola della crescita e della democrazia Con il Decreto Ministeriale del 1975, che definisce le linee guida della progettazione degli edifici scolastici fino ai nostri giorni, prende forma la scuola della crescita sociale e della democrazia matura: la scuola diventa un riferimento di sviluppo per la città; diventa multifunzionale e si apre al quartiere e coinvolge le famiglie.Il contesto scoiale nel quale si sviluppa è molto più dinamico, e quindi è più dinamico il modello didattico che viene espresso. L'attivismo pedagogico di Dewey si fa spazio nei modelli pedagogici per è centrale la creazione di una scuola non convenzionale, non impostata sul nozionismo e sull'ascolto passivo degli insegnanti o lo studio individuale come erano state le scuole sino ad allora, bensì eretta sugli interessi dei discenti. Il rinnovo della forma dell’edificio scolastico - che si realizza prevalentemente nelle prime cinture urbane delle città -nasce quindi dal rinnovo del programma didattico e si declina in architettura con l’idea dell’open-space, con la multifunzionalità, il simbolismo degli spazi, la flessibilità degli arredi.
La scuola dell’interattivitàLa scuola globale, connessa e smartii è quella che si inserisce nella comunità globale attraverso la diffusione pervasiva di Internet e l’apertura della scuola a tutta la cittadinanza, proponendo un tipo di formazione continua. Questo porta all’evoluzione esponenziale delle idee perché il sapere è condiviso in rete e si arricchisce di ora in ora dei contributi di tutta la comunità.Il modello pedagogico è incentrato sul continuo fare esperienza e il sapere deriva dal i Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition,
Sigfried Giedion, Harvard University Press, 1941ii Un metodo di progettazione di qualità per la rigenerazione della
scuola in Calabria, da Dal banco alla nuvola, Giuseppe Longhi29/05/2014 document.doc 2
modo, dai mezzi, dalla nostra disposizione nell’osservarla, conoscerla e comunicarla. Si forma nei processi d’interazione ed attraverso l’attribuzione di significati alla nostra esperienza. La definizione dello spazio di tale impostazione pedagogica è rappresentata - non tanto da edifici – ma dai modelli progettuali immaginati negli anni settanta da Christopher Alexander e Cedric Price che usano le nuove regole della cibernetica per definire le regole di progettazione attraverso una costante e rapidissima interrelazione casuale di connessioni logiche dei dati presenti nella memoria iii. Fanno il loro ingresso nelle scuole i primi computer e la progettazione è incentrata sullo spazio che informa e che fa parte integrante del quadro formativo iv.
La scuola globaleL’aumento della demografia, la globalizzazione economica, la consapevolezza della limitatezza delle risorse – temi sanciti formalmente dalla Conferenza sull’ambiente di Rio del 1992 –, aprono la strada a importanti azioni strategiche collettive coordinate degli organismi internazionali. Il sapere e le risorse umane diventano le nuove risorse strategiche per lo sviluppo sostenibile.Dal punto di vista pedagogico in Italia si rafforzano e diffondono i principi costruttivisti e si rafforza la centralitàv del soggetto e il principio di apprendimento adhocratico e continuo. Le Linee guida del D.M. 11/04/2013 sono la trasposizione di questi principi e propongono un’idea di scuola adattabile, flessibile ed inclusiva.La complessità di progettazione dell’edificio si riflette anche nel disegno degli spazi interni, o più in generale dei microspazi, a causa dei feedback tra corpo umano e spazio fisico e virtuale della scuola e sono formalizzati principi di progetto degli spazi della coesione, della sperimentazione, di apprendimento, spazi tecnici, spazi intelligenti, monitoraggio, integrazione col contesto.
iii Nicholas Negroponte, Toward a Theory of Architecture Machines”, 1969
iv Loris Malaguzzi, verifica fontev JRC, School's Over: Learning Spaces in Europe in 2020:
An Imagining Exercise on the Future of Learning29/05/2014 document.doc 3
Scuola sostenibileLa consapevolezza della limitatezza delle risorse naturali e l’apertura della scuola verso un ruolo educativo collettivo e di rigenerazione urbana sono il contesto nel quale prende forma la concezione olistica del sistema educativo. Le risorse intellettuali, fisiche e naturali contribuiscono assieme alla costruzione del progetto pedagogico.L’edificio scolastico è il terreno di sperimentazione per l’architettura di questo processo olistico: le risorse naturali concorrono alla definizione spaziale per quanto riguarda le caratteristiche climatiche e di consumo energetico.
La scuola Fab/labLa recente evoluzione digitale trasferisce la sua influenza dalla organizzazione virtuale alla organizzazione fisicavi e la metamorfosi del sistema del mercato del lavoro articolato nel pensiero di Andre Gorz vii, mettono in discussione il sistema del sapere e dell’organizzazione della scuola. L’industria creativaviii utilizza la cultura come input, anche se i suoi output sono di carattere principalmente funzionale. La creatività, dunque, utilizza la cultura come risorsa produttiva e, diversamente da quanto avviene per l’industria della cultura, la creatività è capace di produrre industrialmente beni e servizi capaci di generare un ritorno economico quantificabile.La scuola ricongiunge il sapere teorico al sapere pratico attraverso la possibilità di produrre in real-time gli oggetti ideati dalla comunità scolastica secondo modalità open e l’apprendimento diventa un processo continuo che richiede spazi connessi 24 ore su 24.
REPERTORI
vi Neil Gershenfeld, How to Make Almost Anythingvii Andre Gorz, L'immateriale, Torino 2003viii La Commissione Europea, nel Libro Verde su “Le Industrie culturali
e creative, un potenziale da sfruttare”29/05/2014 document.doc 4