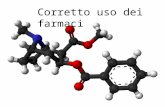LA FAMIGLIA E LE DONNE NEL RINASCIMENTO … · Web viewEsso non significa quindi una rottura...
Transcript of LA FAMIGLIA E LE DONNE NEL RINASCIMENTO … · Web viewEsso non significa quindi una rottura...
LA FAMIGLIA E LE DONNE NEL RINASCIMENTO A FIRENZE (modulo B)
1. L’INVENZIONE DEL PASSATO FAMILIARE A FIRENZEI libri di famiglia fiorentini (XIV-XVI secolo) avevano delle funzioni principali: trasmettere un’esperienza, mettere a parte di conoscenze, obbligazioni, errori commessi. Dunque non solo annotare tutte le notizie utili per gli affari correnti, ma preparare l’avvenire. A fianco di quest’opera immediata opera una memoria capace di spingersi molto più indietro, in grado di interrogare il passato più lontano della famiglia. Con sollecitudine, la borghesia mercantile fiorentina si dedica, dopo il 1350, alla memoria delle proprie origini. Alcuni testi, pubblicati dal XVIII secolo, hanno fatto conoscere le forme più compiute: la Cronica domestica di Donato Velluti, i Ricordi di Giovanni di Pagolo Morelli, la Cronica di Buonaccorso Pitti,…. Vi è tutta una folla più oscura di cronisti familiari che cedono all’ispirazione genealogica. Nelle forme più elaborate, dall’inizio un solenne esordio si incarica di avvertire il lettore che l’argomento è importante. La maggior parte delle ricordanze, tuttavia, non sfocia su un’inchiesta ordinata, e neppure su una esposizione strutturata. Questi libri conservano allora il marchio della registrazione quotidiana, il carattere spezzettato e discontinuo degli avvenimenti annotati giorno dopo giorno. Ancor più modestamente, la maggior parte delle notizie che gli autori delle ricordanze redigono sulle loro famiglie sono introdotte senza alcun preavviso nel bel mezzo delle più banali occorrenze quotidiane. La sovrapposizione di questi due diversi tipi di ricordo ci spinge a porci delle domande tanto sui legami funzionali che li uniscono, quanto sui metodi di lavoro di questi memorialisti e sulle loro fonti.(IL NOME COME SUPPORTO DELLA TRADIZIONE) I Fiorentini che tra il 1300 e il 1530 trattano la storia della loro famiglia, asseriscono di basarsi su di un’antica tradizione orale. Osserviamo che questa tradizione non travalica mai il Medioevo, e che nessuno ha l’imprudenza, a Firenze, di attribuirsi origini romane prima del XVI secolo. Gli informatori dei nostri inquisitori sono più modesti. Le tradizioni che riferiscono riguardano un passato inaccessibile attraverso altre fonti,e tuttavia ancora recente (es. Donato Velluti dice di averlo udito da suo padre, Lapo Castiglionico da una servitrice di sua nonna). Il fatto che tali annotazioni siano rare non riduce l’importanza delle informazioni trasmesse dai vecchi. Il passato che essi evocano conferisce un senso ai segni attuali dell’identità famigliare collettiva: il nome, lo stemma, le terre e le case possedute. La memoria degli anziani è preziosa. È in effetti a partire da quest’epoca che una stirpe onorata si riconosce dal fatto di portare un nome ereditario, trasmesso in linea maschile. Ognuno si rende conto, a Firenze, che l’antichità di questo nome è garanzia di rispettabilità per la famiglia che lo porta. Eppure, questa ha di solito una nozione confusa dell’origine del nome del momento in cui si è fissato. Ed è a questo punto che entrano in gioco le testimonianze degli “antichi” della stirpe (es. Doffo Spini afferma che gli Spini hanno tratto il loro nome da un certo Spina cinque generazioni prima…da lui è in grado di ricostruire la genealogia, ma prima si deve rifare alla tradizione famigliare). Ma è pur sempre una memoria abbastanza povera. Non permette, in particolare, agli indagatori di chiarire i legami genealogici precisi che la loro stirpe intrattiene con altri lignaggi imparentati, i “consorti”, come sono chiamati a Firenze. Nessuna delle genealogie che i Fiorentini sono in grado di ricostruire si estende in ampiezza di là dalla quarta o quinta generazione; ed è a questo livello che generalmente si colloca l’eponimo. La litania di nomi propri che i Fiorentini enumerano quando si presentano nel preambolo dei loro scritti sembrerebbe comunque indicare che era importante far partire il ramo dal quale uno discendeva da più in alto della quarta o quinta generazione. Di fatto la serie dei nomi mostra di avere un duplice ruolo. Da un lato, identifica l’individuo all’interno del suo lignaggio. Ma dall’altro essa funziona anche come indicatore di condizione sociale; in questo secondo ruolo non implica una conoscenza dettagliata dell’intero campo genealogico (come afferma Lapo Castiglionico). È così che la memoria famigliare e la tradizione orale sanno far risuonare fin verso il 1400 il ricordo di una parentela vecchia di duecento anni o più; ma esse si riconoscono incapaci di dar corpo alle rappresentazioni che si poteva fare degli antenati di là di 120 o 150 anni, oltre ai quali non vi era che una semplice serie di nomi sopravvissuti al naufragio del tempo.(STEMMI E STORIE DI FAMIGILA) Doffo Spini considera gli stemmi, nel modo in cui gli collega con i ricordi delle persone cariche d’anni, testimonianze sulle più remote peripezie della stirpe altrettanto degne di fede dello stesso nome; e vi sa leggere un messaggio che egli è il solo, con gli altri antichi, a essere in grado di decifrare e trasmettere. In queste memorie di famiglia, in effetti, gli stemmi appaiono spesso come l’estremo testimone di un’unità perduta. Una schiatta che si conquista la sua autonomia nei riguardi del ceppo originario, un lignaggio che si divide in diversi segmenti prendono un nome nuovo, ma conservano spesso insegne dell’antico clan
famigliare al quale continuano a sentirsi collegate. Il fatto di portare insegne identiche è di per sé indizio di parentela, anche lontana. Oppure, può nascere il sospetto di un’usurpazione fraudolenta. (es. Donato Velluti scopre che la famiglia dei Velluti sarebbe originaria di Semifonte, distrutta dopo un lungo assedio di Firenze nel 1202; egli in realtà non ne ha la certezza, ma ciò colloca i suoi antenati in uno spazio e in un tempo precisi, quelli della prima espansione fiorentina. Anche Buonacorso Pitti colloca a Semifonte le origini della sua famiglia, da dove, poiché sostenevano la causa di Firenze, erano stati cacciati dai Ghibellini che qui opponevano resistenza).(TORRI E DIMORE. LUOGHI E OGGETTI DELLA MEMORIA) Se dunque i nomi e le insegne hanno questo ruolo di fissatori, non sono tuttavia sufficienti per l’immaginazione. Così, la memoria familiare trova il modo di radicarsi con maggior durata e consistenza nei luoghi che gli antenati hanno frequentato. La maggior parte dei racconti pretendono di situarne la culla vuoi in un castello o un semplice villaggio della campagna fiorentina, vuoi in una regione del contado. Tutti questi luoghi di campagna formano ancora soltanto un paesaggio di sfondo, immerso nella penombra di un parziale oblio, anche quando la famiglia ha conservato dei beni in quella regione, e si sforza di stringere alleanze con famiglie provenienti dallo stesso posto. Le dimore fiorentine, che hanno contorni più netti, sono conosciute per i loro rapporti di vicinato e le loro configurazioni; come primi impianti degli antenati immigrati nella città, esse reggono più efficacemente l’evocazione dei momenti in cui la famiglia ha assunto i suoi connotati urbani. E sono esse a costituire un legame con il tempo presente: spesso le famiglie restano fedeli al quartiere dove per la prima volta hanno messo radici. Queste dimore sono sicuramente il centro delle reti di clientele e di amicizie che costituiscono la forza di una stirpe. Le più antiche conservano ancora l’apparato difensivo che poteva facilmente trasformarle in vere fortezze. Esse rappresentano la facoltà di sopravvivenza di una stirpe, la sua forza vitale. Le dimore costruite dagli antenati inurbati assumono dunque all’incirca la stessa funzione simbolica dello stemma o del nome. In esse poi affondano i sentimenti più profondi che determinano l’appartenenza a un gruppo; ed è questo che esprime, a Firenze, la comune denominazione casa usata per la dimora e il lignaggio. Tutto ciò che contenevano queste case viene a far parte della loro definizione. Alla fine del XIV secolo comincia a verificarsi una considerevole diversificazione del mobilio. Nei libri di casa si osserva una vera passione per l’inventario dei mobili. Alcuni di tali oggetti hanno un valore supplementare, perché rimane loro attaccato qualche riflesso del passato (es. Sella da trofeo di Doffo Spini).(“LE NOSTRE CARE SCRITTURE”) A partire dalla fine del XIV secolo, i Fiorentini sono degli infaticabili scribacchini. La coscienza che essi acquistano i quest’epoca, di dover trasmettere ai discendenti il loro bagaglio di conoscenze sul passato della famiglia, si poggia sull’abitudine di registrare per iscritto tutti gli avvenimenti della vita quotidiana (dal 1350). Di qua dalla zona del passato che viene reinventata dal ricordo e dalla tradizione più diffusa della famiglia, si estendono i cento o cento cinquant’anni che sono il tempo degli avi più prossimi. Per questa fascia di tempo, i redattori di cronache familiari conducono le loro inchieste con altri metodi. Certo, essi continuano a sollecitare la testimonianza dei membri della stirpe ancora in vita, ma la maggior parte dei fatti sono raccolti dai depositi degli archivi ai quali hanno accesso. Così, essi possono precisare quali funzioni comunali abbiano esercitato alcuni antenati o parenti, quale ruolo abbiano avuto nella vita politica delle città, le guerre private o le rappacificazioni intervenute tra diverse famiglie. La riflessione sugli avvenimenti nei quali si sono trovati coinvolti può allora sfociare in una storia vera e propria. I cronisti non sembrano tuttavia privilegiare i materiali tratti dagli archivi cittadini, dal momento che dispongono di fonti ben più abbondanti e precise sul passato famigliare: le “iscritture” conservate nella camera del padrone di casa o nello scrittoio del capo di famiglia. Sui suoi libri propri un capo di famiglia deve annotare i conti dell’economia quotidiana e degli affari della casa. A lato dei suoi, sono disposti in bell’ordine i libri che gli ha lasciato suo padre, se è il figlio maggiore. Si tratta di beni preziosi. Quando i Fiorentini devono fuggire la peste o qualche avversità politica, insieme con le loro vesti più preziose sono soliti depositare sacchi e bauli pieni di “scritture d’importanza” presso amici fidati o nei monasteri. E raccomandano continuamente ai loro figli di vegliare con la cura più grande su questa eredità. Dopo del padre, è al figlio maggiore che spetta il compito di conservare libri e scritture (talora in punto di morte consente al figlio di continuare la sua opera). E se a Firenze sono giudicati sfavorevolmente coloro che tengono male i libri o rifiutano di mostrarli ai loro fratelli o ai loro cugini, non vi è crimine peggiore che distruggere gli archivi di famiglia (es. Buonaccorso Pitti critica un cugino che per vendetta aveva bruciato o venduto i libri e le carte rimaste nel suo lato, quello maggiore della famiglia). Da questi depositi famigliari, i Fiorentini attingono in primo luogo la conoscenza del loro passato personale. Sono impazienti di affidare a questi scritti informazioni autobiografiche ricavate dai libri paterni o da
scritture anche più antiche, che, se appartengono a rami cadetti, richiederebbero di non essere più tramandati ai loro discendenti. Li vediamo così cercare la data precisa della loro nascita, ragguagli sulla loro educazione, i loro apprendistati, le circostanze precise del loro matrimonio e le condizioni della dote, sulla cui negoziazione sono spesso rimasti all’oscuro (es. Bernardo: entrambi i figli, Piero e Bartolomeo, ricopiano su propri libri parte dei ricordi del padre e del nonno). Ricerche di tipo analogo forniscono alimento e sostegno alla storia famigliare. Tutti questi avvenimenti, racimolati sul filo dei secoli tra le pagine dei libri di famiglia, raramente sono integrati in un racconti organizzato. Ma taluni autori non si contentano di inserire queste notizie alla rinfusa. Il materiale documentario talvolta è veramente elaborato per se stesso.(CRITICA DOCUMENTARIA E RICOSTRUZIONE GENEALOGICA ) Giovanni Morelli ci fornisce uno splendido esempio del modo in cui un uomo del XV secolo può ricostruire le figure dei suoi antenati a partire da un solo dato rinvenuto tra le carte di famiglia, “in alcune carte di notaio già consumate, stracciate e quasi ispente per antichità”. Dapprima scova una data, il 1170, nella quale un certo “Ruggieri di Calandro di Benamato d’Albertino de’ Morelli” pone la sua firma su di un atto. Ne deduce allora che costui poteva risalire al 1150 circa. Sembrava dunque verisimile che suo padre, Calandro, dovesse avere allora circa trent’anni ed essere nato verso il 1120. e così Morelli arriva ad attribuire a questo Calandro e quindi a suo padre Benamato delle biografie plausibili, “volendo fare di lui alcuna memoria, cercare le circostanze pe’ verisimili che ragionevoli deon essere”. Allo stesso modo, la tradizione familiare attribuisce a Calandro u matrimonio e una nascita fiorentini, e l’aver esercitato il mestiere di tintore; vi sono documenti che avvisano Morelli che ebbe molti figli. Lo scopo di queste deduzioni è quello di determinare la data in cui il primo Morelli si stabilì a Firenze. Morelli suppone che questo primo Fiorentino sia stato Benamato, padre di Calandro, venuto dal Mugello a un’età intorno ai vent’anni; il fatto che prima di sposarsi abbia dovuto fare una qualche fortuna in città, fa dedurre che quando prese moglie fosse sulla quarantina, il che rimanda la data della sua nascita al 1080 circa e quella del suo arrivo a Firenze attorno al 1100. Questi ricercatori lasciano però apparire i loro limiti come storici. Ma non pretendono davvero di esserlo, questi memorialisti dei fatti di famiglia che raramente integrano il passato familiare al passato della collettività, e che privilegiano nel loro intendo l’atto fondatore. Il tempo che essi esplorano non è propriamente storico. È piuttosto il tempo delle generazioni, un tempo del quale l’oblio di uno o due gradini della genealogia ha l’effetto di far attribuire agli antenati delle età favolose, e tutt’al più di far si che ci si interroghi sulla durata della vita di una volta, o sullo scarto che intercorreva tra le generazioni di un tempo. In effetti, il tempo della famiglia non sembra a questi scrittori riconducibile al tempo comune. La storia famigliare non si può misurare con lo stesso metro della storia collettiva. Anzi si costruisce su un insieme di rappresentazioni immaginarie della parentela. La memoria che se ne conserva è ancorata ad oggetti simbolici nei quali si possono decifrare permanenze e spostamenti, ma raramente mutamenti e trasformazioni. Gli eventi e le personalità sono portatori di valori morali. Ma ben dirado queste figure morali sono considerate per quelle loro azioni che avrebbero potuto esercitare un peso sul destino della collettività interna. Da ciò deriva quella mancanza di articolazione che ci colpisce fino alla fine del XV secolo, tra i ritratti di famiglia elaborati dagli autori di ricordanze o di “cronache domestiche”, e la storia comunale.2 LE GENALOGIE FIORENTINENell’abbondante letteratura di famiglia fiorentina la preoccupazione genealogica affiora molto spesso la ricerca sistematica dei legami di filiazione o di parentela acquisita resta l’ambizione di un gruppo relativamente piccolo dei Fiorentini, all’interno del gruppo pletorico dei redattori di libri di famiglia. Gli obbiettivi ostentati da questi genealogisti dilettanti gettano qualche luce sulle loro motivazioni. La prima è il tentativo di supplire alla fragilità degli uomini e dei gruppi che essi costituiscono. Epidemie, disastri delle fortune, rovesci politici suscitano tentativi di salvare dall’oblio qualche frammento del passato (es. Filigno . di Conte de’ Medici che fa iniziare la sua genealogia nel gennaio 1374, in piena peste. Lo stesso fa Donato Velluti; si affrettano a raccogliere il maggior numero di notizie possibili). Due generazioni più tardi (attorno al 1400) cominciano a delinearsi aspirazioni forse nuove (così come si deduce da Giovanni Morelli): consolidare l’assetto politico e la posizione occupata nella città, dal gruppo dei consanguinei. Gli interessi dei genealogisti più antichi sembrano invece essere di ordine privato. Intorno al 1400, la preoccupazione dominante, soprattutto nelle famiglie di più recente fortuna e di posizione scarsamente consolidata, è di dimostrare di discendere da una lunga prosapia, di essere Fiorentini da antica data. È necessario rassicurarla della legittimità delle sue rivendicazioni a esercitare cariche municipali. Allo stesso modo è necessario mostrare la fedeltà della famiglia agli ideali comuni, il rigore della sua fede guelfa: e i racconti familiari sulle origini ne possono arrecare la prova. Infine, bisogna istruire i discendenti su quanto la loro
parentela si estenda in senso laterale; poiché essi devono sapere bene a quale titolo condividono il “divieto” (proibizione di sedere nei collegi e negli uffici comunali), e quali sono gli alleati della loro famiglia, allo scopo di saper manovrare in mezzo agli scrutini e alle elezioni. I Fiorentini hanno dunque numerose ragioni di dedicarsi al gioco della genealogia e di mettere per iscritto le loro ricerche. Il genealogista sottopone quindi i dati che raccoglie a un’elaborazione tendenziosa. Dunque queste rappresentazioni non possono essere prese come semplici rappresentazioni della parentela.(L’INDAGINE GENEALOGICA) La prima rielaborazione del passato famigliare si verifica dunque proprio attraverso il filtro che la conservazione e la disponibilità alla consultazione di questi archivi impongono alla massa di informazioni contenuta nei libri di conti e nelle ricordanze. Nelle copie di atti notarili, o nelle più brevi notizie inserite nei libri di famiglia che ne ricordano il tenore, gli amatori di storia familiare possono trovare nomi, date, menzioni di atti giuridici legati al matrimonio e alla dotta assegnata alle donne, ai decessi e alla trasmissione dei beni ancestrali, alle ripartizioni e alle divisioni tra eredi. Giovanni Morelli, con i suoi silenzi, rivela i limiti della documentazione che un genealogista poteva raccogliere sul proprio lignaggio attraverso queste procedure. Se pure conosce date di nascita dei suoi zii paterni, egli non è più in grado di precisare quelle dei propri cugini germani, figli del maggiore dei suoi zii; e si rifiuta di domandare ai cugini nati dai cugini germani la loro età, per paura che essi credano che voglia “misurar loro gli anni”. Yale osservazione ci permette di indovinare quante attitudini ben radicate nei confronti della vita, della morte e dell’identità potevano essere sconvolte o turbate dalla sola curiosità di un cugino appassionato di storia famigliare. Tuttavia molti di questi genealogisti completano le loro informazioni interrogando direttamente i membri più anziani del loro parentado (il primo ad affermare di averlo fatto è Neri degli Strinati, con persone di entrambi i sessi). È da sottolineare il fatto che anche le donne abbiano preso una loro parte nel lavoro di ricostruzione genealogica, arricchendo le ricostruzioni dei loro nipoti aneddoti, di ritratti e di sprazzi di memoria sulle famiglie di parentela acquisita. Se la scrittura resta maschile, non dimeno il ricordo passa attraverso la parola femminile.(PROSPETTIVE E RAPPRESENTAZIONI GENEALOGICHE) anche quando prendono in considerazione i loro parenti acquisiti, i genealogisti fiorentini hanno come mira principale il gruppo dei discendenti portatori dello stesso nome, piuttosto che la parentela di un individuo particolare. Le genealogie esaminate non fanno risalire mai linee di filiazione a partire da Ego. Al contrario, descrivono tutte una “discendenza”, “progenie”, “schiatta”. Quando i Fiorentini vogliono designare l’insieme dei consanguinei patrilaterali moti o viventi che condividono lo stesso nome, è la parola “casa” che viene usata, nella stessa misura che “famiglia”. E questa “casa” porta con sé tutta una serie di immagini. Più che sbocciar di rami spuntati da un tronco comune, esse evocano i fianchi e le alzate di una solida dimora, ben riparata sotto un tetto la cui sommità sarebbe l’antenato comune. Per designare i rami del loro lignaggio, i Fiorentini parlano anche delle “parti”, o ancor più dei “lati” della “casa”, e del suo “fondamento antico”, piuttosto che di radici o di ceppo (Alberti: come un tesso su una casa). L’altra metafora ricorrente è quella della derivazione a partire da un punto primordiale (Lapo Niccolini: i Fiorentini evocano gli “antichi discesi l’uno dall’altro”). l’universo della propria parentela non si organizza intorno alla figura del narratore; piuttosto si costruisce come una gerarchia derivata secondo generazioni e rami al di sopra dei quali si colloca il grande antenato. Da un genealogista all’altro, le procedure di esplorazione genealogica e di esposizione sono notevolmente omogenee. Gli autori di questi scritti si diffondono in primo luogo sul punto dal quale fanno incominciare la “casa”, il lignaggio, nominando l’antenato comune a tutti coloro che essi intendono riconoscere come membri del gruppo di discendenti derivati da lui. Sopra di lui, tutto quel che fanno è citare una serie di nomi. Da questi lontani antenati non sono spuntati rami avventizi, né altri discendenti diretti di cui essi accettino la parentela. La genealogia si precisa poi ad una biforcazione; è a partire da quest’ultima che si vengono a delineare sia i rami cugini della stirpe, sia due lignaggi che portano nomi differenti ma che si riconoscono come consorti. All’interno di questi lignaggi, i nostri autori procedono successivamente generazione per generazione, descrivendo l’una dopo l’altra le fratrie situate allo stesso livello genealogico. Il procedimento si fa generalmente più elastico a partire dalla stessa generazione dell’autore, o da quelle che lo precedono o lo seguono immediatamente. Allora, egli comincia a distinguere le linee di discendenza che si costituiscono all’interno del gruppo omonimo, e in invece di disperdere la sua descrizione per vie laterali tratta dei figli e dei nipoti, prima di risalire ai propri zii e ai cugini germani dei padri e di esaminare propriamente la discendenza. Quando sopravviene questo cambiamento di procedura, s’indovina l’interesse per sottogruppi più ristretti, per linee di discendenza individualizzate, che si fondano su legami particolarmente stretti tra fratelli o cugini. L’ordine seguito nella descrizione può essere turbato da diverse
considerazioni.; ciò però accade solo nelle cronache di famiglia più elaborate. Tuttavia, la pregnanza delle forme tradizionali della genealogia che permangono anche in questo nuovo genere letterario denominato “cronaca domestica”, può rivelarci quali gerarchie implicite organizzavano la parentela per i Fiorentini: si tratta in primo luogo di definire la discendenza in linea maschile, quindi la fratria tra uguali, e infine di delimitare i sottogruppi familiari, abbozzi di schiatte indipendenti, più sollecite di quel che sarebbe stato, a valle, il loro avvenire, che di stabilire quali erano state, a monte, le loro radici. Questo modo di procedere si impone in maniera abbastanza evidente nelle genealogie schematiche. Alcune linee delle liste genealogiche che i libri di famiglia ci hanno conservato erano accompagnate da disegni (Luca di Panzano, Doffo Spini, Lapo di Castiglionchio). La maggior parte delle genealogie che ci restano non consiste che in mere enumerazioni di nomi; a differenza di queste i tre famosi testi di Velluti, di Pitti e di Morelli trasformano l’arida registrazione nella vera e propria storia di una famiglia, letta attraverso le biografie dei suoi membri, opportunamente giustapposte le une alle altre.(PROFONDITA’ E APERTURA DELLE GENEALOGIE) L’origine di queste linee di filiazione è dunque il primo comune antenato al quale si è in grado di dare un nome. In due casi su tre, questo antenato si colloca nella terza o quarta generazione che precede quella del redattore. In molti casi, questi può anche ricordare la successione dei nomi di antenati diretti più lontani; ma di fatto questi nomi non sono molto più che delle etichette isolate, e gli autori delle genealogie redatte dopo il 1400 sono quasi tutti incapaci di fornirci informazioni che non siano semplicemente di natura onomastica su questi “avi di carta”. L’antenato eponimo non sfugge a sua volta a questa ignoranza. Non si può assumere l’apparizione e la fissazione del nome collettivo ereditario come indicatore assoluto della coscienza che un gruppo può avere di se stesso. Il senso della coerenza familiare è anche riposto nell’evocazione di queste “magioni” si ombre ancora senza nome. La varietà dei punti di appoggio nel tempo passato corrisponde anche al modo di procedere estremamente eclettico dei nostri indagatori di memorie. Infine, non solo i supporti scritti della memoria genealogica sono sovente fragili, ma per di più parecchi redattori, dopo il 1400, provengono da famiglie “nuove”, se non per la data del loro insediamento a Firenze, almeno per l’accesso alla vita politica che le ha rese famiglie di notabili. La cosa non resta senza effetto sulla forma stessa delle loro genealogie. Gli alberi genealogici più fitti arrivano a contare più di un centinaio di nomi di parenti per linea maschile, ma i più smilzi arrivano soltanto a qualche decina. I soli autori che sono veramente in grado di specificare anche lateralmente un gruppo di antenati a un grado superiore alla terza generazione appartengono tutti a famiglie antiche o molto antiche.(COME CHIAMARE I PROPRI “CONSORTI”?) Contare una parentela molto vasta che porti lo stesso nome è motivo d’orgoglio e segno di prestigio. Questi gruppi di consanguinei, tuttavia, non riescono sempre a mantenere un’unità e un’identità comuni. Lapo di Castiglionchio, Velluti, Pitti o Tornaquinci fondano l’atto di nascita della loro “casa” su di un racconto che narra l’uscita da una stirpe più antica. Di questa parentela originaria essi non conservano a testimonianza che pochi segni, tenui ma pur sufficienti a intrattenere talvolta quelle relazioni d’amicizia che si convengono tra parenti. La comparsa di un lignaggio indipendente è segnata, già nel XIII secolo, dall’adozione di un nome differente (es. I Niccolini cambiarono il loro nome da “dei Sirigatti”). All’interno dello stesso lignaggio, tra i parenti che portano lo stesso nome, alcuni genealogisti distinguono a volte una linea di discendenza dall’incerto statuto (es. Niccolò Busini nel 1408 termina su due parenti dei quali si dichiara “non bene informato come sia disceso”. Lo stesso accadde per Giovanni Rucellai). In modo molto generale, quindi, la parola ”consorto” designa le persone con le quali si condivide il godimento di determinati diritti. Può trattarsi di cugini, di membri dello stesso lignaggio, di parenti lontani sui quali si è perduto del tutto il filo e infine veri e propri estranei, nei confronti dei quali non si rivendica nemmeno parentela. I genealogisti operano le loro scelte tra questi “consorti” di ogni genere. Se di alcuni si occupano, su altri preferiscono sorvolare, anche se si trovano nondimeno nella stessa situazione genealogica. Il nostro campione ci consente di cogliere i diversi meccanismi dell’oblio e del rifiuto. Il primo, è quello che risulta dalla separazione fisica e dall’allontanamento geografico (emigrazione da Firenze nei secoli XII e XIII). Le partenze e lo spostarsi in altri paesi non sono d’altronde le sole cause fortuite della segmentazione. La comparsa di un nuovo lignaggio risulta spesso in seguito a qualche malinteso o a qualche imbroglio tra eredi (es. Neri degli Strinati menziona un ramo maggiore della sua stirpe i cui membri furono chiamati i Ciaberi, che però discendeva da una seconda o terza generazione in linea femminile e che quindi non continuò ad esistere). I nuovi lignaggi non si staccano per “segmentazione perpetua”. Nella Firenze del XIV secolo la segmentazione sembra essere stata assai più aleatoria. L’ideale consiste piuttosto nell’unità; per rimettere i questione tale unità, ci
vogliono circostanze eccezionali, delle quali possiamo percepire meglio le forme collettive nel XIV secolo, e le forme individuali nel XV. In una società nella quale i prestigio di una stirpe dipende in larga misura dalle sue scelte politiche e dalla fazione per la quale parteggia, ogni conflitto interno può tradursi in spettacolari rovesciamenti di affiliazione concernenti individui o intere famiglie, e nel loro costituirsi in lignaggi indipendenti che adottano un nuovo nome o un nuovo blasone (es. La cronaca di Dino Compagni). Il processo di segmentazione spontanea di cui s’indovinano le cause e gli effetti politici in numerosi testi o romanzi familiari sulle origini, è ratificato nel XIV secolo dalla legislazione, sia pure in modo piuttosto artificiale. Il Comune incoraggia i magnati, i Grandi, ad assumere lo stato popolare, sfuggendo così alle Ordinanze di giustizia che rendevano ciascun individuo strettamente solidale con la sua stirpe; così facendo, essi sono costretti, dopo il 1361, a cambiare nome e stemma (es. I Tornaquinci perderanno numerosi membri). Ma l’essere usciti dal vecchio lignaggio non rompe tutti i legami. Le opzioni politiche e giuridiche non sono quindi in grado, nel Quattrocento, di alterare in modo fondamentale le strutture del gruppo di parentela. Cause di separazione più contingenti, legate a tare o a sventure individuali, emergono meglio dalle genealogie del XV secolo. Causa di silenzio è, in primo luogo, la presenza di figli bastardi (es. Morelli, il cui bisavolo ebbe un figlio non legittimo). I genealogisti che non ignorano sistematicamente i bastardi del loro sangue, ci mostrano che questa tara è poco compatibile con la perpetuazione di un lignaggio o la fondazione di un lignaggio indipendente. Del resto, la riprovazione colpisce meno il bastardo in persona che la genia da lui discesa, ed è ragion sufficiente per trascurarla, se mai esiste. Un’altra causa di rifiuto è l’attività poco onorevole o la cattiva fortuna di una particolare famiglia (es. Rucellai cita un ramo povero secondario alla sua stirpe).(IL GENEALOGISTA E LE DONNE) Tra i discendenti di una stessa coppia, una causa d’esclusione ben più radicale della genealogia della stirpe è quella di averne ricevuto il sangue per linea femminile. Il gruppo di parentela che si può riconoscere a partire dalle genealogie, dunque, non include, o include in modo saltuario gli individui di sesso femminile nati all’intero del lignaggio, ed esclude le persone dei due sessi che hanno come madre una donna nata in tale lignaggio. Proprio quando essi giustificano le eccezioni che fanno alla mascolinità di quest’ultime, ci chiariscono il senso che conviene dare all’esclusione delle donne (es. Lapo da Castiglionico ricorda due prozie solo perché trasmisero alla sua famiglia ceti diritti sul patronato di una chiesa). Le ragioni sono un po’ dovunque le stesse. Sia che rimangano come uniche sopravvissute del loro lignaggio, sia che abbiano per di più spogliato o “disfatto” i loro agnati ricevendo l’eredità paterna, queste donne sono tolte dall’oscurità, e talvolta dall’anonimato, per la sola ragione che testimoniano una perturbazione nell’ordine auspicabile e normale delle successioni, quello che deve compiersi per linea maschile. L’eccessiva mascolinità delle genealogie fiorentine mette dunque in luce la loro funzione principale: esse devono individuare il reticolo degli eredi maschili. Quando ereditano, le donne suscitano l’indignazione degli uomini della loro famiglia di nascita, perché fanno uscire dalla casata ciò che vi dovrebbe rimanere. Ricordiamo che a Firenze i beni dotali che esse devono trasmettere alla loro discendenza comportano ben pochi beni stabili, case, o partecipazioni commerciali. Un gruppo di testi dà più lungo spazio alle donne nate all’interno del lignaggio. Due ordini di ragioni dirette si possono invocare per render conto di questa sistematica tendenza a cancellare l’elemento femminile. In primo luogo, il ricordo che si conserva delle donne diviene più rapidamente opaco, quanto più si risale lungo la successione delle generazioni. Ciò è vero in particolare per le donne entrate nella famiglia per matrimonio, delle quali i memorialisti recuperano a stento frammenti d’antroponomia, soggetti alle vicende capricciose e casuali degli atti che riguardano la loro dote. Le mogli dunque sono reperibili soltanto i via progressiva, e ci si può chiedere se il loro pur faticoso emergere non si sia prodotto in funzione diretta della diffusione del sistema dotale e della moltiplicazione degli atti notarili che tale diffusione aveva portato con sé. Parallelamente, le sorelle e le figlie che uscivano dalla famiglia per sposarsi, sono trascurate in misura ancora maggiore (es. Velluti le prende in considerazione solo a partire dalla generazione di suo padre). Una ventina di anni dopo aver compilato la sua genealogia , Rucellai aggiunse una rassegna dei suoi parenti acquisiti, partendo da alcune mogli entrate nella famiglia; ma a sua volta si rifiuta di enumerare in dettagli i “parentadi della consorteria de’ Rucellai delle fanciulle uscite e delle entrate, che son grandissimo numero, per modo si tirano drieto meza la città”. Portatrici dell’alleanza matrimoniale, le donne sono dunque le prime a essere sacrificate al desiderio di concisione, persino quando il memorialista si propone di trattare proprio dei parentadi. Sotto la penna del memorialista sorelle e ragazze giunte al matrimonio scompaiono più in fretta delle mogli che sono entrate nel lignaggio. Anche quando si tratta delle generazione dei figli e dei nipoti nati all’interno del lignaggio, il rapporto tra ragazzi e fanciulle rimane assai squilibrato (es. Nicolini dimentica di menzionare le sue tre
figlie. Tale oblio non è però sistematico)l’espulsione delle donne dalle genealogie è direttamente collegata con il loro statuto in relazione alla dote; se in generazione lontane o in gradi di cuginanza troppo remoti esse non compaiono più, o perché i problemi ad esse collegati non concernono di persona il genealogista. E tanto più le donne assumono consistenza, quanto più ci si avvicina a costoro. Tali discriminazioni invece non sono operanti con gli uomini che portano lo stesso nome. Qualunque sia la loro distanza sull’asse longitudinale o su quello laterale della parentela, essi conservano tutti i loro diritti sul capitale comune del prestigio e dei beni della casa. A partire dal 1215, la Chiesa aveva ridotto e fissato per molto tempo i limiti della parentela esogamica; e lo aveva fatto nel quadro di una filiazione indifferenziata, ponendo l’accento tanto sulla linea materna che su quella paterna. Le genealogie fiorentine non hanno evidentemente come scopo di definire, attorno a un determinato individuo, il gruppo di parenti ai quali è interdetto il matrimonio reciproco in rispetto della legge canonica. Tuttavia i genealogisti lasciano sparire un’interpretazione della parentela patriernale che non è conforme alla definizione religiosa. Nei casi in cui i testi fiorentini si interessano alla loro donne, si può constatare che l’appartenenza allo stesso gruppo di parentela, segnalata dal fatto di portare uno stesso nome al momento della nascita, comporta un’interdizione endogamica molto potente, anche nel caso in cui il grado di parentela sia molto più lontano di quello prescritto dalla Chiesa (es. Pitti segnala u matrimonio fra omonimi). Le diverse forme genealogiche ci invitano a interrogarci sui rapporti che potevano esserci tra la realtà vissuta della parentela, e le rappresentazioni che esse ce ne facevano. Le genealogie maschili esagerano dunque l’impressione di una filiazione e di una trasmissione dei beni a inflessione patriernale, che si ricava da altre fonti; tuttavia, esse accentuano più di quanto non tradiscano un orientamento fondamentale della società, o almeno delle classi dirigenti e possidenti della Toscana. Infine, lo spazio assai minore ancora dedicato ai rapporti tra matiro e moglie, alla cellula coniugale, rendono manifesta la preminenza dei legami verticali “eterni” che vincolano i discendenti all’interno del lignaggio, sulle relazioni orizzontali più fugaci che si possono allacciare tra un lignaggio e l’altro. preminenza che modella i comportamenti quotidiani dei Toscani, influenza profondamente la coscienza che essi hanno della loro identità, e popola di numerosi antenati la memoria della loro casa.3 IL NOME “RIFATTO”. LA TRASMISSIONE DEI NOMI PROPRI NELLE FAMIGLIE FIORENTINEQuando i Fiorentini del Rinascimento parlavano del loro “nome”, intendevano con ciò, se appartenevano alla classe dirigente, il nome del loro lignaggio. Il nome proprio che ogni cristiano riceve al momento del battesimo appariva a questi autori legato in modo meno evidente alla loro condizione sociale ed alla sopravvivenza dei loro lignaggi, che i ripetuti attacchi delle epidemie di peste sottoponevano a continue e dure minacce. Di fatto, l’ideologia esplicita del lignaggio e la riflessione sul ruolo, nel suo mantenimento, dell’alleanza matrimoniale, che fu oggetto di strategie esplicite e di analisi serrate, non includono affatto nel loro campo d’azione i processi più oscuri attraverso i quali, all’interno della famiglia, veniva operata la scelta dei nomi propri. L’ascesa al potere della classe mercantile, bei secoli XIII-XIV, è coeva ad un mutamento profondo delle strutture della famiglia e della parentela, cosa che spiega forse il fatto che gli uomini del primo Rinascimento siano stati così sensibili ai temi di carattere familiare. A partire dal XIII secolo, a immagine di ciò che era avvenuto per i lignaggi nobiliari, del XII secolo, i grandi mercanti e banchieri toscani affermano la loro solidarietà di stirpe procurandosi un nome di famiglia che possa trasmettersi in linea maschile. Rafforzando poi il sistema della dote, che esclude le donne dalla trasmissione dei beni patrimoniali, essi accentuano ancor più l’orientamento patriernale dei sistema di filiazione e dell’eredità. Alla fine del Medioevo l’eredità è ovunque divisibile i parti uguali tra i figli, mentre le sorelle vengono “convenientemente” fornite di una dote. Palleggiata tra due lignaggi, quello di suo padre e quello del marito, la donna non è membro a pieno diritto di nessuno dei due. Di che cosa consta il “nome” che designa un Toscano? Per la maggior parte delle persone, nei secoli XIV-XVI, è come il nome proprio ricevuto al battesimo, talvolta con un diminutivo o un nomignolo, che ci si rivolge loro. Per maggior precisione, lo si fa seguire dal nome proprio del padre, e molto spesso da quello del nonno, sul modello. Così che ciascuno si trova a essere identificato da una serie di due o tre nomi propri maschili. , serie che sarà allungata nel caso in cui la memoria genealogica sia chiamata a consolidare la condizione sociale di un individuo, ma nella quale non verrà mai a essere intercalato un nome femminile. Quando questi nomi propri così concatenati non erano sufficienti a distinguere tra i diversi individui, si faceva ricorso ad altre caratteristiche individuali, che avevano funzione di complementi del nome. In riferimento al gruppo professionale o familiare al quale appartiene, un Toscano potrà essere designato col suo mestiere, il suo titolo, la sua origine o il nome ereditario del lignaggio paterno. Si deve infine sottolineare che una semplice catena di tre nomi di battesimo è sufficiente a scongiurare
la maggior parte delle confusioni all’interno di un lignaggio, per esteso che possa essere. E diventa quasi impossibile far confusione, quando il riferimento ai nomi propri del padre, del nonno e del bisnonno ai affianca all’espediente di saltare una generazione prima di riprendere lo stesso nome di battesimo, anche quando vige la consuetudine di impiegare un numero assai ridotto di nomi propri, ripetuti indefinitamente. Con una catena di quattro soli nomi di battesimo non si possono quindi produrre degli omonimi perfetti nell’ambito della stessa generazione, e il rischio di omonimia colpisce soltanto i membri del ramo primogenito. Così, i diversi membri di una fratria sono riconoscibili attraverso la catena dei nomi propri dei loro antenati maschi in linea diretta. Il nome personale potrebbe essere in grado d sfumare questa specificazione agnatizia, ricollegando il nuovo arrivato più particolarmente a una delle sue due linee di discendenza, e, all’interno di questa, privilegiando l’uno o l’altro degli avi. Potrebbe servire a ricordare la bilateralità della filiazione, proprio nel momento in cui il gruppo di parentela si sforza di accentuare il suo orientamento patriernale. Per di più, dal momento che il bambino dopo 1350 riceve il più delle volte non un solo nome di battesimo, ma due, e alla fine del XV secolo persino tre, le possibilità di scelta che i offrono ai genitori possono essere utilizzate per rispondere a sollecitazioni di natura diversa, che non sono conciliabili in un solo nome proprio. In diverse regioni d’Europa l’assegnazione del nome è strettamente legata alla parentela spirituale, e quest’ultima è a sua volta connessa con la parentela più prossima. La scelta del padrino e della madrina si compie tra i parenti prossimi degli sposi, all’interno delle due famiglie; il loro nome proprio è attribuito al figlioccio. L’equilibrio tra i riferimenti ai lignaggi paterno e materno è raggiunto sia congiungendo il parente spirituale col nome individuale, sia alternando la scelta dell’uno e dell’altro per ciascuno dei figli. Nella Firenze dei secoli che vanno dal XIV al XVI, parentela naturale e parentela spirituale si giustappongono, e non interferiscono mai l’una sull’altra. Un’infima percentuale dei padrini e delle madrine appartiene ai consanguinei o ai parenti acquisiti più prossimi al battezzando, almeno negli strati sociali di cui si sono conservati i libri di famiglia. La maggioranza dei parenti spirituali di bambini nati in queste famiglie della borghesia è reclutata tra i vicini, i colleghi, le persone con le quali il padre intrattiene relazioni politiche e d’affari. Colui che attribuisce il nome è in primo luogo il padre. Gli interventi diretti della madre restano rari. Per ciò che concerne il nome del loro figlioccio, i padrini non hanno alcun ruolo che quello di trasmettere nel corso della cerimonia del battesimo alla quale i genitori non assistono, il secondo nome proprio era conferito all’ingresso della chiesa, il nome principale era imposto al fonte battesimale. Nel suo libro familiare, il padre indica spesso a quale dei due nomi propri attribuisce la priorità. Spetta dunque al padre il compito di specificare i nomi propri che i padrini dovranno ripetere al battesimo. La selezione tra diversi nomi, i meccanismi attraverso i quali sono trasmessi, le mode che possono influire sulla loro scelta e la loro distribuzione, sono fenomeni difficili da percepire prima che compaiano testimonianze sistematiche, come i registri parrocchiali. L’insieme dei comportamenti che presiedono alla scelta dei nomi propri non può essere analizzato che a condizione di disporre di informazioni complete. Ed è proprio nel vasto corpus dei libri di famiglia che queste preziose informazioni si possono trovare, insieme alle notizie biografiche e materiale genealogico. Le notizie in essi contenute potevano avere utilità politiche e fiscali. Il capofamiglia registrava dunque giorno dopo giorno gli avvenimenti che marcavano la vita della sua casta, le nascite, i matrimoni, le morti. E quando faceva battezzare i suoi figli o i suoi nipoti, registrava non solo il nome di battesimo che era stato loro attribuito, ma anche quelli dei loro padrini e madrine. Alla fine, spesso si preoccupava di giustificare la scelta che aveva fatta dei nomi propri del bambino. Talora nei libri di famiglia compare il termine “rifare” (riferito al parente del bambino che ora il padre vuole “rifare”); questo termine rimanda a prima vista all’idea che grazie all’attribuzione del suo nome, un antenato o un parente prossimo si reincarnerà in qualche modo in un nuovo nato. Tra tutti i membri della parentela, è proprio a lui che il bambino sarà particolarmente legato, e questo legame implica al tempo stesso l’attributo simbolico rappresentato dal nome, e la stessa “corporeità” dei suoi portatori. Tra i casi la cui provenienza del nome è nota, si può constatare che la metà, tanto dei maschi che delle femmine, ne porta un tratto della riserva della famiglia paterna. Un bambino su sei, e una bambina su dieci ricevono il loro nome dalla famiglia materna, per quanto la si conosca. Se scartiamo l’idea che l’indeterminazione possa introdurre distorsioni apprezzabili, e se ci atteniamo ai nomi propri di provenienza ben chiara, potremo dunque supporre, in prima approssimazione, che la linea di discendenza paterna fornisse un numero di nomi tre o quattro volte maggiori di quella materna, e che tale preferenza riguardasse le femmine in misura almeno pari a quella dei maschi. Un gran numero di femmine porta il nome di una sorella morta in precedenza; i maschi ricevono più raramente il nome di un fratello maggiore scomparso. A fianco di questi nomi prelevanti nell’ambito familiare, i nomi principali che
vengono trasmessi dai padrini, o che sono ispirati dalla loro personalità, restano l’eccezione: non sono più di cinque per tutti i maschi e le femmine del campione considerato. Negli ambienti urbani dai quali sono uscite le ricordanze, una situazione così anormale si verifica solo quando è manifestazione motivata da una particolarità eccezionale, in generale la presenza di una padrino illustre. Un gruppo di questi nomi poi, decisamente minoritario, ci mostra che si viene discretamente affermando un diverso orientamento onomastico: una parte dei nomi si devono alla devozione personale nei confronti di un santo particolare, manifestata a volte da un voto da compiere, o anche a una devozione che potremmo dire automatica, evocata dalla festa del calendario religioso, o dall’associazione di un santo determinato ad un certo tipo di nascita. Per esempio, i bambini sottoposti a battesimo d’urgenza in casa, sono chiamati Giovanni (-na), e così messi subito sotto patronato del Battista. L’impronta che la discendenza paterna conferiva al bambino è soprattutto notevole per i figli maggiori. A partire dalle seconde nascite queste proporzioni scendono di circa la metà. La parte concessa alla manifestazione della devozione è invece molto più costante, qualunque sia il rango dei figli. I nomi propri secondi sono meno difficili da collocare nel loro contesto, poiché troviamo riferimenti religiosi all’origine della scelta dei tre quarti di quelli che si possono spiegare. La parte che vi occupa la devozione è predominante. Tuttavia si scartano certi santi troppo oscuri a vantaggio di patroni celesti più importanti, la cui festa sia negli immediati paraggi. Rimane probabile che i predicatori abbiano contribuito non poco alla comparsa del secondo nome toscano, a partire dalla fine del XIV secolo. Il padre non di rado gioca sull’ambiguità di un nome proprio per esibire una devozione, sottolineando al tempo stesso il richiamo del nome di un antenato, o la concessione fatta all’altra delle sue discendenze (es. Bartolomeo Valori nel 1456 annota che il secondo nome del figlio è dovuto alla festa di san Pietro). Mentre l’attribuzione dei nomi dei noni paterni ai figli maggiori è generalmente rispettata, l’alternanza tra le due discendenze non rappresenta la regola. Il padre ricorre più volentieri a parenti di linea paterna relativamente remoti, o ai suoi propri parenti materni,che ai parenti acquisiti. Nono solo i nomi di lato paterno soppiantano facilmente quelli materni, ma gli stessi santi del calendario non di rado usurpano il posto che dovrebbe spettare ai nonni materni. Fortunatamente i nostri Fiorentini giustificano l’interferenza di parenti diversi, quando sottraggono la priorità ai nonni dei bambini (es. Giovanni Morelli cha dà al suo primo figlio il nome di un suo fratello maggiore che la peste si era portato via, ed è solo il suo secondo figlio a ricevere il nome del nonno paterno). La morte stessa conferisce una priorità che può sconvolgere il normale ordine gerarchico di attribuzione dei nomi. Gli stessi redattori delle ricordanze ci fanno spesso notare che hanno scelto un nome piuttosto che un altro perché sentivano di essere tenuti a “rifare” un parente da poco defunto. No si può “rifare” un vivo, mentre “rifare” un morto della propria stirpe è sentito come un vero e proprio dovere. Ed è per questo steso motivo che si giustifica l’apparizione di nome propri materni, sommersi da un insieme di nomi in maggioranza paterni. Il ricorso a nomi materni che non siano quelli dei diretti nonni del bambino, deve essere giustificato dalla morte recente, e al tempo stesso del prestigio di colui che li portava. L’urgenza di attribuire nuovamente il nome di un parente defunto è specialmente sentita, tuttavia, entro la più ristretta cerchia della famiglia coniugale. Essa si esprime in primo luogo nel rapporto quasi automatico che i riscontra tra il nome proprio della prima moglie del padre, e quello della prima figlia nata da una seconda unione, che precede qualsiasi attribuzione dei nomi delle nonne della bambina (es. Biagio Buonaccorsi). La dissimmetria tra le linee di discendenza riappare in questi riporti, dal momento che è impossibile, per una vedova che si risposa, conferire a un figlio di secondo letto il nome del suo primo marito. L’attribuzione del nome del padre al suo figlio postumo è anche praticata come regola, e la prematura disparita del padre è la sola spiegazione di questi casi aberranti in cui il figlio porta lo stesso nome di suo padre. All’interno di una fratria, il fatto che i nomi di un fratello o di una sorella morti tendano a scivolare su un figlio nato successivamente ci rivela ancor più chiaramente questa comunanza dei morti e dei viventi di una stessa stirpe. “Rifare” i morti non riguarda solo i bambini deceduti, di cui si riprende il nome. Attraverso di essi, sono “rifatti” i nomi di antenati, che sono stati già attribuiti, e che è urgente e logico attribuire subito a nuovi portatori. Ma questo processo concerne anche i “nomi di devozione”, che sono scelti al di fuori della riserva propriamente familiare per motivi di ordine religioso, e che, per il solo fatto di essere dati a un primo bambino, sono ormai integrati in questa riserva. Presi alla sprovvista da una morte repentina, i genitori possono arrivare persino a cambiare il nome di bambini già battezzati, sostituendolo con quello di un parente prossimo improvvisamente defunto; nel far questo, tengono sempre conto del sesso dello scomparso. Inoltre da alcuni esempi (come quello di Filippo e Lorenzo di Matteo Strozzi: entambi attribuiscono alle figlie il nome della madre defunta) rivelano che non esistesse competizione tra fratelli nella riattribuzione del nome di un defunto, ma che ognuno sente rispetta l’obbligo
di onorarne la memoria.; e ciò avviene in funzione del posto che il morto occupava nella vita familiare, dell’onore che si vuole pure testimoniare al suo più prossimo sopravvissuto, e persino degli eventuali legami affettivi che si potevano aver stretto col defunto. Un corollario della pratica che consiste nel “rifare” i defunti, è che due membri della stessa fratria o della stessa famiglia coniugale non possono portare lo stesso nome proprio. Sembra poi che fin verso il 1460, i padri che così spesso riportano su un nuovo venuto il nome di una antenato o di un parente morto da poco, si vietino spontaneamente di “rifare” dei vivi. Nell’ultimo terzo del secolo e all’inizio del XVI, al contrario, non solo le attribuzioni di nomi appartenenti a persone ancora i vita sono più frequenti, ma le giustificazioni che il padre offre di questo fatto dimostrano che egli è ben cosciente di infrangere una sorta di proibizione che fino ad allora era rimasta implicita. I membri della stirpe devono comunque essere “rifatti” ma perché il loro nome possa incarnarsi in un nuovo corpo, devono per prima cosa esser passati al rango di antenati. Imporre a un neonato il nome di un parente ancora in vita, significherebbe farlo entrare anzitempo nel gruppo di antenati estinti. Perché i morti si manifestano come presenze che possono rivelarsi tanto pericolose che protettive, quali che siano stati quando erano in vita. Il doppio significato del verbo “rifare”, che vuol dire sia “fare nuovamente” che “risarcire”, indica che onorando i defunti e facendoli reincarnare, i vivi evitano di alienarseli. Non è quindi l’individuo che viene dotato di un attributo, ma è piuttosto il nome stesso che si trova ad essere rivivificato. I nomi propri formano una sorta di patrimonio familiare del quale nulla deve essere trascurato o andare perduto. La “casa” ideale rinchiude in sé tutti i membri viventi o defunti della stirpe. Nel ricordo degli stessi genitori, i bambini con lo stesso nome finiscono per confondersi in un sol personaggio, la cui permanenza è garantita dal fatto di portare lo stesso nome. La nascita spirituale di un bambino, che riceve il suo nome con l’acqua del battesimo, annulla così la morte del precedente portatore di questo nome. Il nuovo portatore, grazie al nome proprio, diviene partecipe di questa sorta di individualità collettiva che è la stirpe. Alcuni di essi cercano anche di imprimere sui loro figli illegittimi il marchio rappresentato dal nome proprio. Le “case” fiorentine utilizzano il loro patrimonio simbolico o genealogico al modo stesso del loro patrimonio di case e di possedimenti terrieri, come elementi di forza nel gioco dei rapporti sociali; il nome di battesimo, e non solo quello di famiglia, sono in questo gioco carte eccellenti. Come il rango di nascita non influisce punto sui diritti ad ereditare, così i nomi propri possono essere riportati da un avo su un primo nato, poi su un figlio nato successivamente, a seconda dei decessi e senza un ordine di prevalenza prestabilito. L’uguaglianza tra eredi maschi assicura a livello della fratria la libera circolazione e la ripetizione dei nomi antichi, poiché l’obbligo di “rifare” i morti non può essere impiegata col segreto intento di trasmettere a un erede determinato tutto l’insieme, o una parte privilegiata del patrimonio. E poiché la stirpe materna non ha da trasmettere nient’altro che la dote, il prestigio della parentela acquisita e la fecondità del ventre della sposa, i prelievi dei nomi in quell’ambito si riducono al semplice omaggio ai nonni diretti del bambino. In confronto agli eredi maschi, le femmine ricevono la dote e si ritroveranno aggregate alla stirpe dei mariti, dei quali non aggiungeranno i nomi a lato del loro nome proprio. Perciò, è poco importante che siano riconosciute attraverso il loro nome proprio come membri di questo gruppo di parenti. La loro situazione è riflessa dalla maggiore incertezza che caratterizza l’origine dei loro nomi di battesimo nella scelta ai quali la moda, l’amicizia, i rapporti con padrini o madrine, e persino legami affettivi con certi vicini operano in qualche modo più liberamente che nella scelta dei nomi maschili. Infine, quando si accinge a “rifare” un defunto, il padre rispetta con molta cura il sesso del suo nome.4 UN’ETNOLOGIA DEL MATRIMONIO IN ETA’ UMANISTICAPoco dopo il 1500 Marco Antonio Altieri scrive un dialogo intitolato “Li nuptiali”; l’interesse cha ha per noi quest’opera risiede nel fatto che essa concepisce i rapporti e gli interscambi tra cultura dotta e pratiche “popolari!” senza postulare la supremazia dei modelli della prima sulle seconde, perlomeno riguardo all’argomento di cui si occupa, quello dei riti e delle feste, e in modo particolare quello dei rituali nuziali. Altieri si sforza di conciliare l’’ordine della città con quello religioso. E per decifrare meglio i retaggi rituali misura questi ordini con il metro dell’Antichità. Così facendo, egli getta le basi di un’etnologia del matrimonio che pone fortemente in luce i fermenti novatori della riflessione umanista che precedette la Controriforma. Egli appartiene alla nobiltà urbana di Roma, la cui ricchezza nel XV secolo si fondava sulle proprietà cittadine, ma anche sui possedimenti rurali. Per tradizione, questa piccola nobiltà esercita anche le funzioni pubbliche e occupa tutte le cariche capitoline. Verso la fine del XV secolo, questa piccola nobiltà comunale vede i suoi privilegi politici tradizionali diminuire progressivamente, a causa della concorrenza di nuovi venuti, Altieri sembra rispecchiare molto bene il rancore delle vecchie famiglie romane; il nuovo corso della politica
papale le porta a sentirsi negate della loro identità. I Romani, secondo Alfieri, devono prendersela con se stessi, e devono correggere i loro difetti, se vogliono veder mutato il corso degli avvenimenti, e ristabilita la loro condizione politica ed economica. “Li nuptiali”, stano alla prefazione, sarebbero un’opera di circostanza, un elogio dell’amicizia, dell’alleanza matrimoniale e della festa che ne è l’espressione,e sono per l’appunto composti in occasione delle nozze di un amico romano del loro autore. Redatti in una sorta di vernacolo e sotto forma di dialogo, essi mettono in scena una decina di gentiluomini vicini all’Altieri col pretesto di esser d’aiuto al buon svolgimento delle nozze del suo giovane amico, Altieri si appresta a rispondere alle loro domande,e a sottoporre alla loro discussione ciò che egli conosce dei matrimoni del passato. Ma, sotto il pretesto di gettar luce sui riti nuziali, Altieri persegue con tutta evidenza un disegno politico. Secono lui, i suoi contemporanei si rivelano tanto ignoranti sugli usi che si devono seguire in materia di matrimoni, a causa del fatto che stanno sempre più dimenticando i fondamenti stessi della “solidarietà sociale”. Questi vizi moderni hanno origine dal disprezzo che ciascuno ostenta nei confronti del matrimonio e della procreazione. Si tratta di restituire a una classe sociale “invilita” la perduta coesione con la pratica delle cerimonie tradizionali. La seconda parte del “Li nuptiali” cerca di far apparire tutti i sensi possibili dei riti che accompagnavano un tempo la conclusione di un matrimonio. Nella terza parte egli estende la discussione alle funzioni sociali della festa, e di esaminare il ruolo che in essa devono assumere coloro che impersonano la “nobiltà” e la “civiltà”, vale a dire i suoi stessi amici della piccola aristocrazia cittadina. Così, è nella parte centrale dell’opera che Altieri si interroga sui rapporti che intercorrono tra prassi e tradizione. Commenta quindi i costumi matrimoniali del passato. Egli li conosce attraverso le sue osservazioni personali, visto che ha ancora potuto vedere, nella sua giovinezza, prima del deplorevole papato di Sisto IV del Borgia, lo svolgimento delle nozze secondo la tradizione, quando ancora era meno guastato dallo spirito mercantile e dalla corruzione della nobiltà di quanto non fosse verso il 1500. Altieri asserisce anche di aver indagato presso persone più anziane di lui. E sembra anche che abbia potuto condurre un’inchiesta documentaria. Quanto ai riti antichi, con i quali le metterà costantemente a confronto, ne ha conoscenza grazie alla sua formazione umanistica (riunioni dell’Accademia Romana, patrocinate da Pomponio Leto e da Platina). Egli parte, nel suo processo di confronto, da un complesso di pratiche, preso nel suo insieme, e risale lungo il corso del tempo per comprenderne il senso e la funzione. Procedura che si fonda più sulla percezione delle analogie che sulla ricerca sistematica delle origini di un fatto contemporaneo. La rete di corrispondenze che Altieri sa costruire attorno ad ogni gesto, ad ogni simbolo del rituale nuziale, lo conduce alla fine a interrogarsi sul significato centrale delle forme rituali, un significato suscettibile di legittimare al tempo stesso tanto i riti antichi che quelli moderni. Tale griglia di lettura gli fornisce non solo la preziosa arma ideologica per la lotta politica che gli ha ispirato questa ricerca, ma anche una teoria più generale dell’alleanza matrimoniale. Altieri non pretende di ripristinare le usanze degli Antichi, al contrario, i riti dell’età d’oro comunale di Roma che egli auspica di far riviere sono quelli che “i nostri padri, i nostri antiqui” osservavano al tempo stessi con fasto e rigore. Le sue riflessioni rinviano dunque a un passato ancora recente. Quei tempi (3/4 generazioni prima) furono dunque un modello irreprensibile dal punto di vista della teologia del matrimonio messa in opera dalla Chiesa dopo l’inizio del XIII secolo. Quanto alla discussione dei riti nuziali, egli vi si può dedicare altrettanto liberamente; ciò non significa ancora affrontare un campo riservato, come sarà invece un secolo più tardi. Tracciando per i suoi amici il quadro di riferimento storico come un tempo degli “antiqui”, dei “modi antiqui”, il nostro etnologo dilettante gioca un poco su una certa ambiguità della terminologia, allo scopo di stabilire fin da principio una sorta di continuum dell’ordine rituale. Altieri si trova a legittimare le situazioni rituali della sua epoca servendosi di citazioni di testi antichi. Al termine di ciascuna delle sue analisi, lo scarto di un abbondante millennio che separa l’Antichità dall’epoca comunale gli appare inferiore agli scarsi cent’anni che sono trascorsi dall’inizio di quest’ultima all’epoca nella quale egli disserta. La parte descrittiva del suo discorso appare molto coerente. “Li nuptiali” non sono una semplice collezione di curiosità e di aneddoti. Altieri ricostruisce un ordo rituale attraverso il quel può tentare la lettura di un intero sistema sociale. L’ordine rituale ha come fine il fare, cioè il costituire e mantenere le amicizie e l’intreccio di relazioni solidali che la guerra e le aggregazioni si accaniscono di disfare. Il matrimonio, l’alleanza matrimoniale sono l’antidoto dell’aggressività, della conflittualità , del malinteso interesse. “li nuptiali” favoriscono una serie di spiegazioni su ciascuno dei riti esaminati. In primo luogo, interpretazioni di ordine filologico, che affastellano tutta una serie di etimologie dalle improbabili gerarchie e derivazioni, ma sostanziate da citazioni di autorità antiche o cristiane. Scorrono in successione, sotto la penna dell’Altieri, interpretazioni storiche, morali, giuridiche, allegoriche, fino ad intessere intorno a ciascun
elemento rituale un intero reticolo di significati. E spesso l’autore stesso è costretto ad ammettere la sua perplessità nello sforzo di ricavarne “il vero significato”. Così, ad esempio, a proposito della spada che nel XIV secolo si teneva sopra la testa degli sposi nel momento in cui si scambiavano i consensi: questo rito suggerisce ad Altieri più possibili ipotesi (es. Unione che solo con il ferro può essere spezzata). Ravvisando poi la storia delle prime spose dei Romani dietro ciascuno dei riti nuziali del suo tempo, l’Altieri vuole ricordare all’aristocrazia romana che la via più breve dal disordine all’ordine, dalla guerra alla pace, dall’acciecamento politico all’armonia sociale, è il rito del matrimonio; rammenta così costantemente la fondazione di Roma, costituita su un assassinio e sul matrimonio per ratto, ma anche la pace che ne conseguì. Il matrimonio e i suoi riti consacrano la forza e le forme violente di appropriazione delle donne e dei beni. L’Altieri non è mai così chiaro sul significato profondo che attribuisce ai triti nuziali come quando descrive la danza della “giaranziana”, una specie di farandola piuttosto complicata, che tutti gli invitati delle nozze eseguivano a due riprese. I danzatori vi si schieravano secondo il grado di parentela con lo sposo, e secondo la propria “condizione”. I movimenti portavano. Ciascuno dei partecipanti a “reconoscere la coniunctione”m, cioè a salutare e a toccare con mano tutti gli altri ballerini, uno per uno; cosa che poteva durare per delle ore. Il compito di mettere in ordine i danzatori e di condurre la danza rappresentava un impegno terribile, nel quale non erano ammessi errori. Egli riconosce in questa “giaranziana” lo stesso tema fondamentale dell’alleanza matrimoniale, del quale il ratto delle Sabine ed i connubi che ne risultarono rappresentano il canovaccio leggendario. Lo scambio dei saluti rituali, il “riconoscimento” del parentado fanno seguito all’iniziale scambio di scappellotti. La violenza è sottesa all’acquisizione delle donne e l’atto genitale. Altieri sviluppa in un altro passo il tema della pace sociale fondata sul rispetto delle gerarchie e accresciuta dalle feste collettive. Qui, il pretesto per le sue considerazioni gli viene offerto dalla cavalcata che va a prendere la sposa e la conduce a suo marito. Il raduno dei personaggi che devono parteciparvi gli fornisce l’occasione di esaminare il posto che ciascuno di essi occupa nella società, che deve essere espresso dalla loro collocazione all’interno del corteo. La parata nuziale funziona dunque qui come allegoria di una società riconciliata nello svolgimento della festa. Trascurare questi riti significherebbe, riferito ai nobili romani del 1500, omettere l’elemento riparatore dell’alleanza matrimoniale. La sposa, moneta od oggetto di scambio nelle transazioni bellicose o amichevoli dell’alleanza, è costantemente presentata dall’Altieri in un ruolo passivo. Ed essa conserva questo atteggiamento, anche quando il nostro autore ammette che il matrimonio cristiano si fonda sul mutuo consenso ed auspica che tra i due sposi nasca un desiderio reciproco. Nel raccomandare alla novella sposa la riservatezza e la sottomissione, l’Altieri riprende in prima fila le Sabine, che accettano l’unione che veniva loro imposta con la forza, e testimoniano ai loro mariti romani la stessa fedeltà che avevano nei confronti delle loro famiglie di nascita. Ed è ancora garanzia del mondo antico che legittima i riti magici che dovevano assicurare la fecondità della donna e della coppia. Altieri, spalleggiato dalle sue reminiscenze classiche, è ancora in grado di sottoporre ad un esame tutto ciò che la Chiesa, dopo il Concilio di Trento, giudicherà un guazzabugli di usanze prive di senso o troppo contaminate dalla superstizione. L’Altieri invece non rifiuta nulla, mettendo in gioco prima di tutto l’equilibrio tra le famiglie, la pace e la riproduzione sociali, invece che la salute e la felicità della singola coppia. Ciò che egli rifiuta è il malcostume dei tempi recenti, che adultera il retaggio del passato. Quella che Altieri inventa non è tanto l’etnologia del selvaggio, del barbaro, del contadino arretrato, quanto invece quella del “mondo che abbiamo perduto”. “Li nuptiali”, sotto certi aspetti, elaborano precocemente alcune linee di resistenza che la riforma cattolica del matrimonio porterà presto all’esasperazione, nelle famiglie. Vi è tuttavia una contro ripartita alle rivelazioni che egli presenta ai suoi amici romani sul senso profondo delle loro feste. Nell’intento di fornir loro un’arma che li aiuti a restaurare i vecchi valori “repubblicani”, egli propone loro, in realtà, un ruolo fatto su misura per un’aristocrazia addomesticata dai Tempi Moderni: quello di serbatoio dei sentimenti rituali riemersi dal suo paziente lavoro di archeologo, quello di essere e rimanere i docili eredi di un passato il cui senso profondo è divenuto per loro oscuro.5 ZACCARIA O IL PADRE SPODESTATO. I RITI NUZIALI IN TOSCANA TRA GIOTTO E IL CONCILIO DI TRENTOTra il 1300 e il 1500, un tema iconografico, il matrimonio della Vergine, conosce una straordinaria fortuna nell’arte dell’Italia centrale e settentrionale. La sua insistente fioritura sulle pareti dei santuari della Toscana, e in seguito dell’Umbria di altre regioni d’Italia, sembra che suggerisce che la Chiesa vi abbia trovato uno strumento efficace per l’edificazione spirituale dei fedeli. Ma con quali scopi? Prima del Concilio ei Trento, gli sforzi compiuti dalla Chiesa per controllare le cerimonie cha accompagnavano il matrimonio erano esercitati su
situazioni che, nell’Occidente cristiano, si presentavano molto varie. I rituali di acquisizione di parentela avevano seguito un’evoluzione largamente autonoma dopo il Basso Impero. Ma, a partire dal IV secolo, nell’Impero d’Occidente, il “matrimonium justum” si fondava soprattutto sulla volontà di matrimonio. I costumi e i riti nuziali dovevano dimostrare queste volontà, senza che la validità del matrimonio fosse legata a particolari forme. L’attitudine della Chiesa fu quella di lasciare che le sue pecorelle fossero libere di osservare il “costume del luogo”, alla sola condizione che gli sposi potessero esprimere liberamente il loro consenso. E così, il consenso espresso dai coniugi doveva diventare la base su cui si fondava il matrimonio cristiano. È dunque sotto il segno della libertà della forma che, nella cristianità occidentale, si è svolta l’intera storia dei rituali matrimoniali fino al Concilio di Trento. Nell’866, Papa Nicola I invia ai Bulgari una risposta rimasta famosa, nella quale mette in evidenza la concezione dei riti nuziali che aveva prevalso in Occidente: tali riti si dovevano intendere subordinati al “consenso di coloro che contraggono i legami del matrimonio e di quelli che esercitano autorità su di essi”. Il principio permette ugualmente di mantenere e anche sviluppare autonomamente antichi rituali popolari e una liturgia delle nozze, nelle province occidentali della cristianità.(LO SVOLGIMENTO DELLE NOZZE NELLA FIRENZE DEI SECOLI XIV E XV) Fondamentale, come testo di riferimento, è senza dubbio quello di Altieri. È da un punto di vista assolutamente laico che egli condanna diverse usanze civili del suo tempo. Le critiche che egli muove, dunque, sfuggono ai limiti entro i quali si restringono le denunce ecclesiastiche di superstizioni popolari, mentre la descrizione che egli offre dei rituali di matrimonio sopravanza largamente i quadro strettamente liturgico dei rituali diocesani. Agli stessi difetti sfuggono i testi di origine civile, che sono generalmente legati a una regolamentazione suntuaria e che si trovano spesso dedicati dalle comunità italiane agli usi e agli abusi dei tempi di festa pubblica. Il campo di indagine può allargarsi di molto se si pone a confronto la documentazione di origine giuridica, almeno con i racconti che ne hanno fatto gli stessi autori del dramma nuziale, negoziatori del matrimonio o sposi. Testi di questo genere si possono trovare in gran numero nei libri di famiglia. Queste relazioni che in questi libri vengono fatte dei matrimoni dei loro cari e delle spese causate dai festeggiamenti, precisano accuratamente i tempi forti ed il concatenarsi delle cerimonie, agli attori, le attitudini e i gesti che ci si attende da loro, i regali e gli oggetti che circolano dall’uno all’altro, e persino alcune delle parole che essi devono pronunciare per dar corpo al oro progetto nuziale. I racconti che riferiscono gli accordi e i matrimoni sono dunque generalmente intercalati in blocco nelle annotazioni che i Fiorentini si sforzavano di fare degli avvenimenti di casa. Due tratti distintivi manifestano ciò che potremmo chiamare l’arcaismo dei rituali popolari italiani, che erano restati tributati in influenze romane e longobarde, e in genere poco sensibili all’azione della Chiesa. Potremmo paragonare l’architettura dello scenario matrimoniale a un trittico. La predella sarebbe rappresentata dai primi negoziati e dall’accordo preliminare tra le parti, elemento che deve sostenere tutto l’insieme. Questi primi negoziati sono avviati da un sensale specializzato o anche da qualche volenteroso, più o meno interessato, che si presenta a porre un buon partito. In seguito si svolgono con la mediazione di uno o più “mezzani”, di solito amici delle famiglie che fanno da cuscinetto tra gli interessi contrastanti dei contraenti, per culminare infine in un intimo riscontro tra le parti, cioè tra parenti dei futuri sposi accompagnati da tre o quattro dei loro congiunti: tutti insieme, essi confermeranno gli accordi matrimoniali. Nel XV secolo, le condizioni di questo accordo erano stese per iscritto. In effetti, l’accordo resta molto spesso ancora confidenziale. Alcuni gesti simbolici avevano già comunque sanzionato l’accordo (es. A Roma “l’abboccamenteo”, a Firenze “il toccamano o impalmamento”). Dopo questo accordo, il fidanzato si precipitava dalla sua promessa sposa, e le portava di solito qualche regalo mentre la famiglia di lei gli offriva in cambio una bella cena. La prima pala del trittico consiste in un incontro solenne e pubblico tra le due parti, accompagnate dal maggior numero possibile dei loro parenti e amici. Tuttavia, vi comparivano soltanto i membri si sesso maschile delle famiglie che si accingevano ad apparentarsi. Neppure la stessa fidanzata è invitata a questa festa maschile. Il fidanzato promette di prenderla in moglie nei termini e alle condizioni convenute. Frattanto, un notaio avrà redatto “l’instrumento delli futuri sponzalitii”, nel quale saranno annotate la dote e le altre condizioni finanziarie del matrimonio. Entrano in gioco i garanti e gli arbitri, che avranno il compito di precisare i termini del contratto e di sorvegliare che siano rispettati (es. A Roma questa sequenza si chiama “fidanze”, a Firenze “giure/sponsalia”). Questo tipo di impegno è fortemente costrittivo, e non può essere rotto senza gravi conseguenze. A Firenze non si fanno delle vere e proprie pubblicazioni ufficiali. La pubblicità data all’accordo permette dunque a eventuali oppositori di sollevare prima delle nozze le loro obiezioni sulla liceità del l’unione. Ma a questo punto della procedura ‘accordo, un intervento che la rimetta in questione senza una buona ragione rischia di scatenare semplicemente la
guerra civile e almeno una duratura inimicizia da parte delle famiglie che ricevono l’offesa. Quanto al lasso di tempo che poteva intercorrere tra “l’impalmamento” e le “giure” solenni, era di solito troppo breve per poter consentire un serio controllo dall’esterno. L’applicazione delle regole sugli impedimenti di matrimonio del Concilio Laterano IV non poteva che rimanere piuttosto vaga, in simili condizioni. La seconda pala del trittico mette in scena il domicilio della fanciulla. Qui si riconoscono i suoi propri parenti e quelli acquisiti, maschi e femmine, invitati dal padre, che ha provveduto a far venire anche un notaio. Il fidanzato vi si reca con i suoi parenti e amici; allora il notaio pone le domande prescritte dalla Chiesa, così da ricevere l’assenso espresso dai futuri sposi all’unione negoziata dalle loro famiglie. Dopodiché prende la mano destra della donna e la conduce verso lo sposo che le infila al dito l’anello nuziale. Il notaio registra tutta questa sequenza “nell’instrumentum matrimonii”. Seguono a questo punto l’offerta dei regali portati dallo sposo e dal suo seguito ai nuovi parenti,e poi una colazione o un banchetto offerti dalla famiglia della sposa. A Firenze, questa cerimonia è chiamata generalmente “il dì dell’anello”. Al termine di questa giornata, i promessi sposi sono considerati ormai marito e moglie. Ma per essere perfetto, il matrimonio deve ancora essere consumato, dopo che siano stati dati segni pubblici alla comunità intera, per certificare la sua avvenuta celebrazione. La terza pala del trittico è dedicata a questa cerimonia “pubblicitaria”, nel corso della quale la novella sposa è trasportata da suo marito, i cui parenti e amici accolgono con un banchetto e con festeggiamenti che talvolta si protraggono per parecchi giorni. Tradizionalmente, è al termine del giorno delle nozze che viene consumata carnalmente l’unione. La sposa, in lacrime, prende congedo dai genitori e si reca solennemente alla casa di suo marito, accompagnata dagli amici di quest’ultimo. Vestita a festa e incoronata, montata su una cavalcatura bianca, attraversa la città sul far della sera, alla luce delle torce, scortata dagli amici dello sposo. Secondo l’Altieri, gli sposi romani si riunivano, al contrario, la domenica mattina, in una chiesa nella quale ascoltavano una messa, terminata la quale il prete li benediceva; ciò non accadeva invece a Firenze, dove il tragitto che compie la sposa verso il suo nuovo domicilio non comporta alcuna sosta in un luogo di culto. Per riassumere, viene mantenuta molto netta la distinzione tra la fase contrattuale e la fesa festiva. Nel XV secolo, l’ultima fase, cioè quella delle nozze propriamente dette, rischia di soffrire dello squilibrio che il carico raddoppiato delle cerimonie anteriori ha introdotto nell’insieme del quadro. Non è in realtà senza interesse poter collocare nel tempo queste cerimonie, collegando un determinato giorno della settimana, se si vuol cogliere l’economia dello scenario nuziale e valutare l’importanza dell’influenza che a questo punto la Chiesa può esercitare su di esso. Altieri ci fornisce alcuni riscontri cronologici. Nella Roma dei suoi avi (fine XIV) è proprio la domenica il giorno della solennità in cui si può contare sulla più grande affluenza di persone, che viene privilegiata per il trasferimento pubblico che farà sapere a tutti questa nuova unione. egli però, mentre ci specifica il lasso di tempo che divide i primi tre atti (da 8 a 15 giorni “dall’abbocacametno” alle “fidanze”), resta invece riservato circa i giorni scelti per le prime tre cerimonie. Questo abbozzo di cronologia può però essere ricostruito grazie ai narratori fiorentini. Per le tre principali cerimonie attorno alle quali si organizza il rituale, si preferisce il più delle volte la domenica: ma anche il giovedì e il mercoledì. Il predominio della domenica come giorno in cui si celebrano alcune delle cerimonie nuziali più importanti, rivela probabilmente il desiderio di conferir loro una pubblicità che faccia colpo, piuttosto che quello di integrarle alle normali cerimonie religiose domenicali. In secondo luogo, le fluttuazioni che caratterizzano il luogo e l’importanza relativa delle differenti fasi del dramma nuziale, potrebbero far emergere alcuni cambiamenti profondi di tutto il rituale. Altieri attribuisce ai suoi antenati romani una saggia discrezione, che faceva sì che s’attendesse la sera delle nozze per introdurre la sposa nel letto coniugale, per lungo che fosse stato il periodo che aveva separato il matrimonio dal momento in cui la sposa si recava da suo marito. Questa sembra essere stata la pratica più corrente nella Firenze del XIV e degli inizi del XV secolo. Nei ricordi domestici della fine del XV secolo e degli inizi del XVI, le annotazioni esplicite sul momento della consumazione si fanno più frequenti; è dunque evidente che l’unione viene consumata nel domicilio dei genitori della giovane sposa; le testimonianze dei contemporanei sembrano confortare l’impressione che vi fosse un certo accostamento tra “dì dell’anello” e consumazione. Una ragione poi che spiega la fretta con cui i Fiornetini delle classi agiate si davano a consumare l’unione è che, nel XIV secolo, è d’uso che le cerimonie matrimoniali non siano celebrati se no dopo l’avvenuto pagamento della dote. Questa norma di solito patisce innumerevoli eccezioni e distorsioni. Dopo il 1434, una nuova istituzione finanziaria, il Monte delle Doti, consente ai Fiorentini che ne hanno i mezzi di mettere a frutto un capitale, destinato a costituire la dote della loro figlia. Alla scadenza, il marito riceve la somma una volta che il matrimonio sia stato consumato. Questa modificazione della scena nuziale ha giocato in favore
del “dì dell’anello” nel quale si pronunciavano i “verba de praesenti” che rendevano ormai lecita l’unione carnale. Il giorno seguente, sin dal primo mattino, lo sposo si precipitava a pagare la gabella sulla dote, per andare a incassare subito la somma che lo Stato gli doveva. Viene così a emergere, intorno al 1500, un nuovo insieme cerimoniale più fortemente incentrato e raccolto attorno ai “verba de praesenti”. La garanzia fornita dalle istituzioni della Repubblica al pagamento della dote, testimonia una mutata attitudine delle classi più agiate nei confronti dell’intervento statale nei loro affari di famiglia. Questa dipendenza è ancora più netta nelle famiglie che fanno parte della clientela del Principe dopo il 1470. il ruolo di pronubi che i Medici rivestirono abilmente è noto. Parecchi libri di famiglia mostrano che i Medici si sono affermati con forza come i garanti per eccellenza del matrimonio tra le famiglie della loro clientela, e in seguito di tutta l’aristocrazia urbana. Dal terzo quarto del XV secolo non ci fu più bisogno della solennità e della pubblicità di una chiesa, e neppure del concorso di tutti i “parenti e amici” riuniti, per dare solennità al “giuramento”. I rituali fiorentini mantengono la presenza ecclesiastica e la consacrazione nei limiti di una pertinace marginalità. La stessa scelta della chiesa o delle sue vicinanze per celebrarvi “giure” sembra destinata soprattutto a creare un clima di neutralità, e al tempo stesso a conferire una certa pubblicità alla pace sigillata dall’”osculum” ed al reciproco impegno delle famiglie. La Chiesa non opera alcun intervento diretto nella cerimonia delle “giure”, né attraverso i suoi rappresentanti, né con la sua legislazione. L’aspetto poi più sorprendente dei rituali nuziali fiorentini e della loro arcaica autonomia, resta inoltre la grande negligenza che essi mostrano nei confronti della benedizione religiosa. Nelle classi popolari la sequela di atti giuridici che circondavano il matrimonio è più concentrata e accorciata di diversi episodi, ma qui il clero ha la possibilità di svolgere un ruolo maggiore di quello che gli spettava nei confronti delle famiglie descritte dai libri di famiglia. Non sappiamo però ben quali fossero i gesti e i simboli popolari della promessa in Toscana. Gli artigiani e i lavoratori fiorentini passavano invece regolarmente dal notaio per registrare la dote che davano alle loro figlie; ed il bravo notaio registrava accuratamente lo scambio dei consensi e la consegna dell’anello nuziale. Ma sembra che l’anello dei poveri venisse più spesso infilato sotto le volte di una chiesa, davanti a un prete o a qualche uomo di religione che serviva da testimone.(L’ANELLO NUZIALE DEI TOSCANI E LO SPOSALIZIO DELLA VEGINE) L’anello, come oggetto simbolico, ha una lunga storia nei riti nuziali dell’Occidente. L’anello di fidanzamento romana dava una garanzia alla promessa, è venuto arricchendosi più tardi della nozione orientale di caparra, o pegno sulla dote promessa. Nel corso dell’Alto Medioevo, l’anello si è trovato integrato nella cerimonia della “desponsatio” germanica, che rappresentava un impegno molto costrittivo. Quando la Chiesa poté imporre meglio la sua concezione del carattere consensuale dell’unione, la consegna dell’anello slittò dalla prima alla seconda cerimonia. In questo passaggio, essa conservò in pieno il suo carattere di promessa vincolante al matrimonio in forma definitiva, con l’effetto di autorizzare alla consumazione dell’unione. Quando un Fiorentino colto afferma di vedere nell’anello nuziale un pegno di fede scambiata, intende parlare in primo luogo della fedeltà della sposa. È soltanto lo sposo che consegna l’anello., sul quale gli aristocratici Romani descritti dall’Altieri incidono lo stemma del loro lignaggio. Sono probabilmente questi rapporti con atti giuridici e simbolici molto diversi, e il fatto stesso di essere ben radicato nel rituale popolare del matrimonio che han fatto dell’anello un oggetto simbolico d’importanza fondamentale. Questa polisemia e questa ricchezza simbolica hanno fatto convergere ben presto l’attenzione della Chiesa su di esso. Ben integrato nella nuova pastorale coniugale fondata sulla comprensione del carattere del matrimonio, è ben essi l’oggetto che ritroviamo al centro della rappresentazione del matrimonio della Vergine, nei secoli XIV e XV. Il racconto delle nozze della Vergine ,e il miracolo col quale Giuseppe fu designato come padre terrestre di Cristo, sono stati rappresentati in molti modi (es. Protovangelo di Giacomo, testo apocrifo dello Pseudo Matteo, “Libro della Natività della Vergine” = una colomba si posa sul bastone di Giuseppe, designandolo come sposo di Maria, ancora in giovane età. In alcune versioni viene nascosta la vedovanza di Giuseppe). L’iconografia di questa pia leggenda tra l’XI secolo e il 1300 si fonda su tradizioni molto antiche e varie. A sud e a nord delle Alpi, alcune rappresentazioni precedenti quest’epoca ignoravano ancora gli apocrifi: rappresentavano un semplice matrimonio, nelle forme tradizionali ereditate dell’arte antica, nelle quali una figura centrale unisce la mano di un giovane Giuseppe a quella della Vergine. Su altre immagini il racconto orientale si lascia riconoscere in certi dettagli che le versioni occidentali in seguito abbandonano, ma che rispuntano in pieno XIII secolo a nord delle Alpi: piccola statura della Vergine che non ha ancora completato la sua crescita, gesto del Gran Sacerdote che corrisponde meglio all’affidamento di Maria alla custodia di Giuseppe. Le rappresentazioni del matrimonio della Vergine che si moltiplicano nei secoli XII e XIII in ambienti tedeschi e francesi,
infine, comportano riferimenti più precisi al Libro della Natività. Intorno al 1300, queste rappresentazioni del matrimonio della Vergine sono quasi del tutto sconosciute in Italia. Sarà Giotto colui ch, nella cappella dell’Arena a Padova, rinnoverà questa iconografia in modo decisivo. Il ciclo che egli dedica alla vita della Vergine riprende i modelli preesistenti, seguendo fedelmente la “legenda aurea” di Jacopo da Voragine (si svolge alle porte del Tempio e non dentro, poiché secondo il rito ebraico il matrimonio non è un sacramento, Giuseppe mostra il pelo brizzolato, Maria è cinta da una corona di fiori). È anche vero però che la posizione frontale del sacerdote riprende lo schema ereditato dai Romani, per i quali la “Juno pronuba” e poi il suo erede, il “Crisot pronubus”, presiedevano alla destra di Juno. Giotto poi si scosta dalla tradizione del nord delle Alpi rappresentando il dono dell’anello nuziale proprio dei suoi compatrioti. La Vergine tende l’indice della destra, mentre Giuseppe le presenta l’anello. Questo rituale sarà raffigurato in tutta la gran fioritura del matrimonio successive al 1300. è poi raffigurato un giovane che leva la mano sulla schiena di Giuseppe, senza però nulla di minaccioso; Raffaello Corso vi ha riconosciuto la rappresentazione di un rito popolare che era ancora condannato dai sinodi italiani del XVIII secolo: la pacca sul dorso dello sposo del suo “competer anuli” al momento dello scambio dei consensi. La rappresentazione sul modello di Giotto conoscerà una vastissima fortuna in Italia. Sono in primo luogo i pittori toscani quelli che fanno a gara a sottolineare determinati dettagli del suo affresco. Lo “sposalizio” di Giotto conferisce al dono dell’anello un innegabile tono religioso, ma nel contempo rispetta largamente i gesti della pratica rituale dei toscani, e dunque si accontenta di collocare un attore ecclesiastico là dove i suoi conterranei facevano agire attori civili. È dunque al posto del notaio che i pittori mettono Zaccaria, ma anche a quello del padre o del tutore della sposa che consegna quest’ultima al marito nel “dì dell’anello”. Attraverso lo “sposalizio”, la Chiesa afferma la necessità del suo intervento prima che la donna sia condotta a suo marito, prima che il matrimonio si consumato. I pittori dello “sposalizio” si sono talvolta lasciato trascinare lontano, nel dedicarsi a questo spostamento iconografico dei riti popolari. I pittori toscani del XIV secolo, in effetti, hanno snaturato l’invenzione di Giotto, facendone l’indizio di un confronto esasperato tra classi d’età. E ci volle molto prima che la Chiesa combattesse contro queste congrue interpretazioni. Per tutto il XIV e XV secolo, pittori e scultori toscani caricano il gruppo dei pretendenti di sentimenti sempre più ostili. Nel XV secolo, il vero e proprio conflitto di generazioni che è ormai divenuto lo “sposalizio”, viene descritto con una crescente ricchezza di dettagli. E quando infine Signorelli fa sparire ogni riferimento al miracolo delle verghe (la colomba che si posa su quella di Giuseppe), restano in gioco soltanto i conflitti tra classi d’età, e non c’è più bisogno di invocare la leggenda per giustificare i sentimenti di violenza attribuiti ai personaggi. Lì interpretazione del gesto rituale rappresentato da Giotto (l’ostilità dei pretendenti) conduce i pittori toscani a farne il simbolo del conflitto tra le generazioni e della censura matrimoniale esercitata dai giovani celibi contro il vecchio che convola a giuste nozze. Questa tendenza dei pittori toscani è però stata sopportata dalla Chiesa fin versi il XVI secolo (si addolciscono poi le espressioni dei giovani). All’inizio del XVI secolo, anche i pittori lombardi addolciscono l’espressione dei giovani. Quando infine scompare ogni riferimento al miracolo delle verghe, i Veneziani, i Lombardi o i Romani, a differenza del Signorelli, non vedono più nello “sposalizio” altro che l’occasione per una severa meditazione sul matrimonio. Quando il rituale romano impone dovunque la benedizione dell’anello davanti all’altare e al cospetto del “magistero ecclesiastico”, lo “sposalizio” ha ormai fatto il suo tempo.(PROSPETTIVE DI RICERCA) insistendo su alcuni dei luoghi, dei gesti e degli oggetti implicati negli sponsali, il matrimonio della Vergine è servito a valorizzare i punti ai quali la Chiesa ha cercato di ancorare la sua presenza. E vi è riuscita nel XVI secolo, mettendo da parte il suo vecchi strumento iconografico dello “sposalizio”. Questi esempi mostrano come a Firenze le esortazioni ad accorciare e semplificare lo scenario nuziale dei potenti non provengono per lo più dalla Chiesa. Queste modificazioni interne vanno in direzione di una crescente privatizzazione, più che di una reale interiorizzazione del carattere consensuale del matrimonio. I limiti pratici della dottrina in materia di consensi sono altrettanto evidenti negli statuti sinodali fiorentini del 1517. A quest’ epoca, il clero fiorentino si propone di combattere le pratiche popolari di ignoranti che non comprendono la forza delle parole che pronunciano, credendo spesso di fidanzarsi quando invece pronunciano le parole stesse del matrimonio. Ebbene, il rimedio è impegnare le parti a invitare il prete parrocchiale o un notaio, che chiederanno al futuro sposo se accetterà di sposare la ragazza quando lei stessa o la sua famiglia lo pregheranno di farlo. Combattendo l’ambiguità degli accordi popolari, la Chiesa fiorentina del 1517 condanna anche il oro carattere reciproco. In maniera ambigua, e ancora alquanto timida, lo “sposalizio” ha preparato il terreno alla penetrazione della Chiesa in questi rituali. Ma non ha potuto influire se non proponendo a sua volta la figura di un pontefice che si
avvicina molto nei gesti e nelle funzioni, al ruolo del tradizionale “donatore” della sposa e garante del contratto matrimoniale.6 IL COMPLESSO DI GRISELDA. DOTE E DONI DI NOZZE NEL ‘400Diana Owen Hughes ha ricostruito in che modo in Occidente si sia verificato il passaggio da un sistema di prestazioni matrimoniali fondato sul “prezzo della sposa” al sistema dotale vero e proprio. Ha toccato la maggior parte delle regioni dell’Europa occidentale tra l’XI il XIV secolo. Si è mostrata precoce nell’aristocrazia, che fu seguita più tardi dalla borghesia d’affari delle città mercantili. Ha poi subito un’accelerazione e un’amplificazione con l’aumentata circolazione monetaria, e con la crescente complessità degli scambi economici. Infine, essa è andata di pari passo con l’affermarsi più netto dei diritti dei maschi sul patrimonio fondiario ereditario dei loro padri, a scapito delle loro sorelle. È possibile che gli uomini abbiano preferito ormai fornire una dote ai membri femminili del loro gruppo di filiazione, piuttosto che alle loro spose. Negli ultimi due secoli del Medioevo questa evoluzione si è già compiuta nell’Italia centrale e settentrionale. Questa pratica dotale riflette un’esigenza ormai totalmente interiorizzata. La dote penetra nel cuore dell’ideologia sociale del tempo; funziona dunque come una sorte di regolazione sociale. E, se largita a fanciulle povere e meritevoli, diviene anche opera di misericordia. Dopo il 1430, un’importante innovazione finanziaria la colloca al centro dell’apparato statale. Istituendo una sorta di assicurazione dotale, il Comune di Firenze garantisce il maturare di una dote “decente” a una ragazza di diciotto anni il cui padre abbia accettato di sottoscrivere un deposito al “Monte delle Doti”. Eppure, l’affermarsi della dote non va esente da urti e da tensioni. Intorno alla metà del XIV secolo, si levano le prime voci di dissenso, che venfgono in particolare sullo smisurato e sempre crescente ammontare delle doti. Ma il principio non viene mai rimesso in questione. Bisogna però sottolineare come moglie dote vadano sempre nella stessa direzione. Perché mai una famiglia nella quale la donna entra dovrebbe esigere prestazioni supplementari, come la dote o un corredo, quando attraverso il matrimonio di uno dei suoi figli acquisisce giù i diritti sulla sposa, sul suo lavoro e sulla sua discendenza? La funzione che i giuristi del tempo attribuiscono alla dote non offre soluzioni soddisfacenti. Inoltre, in caso di morte del marito, la vedova riesce a stento a recuperare quella stessa dote della quale deve campare. Dunque la dote serve ad assicurare un flusso di beni dalle famiglie di donne agli eredi delle famiglie che le hanno ricevute (così secondo Jack Goody). Questa teoria però si applica purtroppo alquanto male alle contrade europee. A Firenze, il sistema dotale funziona dunque contro la teoria, e per giunta funziona male, crea tensioni insopportabili, suscita infine recriminazioni da parte di coloro che lo vivono quotidianamente. Tuttavia funziona, e diventa il sostrato nel quale vengono a radicarsi riflessi psicologici e rappresentazioni sociali. Sono ben rari, nei secoli XIV e XV, i documenti notarili che menzionino altra cos che la dote e gli atti legali che presiedono alla sua determinazione e alla sua consegna. Al contrario i libri di famiglia si distinguono anche per la ricchezza e la precisione con cui registrano i più minuti avvenimenti associati al rituale privato o pubblico delle nozze che ci riferiscono. Il loro redattore suole notare accuratamente lo svolgimento cronologico dell’intero processo matrimoniale. La stessa dote, con tutto ciò che la costituisce si trova là registrata in dettaglio, e con molta più accuratezza che nei registri notarili. In particolare, vi appariva in tutta la sua diversità e varietà, l’insieme dei doni che si scambiavano gli sposi e le loro famiglie.( DONI MARITALI: UNA COTRODOTE CLANDESTINA?) Ogni operazione che concerne la dote ed il corredo richiede, nel ‘400, una pubblicità legalizzata. Così, il pagamento della parte monetaria della dote, viene scaglionato a partire dallo scambio dei consensi e ciascuno di questi pagamenti produce un atto ufficiale debitamente registrato da un notaio, e compiuto in presenza di testimoni. I versamenti possono succedersi per la durata di anni. Ma avviene molto di rado che la donna vada a stabilirsi presso suo marito prima che almeno parte della dote sia stata versata. Quanto al corredo, è obbligatorio che sia consegnato per le nozze o il giorno seguente; il suo trasporto sanziona il compimento del matrimonio, la coabitazione e la consumazione. Altre prestazioni si compiono, alle quali però viene data una pubblicità ben inferiore. Nei giorni o nei mesi che precedono il matrimoni oil marito in effetti fornisce sua mogli e di un intero guardaroba: un vero contro-corredo. Questi doni maritali costituiscono una sorta di contrappeso alla dote recata dalla sposa, contrappeso da giudicarsi anche nel cotesto delle procedure simboliche attraverso le quali si instaurano nuovi rapporti tra diversi lignaggi o all’interno delle famiglie (es. Marco Parenti spese per sua moglie una somma che rappresenta più di due terzi della dote: egli sposa al di sopra del suo rango). Benché il diritto non prescriva niente di simile, l’impegno di vestire adeguatamente la sposa nel periodo nuziale è avvertito come una necessità ineluttabile da parte del marito toscano. Le somme spese dai mariti, salvo qualche caso, restano in genere entro limiti ragionevoli. Questo tipo di obbligo non è
caratterizzato dal solo strato superiore della società urbana. Anche il marito di campagna si sente di fatto obbligato a “mettere addosso” a sua moglie una somma equivalente all’altra metà della dote. E poiché anch’egli, come i Fiorentini benestanti, non dispone che molto di rado dei liquidi necessari, sarà costretto ad attendere il pagamento contante della dote, per trarsi d’impaccio e ricevere la donna alla quale ha già infilato l’anello nuziale. L’interdipendenza delle due parti è dunque estremamente sensibile. È chiaro che il versamento della dote non viene sempre considerato un fattore di arricchimento per lo sposo; quando il padre gli manda la ragazza con tanto di corredo e di danaro sonante in abbondanza, il marito sovente si lagna che tanto gli sarebbe valso di non prendere moglie per niente, visto che la dote in denaro liquido dovrà servire a vestire la sposa. Le testimonianze a noi giunte sembrano voler dire che una parte della dote era distolta dalla soddisfazione delle necessità della vita coniugale, per rispondere piuttosto a quella dei bisogni personali della donna maritata. Di sicuro, la dote non è in grado di lanciare il giovane marito nel mondo degli affari. Come interpretare allora la moderata opposizione dei mariti fiorentini a queste esigenze del costume? A dire il vero, i doni nuziali non si possono confondere con la “donatio propter nuptias”, contropartita maritale della dote, che dopo il XII secolo e la nascita del diritto romano è coesistita con il “Morgengabe” di origine germanica, e ne ha assunto la veste fino a rimpiazzarlo un po’ ovunque nell’Europa meridionale. È noto che questa donazione è stata mantenuta, a partire dal XIII secolo, entro limiti assoluti, che le hanno sottratto qualunque sensibile importanza pecuniaria, nel momento in cui l’ammontare della stessa dote si innalzava anche nelle classi urbane. Nel diritto, come nella pratica, la donazione del marito è dunque venuta eclissandosi. Eppure, essa esprimeva un bisogno che il diritto aveva sempre rispettato: quello di stabilire uno scambio reciproco, e all’incirca equivalente, tra le due parti contraenti. È la stessa esigenza che troviamo nella donazione del “Morgengabe” (morgincap dei documenti toscani), dono che il marito fa a sua moglie il mattino della notte di nozze. Un tempo composto di beni immobili, ha ben presto suscitato reazioni ostili, che si sono poi tradotte nelle limitazioni poste al libero godimento di questa donazione da parte della donna. Si impose a poco a poco che il morgincap tornasse agli eredi del marito. La rivoluzione giuridica operatasi a partire dai secoli XI e XII non era certo stata in grado di cancellare una struttura di scambi che affondava le sue radici in un’epoca lontana. Mi sembra che l’obbligo della vestizione della sposa da parete di suo marito prosegua direttamente la funzione che aveva assunto il Morgengabe. Non bisogna però giudicarlo come forma giuridica degradata.(LA “VESTIZIONE” DI GRISELDA) Il fatto che la sposa faccia portare al suo nuovo domicilio la sua biancheria e i suoi oggetti personali, che costituiscono il corredo, significa che la famiglia nella quale è nata in qualche modo rompe i suoi legami e rinuncia ai suoi diritti su di lei. La letteratura etnologica ha mostrata che l’atto di vestire la sposa è un rito di passaggio, e più precisamente un rito di aggregazione. La pratica dei Fiorentini lo conferma. Il marito fiorentino resta comunque il principale proprietario degli oggetti che vengono offerti a sua moglie durante il periodo delle nozze. La sorte alla quale i suoi doni vanno incontro alla dissoluzione del matrimonio, resta sospesa alle sue ultime volontà. Nei casi in cui la moglie ha potuto conservarli fino alla sua vedovanza, è necessario, per garantire che la sposa ne possa godere, che il marito la abbia espressamente destinati a ciò nella stesura del testamento (es. Notaio se Antonio Bartolomei che in tal modo lascia alla sua futura vedova vestiti, gioielli e danaro). Più di una vedova abbandonava il tetto coniugale, in caso di mancata precisazione nel testamento, lasciandovi agli eredi non soltanto la dote e il corredo, ma anche lo stesso guardaroba rituale del giorno delle sue nozze. Ben prima che la coppia sia separata dalla morte, ci si accorge che i doni in vestiti e gioielli fatti alla sposa sono assai di frequente recuperati da suo marito poco dopo il matrimonio. Spesso egli li aveva addirittura presi in prestito da parenti, amici, gioiellieri o prestatori di professione, ai quali li restituisce dopo un certo lasso di tempo, in genere nel giro di una anno. Talvolta il marito, una vota terminato il rito, arrivava a vendere questi ornamenti (es. Marco Parenti). Quando il marito non le ha prese in prestito, trae sovente un profitto facendole cedere in affitto da professionisti di questi scambi ad altri sposi in cerca del bagaglio nuziale di rito. Il fatto che si possano prendere a prestito, mette in luce il ruolo essenzialmente rituale del gesto di offerta che il marito deve fare a sua moglie. Figura emblematica potrebbe essere la Griselda immortalata da Boccaccio nell’ultima novella del Decamerone. In Griselda, che viene presa vergine, povera e ignuda, addobbata per le nozze in presenza di tutti i vassalli e poi rispedita via in camicia dal barone suo sposo nella misera capanna ove è nata, i contemporanei di Boccaccio avranno certo riconosciuto gesti e comportamenti profondamente radicati nella pratica nuziale del loro tempo. Verso la metà del XIV secolo, la vestizione della sposa ad opera del marito conserva il carattere costrittivo dei gesti rituali. Per oltrepassare le frontiere che separano il mondo umano da quello
soprannaturale, Griselda deve dapprima assumere gli abiti che le si convengono, e poi spogliarsene. Allo stesso modo, la donna fiorentina porterà con sé i suoi beni dotali, e Griselda la sua camicia, lasciando ogni ornamento donatole dallo sposo sotto il tetto degli eredi di lui. la “vestizione” di Griselda e l’abbigliamento della sposa mantengono i “doni” del marito nel campo del simbolico. Tuttavia, la natura e le particolarità di alcuni altri doni che vengono fatti alla sposa dai suoi parentadi, possono servire a chiarire il contesto nel quale il marito adornava sua moglie e l’accoglieva sotto il so tetto.(IL GIOCO DEGLI ANELLI) A Firenze, il giorno delle nozze o la mattina seguente, il padre del marito e alcuni membri del suo parentado facevano da parte loro alla novella sposa dei regali, che consistevano generalmente in anelli. Nel gruppo dei donatori figurano in buona evidenza delle donne parenti prossime dello sposo (es. Resoconto di Francesco di Giuliano d’Averardo). Nessuna ragazza nubile partecipa però a questo gioco. Questo fatto ci vieta di interpretare la consegna degli anelli come un ricordo dello sposalizio nel quale il marito, nella casa di suo suocero, aveva offerto due o tre anelli a sua moglie, dopo lo scambio dei consensi. Sembra che gli anelli assegnino alla novella sposa il suo posto in un gruppo di parenti, ma più precisamente in un gruppo di donne. Per effetto di essi, ella si trova fin da principio situata all’interno della famiglia coniugale, quella che forma con suo marito. Tutti questi anelli, in un certo senso, tracciano i limiti della parentela e inseriscono la sposa nei suoi cerchi concentrici. Ma gli anelli hanno un altro significato ancora. Nella presenza dominante che qui esercitano le donne parenti del marito, s può anche leggere l’insistenza nel far comprendere alla novella sposa il suo statuto di donna all’interno della nuova famiglia. La sposa si trova ad essere trapiantata anche dal suo gruppo di fanciulle sottomesse a un padre. Il fatto è che donando un anello alla novella sposa, le parenti del marito si privano del possesso di un regalo che era stato fatto loro esattamente nelle stesse circostanze. Le ricordanze ci dicono che questi doni non hanno altro senso che quello rituale, e che non entrano, più dei vestiti e dei gioielli offerti da marito, nel definitivo possesso di colei che li riceve. Gli anelli sono donati alle novelle spose da parte di mogli già insediate, ma sono pur sempre gli uomini che restano padroni del gioco (es. Filippo Strozzi apre una rubrica “Anelli donati” nel suo libro di famiglie). Il simbolismo dell’anello è largamente usato nei libri di famiglia. Eppure, la circolazione degli anelli può essere bloccata per molto tempo, e i legami della parentela acquisita, se gestiti in modo sbagliato, si possono allentare. In effetti, un circolo di doni tra parenti acquisiti non può essere inaugurato se non per iniziativa di un uomo sposato, poiché parentado della donna, a Firenze, non prende parte all’offerta dei doni, il giorno delle nozze, nella casa del marito. È possibile che se i pagamenti della dote sono differiti per troppo tempo, e se i rapporti tra le famiglie si sono inaspriti, il marito non si dia punto da fare per inaugurare un ciclo di scambi regolari. L’acquisizione della parentela, dunque, non sfocia automaticamente in rapporti rituali costanti e ciclici tra le famiglie. Ma come raggiungere questo scopo, nei casi in cui i matrimoni sono separati da lassi di tempo tropo lunghi? A Firenze, un’altra serie di scambi incrociati viene a dar seguito allo scambio degli anelli e dei doni di nozze. Questi avvengono in occasione delle nascite di bambini in seno di queste unioni, e comportano il medesimo obbligo di restituire l’oggetto “donato”. I Fiorentini vedevano in ciò esplicitamente un sostituto e una prosecuzione del gioco di scambio degli anelli. Alla nastia del bambino nella borghesia fiorentina, è d’uso offrire alla madre una coppa d’argento, adorna degli stemmi delle due famiglie che col suo matrimonio si sono imparentate. Questa tazza viene a rinnovare il ciclo di scambi, al momento in cui l’anello ha già compiuto i suoi giri di andata e ritorno. Se poi prendiamo in considerazione anche le prestazioni alimentari di ogni genere che accompagnano e ritmano il processo nuziale, ci è facile constatare che esse condividono con i regali agli sposi questo carattere di reciprocità e di circolarità del dono (es. Altieri sottolinea l’importanza di questo gesto). La pratica fiorentina che affiora tra le annotazioni dei libri di famiglia, testimonia della scrupolosa cura con la quale venivano in effetti registrati questi prestiti e il loro movimento. Così, il rituale definisce e riproduce tutta una serie di cicli di scambio. Se prestiamo fede all’Altieri, i doni che il matrimonio provoca, a Roma, esigono che entrambi i parentadi si trovino riuniti in uno stesso luogo. Dopo lo scambio dei consensi che si compie, come a Firenze, nell’abitazione del padre della sposa, “tutto el parentato delli più proximi et coniuncti del marito”, che lo ha accompagnato, ripete subito dopo di lui il gesto, e offre “qualche anelletto avero alguna altra cosetta” a sua moglie. La risposta non si fa attendere: la madre della sposa offre a suo genero un bacile ornato degli stemmi delle due famiglie, e a “tutti coloro quali havessiro dunato”, fa dono di qualche pezza di stoffa. A Firenze, invece, il contributo degli amici e dei parenti del marito si limita, quel giorno, a un modesto contributo di confetteria e cibarie destinate alla colazione che concluderà la giornata. Dopo aver infilato l’anello a sua moglie, lo sposo fiorentino procede a una distribuzione di veli, di stoffe, di cuffie e di calzature o di zoccoli a alle
donne della famiglia di sua moglie. La risposta e i contro doni no seguiranno che il giorno successivo, quando arriva il corredo, e la donna si dà a distribuire a sua vola veli, camicie, pantofole o piccoli doni ai membri della casata di suo marito. I Fiorentini quindi hanno preferito associare il parentado del marito all’insediamento della posa sotto il suo tetto, piuttosto che al rito di formazione della coppia, secondo i precetti della Santa Chiesa, presso il padre della donna.(L’OSTENTAZIONE SUNTUARIA) I reali di nozze, che potrebbero sembrare fittizi poiché provvisori e fugaci, sono tuttavia dei doni nel senso proprio della parola: perché essi siano veramente efficaci, è necessario che siano restituiti. Ecco perché ci si sforza di farli circolare il più possibile, non solo subito dopo il matrimonio. Il potere pubblico ha cercato di imporre dei limiti a questo gioco di scambi del quale non era in grado di controllare lo svolgimento. Ci si può chieder perché porre limiti all’espressione rituale dell’alleanza matrimoniale, e delle particolarità che essa poteva assumere in luoghi diversi. Su questo punto, le delibere suntuarie sono assai prodighe si insegnamenti. Nel XIV secolo, sembra che sci si preoccupi di limitare le esagerate gozzoviglie cerimoniali, più che la quantità dei regali o il numero dei donatori. Tuttavia, alcuni statuti ci fanno vedere già a partire da quest’epoca la diffidenza che le autorità religiose o quelle comunali provavano nei confronti dello scambio di doni e controdoni, che faceva ripercuotere lontano dalla cerchia dei parenti più prossimi il dispendio che un’unione matrimoniale comportava (es. Statuto di Arezzo del 1327 vietava a chiunque di offrire doni alla moglie il “dì dell’anello”, e di mandare dei donamenta al marito per tutto l’anno successivo. Limita poi il valore del “cofanellum vel aliqua areda” inviati dal marito a sua moglie). Anche a Firenze, fin da principio si porranno dei limiti alle riunioni pubbliche in occasione degli sposalizi, prima ancora che si osasse contemplare la possibilità di limitare quelle dei parentadi in occasione dei banchetti nuziali; nel 1415, duecento invitati maschi potevano ancora partecipare alle “giure” dei ricchi Fiorentini, mentre solo una trentina di persone di entrambi i sessi viene invitata a partecipare al pasto di nozze. Le leggi suntuarie cercano talvolta di smontare il meccanismo ad opera del quale doti e regali del marito sono trascinati in una spirale inflazionistica, in una sorta di corsa alla rovina (altro es. Statuto di Tivoli; nel 1308 vengono aggiunti alcuni articoli intesi a regolare lo svolgimento delle nozze).7 LE ZANE DELLA SPOSA. LA DONNA FIORENTINA E IL SUO CORREDO NEL RINASCIMENTOQuando una fanciulla si sta per sposare, nel XV secolo, il problema della sua dote e del suo corredo preoccupa già da tempo i suoi genitori. Il ruolo e il significato giuridico delle prestazioni e dei doni collegati con il matrimonio nel Rinascimento sono divenuti anzitutto l’occasione di affermare al cospetto di tutti la posizione sociale alla quale pretendono di appartenere le due famiglie che partecipano al matrimonio. Il corredo può, a differenza della dote, essere esibito tutto intero, al momento del suo trasporto, oppure nei suoi singoli componenti, sia addosso alla sposa che nella sua nuova dimora. In contraccambio, il marito e la sua famiglia non dovranno lesinare sui doni e sulle vesti da parata che la novella sposa indosserà, in loro nome, nel giorno delle nozze e per l’intera anno successivo. Tra la metà del XIV secolo ed il primo terzo del XV, i corredi fiorentini rappresentano una parte più o meno costante nell’insieme dei beni recati alla donna. Tuttavia, né il costume né il diritto sembrano istaurare un rapporto fisso tra il corredo e gli altri apporti dotali da parte femminile. Da allora, il corredo non rappresenta più un affare di modesta importanza. Nel periodo di cui ci stiamo occupando, si ritiene in pratica che il corredo faccia semplicemente parte della dote. Ora, tra il XII e il XV secolo, il diritto ha subito una profonda evoluzione. Certo, la donna si vede riconoscere dai giuristi e dagli statuti comunali garanzie di principio e di procedura, per quanto riguarda la restituzione della sua dote in caso di vedovanza; tuttavia essa nella pratica si trova a urtare contro interpretazione riduttive dei suoi diritti, e contro i ritardi e le inadempienze della famiglia di suo marito che riescono anche troppo spesso a impedire di esercitarli effettivamente. Mentre i due coniugi sono in vita, il dominium e l’administratio dei beni dotali spettano in modo incontestabile al marito. Il valore del corredo, in questo periodo, è sempre calcolato sull’ammontare totale della dote. Designato con il termine “donora”, il corredo delle donne fiorentine deve essere loro restituito per un valore equipollente quando la morte del marito le rende vedove. Incluso com’è nella dote, il corredo ne segue dunque le sorti. Le conseguenze dell’assimilazione dei beni “parafernali” a quelli dotali non sono però sempre così cupe. Infatti, se il contesto giuridico si presenta generalmente sfavorevole alle vedove, vi sono garanzie legali sufficienti a consentire a queste donne un margine di manovra discretamente ampio. E il corredo trae vantaggio dal suo inserimento tra i beni dotali, poiché si fa obbligo di restituire il valore di stima fissato all’inizio dell’unione, quando quei beni d’uso erano quindi ancora nuovi. All’opposto, sembra che quando la moglie muore senza aver dato figli a suo marito, l’antico obbligo di restituire il corredo alla famiglia della donna venga a cadere in disuso nel corso del XIV secolo. Le ricordanze fiorentine
attestano talvolta che il marito si sente in obbligo di restituire alla sua famiglia acquisita gli abiti e gli oggetti personali che la moglie defunta gli aveva portato in casa (es. Ser Niccolò Monachi). Nell’ultimo quarto del XIV secolo il costume esige dunque ancora che gli oggetti più intimi della donna siano rimandati alla famiglia d’origine. Nel XV secolo, le ricordanze fiorentine non fanno apparire più traccia delle origini legali di quest’usanza. Come la dote pecuniaria, il corredo tende sempre più ad essere assorbito tra i beni della famiglia che si è formata e dei suoi discendenti. Ci si può chiedere se la famiglia della donna, e la sposa stessa, non avessero sviluppato una tattica che portasse a gonfiare il valore del corredo a scapito della parte pecuniaria della dote. La famiglia del marito, dal canto suo, si preoccupa di non congelare una parte troppo grande della dote in beni d’uso destinati alla moglie; così, la “scritta”, o accordo preliminare tra le famiglie, stabilisce esplicitamente l’equivalente in valuta delle “donora” promesse. Se la stima reale dei rigattieri corrisponde al valore previsto inizialmente, i numerosi articoli del corredo che non sono compresi in tale stima sono il segno rivelatore delle pressioni esercitate dalla famiglia della sposa per far sì che le “donora” esibiscano una munificenza che sfugge ad ogni calcolo. Ed è proprio questa larghezza ciò che costringerò il marito ad una risposta altrettanto generosa nei confronti della moglie. Queste osservazioni ci consentono di restituire al corredo un ruolo centrale tra i beni che la donna reca con sé. Ciò significa anche restituire al vestiario e agli ornamenti tutto il loro significato sociale. Nel primo periodo i corredi femminili comprendono spesso bauli che dopo il 1450 scompaiono del tutto dal novero degli oggetti portati dalla donna. Ciò che la sposa reca nella casa del marito il giorno delle sue nozze, concerne soprattutto il suo corpo e il suo uso personale. Ogni buon corredo comprende una o due dozzine di camicie lavorate all’usanza da donna novella, e diversi tipi di biancheria intima. In alcuni rari casi a noi pervenuti alcuni capi alludono anche alle funzioni procreative della sposa e alla sua futura qualità di madre. Non c’è poi corredo che non contenesse qualche vestito da festa. Il terzo e immancabile sottoinsieme riguarda le cure della toilette personale e gli arnesi che dovranno tenere occupati il corpo e le mani della sposa; ogni giovane moglie ha con sé il necessario per cucire. Tre ordini di valore, tutti collegati con il corpo femminile, regolano l’organizzazione del corredo: l’intimità; la pompa e il prestigio di cui esso dovrà recar testimonianza; l’attività silenziosa e quasi immobile della donna, reclusa nella propria casa. Il corredo fiorentino del XV secolo non trascura nemmeno la sua anima. Vi è infatti incluso di regola un “libriccino di donna” o “di Nostra Donna” che non è altro che un libro di devozioni, talvolta anche “miniato”. Non è poi raro che la moglie entri nella stanza maritale qualche immagine sacra, anche se ciò è di solito affidato allo sposo. Ancor più degne di nota sono le figurine di personaggi della storia sacra, sorta di bambole devote che raffigurano il Bambino Gesù ovvero qualche santa. A loro volta sono fornite del proprio guardaroba di vestiti di broccato o di velluto, queste bambole sono collocate sopra un altarino familiare, o dentro un tabernacolo fatto fare appositamente. Nella loro stesa composizione e struttura, i corredi delle donne fiorentine del Rinascimento esprimono ciò che gli uomini del tempo ponevano al centro del matrimonio: una donna, futuro ricettacolo del seme maritale. Ella deve essere vergine e illibata quanto nuovo e fiammante è il suo corredo. Non vi è niente nel corredo che parli chiaramente del vivere quotidiano, della coppia, della sua fondazione e della sua durata, e neppure del legame che si viene a creare. L’accento posto in modo quasi esclusivo sul corpo femminile è probabilmente tipico delle classi superiori della società urbana. Conosciamo molto meno il contenuto dei corredi popolari. Di questo corredo è artefice la stessa fanciulla? Non disponiamo che di marginali indizi. Si può per lo meno constatare che il taglio degli abiti di gala che ne costituiscono i capi più importanti viene affidato a degli specialisti. Su questo argomento intervengono anche le donne di casa, e con una certa autorità. Dal lato della famiglia del marito, accade più o meno lo stesso: anche là sono le donne quelle che lavorano per costruire il “corredo” maritale. È infatti a lui che spetta, almeno dopo il 1450, il compito di mettere insieme le “masserizie”, cioè i mobili della camera e la biancheria di casa. In questo compito, lo sposo è aiutato dalle sue parteni più prossime. Svariati indizi portano poi a credere che il corredo rappresenti il principale canale attraverso il quale dei beni femminili sono trasmessi da una madre a sua figlia. Ad esempio alcune testimonianze ci mostrano come delle figurine del Bambino Gesù e di santi e sante riccamente adorne seguono dunque delle vere e proprie linee di successione femminile, che s’interrompono soltanto nel caso che colei che le eredita entri in convento. Altri capi meno caratteristici seguono itinerari analoghi. Il libro delle preghiere, per esempio, ed è assai probabile che molte altre di queste “cose minute”, raffinati oggetti da toilette o da cucito abbiano seguito la stessa via. Ed è anche questo il modo in cui si conserva nella figlia il ricordo della madre. I legami tra donne sono infatti particolarmente, poiché spesso la morte della madre li tronca prematuramente, o un suo secondo matrimonio li rende più deboli. La trasmissione in linea femminile assume talvolta forme ancora più sottili.
Come interpretare altrimenti il ritorno di determinati colori, le ricorrenze cromatiche che caratterizzano il corredo di una figlia, seguendo il modello di quello materno? Anche qui, non si possono ravvisare con precisione queste filiazioni dei corredi, se non quando essi si allontanano dalla norma corrente. Ma il corredo non è soltanto metafora. È anche una ricchezza ben tangibile e reale, strettamente collegata alla donna. Lo si indovina dal modo in cui viene “gonfiato”, ben oltre il suo valore negoziato preventivamente, in un gioco nel quale le due famiglie che partecipano al legame matrimoniale cercano di far sì che la donna abbia il massimo beneficio possibile. In un simile contesto, è precisamente sul corpo della donna che si gioca questo confronto. La donna non è soltanto la vetrina di suo marito, ma è il supporto di una rivalità tra due gruppi di parentela concorrenti.8 GENITORI DI SANGUE, “GENITORI DI LATTE”. ANDARE A BALIA A FIRENZELa borghesia fiorentina ha praticato assai largamente,a partire dalla metà del XIV secolo, l’affidamento a balia dei suoi bambini. Ciò viene puntualmente registrato nei libri di famiglia. Tali ricordanze fanno apparire l’ampiezza sociale dell’affidamento a balia, almeno per quanto riguarda il XV secolo, mentre prima del 1360 è ancora piuttosto difficile farsene un’idea esatta. Le ricordanze inoltre non segnalano mai in alcun modo che le madri fiorentine abbiano allattato i loro figli, a meno che non si tratti di circostanze eccezionali. Si dovrebbe poter scendere a un livello sociale ancor più basso, probabilmente,e soprattutto uscire dall’ambito di Firenze, per ritrovare un mondo in cui la madre adempie alla naturale funzione di allattar i suoi figli. Non esiste alcuna discriminazione sul problema di sapere quale dei figli la madre alleverà personalmente, e quale no; ma può invece intervenire, in funzione del sesso e del rango del bambino, nella stessa scelta della nutrice. Le ricordanze ci chiariscono quali siano stati i criteri seguiti nella selezione di queste vice-madri, ed anche quali fossero le modalità d’esercizio ed i controllo esercitato sull’allattamento a balia.(LA SCELTA DELLA BALIA) A Firenze, dare a balia un bambino implica per la maggior parte dei genitori una separazione dal bambino stesso. La tendenza generale tra ‘300 e ‘500 è verso una certa sparizione della balia che vive sotto lo stesso tetto del suo datore di lavoro. Le balie rurali sono i costante crescendo dal 1300 al 1530. gli statuti comunali del 1415 e la pratica descritta dai libri di famiglia mostrano che il salario della balia varia ampiamente, a seconda della sua residenza. Una balia in casa è un lusso che si paga molto più caro di quanto non costi una contadina che continui a vivere nella sua masseria. Se viene ad abitare presso il suo datore di lavoro, la donna guadagna dai 18 a i 20 fiorini all’anno, tra il 1400 e il 1480, che è più di quanto percepisca qualunque altra categoria di salariati domestici. La mappa della residenza delle diverse balie mostra che i Fiorentini non erano affatto restii a mandare i loro neonati abbastanza lontani da casa loro. Per quanto riguarda le nutrici fiorentine vere e proprie sembra che fossero riservate all’impiego per brevi periodi. Un primo campione, che si riferisce alle balie, rivela che i Fiorentini tengono in casa più spesso i maschi che le femmine. Anche l’ordine di nascita ha la sua importanza in queste strategie dei genitori: in una famiglia su quattro, il figlio/a maggiore o i figli/e maggiori godono di un certo vantaggio sui loro fratelli più giovani, e sono mantenuti più volentieri entro un raggio più breve dalla loro casa. È però difficile affermare che si tratti di una politica cosciente da parte di questi genitori. Come trovare la balia ideale? Il futuro padre fiorentino che si mette a cercarla fa correre la voce in tutta la sua cerchia di clienti e di amici. Se è lui stesso proprietario di qualche bene in campagna, può contare sulla conoscenza del terreno. 0nei casi più disperati, il padre può infine ricorrere a una di quelle “acconciatrici di balie e di serve” specializzate. Ma qual è dunque la balia ideale? Il primo criterio di scelta è l’abbondanza e la “freschezza” del suo latte. La balia ideale è una donna che abbia partorito da poco, e il cui bambino è morto (es. Margherita Datini era spesso incaricata di cercare balie e seguiva questo criterio nel limite del possibile). Alla fine del XIV secolo,e ancora nel corso del XV, la maggior parte dei nuclei familiari urbani più abbienti hanno in proprietà delle schiave domestiche. La loro presenza non è costante. E le funzioni alle quali sono destinate sono la soddisfazione delle esigenze sessuali del padrone di casa, dei suoi figli che tardano a sposarsi o degli amici di famiglia, e in secondo luogo l’allattamento dei loro neonati. La gravidanza di una schiava non presenta solo aspetti negativi, ma comporta anche la possibilità di un rischio, cioè il deterioramento di un prezioso capitale, ma se il parto è andato bene, suo figlio può essere prontamente abbandonato in uno degli ospizi cittadini,e così la schiava, in due o tre anni di onesto servizio, permetterà al suo fortunato proprietario di ammortizzare il denaro investito per il suo acquisto, facendogli risparmiare le spese di una balia salariata in casa, oppure gli procurerà una cospicua rendita facendosi collocare “cum lacte” sotto un altro tetto. Anche delle serve libere di condizione libera non sono del tutto al sicuro da questo genere di calcolo. Ciò che abbiamo appena detto suggerisce l’idea che i criteri più importanti nella scelta di una balia non dovevano essere le sue qualità morali. La
maggioranza delle donne che offrono il loro latte,se ne può essere certi, esibisce un’identità coniugale del tutto irreprensibile. Una volta su quattro, tuttavia, il libro del Fiorentino non riporta che le generalità del balio, il marito della nutrice, e passa completamente sotto silenzio il nome personale della donna. Dietro la ruvida figura del marito, la balia resta un’ombra indistinta; è all’uomo che il padre affiderà il bambino da allevare e da allattare.(L’ALLATTAMENTO: UNA FACCENDA DA UOMINI) Nella gestione dell’allevamento a balia, gli interventi dei genitori hanno origine soprattutto dal padre. La contrattazione si concluderà il più delle volte tra il padre naturale e il balio. Se hanno deciso di prendersi in casa la balia, i Fiorentini la sistemano, a quanto pare, nella parte alta della casa, vicino alla cucina, “nella camera delle serve”. In questo modo, è più facile per loro controllare gli spostamenti delle donne del loro ambiente domestico, e sorvegliare la gente che esse frequentano. Tenere la balia in casa ha in effetti il vantaggio di evitare la possibilità, teoricamente plausibile, che una gravidanza inattesa venga ad interrompere l’allattamento. Quando un bambino viene portato fuori dalla casa paterna in braccio alla sua nuova madre, il controllo sul susseguirsi degli avvenimenti si allenta, salvo nel caso in cui i parenti affidatari e mezzadri della famiglia si vengano a confondere. Non sembra poi che il padre si prenda la briga di spostarsi appositamente per seguire di persona i progressi del suo rampollo. Gli affidatari portano qualche volta il bambino a Firenze “a farlo vedere”. Ma le notizie circolano soprattutto grazia a degli emissari che percorrono continuamente la campagna, dalla residenza cittadina alle cascine dei Fiorentini.(LE ROTTURE DI CONTRATTO) Se la balia rimane incita, o se il bambino non cresce bene, il padre è costretto a cercarsi una nuova nutrice o a rompere il legame che lo legava ai balii. È a lui che tocca riconoscere eventuali alterazioni del latte, far confessare gravidanze tenute nascoste e prendere, se il caso,la decisione che s’impone. Dal momento in cui si accorge del suo stato,una balia onesta deve riportare il bambino ai suoi genitori. Le ricordanze mostrano chiaramente che il più delle volte, in effetti, lo fa. Questi incidenti di percorso quello di far sì che alcuni bambini vengano sballottati da una balia all’altra. In media, essi restano non più di una decina di mesi presso una sola nutrice. Questa mobilità è forte soprattutto nel XIV secolo, e si va attenuando sensibilmente nel XV.(LA MORTE DEL BAMBINO) Circa il 20% delle cessazioni di affidamento a balia sono imputabili al decesso del neonato. Nell’85% dei casi è la “malattia” che s’è portata via il bambino: negli altri, i parenti affidatari sono costretti a confessare di essere la causa diretta della sua morte, e che lo hanno “affogato” mentre dormivano. Secondo il padre, l’incidente è dovuto una sola volta al marito della balia, che viene accusato formalmente di essersi rivoltato nel sonno addosso al bambino: in tutti gli altri casi, è la stessa balia a subire l’ignomia per la sua negligenza. In questi casi il padre non si appella ad altra giustizia che non sia quella divina, anche quando ha il sospetto che l’incidente avrebbe potuto essere evitato. D’altra parte, si spiegherebbe assai male un soffocamento deliberato da parte di una balia pagata con grande regolarità. È degno di nota che i bambini “affogati” non comincino a comparire esplicitamente nei libri di famiglia che nel XV secolo, e che si vadano moltiplicando all’inizio del XIV. Una certa sensibilizzazione nei confronti di questa causa di mortalità infantile si deve all’intervento della Chiesa, che nomina ufficialmente quell’atto come delittuoso, ed attira prontamente l’attenzione dei genitori e delle balie sulle loro responsabilità. Di pari passo con questa presa di coscienza, si cercano rimedi, perfino del momento in cui dorme al calduccio accanto alla sua balia. Molte delle ricordanze registrano in dettaglio il corredo che accompagna il lattante. La culla nel XVI secolo è spesso accompagnata da un dispositivo (un archetto) che ha la funzione di impedire che le coperte soffochino il bambino, e che quest’ultimo rotoli a terra se viene cullato troppo brutalmente. Comunque sia, l’archetto non evita completamente gli incidenti. In alcuni corredi vediamo poi comparire delle “cassette da mettere nel letto”, nel momento in cui la campagna della Chiesa tocca il suo culmine. Altri sistemi sembrano avere per i genitori un’importanza altrettanto grande. Così, i lattanti lasciano le loro case bardati di numerosi talismani<. Una piccola croce o “Agnus dei”, medagliette devozionali, ma anche il ramo o il mazzetto di corallo, o persino dei “denti di lupo con ghiera d’argento”. Questo arsenale dovrà tenere lontano il malanno, e soprattutto il malocchio al quale le balie imputano tutti i loro dispiaceri. Per i maschi il tasso di mortalità infantile è nettamente più alto che per le femmine. Di che cosa periscono questi bambini a balia, quando se li porta via la “malattia”? le diagnosi del padre sono piuttosto rare, e naturalmente imprecise. Tuttavia, la distribuzione dei decessi nelle diverse stagioni rivela qualche volta dei tratti che permettono di ricostruire la causa della morte. Possiamo constatare che i neonati fiorentini resistono assai meno in primavera e in autunno, stagioni piovose, dei loro fratelli già cresciuti.(LO SVEZZAMETNO) Se riesce a schivare i pericoli, lo svezzamento significa per lui la separazione dalla donna che lo ha nutrito fino a quel momento, e la sua reintegrazione nella propria
famiglia, se è stato allattato altrove. Di questo evento importante non si sapeva granché fino ad oggi. I tre quarti dei redattori di ricordanze presentano se medesimi come i responsabili, o perlomeno i principali partecipanti al momento in cui si tratta di decidere l’inizio dello svezzamento. Né la balia, né tantomeno la madre compaiono mai come esperte in materia. Secondo le informazioni, tre bambini su quattro messi a balia arrivano ad essere restituiti, già svezzati, ai loro genitori. Come ci si può aspettare, l’età dello svezzamento è sensibilmente inferiore a quella del momento in cui viene restituito ai genitori. Talora il bambino rimane presso la balia per un periodo superiore; in questo caso la balia è diventata da custode ad educatrice e per questo lavoro viene pagata a un prezzo almeno due volte inferiore. È degno di nota che questo periodo sia più facilmente ammesso dai Fiorentini quando si tratta dei loro figli maschi, che delle femmine. Complessivamente, il ritorno della bambina è anticipato in rapporto a quello di suo fratello. Gli statuti urbani, comunque, non facevano differenza fra i due sessi. Ancora nel 1415 essi prescrivono come durata legale del contratto di messa a balia una tredicina di mesi, periodo che solo i genitori possono accorciare di loro iniziativa. Cosa che questi non mancano di fare. L’accorciamento dell’affidamento a balia interessa i maschi in maniera più marcata delle femmine. Alcuni statuti toscani della fine del XIII secolo raccomandano una durata di tre anni per l’affidamento a balia, e tali prescrizioni sono ripetute fin in pieno XV secolo, mentre i pedagogisti ed i medici attestano già a partire dal XIV che la durata realmente osservata era più breve. In tutti i casi, nel XV secolo gli svezzamenti più tardivi sono privilegio delle famiglie più ricche. A volte, circostanze imprevedibili intervengono ad affrettare il momento dello svezzamento; in linea generale, tuttavia, è il padre che decide, tenendo conto delle condizioni del bambino e delle proprie finanze. La loro madre, a sua volta, non manca di trarre dei benefici dall’affidamento a balia dei suoi bambini. In una società in cui si maritano le fanciulle prima dei 18 anni, e la fecondità è particolarmente valorizzata, è forse più facile per una donna acconsentire a parti più ravvicinati, che agli obblighi permanenti dell’allattamento. Tra una nascita e l’altra, la Fiorentina di queste classi agiate può dunque sperare in una tregua reale, libera da ogni impegno di allattamento, e lunga da 8 a 12 mesi. Non sembra esserci dubbio sul fatto che le donne di Firenze siano state molto sensibili a questi vantaggi.(IL SANGUE E IL LATTE) Dall’inizio alla fine del contratto, il padre del bambino si pone come il contraente principale. Come abbiamo visto, il motivo addotto dalle balie o dal padre, al momento della risoluzione di un contratto, è molto spesso la gravidanza della balia stessa. Ebbene, quando i Fiorentini si ribellano contro quest’ultima, essi affermano di temere meno l’esaurimento del suo latte che il suo snaturarsi, il suo pervertimento. È possibile che la medicina di derivazione galenica abbia insegnato ai Fiorentini più colti che la gravidanza fa giungere alle mammelle un latte più povero e di qualità scadente. Ma nelle ricordanze, il latte “pregno” è anche chiamato latte “sozzo”, cioè assai grossolano e probabilmente un po’ velenoso. Permettere che sia succhiato significa avvelenare con lenta perfidia il disgraziato bambino. In tutti i casi, l’affidamento a balia è una risposta a una duplice paura, quella di commettere un peccato carnale quella di infrangere le convinzioni o gli interdetti che riguardano l’allattamento. Ma questo compromesso si basa su un’ipocrisia di fondo. I genitori, in verità, preferiscono non darsi pensiero del peccato che rischiano di imporre alla coppia dei balii (continenza oppure metodi contraccettivi incompatibili con la loro salvezza eterna, così come segnalato da Noonan e Flandrin). I balii, comunque, non sembrano condividere i timori dei loro datori di lavoro, per quanto riguarda la qualità del latte di una donna incinta. Solo il timore di andare incontro ad una sanzione, s infrangono la legislazione vigente, deve dunque aver spinto i nostri mezzadri toscani a dichiarare con tanta prontezza le gravidanze e a restituire il bambino. Inoltre viene a galla un’altra contraddizione: i moralisti della famiglia, i medici che essi hanno letto, i predicatori che hanno ascoltato, non si stancano mai di attingere dagli Antichi le loro raccomandazioni contro il principio stesso dell’allattamento da parte di una donna diversa dalla madre. Per essi, la madre nutre col suo sangue il bambino che porta in seno e, dopo la sua nascita, col suo latte, che viene presentato come un diretto derivato del sangue mestruale. Tale idea induce i medici a raccomandare che si scelga come balia, in mancanza della madre, una donna di ripiego, pur sempre preferibile a un latte animale. I portavoce eruditi dei borghesi toscani ripetono queste considerazioni a sazietà. E ne traggono la conseguenza che la scelta della sposa è estremamente difficile e importante, poiché essa nutrirà suo figlio col suo sangue e col suo latte, e gli trasmetterà u insieme di qualità complementari alla parte trasmessa dal padre. Perché nella pratica i nostri Fiorentini eludano così allegramente questi bei precetti, bisogna bene che siano imposti loro valori infinitamente più forti ed efficaci di quanto non fosse il retaggio medico e morale delle persone colte. Questi valori sono quelli del lignaggio: essi fanno sì che si ritenga che i figli nati dalla coppia
appartengano essenzialmente al padre e al duo parentado, minimizzando l’apporto e il ruolo femminile entro il gruppo familiare.9 LE SERVE A FIRENZE NEI SECOLI XIV E XVIl ‘400 è stato una sorta di età d’oro delle donne di servizio; gli uomini del tempo sono impegnati con ostinazione a valorizzare le attività domestiche delle loro mogli e delle loro figlie. Il XV secolo è anche un’epoca nella quale la congiuntura demografica ed economica ha migliorato sensibilmente le condizioni del lavoro salariato. Non è però stata dedicata tutta l’attenzione dovuta al contesto ideologico e culturale della condizione del servizio domestico, in Italia, alla fine del Medioevo. Eppure, la famiglia della quale divengono membri questi servitori e queste serve, rappresenta un universo molto articolato, che un insieme di valori unisce saldamente in modo forse artificiale, ma certo molto efficace. Il lavoro delle donne, alla fine del Medioevo, è molto più difficile da circoscrivere e valutare di quello degli uomini. Anche quando esse lavorano per il maggior profitto di imprese industriali, come nella filatura e tessitura, la loro attività si cela troppo spesso all’ombra di case private, o negli intervalli delle loro mansioni familiari. Nel loro caso ci si deve accontentare di poche notizie frammentarie sui compensi e sui contratti d’assunzione, oppure di brevi allusioni letterarie, quando si indaga il lavoro salariato femminile, e i particolare quello domestico. La prestazione d’opera domestica fa parte di un mercato di lavoro nel quale le donne entrano in concorrenza con gli uomini, ed entro il quale esse sono in grado di occupare impieghi dei quali pochi sono a quel tempo considerati specificamente ed esclusivamente femminili. I salari riservato a questi lavoratori domestici non specializzati sono dunque probabilmente i soli che possano gettare qualche luce sui rapporti tra i sessi che erano prevalenti sul mercato del lavoro (perché degli altri settori abbiamo poche informazioni riguardo le donne). Inoltre, una mansione esclusivamente femminile, l’allattamento dei neonati, ci permette di distinguere una sorta di aristocrazia qualificata. Infine, l’esistenza di una schiavitù domestica, ancora molto presente a quest’epoca, arreca un elemento aggiuntivo di concorrenza sul mercato del lavoro, del quale bisognerà valutare gli effetti. Queste osservazioni permettono di supporre che il chiuso universo della vita domestica sia strutturato da alcune gerarchie interne.(LA “SERVA PADRONA”) Un luogo e un ruolo precisi sono attribuiti alla moglie in modo perentorio. L. B. Alberti riprende queste considerazioni; le pagine che egli dedica alla suddivisione dei ruoli maschile e femminile suonano molto vicine alla realtà. Tre sono essenzialmente i campi che competono alla brava moglie: la gestione dei beni che si tengono all’interno della casa, i buoni costumi e il clima d’intesa quotidiana che deve regolare i rapporti tra tutti i membri di essa, e infine i figli. Il padrone di casa conserva nondimeno il diritto ad una supervisione sull’intera gestione domestica. La donna agisce in ogni modo per delega. Il suo potere domestico non la associa, secondo l’Alberti, alla “maggiore e propria cosa” di suo marito: non deve neppur sapere dove sono rinchiuse le “care scritture”,….. Cionondimeno, le è assegnato un posto di guardia di importanza essenziale. Ma la nostra “padrona-serva” non è stata educata per assolvere a tutte le mansioni domestiche; suo marito le vieta per primo di abbassarsi a farlo. Sua madre le ha insegnato soltanto a filare e cucire. Spetta al marito il compito di insegnarle praticamente tutto. Francesco da Barberino, all’inizio del XIV secolo, modifica il contenuto dell’educazione delle fanciulle secondo una gradualità che tiene conto della loro condizione sociale. La figlia di un cavaliere o di un uomo di legge non sarà tenuta ad imparare a “borse fare o cucir o filare” se non per vincere la noia. Farle insegnare da “donna o altra servigliare ciascuno comune o sottil cucinare” ha come unico fine quello di dotarla di un’arte femminile per eccellenza, che è quella di servire a tavola e di far contenuto “un signore, il quale è ghiotto o conosce i morselli”. Il servizio a tavola, che i Fiorentini mostrano di apprezzare tanto nelle donne che lo hanno imparato, è anch’esso una distinzione di classe: non si tratta certo di darsi da fare tutti i giorni attorno ai fornelli. Dall’altro canto, Francesco da Barberino moltiplica le mansioni casalinghe alle quali devono esser iniziate le figlie di mercanti o di piccoli borghesi. Se è biasimevole che esse apprendano a leggere e a scrivere, devono però saper assolvere a “molte più minute masserizie che domandan le caste”. Nei ceti ancora più bassi, le ragazze del popolo dovranno evidentemente sapere “bene cucire, a filare e a cuocere meglio e masserizia fare, e como ancella sostenere per casa fatica e briga al condor la famiglia”.(LE DONNE A SERVIZIO) Vi è poi la “gente rozza e inetta” che sotto la sorveglianza della padrona di casa assume le funzioni femminili e le mansioni domestiche che il rango vieta a quest’ultima di compiere. Tra il 1300 e il 1530, soltanto il 14% delle donne a servizio domestico sono di origine toscana. Le altre si distribuiscono in proporzione uguale tra donne provenienti dalla campagna e donne cittadine. Dopo il 1450 si nota un aumento molto considerevole delle domestiche che provengono dalla campagna. A queste domestiche vanno poi aggiunti un centinaio di servitori di sesso maschile che sono numerosi soprattutto nei primi due periodi considerati. Ciò di cui i
padroni di casa sgravano sono dunque le mansioni troppo pesanti, troppo vili o troppo costrittive che rientrano nella gestione della “masserizia” attingere l’acqua, alimentare il fuoco, cucinare, fare il bucato, allattare e pulire i bambini,…, sono compiti che ricadono su queste persone. I valletti possono avere anche l’incarico di accompagnare il loro padrone nei suoi spostamenti, o di svolgere per suo conto delle commissioni dentro e fuori Firenze. Quando il padrone assume una serva, precisa talvolta una mansione particolare che sarà tenuta a svolgere, o al contrario, che sarà esentata dal fare. Ora, il fatto che alcune domestiche siano in grado di negoziare l’esonero da compiti troppo duri, lascia credere che esse si trovino in un rapporto di forza che è loro favorevole. Questo rapporto è determinato in primo luogo da una generale scarsità di manodopera. In effetti, è sbagliato affermare che le case medievali rigurgitino di servitù. Anche famiglie piuttosto ricche si accontentano di un numero assai ridotto di servitori e di domestiche. Quattro o cinque tra domestici e sciavi sembrano essere già l’eccezione, mentre la maggior parte delle famiglie della media o della buona borghesia fiorentina non ne possiede che uno o due. L’altro elemento che gioca a favore delle donne di servizio, è il fatto che gli uomini cedono loro progressivamente spazio, nel corso di una buona parte del XV secolo. Il rapporto numerico tra domestiche e servitori maschi si eleva sensibilmente a favore delle prime, dopo il 1400. dopo il 1500, tuttavia, l’assunzione di servitori maschi va aumentando. Nel XV secolo, le donne hanno in mando il mercato dell’impegno domestico, in modo più saldo di quanto lo tenessero nel secolo precedente. Un altro elemento rivelatore delle migliorate condizioni è il carattere piuttosto precario di molte di queste assunzioni. Dagli ultimi anni del XIII secolo e fino al 1450, i salari sono uniformemente annui. Ciò non significa che la domestica sia obbligata a portare a termine un intero anno di servizio per essere pagata, anzi la stragrande maggioranza delle serve lascia il servizio nel corso dell’anno. Può darsi che il preavviso di una quindicina di giorni costituisse l’uso abituale, tanto che non valeva la pena di registrarlo; alcuni datori di lavoro affidano al loro libro di casa il ricordo della sgradita sorpresa fatta loro da una “fante” che aveva lasciato il posto senza alcun accordo preliminare. Resta quindi l’impressione che i più delle volte sia stata la donna a prendere l’iniziativa. È però vero che, se la serva no si rivelava essere una ladra matricolata, il padrone preferiva in genere tenersela stretta più a lungo possibile, per non doversi rimettere in caccia di una sostituta. Questa estrema mobilità delle serve è comunque soprattutto caratteristica del XV secolo. Molte di queste serve dispongono di un’autonomia sufficiente per concludere da se stesse l’accordo col loro futuro padrone. È certamente piuttosto difficile determinare con certezza il loro stato civile. Nel XV secolo, tuttavia, le donne sposate o vedove si sentono generalmente attribuire il titolo di “Monna”. I dati a nostra disposizione rivelano l’importanza, tra le serve salariate, del gruppo delle ragazze celibi nel XIV secolo e alla fine del XV, e inoltre mettono bene in luce la loro diminuzione nei confronti delle donne sposate e delle vedove, nella prima metà del XV secolo. Se il ‘400 è stato un’età d’oro per le domestiche, è soprattutto quest’ultima categoria di donne che ha beneficiato della cosa. I salari corrisposti alle domestiche nella prima metà del XV secolo confermano quanto la congiuntura fosse loro favorevole. Anche se la domestica viene in realtà pagata in piccola moneta d’argento o di più bassa lega, questa stima del suo salario va a suo favore, poiché segue meglio l’inflazione. I salari delle donne di servizio, inoltre, vanno più che raddoppiando, dopo il 1348, e riescono a raggiungere quelli dei servitori maschi. Le paghe delle balie domestiche hanno un’impennata ancor più considerevole dopo la Peste Nera. Dopo il 1470, diviene evidente che questa situazione va lentamente degradandosi. La popolazione, che comincia nuovamente a crescere, getta ben presto sul mercato del lavoro dei giovani che intraprendono la loro carriera al servizio delle famiglie più agiate. La domanda di balie resta forte, ma i salari delle balie domestiche hanno anch’essi un tracollo dopo il 1480. questi ribassi sono evidentemente tanto più sensibili, in quanto i prezzi hanno cominciato a montare, nel corso degli anni 1470. I tre quarti delle paghe continuano a essere calcolati in fiorini; perciò questi ultimi sono assunti come moneta di riferimento valutario. Mentre la moneta d’oro prosegue la sua rapida crescita nei confronti di quella d’argento, il tasso di cambio del fiorini che serva da base al calcolo delle paghe spettanti alle domestiche, viene bloccato una volt per tutte, dopo il 1440, al suo livello di prima del 1430, e cioè a 4 lire al fiorino. È anche vero che le domestiche vivono a spese dei loro padroni e che hanno alloggio assicurato. L’uso del XIV secolo vuole poi che il padrone fornisca ai suoi servitori gli indumenti da lavoro necessari,e tale abitudine sembra continuare anche nel XV, benché numerosi atti di assunzione mostrino che la generosità del padrone può limitarsi al dono di una camicia o di un paio di scarpe all’anno. Così, l’abbigliamento resta in larga misura a carico delle donne di servizio, e molti datori di lavoro devono concedere loro degli anticipi sulla paga, perché possano rinnovare il guardaroba. D’altar parte questo è uno dei mezzi di cui dispongono le domestiche per incassare una parte o la totalità del loro salario,
il cui pagamento viene fatto raramente a date fisse. Il problema dell’abbigliamento è altrettanto importante nell’assunzione di una categoria di domestiche che nell’ultimo terzo del XV secolo è in netta crescita, quella cioè delle ragazzine che vanno a servizio per mettere insieme lo loro dote. I contratti d’impiego di questa manodopera infantile o adolescente prevedono che la giovane domestica abiterà nella casa del suo padrone fino al giorno del suo matrimonio, se vuole incassare ciò che le è dovuto. Stipulato generalmente tra un parente prossimo della ragazza ed il suo futuro padrone, un contratto di questo tipo prevede che dopo un tempo variabile il padrone, le verserà la dote. Lasciato arbitro di decidere a che età sarà conveniente farla maritare, il padrone si presenta come una figura onnipotente alla ragazzina che cresce sotto il suo tetto. Se lo abbandona prima del matrimonio, essa rischia di andarsene coi soli vestiti che ha addosso, o tutt’al più con ciò che il suo padrone avrà piacere di darle. Solo in casi eccezionali è previsto che venga pagata in proporzione agli anni effettivamente passati al suo servizio. Questa manodopera femminile resiste molto raramente a lavorare in simili condizioni, in modo da incassare la dote prevista. Se scendiamo ancora di un gradino nella gerarchia del lavoro domestico, incontriamo la turba delle schiave importate da paesi lontani, profondamente estranee alla cultura toscana e condannate a rimanere emarginate per tutta la vita. P. Guarducci e V. Ottanelli hanno recentemente sottolineato come i datori di lavoro incoraggiassero l’importazione di manodopera schiavile per fare pressione o impressionare la manodopera locale che spingeva troppo lontano le sue rivendicazioni salariali, dopo la grande peste. Certo il numero ridotto degli schiavi domestici non può però essere considerato come una contromisura destinata a competere direttamente contro il rialzo dei salari. Questa misura di dissuasione ha tuttavia consentito una certa tranquillità ai capifamiglia che potevano permettersi di acquistare una schiava. Acquistandole o affittandole, essi erano in grado di far fronte alla penuria di balie che raggiunge il suo culmine nei primi due terzi del XV secolo: una balia su dieci è una schiava. Resta da dire che le schiave non sono numerose in Toscana, e sono rare le case che ne ospitano più di una. È possibile che queste schiave circolassero tra diverse famiglie: potevano essere affittate, rivendute o date in prestito. Inoltre la schiava è costretta a soggiacere alle voglie del suo padrone ed ai desideri dei suoi amici. E come potrebbe opporre loro una qualunque resistenza, dal momento che non gode di alcun diritto. Le case fiorentine ospitavano parecchi figli illegittimi nati da questi amplessi servili. Ma infinitamente più numerosi sono i neonati abbandonati all’ospizio dei trovatelli (es. Ospizio di San Gimignano). Le ricordanze fiorentine ci mostrano anche i bravi padri di famiglia nell’ora dubbiosa della scelta: è più conveniente tenersi il bambino e allevarlo, o è meglio abbandonarlo? Non tutti i figli delle schiave sono dunque sistematicamente respinti, anzi un certo numero di essi ritorna dalla balia alla casa del suo padre naturale o del proprietario di sua madre. Avviene così che la sposa in carica e le nuore che vivono sotto il suo tetto non possono certo rivendicare l’esclusiva delle prestazioni sessuali di loro mariti. Quando giovani spose entrano nella loro nuova casa, anche troppo spesso vi trovano i figlioli che questi hanno avuto da rapporti con schiave.(IL PREZZO DELL’ONORE) La gerarchia dei salari contribuisce certamente anche a stabilire una gerarchia dell’autorità e della considerazione che ciascuno riesce a conquistarsi nel piccolo mondo domestico. Pagata meglio di qualunque servitore di sesso maschile, i prima fila viene la balia. Seguono poi i servitori maschi, spesso dei giovani, i cui salari sono a metà strada tra il suo e quello delle altre serve di casa. Più vicini al padrone, i servitori maschi partecipano in una certa misura della sua autorità e della sua superiorità nei confronti del personale femminile. Tra le domestiche, una prima grande divisone si verifica tra le donne adulte e le ragazze che lavorano per la loro dote, tra le donne che possono negoziare l’ammontare delle loro paghe e, se il caso, andarsene, e le ragazzine costrette a subire il padrone come se fosse un secondo padre. Nel gruppo delle salariate propriamente dette, si indovina che i salari più bassi, inferiori ai salati-tipo previsti dagli statuti cittadini nel 1415, sono quelli che spettano alle donne più anziane o poco valide. Al punto più basso di questa scala di salari stanno naturalmente le ragazzine. Fuori da questa piramide salariale, stanno gli schiavi. Ma il loro gruppo è attraversato a sua volta da un’importante cesura; la schiavitù nell’area mediterranea, conosce una serie di gradazioni (es. Molte donne di Ragusa che vivono a Firenze sono state vendute da un loro parente, o si sono vendute da se stesse come chiave a termine). In tutti i casi, dal carattere ambiguo di questo tipo di contratto risultano confusioni; tutto questo mondo di donne sfruttate doveva veder confondersi le mezze-tinte della schiavitù con quelle del servizio domestico, nel grigiore dei rapporti quotidiani. Verso la fine del XV secolo e all’inizio del XVI ,le serve sostituiscono le schiave, ormai sempre meno numerose, nel rifornire agli gli asili di neonati abbandonati. Né il computo dei salari, né l’accertamento delle condizioni giuridiche rendono conto per intero delle suddivisioni interne che intervengono nel gruppo del personale
domestico. Inoltre, la considerazione che i padroni accordano alla loro serva dipende molto dal rapporto che costei intrattiene nei confronti del matrimonio e di una delle sue condizioni fondamentali, l’onorabilità sessuale. A quanto risulta, la balia è non solo meglio pagata, ma anche coccolata, ben nutrita e protetta dalle attenzioni lubriche del padrone di casa, perché la sopravvivenza del bambino che le è stato affidato dipende dalle sue buone condizioni di salute. La balia che rimane incinta attenta all’onore del padre del lattante affidatole; il ruolo di sostituirla della madre che essa viene a ricoprire nei confronti del piccolo le impone di dar prova delle stesse qualità morali che ci si attende dalla sposa, tanto più che essa le trasmetterà al neonato. È verosimile che un analogo criterio di purezza sessuale impedisce ai padroni di esercitare un’eccessiva rudezza nei confronti delle giovani serve che si costituiscono la dote. A differenza delle domestiche adulte, considerate responsabili delle loro azioni, queste ragazzine sono gelosamente sorvegliate, e vengono cacciate via se non si comportano bene. Nell’altra estremità dei valori sessuali domestici, al contrario, si colloca la schiava. Per la maggior parte “nubili a vita”, le schiave che si sono vendute a termine vengono in genere liberate troppo tardi per avere la possibilità di farsi una famiglia (es. Eccezione Circassa Giuliana). La favorevole congiuntura economica e demografica ha certamente migliorato le condizioni di lavoro delle serve, dopo il 1350. l’aura di sospetto attribuita alla condizione di serva salariata rimanda alle divisioni fondamentali dei ruoli sessuali in vigore nella società fiorentina, il ci principio è che la donna deve custodire nella casa i beni che suo marito vi introduce. Ora, permettere a una donna bisognosa di accumular guadagni compiendo gli stessi lavori della donna di casa, è pur sempre una confusione dei ruoli. Solo la balia sfugge in una certa misura a queste condanne morali.10 LA “MADRE CRUDELE”. MATERNITA’, VEDOVANZA E DOTE NELLA FIRENZE DEI SECOLI XIV E XVA Firenze gli uomini sono e fanno la “casa”. La casa designa allora l’insieme degli antenati defunti e dei membri viventi del lignaggio, di tutti quelli che sono portatori di uno stesso sangue e di uno stesso nome, che rivendicano un antenato comune, un eroe eponimo dal quale il gruppo ha ereditato la sua identità. Allo stesso modo, anche i beni passano da una generazione all’altra per linea maschile. Nel novero di questi beni figura l’abitazione materiale. Le donne non sono che ospiti passeggere di queste case. Agli occhi dei contemporanei, i loro movimenti in rapporto alle case determinano la loro personalità sociale. È precisamente attraverso le loro “entrate” e le loro “uscite” fisiche dalla casa che le loro famiglie originarie o acquisite tengono conto del contributo femminile alla sua grandezza. Il matrimonio, la vedovanza, questi continui va e vieni delle mogli tra le diverse case finiscono per introdurre una vera e propria indeterminatezza nel modo stesso di designarle: è necessaria sempre una referenza maschile, quindi sarà sempre in rapporto con suo padre o suo marito, anche se morti, che si farà menzione di una donna. Le donne non sono dunque elementi permanenti del lignaggio, e di esse si mantiene un breve ricordo. Una donna importante sarò eventualmente dotata di caratteri positivi e segnalata all’altrui attenzione, ma l’autore di cronache familiari, come il genealogista si sentiranno in obbligo di fornire delle spiegazioni, tanto una simile procedura elogiativa corrisponde male all’idea che ci si fa normalmente delle parenti. Ugualmente degne di una “ispeziale memoria”, ma questa volta segnate dal marchio della riprovazione familiare, sono le donne che stornano le eredità. La determinazione dell’identità femminile dipende dunque dai suoi movimenti in rapporto alle ”case” degli uomini. Il corollario che ne discende è che la buona società fiorentina tollera altrettanto male sia lì immobilità che la solitudine delle donne. Se resta zitella, l’unica via è allora il convento. E non meno sospetta è anche la solitudine connessa alla vedovanza. Benché la Chiesa consigli alla vedova portata alla castità di non rimaritarsi, i laici hanno la più scarsa fiducia nelle attitudini di una vedova a rimanere casta. Diventa allora cruciale il problema della residenza di una vedova, poiché essa minaccia l’onore non di una sola, ma di due famiglie in una volta.(SULLA RESIDENZA E SULLA VIRTU’ DELLE VEDOVE CON DOTE) In teoria, la vedova sembra disporre di una certa possibilità di scelta. Può rimanere nella famiglia del marito, presso i figli; può vivere indipendentemente senza risposarsi; può rimaritarsi, e lasciare la famiglia che l’aveva accolta per la prima volta. Ma nella pratica, la vedova si vede proibire la seconda di queste soluzioni, e si trova ad essere oggetto di pressioni contraddittorie che le impediscono di fare serenamente una scelta tra le altre due. I dati mostrano che le vedove sono assai più numerose dei vedovi. La vedovanza maschile riguarda soprattutto persone molto anziane, poiché i vedovi tendono a risposarsi prontamente fino a tarda età. La vedovanza definitiva per le donne è invece molto più precoce, dopo la quarantina. L’appartenenza a diversi ceti sociali aggiunge ulteriori costrizioni a questa realtà. Tra i Fiorentini più ricchi, la probabilità che una vedova viva sola precipita. Come è evidente, la dote è strettamente legata al destino di una donna. In linea di
principio, i beni dotali che la sposa porta a suo marito le rimarranno attaccati per tutta la vita: essi hanno la duplice funzione di sopperire alle spese della vita familiare e al mantenimento della sopravvissuta, in caso di morte del marito. Purtroppo però questo schema è sovente negato dalla realtà dei fatti. Ogni vedovanza rimette in questione l’equilibrio economico al quale il gruppo familiare è pervenuto quando il padre era in vita. Se la vedova ha superato la quarantina, la difficoltà di trovare un nuovo marito non induce in genere i parenti di lei ad intervenire. Spetta agli eredi del marito di convincerla a rimanere presso di loro e a non “andarsene con la sua dote” per vivere in modo indipendente. Sul letto di morte, suo marito si sforza del resto in tutti i modi di convincerla a rinunciare a simile pretesa. Se tuttavia la vedova non va d’accordo con gli eredi di suo marito, e preferisce scegliere la sua libertà, non potrà pretendere altro che la sua dote. Un ultimo caso è possibile: se gli eredi non se la vogliono tenere in casa e rifiutano di restituirle la dote, la vedova fiorentina conserva ancora la “tornata”, un diritto di rifugio nella sua famiglia di nascita. Accoglierla, garantirle i mezzi per vivere e un tetto resta un obbligo per i suoi parenti più prossimi o per i loro eredi. Nel XV secolo, alcuni testatori fiorentini, riservano una delle loro case ad “accogliere per il futuro tutte le donne uscite dalla casa e rimaste vedove e di assicurar loro la tornata”; veri e propri asili di famiglia. Disposizioni di questo genere testimoniano dell’ansietà che comporta, per gli uomini molto sensibili all’onore della propria casa, l’idea che delle donne della loro famiglia non siano in qualche modo inserite in un gruppo di parentela. Anche se ormai avanti con gli anni, la vedova costituisce una minaccia per la reputazione delle famiglie dabbene. Visto che ha già goduto dei piaceri della carne, essa è naturalmente incline a cadere in una vita dissoluta di peccato e di lussuria. Ma la posta che è i gioco, e che fa perso sulla donna sposata, non appare in piena luce che nel caso in cui la vedova è giovane. E ciò perché in tal caso la vedovanza riaccende le pretese della famiglia nella quale è nata, nei confronti dei beni che si è portata in dote. Facendola risposare essi possono entrare in un nuovo giro di alleanze. Il matrimonio non basta a cancellare la parentela di sangue. Esso non significa quindi una rottura definitiva tra la sposa e la sua famiglia d’origine. Dal momento in cui il primo marito è stato sotterrato, non appena conclusa la cerimonia funebre, i parenti della moglie vengono a riprendersela senza indugio, se è una donna giovane, e se la riportano a casa. Il diritto delle famiglie di nascita di riprendersi queste vedove si rivela più forte delle stesse volontà testamentarie del defunto. Una defezione di tale tipo rappresenta una duplice minaccia, sia per i figli della coppia che la morte del padre ha distrutto, che per i figli di un eventuale primo letto. Se infatti la loro madre o la loro matrigna li abbandona improvvisamente per convogliare a nozze una seconda volta, la loro situazione economica subisce di solito un colpo ancora più grave di quando una vedova matura richiede la sua dote per ritirarsi dove più le conviene. Così i mariti che hanno fatto testamento, e lasciano dei figli in età minorile e una vedova troppo giovane, si sforzano con accanimento di allontanare il pericolo, moltiplicando i dispositivi di dissuasione. Da qui derivano anche le raccomandazioni perché le doti richieste siano mantenute entro limiti ragionevoli. Altrimenti, la loro restituzione rischierebbe di compromettere definitivamente l’avvenire dei figli. Il atto poi che una vedova passi a nuove nozze, fa sì che si profili in effetti una seconda minaccia: l’abbandono dei figli. Essi appartengono al lignaggio del padre. Di conseguenza risiedono generalmente presso i loro parenti in linea paterna. Eccezionale è il caso di figli che seguano la loro madre dopo che si è risposata. La nostra documentazione ci è testimone del carattere di solito provvisorio delle disposizioni che concedono ad una vedova di installare i suoi figli di promo letto nella casa di un secondo marito. Quando una vedova lascia la casa per convolare a nuove nozze, se ne va dunque con la sua dote, ma senza i suoi figli. Giuridicamente inermi, rese docili dalla loro educazione, le vedove possono solo in casi eccezionali evitare le nuove nozze, se così i loro parenti hanno deciso(“BUONE MADRI” E “MADRI CRUDELI”) La “madre crudele” è si la donna che lascia i suoi giovani figli, ma è soprattutto la madre che è “partita con la sua dote” (es. Giovanni Morelli la cui madre si risposò quando egli aveva solo tre anni). Invero, non c’è “buona madre” che non sia “al tempo stesso padre e madre”. Infatti colei che, per quanto ancora giovane, rifiuta di risposarsi per non abbandonare i suoi figli, è contemporaneamente un padre e una madre per i suoi figli. La vedova che viene considerata una “buona madre” p anche quella che si dedica all’educazione dei figli con fermezza e disciplina. È ben vero però che la sua inesperienza della vita pubblica e politica costituisce per lei una limitazione molto grave, per di più le sua cultura è sovente limitata; e ciò che è peggio ancora, essa non è in grado di trasmettere ai suoi figli l’eredità spirituale del lignaggio. È chiaro che un’educazione esclusivamente materna si rivela per forza in qualche modo lacunosa e parziale. Nondimeno, se esercitata con vigore e costanza, la si può paragonare a quella del padre. Al contrario, la “cattiva madre”contravviene ai valori del lignaggio dei suoi figli per essersi mostrata troppo docile nei confronti della sua famiglia di
nascita. In questo, essa non fa che manifestare i difetti che sono tipici delle donne. “Incostante, leggera e frivola”, essa oscilla tra una famiglia e l’altra, “dimentica” i suoi figli e suo marito appena sepolto, per inseguire il piacere dei sensi nel letto di un secondo consorte. Nessuna donna è perfetta; soltanto il sesso maschile può farsi forte di una perfezione che è fatta in primo luogo di fissità o di permanenza.11 LE SANTE BAMBOLE. GIOCO E DEVOZIONE NELLA FIRENZE DEL ‘400La linea che separa le pratiche di devozione dai comportamenti lucidi è fragile e sottile. Alcuni storici hanno messo in evidenza la somiglianza tra le bambole medievali e le figure di devozione dell’epoca. Alcune di queste sono servite da supporto a pratiche che avevano l’intento di stimolare l’immaginazione e la facoltà di identificazione propria delle donne e dei bambini, aprendo così davanti a loro la via del divino. Il gioco, il sogno, il rito: tre facce del dramma che si svolge tra il credente e il suo dio. I libri domestici fiorentini registrano tra il 1450 e il 1520, bambole di questo genere, regalate dai genitori alle giovani spose, e persino a ragazze che entrano in convento. Per la maggior parte, questi “bambini” sono immagini infantili, fantolini di sesso maschile riccamente vestiti. Alcuni di questi bambolotti sembrano privi di qualunque elemento che ne connoti la qualità religiosa, il più delle volte, tuttavia, le bambole dei nostri Fiorentini hanno una personalità cristiana più evidente. A fianco del Bambino Gesù ornato, compaiono anche delle celebri sante del Pantheon cristiano (es. Margherita, Maddalena,…). Quando la qualità di queste “bambole” non è specificata, si può tuttavia inferire, dagli esempi che precedono e dalla natura degli oggetti che li accompagnano, che questi “bambini” hanno una funzione religiosa. A dire il vero, l’esistenza di queste effigi del Bambino Gesù ci sorprende meno che la loro presenza in corredi femminili del XV secolo. Gli storici dell’arte o della religione hanno in effetti trovato numerose testimonianze plastiche della devozione verso il Bambino divino prima del XVII secolo, epoca in cui il suo culto si generalizzava con l’apparire dei presepi. L’Italia annovera pochi esempi di Bambino Gesù che siano stati collegati ad un presepio con molti personaggi attorno, prima del XVII secolo. L’arte toscana sembra privilegiare piuttosto, nei secoli XIV e XV, un’immagine del Cristo infante trionfalmente eretto, immagine che si suole collocare sull’altare in occasione delle maggiori festività, e in particolare nel Natale. O Kurz ha studiato le varianti figurative di questo bambino, glorioso portatore dei simboli della passione, in atto di uscire da un calice, ed ha cercato di chiarirne il significato in rapporto ai problemi tecnici ed iconografici che la liturgia dell’Eucarestia pone agli artisti del XV secolo. Essi sono a quel tempo sollecitati a escogitare ricettacoli che siano degni dell’Ostia, ed a integrarli nella struttura nel grande altare. I loro tentativi sfociano dopo il 1450 nelle soluzioni inventate da Deisderio da Settignano, il tabernacolo murale (che riprende ed esalta l’antico motivo del Bambino Gesù che esce da un calice, prefigurazione miracolosa della Passione) e il “Tempietto”. Il successo immediato che ebbe il “bambino” di Desiderio è attestato dalle numerosissime copie che se ne trovano nei musei fiorentini, italiani e stranieri. L’uso di erigere una figura del Bambino Gesù sull’altare, a Natale, sembra diffondersi alquanto alla fine del XV secolo. E poiché i Fiorentini non dispongono di reliquie tanto preziose, il rapimento del prezioso bambino di marmo di Desiderio e le innumerevoli copie che se ne fecero, corrispondevano evidentemente alle attese dei devoti dell’infanzia divina. L’importanza dei “bambini” che entrano nei corredi fiorentini deriva dal fatto che essi allargano il campo di questa devozione, per includervi le dimore private della borghesia. Stando poi ai nostri testi i proprietari di queste “bambole” sono delle donne; queste statuette passano da una donna all’altra. La madre tramanda il suo “bambino” a sua figlia, sia che questa entri in convento, sia che passi sotto l’autorità di un marito. Pezzi di notevole importanza nel corredo di una fanciulla, queste bambole figurano tra gli oggetti sottoposti a stima da parte di un professionista. Essi sono consegnati non a delle ragazzine, ma a delle giovani donne, nel momento stesso in cui si determina il loro destino matrimoniale. È necessario dunque che siano state celebrate le loro nozze perché esse possano ricevere il loro “bambino” fatto di legno e di broccato. G. Marcotti, nel 1881, avanzò un’ipotesi: l’uso di donare alle spose un bel bimbo avrebbe avuto la credenza che la donna avrebbe dovuto partorire un figlio simile all’immagine che tiene sotto gli occhi durante la gravidanza. Queste pratiche le farebbero rientrare nel novero degli agenti magici che intervengono nei riti di fecondità associati alla celebrazione delle nozze. L’ipotesi non è del tutto inverosimile. La comparsa di bambino in un rituale fiorentino del XIV secolo è sicuramente ben attestata. Alcuni statuti suntuari che nel 1388 regolano lo svolgimento delle cerimonie nuziali vietano al servitore che reca il cofanetto con i doni del novello sposo a sua moglie, di farsi accompagnare da un “fanciullo o fanciulla di qualunque età si sia”, pena una multa di dieci fiorini. Dell’ipotesi di Marcotti si potrà tener ferma l’idea del trasferimento magico delle virtù e dei poteri dell’effige a colui che ne fa uso. Ritti sugli altari, i “bambini” sono destinati ad abbellire un oratorio
famigliare nella camera del capofamiglia. È in questo punto della casa che si concentra la devozione dei suoi abitanti, ed è lì che l’immagine della pietà può permettere di entrare i contatto con il sacro. Questi contatti si fondano su una delle qualità che la Chiesa riconosce tradizionalmente all’immagine: “eccitare il sentimento di devozione, che le immagini eccitano meglio dei suoni”. La percezione del sacro attraverso l’immagine viene insegnata ai bambini fin dalla più tenera infanzia dagli atteggiamenti spontanei degli adulti, ed anche dai loro sforzi intenzionali e coscienti. Attraverso queste rappresentazioni (come la Strage degli Innocenti) si intende indurre i bambini, fin dalla più tenera età, a identificarsi con i personaggi delle immagini. Questo coinvolgimento passivo del bambino e delle donna mediante la vista viene tuttavia integrato e completato da procedure educative nelle quali essi sono più attivi. Gli altari privati rappresentano talvolta gli strumenti di un vero e proprio apprendistato della devozione attraverso il gioco. L’identificazione e la partecipazione costituiscono il movente principale delle pratiche di devozione che vengono proposte ai Fiorentini fin dalla loro più tenera età. Bambino Gesù, Nostra Signora o Crocifisso diventano così immagini efficaci, capaci di trasferire una parte dei loro poteri ai loro devoti, nel momento in cui l’emozione di questi ha raggiunto un punto tale che esse devono cedere. L’autore francescano delle “meditazioni della vita di Cristo”, ed i suoi imitatori del XIV secolo, spalancano davanti alle anime devote ed agli artisti un repertorio immenso di atteggiamenti e di sentimenti che fanno dell’immagine il primo e il più immediato interlocutore del buon cristiano. La rappresentazione mentale sfocia qui in una manipolazione immaginaria del personaggio sacro. Che queste condotte spirituali siano state messe in scena e simulate è un fatto bene attestato a partire dal XV secolo. La pratica rituale più corrente è l’esposizione del Bambino Gesù non solo sull’altare, in posizione trionfante, ma anche coricato in una culla o in una mangiatoia, a Natale; i fedeli vengono ad adorarlo e a toccargli e baciargli i piedi. Quest’usanza si ritrova talvolta amplificata in una vera e propria messa in scena teatrale, che consente a un’itera comunità di rivivere le scene del Vangelo (es. Sotto Savonarola veniva rappresentato l’Epifania). Il rito e la sacra rappresentazione non sono i soli luoghi nei quali il Bambino Gesù attraversa il muro dell’arte. Anche i mistici sono così profondamente compenetrati delle esortazioni dei loro confessori e delle immagini ad esse ispirate, da arrivare a realizzarle, amplificate, nelle loro visioni. Ciò in particolare avviene per le suore, giovani donne chiuse sin dall’infanzia in convento, oppure sottomesse a un marito distante e separate dei loro bambini fin dal giorno della loro nascita. Immaginandosi nei loro sogni come serve e balie del bambino, le “spose di Cristo” si sforzano di vedere e di sentire fisicamente il loro sposo spirituale, di portarlo su di sé, di farlo succhiare al seno, di toccarlo e di “abbracciarlo”, di “godere dei suoi amplessi”. Un simile linguaggio rivela ed esprime un profondo turbamento dei sensi. E quando i chierici chiamano la Vergine “la loro mamma” , non fanno altro che ripetere, in senso inverso, i rapporti madre-figlio che l monachelle coltivano dal canto loro nei confronti del loro “bambino”. I fiorentini avrebbero cominciato allora a guardare più da vicino i loro pargoli in carne ed ossa, perché la loro pratica del sacro li aveva condotti a coccolare dei Gesù fatti di stucco e di cartapesta.