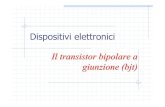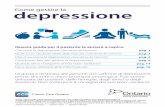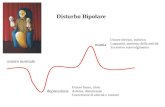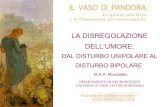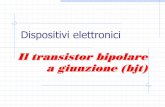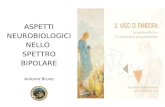Disturbo bipolare e cefalea a grappolo: identificazione di ...
La Depressione Bipolare
-
Upload
depressione-bipolare -
Category
Documents
-
view
217 -
download
2
description
Transcript of La Depressione Bipolare

La depressione bipolare: linee guida per la diagnosi e la valutazione
di Giada Fiume
Giada Fiume, psicologo, psicoterapeuta, Presidente e Socio Fondatore del Centro di Psicologia Integrata per il Benessere. Email: [email protected]
Abstract: il presente lavoro approfondisce il costrutto di depressione bipolare e delinea gli aspetti principali degli stati misti, disturbo dell’umore nel quale sono presenti contemporaneamente manifestazioni psicopatologiche depressive e maniacali per periodi di tempo prolungati . Vengono proposte informazioni diagnostiche e discusse le principali scale di valutazione utilizzate in campo internazionale.
Key Words: depressione bipolare, stati misti, psicopatologia
La unicità e specificità della Psicopatologia è di essere una scienza in continuo equilibrio tra due poli epistemologicamente (e ideologicamente) separati: le scienze della natura (Naturwissenschaften) e le scienze dello spirito (Geisteswissenschaf-ten), tra lo spiegare (Erklären) ed il comprendere (Verstehen), tra gli ordini causale e motivazionale. Questa specificità è al contempo la sua ricchezza e il suo limite; e, tra i limiti, quello più evidente è che, proprio per la sua doppia “anima”, in Psicopatologia anche i concetti definiti con maggior precisione si riferiscono comunque a fenomeni che non sono esattamente e completamente definibili e quantificabili, così come ci si aspetta sia possibile per i fenomeni puramente “naturali”. Nella valutazione della presenza/assenza della depressione bipolare si pone il problema che il criterio di inclusione determini anche l’estensione dello spettro e quindi il numero delle entità cliniche da includere. In questo caso, ci si basa sulle somiglianze fenomeniche da un lato (ma molti disturbi con le stesse caratteristiche non vengono inclusi) e sulla presenza di una base caratteriale dall’altro.
Negli ultimi trenta anni del secolo scorso la distinzione unipolare-bipolare all’interno della malattia maniaco-depressivo, originariamente concettualizzata da Edda Neele (1949) e Leonhard K. (1957) e successivamente sviluppata da Winokur et al. (1972) ha dimostrato un grande valore euristico per la ricerca clinica e terapeutica; questo approccio dicotomico, tuttavia, lascia indefinite molte

condizioni affettive che si trovano all’interfaccia tra disturbo unipolare e bipolare. Originariamente, Dunner et al. (1976) e Dunner e Fieve (1979) identificarono i pazienti bipolari II sulla base della presenza di gravi episodi depressivi maggiori alternati a periodi ipomaniacali che non richiedevano ospedalizzazione. Per quanto l’ospedalizzazione possa essere considerata un criterio artificiale nella definizione della soglia diagnostica per la mania, questa concettualizzazione ha rappresentato tuttavia un progresso importante verso il riconoscimento di un insieme vasto di pazienti bipolari i cui periodi di eccitamento rimanevano a livello ipomaniacale. Klerman (Horwath E, Johnson J, Klerman GL, Weissman MM.. 1992) ha esteso questa concezione ed ha incluso tra le forme bipolari attenuate quelle proprie di soggetti che presentano episodi maniacali e ipomaniacali in seguito al trattamento farmacologico, specialmente con antidepressivi (Disturbo Bipolare tipo III). Più recentemente Akiskal H.S. (1983) ha proposto una concettualizzazione più estesa di spettro bipolare attenuato, includendo in esso le depressioni con episodi ipomaniacali (sia di breve che di lunga durata), i tratti temperamentali d’ipertimia e ciclotimia così come i soggetti con familiarità positiva per Disturbo Bipolare. Di grande interesse clinico e diagnostico è la rielaborazione schematica delle varie forme dello spettro bipolare proposta da Akiskal e Pinto (1999) che hanno rilevato almeno sette differenti sottotipi clinici (Tabella 1)
Tab. 1 CLASSIFICAZIONE DELLE PRESENTAZIONI DI SPETTRO BP. 7
Configurazioni categoriali in base alle caratteristiche di decorso ( Akiskal e Pinto, 1999)
Bipolare I Depressione e mania
Bipolare I e 1⁄2 Depressione e ipomania protratta
Bipolare II Depressione e ipomania
Bipolare II e 1⁄2 Depressione e ciclotimia
Bipolare III Depressione e ipomania farmacologica
Bipolare III 1⁄2 Bipolarità associata all’uso di stimolanti
Bipolare IV Depressione e temperamento ipertimico

Nello spettro bipolare vengono riuniti diverse forme di depressione ricorrente, includendo i bipolari tipo I, i bipolari “atipici”, i ciclotimici, i distimici ed altri tipi con quadri fenomenici intermedi. In questo tipo di spettro, quadri clinici parzialmente eterogenei (tanto da ricevere denominazioni diverse nelle classificazioni diagnostiche) ma con una sintomatologia e un decorso in parte sovrapposti, vengono riuniti tra loro, in quanto si suppone siano solo variabili fenomeniche di un’unica patologia di base: il disturbo bipolare. Il concetto di spettro bipolare così delineato è in accordo con le descrizioni classiche della malattia maniaco-depressiva proposte da Kraepelin (1905) e Kretschmer (1921) i quali hanno considerato gli stati affettivi lungo un continuum che varia dalle forme gravi a quelle attenuate spaziando, senza una netta linea di demarcazione, dalle forme psicotiche alle disposizioni temperamentali.
Tra Depressione e mania: lo stato misto
Il termine “stato misto” (SM) designa un disturbo dell’umore nel quale sono presenti contemporaneamente manifestazioni psicopatologiche depressive e maniacali per periodi di tempo prolungati. La commistione di sintomi di opposta polarità si esprime nella tinta del tono affettivo, nel corso e nel contenuto del pensiero, nell’attivazione o nel rallentamento motorio. Aspetti caratteristici quali perplessità, labilità emotiva, eccitabilità, tensione, ansia ed agitazione, irritabilità, disforia, ostilità possono associarsi di volta in volta a manifesta- zioni meno costanti quali confusione, impulsività e sintomi psicotici, con contenuti ideativi e percettivi di opposta coloritura affettiva. In questo modo viene a prodursi una grande varietà di quadri clinici che possono assumere forme più disparate, peraltro assai mutevoli. Tranne poche eccezioni, gli stati misti sono stati relativamente trascurati negli anni passati e solo nell’ultima decade si è rinnovato l’interesse per queste condizioni psicopatologiche. Ciò ha portato allo sviluppo di interessanti linee di ricerca sulla loro natura biologica, sulle caratteristiche nosografiche e cliniche e sulla risposta ai trattamenti. Nonostante siano stati pro- posti modelli innovativi di classificazione, le caratteristiche cliniche ed i confini degli stati misti rimangono mal delineati. Nei principali sistemi diagnostici internazionali (DSM, ICD), mentre l’episodio maniacale e quello depressivo sono definiti mediante una serie di criteri operativi, lo SM viene caratterizzato genericamente dalla simultanea presenza di aspetti sin- dromici depressivi e maniacali. La mancanza di criteri diagnostici validi e specifici per lo SM ha reso più difficile lo studio dei rapporti fra queste condizioni e le altre polarità degli episodi affettivi, soprattutto quando la mania si presenta con umore disforico o la depressione si caratterizza per l’agitazione psicomotoria. Poco chiara è pure la relazione con alcuni aspetti

evolutivi dei disturbi dell’umore, quali la cronicità e la rapida ciclicità. Inoltre, la frequente contaminazione psicotica della condizione mista, già sottolineata dagli autori classici, pone problemi di diagnosi differenziale dalle manifestazioni psicotiche proprie di altri ambiti nosografici, come la schizofrenia ed i disturbi schizoaffettivi. L’autonomia delle for- me miste è stata criticata da molti, sulla base dell’osservazione comune che quadri espansivi, maniacali o ipomaniacali, sono spesso contaminati da elementi depressivi e, pertanto, non sarebbe necessario ricorrere ad una categoria diagnostica diversa per lo SM. Tuttavia, riprendendo le descrizioni classiche di Kraepelin (1905), alcuni autori (Himmelhoch e Garfinkel, 1986; Campbell, 1953; Himmelhoch, Mulla, Neil, Detre, Kupfer, 1976) hanno, riproposto una concezione dello SM come disturbo dell’umore separato sia dalla mania che dalla de- pressione, sottolineando l’importanza teorica e pratica di questa distinzione. La discussione sull’autonomia dello SM come terza polarità dei disturbi dell’umore riveste implicazioni importanti sul piano terapeutico. Questi quadri psicopatologici possono non rispondere bene ai trattamenti convenzionali per la mania; inoltre, la contemporanea presenza di sintomi depressivi e maniacali sembra costituire un terreno predisponente per la comparsa di manifestazioni etero e autoaggressive. Allo stesso tempo, anche il trattamento psicoterapico impone al clinico una maggiore attenzione alle fluttuazioni del tono dell’umore, talvolta sostenendo e talvolta contenendo il proprio paziente, lavorando direttamente sulla strutturazione di strategie comportamentali da attuare all’insorgere della sintomatologia specifica.
Inquadramento nosografico
La prima classificazione organica degli SM si deve a Kraepelin (1905), il quale ha di- stinto schematicamente alcuni sottotipi a seconda del diverso combinarsi delle alterazioni dell’umore, del pensiero, della psicomotilità:
1) depressione agitata: caratterizzata da umore depresso e da agitazione psicomotoria; 2) stupor maniacale: nel quale l’euforia ed i sentimenti di aumentata capacità e potenza si presentano unitamente ad inibizione sul piano motorio, verbale ed ideativo, talvolta fino a giungere ad un vero e proprio quadro di arresto; 3) depressione con fuga delle idee: l’umore è depresso, la motilità e l’eloquio sono rallentati; in contrasto i pazienti riferiscono affollamento di pensieri che talora viene manifestato con ipergrafismo;
4) mania improduttiva: con umore euforico ed aumento dell’attività motoria che si esprime con un affaccendamento del tutto inconcludente. L’eloquio è rallentato ed

i contenuti del pensiero sono scarsi;
5) mania depressiva: l’umore è orientato in senso depressivo, ma in primo piano è l’irritabilità, con estrema intolleranza e reattività alle minime stimolazioni dell’ambiente;
6) mania acinetica: con elevazione dell’umore, distraibilità, fuga delle idee associata ad inibizione motoria.
Questa classificazione è stata criticata da molti come eccessivamente schematica e non pienamente rispondente alla realtà clinica; tuttavia, da allora, lo SM è stato presente in tutti i sistemi nosografici, senza che ne venissero ulteriormente precisati i limiti e le caratteristiche distintive dalla mania e dalla depressione. Negli anni più recenti, la definizione di criteri operativi per la diagnosi ha portato ad una riconsiderazione di queste condizioni psicopatologi- che. L’RDC (Spitzer, Endicott, Robbins, 1981) riconosce due tipi di SM: nel primo i sintomi depressivi e maniacali concomitano nello stesso episodio, nel secondo gli episodi maniacali e depressivi si susseguono senza soluzione di continuità. Sia il DSM-III-R (A.A.V.V., 1987) che l’ICD-10 forniscono criteri operativi per la diagnosi di SM non esenti da ambiguità (tabella I). Secondo il DSM-III-R devono essere soddisfatti contemporaneamente i criteri per la mania e per la depressione maggiore o, in alternativa, i due episodi devono succedersi rapidamente entro pochi giorni.
Così operando non viene evidenziato il caratteristico polimorfismo sintomatologico e non si distinguono gli stati misti dalla rapida ciclicità. Inoltre, il manuale non considera quei casi che, pur presentando elementi sia della sfera espansiva che di quella depressi- va, non soddisfano pienamente tutti i criteri di entrambi i tipi di episodio. Il DSM-IV, pur separando la forma a rapidi cicli, prevede sempre la contemporanea presenza della piena sindrome maniacale e depressiva. Inoltre indica come criterio di esclusione che la sintomatologia mista «non deve essere determinata dall’effetto diretto di sostanze o di una condizione medica generale». La valutazione di quanto un effetto sia diretto o meno appare alquanto problematica, anche in considerazione del fatto che tra i fattori più frequentemente associati all’insorgenza di SM sono stati considerati l’azione di tossici o sostanze e la presenza di danni del SNC. L’ICD-10 fornisce una definizione lievemente più ampia pur non formulando dei criteri specifici per lo SM. Inoltre, in questo sistema, per la diagnosi è necessaria la presenza nella storia del paziente di un altro episodio affettivo. Sono pertanto esclusi gli SM che, come

spesso accade nella realtà clinica, si presentano come primo episodio. Dei criteri operativi per la diagnosi di SM sono stati formulati dalla scuola di Vienna e sono imperniati sul concetto di instabilità del “dinamico”, proposto inizialmente da Berner, Gabriel, Katschnig (1983). In questa concettualizzazione viene dato risalto all’instabilità della condizione mista, caratteristica condivisa con la rapida-ciclicità; l’umore non assume un orientamento definito ma rimane persistentemente fluttuante, generando una condizione di perplessità o di rapidi mutamenti emotivi. Il gruppo di lavoro ha sviluppato questa concezione proponendo una serie di criteri che si fondano su di una descrizione particolareggiata del quadro psicopatologico; tuttavia, non prendono in considerazione la possibile presenza di una fenomenica psicotica e non mantengono distinte le forme a cicli rapidi, ritenendole condizioni con eziopatogenesi comune a quella degli SM. Una parte della letteratura nord americana degli ultimi anni, nell’affrontare lo studio degli SM, fa riferimento principalmente alle for- me maniacali contaminate da elementi depressivi. A questo proposito, si è parlato di mania disforica, considerandola di volta in volta come una varietà di mania (Janzarik, 1959), come una forma espansiva di particolare gravità, o come uno stato di transizione tra mania e de- pressione. Recentemente, il gruppo di Cincinnati costituito da Bunney W.E., Murphy D.L., Goodwin F.K., Borge G.F., ha proposto una definizione di “mania mista” conforme al con- cetto di mania disforica, che prevede la presenza, in aggiunta alla piena sindrome maniacale, di solamente 3 dei 5 criteri previsti per la diagnosi di episodio depressivo maggiore (Bunney W.E., Murphy D.L., Goodwin F.K., Borge G.F.,1972).
Utilizzando questa definizione allargata di “mania mista”, McElroy S.L., Strakowski S.M., Keck P.E., Tugrul K.L., West S.A., Lonczak H.S. (1995) hanno evidenziato alcune caratteristiche distintive di queste forme rispetto a quelle maniacali pure: una maggiore frequenza nel sesso femminile, un maggior numero di episodi misti precedenti, una maggiore probabilità di presentare episodi misti all’esordio ed una comorbilità più elevata con disturbi d’ansia, in particolare con il disturbo ossessivo-compulsivo. Meno considerate nella letteratura recente sono le forme depressive agitate degli stati misti, originariamente delineate da Kraepelin, e caratterizzate dalla aggiunta ai sintomi depressivi di elementi di eccitazione quali agitazione psicomotoria, ipersessualità ed accelerazione del pensiero. Recentemente, Koukopulos et al. (1992) hanno fornito una attenta descrizione delle caratteristiche cliniche di queste forme morbose, sottolineando l’importanza di un loro corretto inquadramento dia- gnostico.

SCALE DI VALUTAZIONE PER LA DEPRESSIONE E LA MANIA
Esistono ampie evidenze di come la depressione bipolare, ancora oggi, spesso non venga diagnosticata e trattata correttamente. Diversi fattori contribuiscono al mancato inquadra- mento diagnostico della depressione bipolare:
m la mancanza di accordo sulla definizione di spettro bipolare; mla difficoltà nel misurare e quantizzare sintomi che vanno a caratterizzare lo stato misto; m l’alternanza di sintomi che si collocano sulle estremità opposte del continuum dello spettro dell’umore ; m la presenza di strumenti di rilevazione che rilevano separatamente i sintomi depressivi e quelli maniacali. Attualmente la diagnosi viene effettuata facendo riferimento a strumenti di rilevazione che separatamente rilevano sintomi depressivi e sintomi relativi alla mania.
A tal proposito allo scopo di fornire una visione d’insieme vengono qui di seguito presentati alcuni strumenti di rilevazione maggiormente utilizzati ai fini di ricerca e nella pratica clinica, sottolineando che
alla depressione e alla mania, per quanto facce del medesimo disturbo, la valutazione standardizzata ha riservato un trattamento molto diverso. Per la depressione, infatti, sono stati messi a punto numerosi strumenti di valutazione e si sono registrati, probabilmente, i maggiori progressi, mentre nel campo della mania, gli strumenti disponibili sono in nume- ro molto limitato (Conti, 1999). Successivamente verranno presentate sistematicamente le interviste per la rilevazione del fenomeno depressivo, le scale di etero valutazione, le scale di valutazione della mania e due strumenti specifici per la rilevazione della depressione bipolare.
a. Interviste per la rilevazione del fenomeno depressivo
Le interviste strutturate maggiormente utilizzate nella ricerca e nella pratica clinica con un buon livello di affidabilità sono di seguito descritte:
m Schedule for Affective Disorder and Schzofrenia (SADS) (Endicott e Spitzer, 1978). Nella forma originale la SADS comprende due sezioni, la prima (SADS I) prende in con- siderazione l’episodio attuale o l’ultimo anno nel caso di un episodio recente, la seconda (SADS II) è centrata sull’anamnesi psichiatrica e sui trattamenti, ma prende in conside- razione anche eventuali disturbi cronici che possono essere presenti al momento della valutazione. Lo scopo primario della SADS è l’identificazione di quei sintomi associati e importanti per la diagnosi

differenziale dei disturbi affettivi. Il campo di applicazione privilegiato per la SADS è certamente quello delle ricerche sulla depressione, della quale fornisce i criteri per identificare fino ad 11 sottotipi di depressione maggiore. L’impiego di questo strumento deve essere fatto da persone esperte, che si siano sottoposte ad un training assai lungo ed impegnativo;
m La Structured Clinical Interview for DSM (SCID), è un’intervista semistrutturata sviluppata da Spitzer e collaboratori (1987) per la diagnosi della maggior parte dei disturbi di Asse I e per quelli di personalità sull’Asse II. Per i disturbi di Asse I, la SCID fornisce anche una valutazione di gravità e consente di stabilire la percentuale di tempo in cui i disturbi sono stati presenti negli ultimi 5 anni. Ciascuna delle tre versioni per le diagnosi di Asse I è composta da 8 o 9 moduli contenenti, ciascuno, le domande per indagare l’esi- stenza dei criteri per diverse categorie diagnostiche (disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, abuso di sostanze, etc.).
m Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) scala di valutazione diagnostica semi-strutturata messa a punto congiuntamente dai gruppi di Sheehan (USA) e di Lecrubier (Francia) (Sheehan et al., 1998) e oggi tradotta in numerose lingue (oltre 35). Partendo da questo presupposto, gli Autori hanno scelto di focalizzare l’attenzione sui sintomi attuali (con l’eccezione del disturbo bipolare per il quale è rilevante sapere se un soggetto con un episodio depressivo in corso ha nell’anamnesi un episodio maniacale o ipomaniacale). La M.I.N.I si caratterizza per essere:
1. breve, semplice, chiara e facile da somministrare; 2. altamente sensibile, in grado, cioè, di identificare la massima percentuale
possibile di soggetti con un determinato disturbo; 3. specifica, capace di escludere, cioè, i soggetti senza disturbi;
87
4. compatibile con i principali sistemi internazionali di classificazione diagno- stica, l’ICD-10, il DSM-III-R (inizialmente) ed il DSM-IV successivamen- te;
5. in grado di cogliere le più importanti varianti subsindromiche;
6. utilizzabile tanto nella pratica clinica routinaria (sia psichiatrica che di me-

dicina generale) che in ambito di ricerca.
b. L’etero-valutzione della depressione
mHamilton Rating Scale for Depression – HRSD o HAM-D (1960), è senza dubbio la più conosciuta e la più usata nel mondo. Nella sua formulazione originale del 1960 l’HAM-D era composta da 17 item, portati a 21 nella versione successiva del 1967; oltre a queste ne sono calcolate numerose altre versioni con varianti più o meno arbitrarie, la più nota delle quali è quella a 24 item. La versione più diffusamente utilizzata è, probabilmente quella pubblicata nello “ECDEU Assessment Manual” (William G., 1976). I criteri di valutazione sono, per la maggior parte degli item, la risultante dell’integrazione tra l’osservazione obiettiva dei segni e l’esposizione soggettiva dei sintomi, anche se il criterio di gravità fa riferimento prevalentemente agli aspetti obiettivi. La HAM-D non è uno strumento diagnostico e non deve essere usata a questo scopo (Hamilton,1967) poi- ché per porre una diagnosi è necessario che gli item accertino “non soltanto la presenza dei sintomi che il paziente ha, ma anche di quelli che il paziente non ha”. Come tutte le scale dimensionali, infatti, la HAM-D esplora e valuta la sintomatologia depressiva indi- pendentemente dal contesto psicopatologico-clinico in cui essa si colloca, dato che una componente depressiva la possiamo incontrare praticamente in qualsiasi ambito diagnostico (compresa la mania, vista l’esistenza dello Stato Misto).
m SADS-C, una scala derivata dalla Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia- SADS, (Spitzer & Endicott, 1978). Gli Autori sono partiti dalla constatazione che una parte del successo della HAM-D è da ascriversi alla sua brevità, ottenuta peraltro a scapito della completezza dell’area esplorata, con omissione di sintomi comunemente considerati rilevanti per il concetto di depressione. La SADS-C esplora perciò, in manie- ra più ampia della HAM-D, la sintomatologia depressiva.
c. Scale di valutazione della mania
m Maniac-State Rating Scale – MSRS ideata da Beigel e coll., (1971). La MSRS è costituita da 26 item per ciascuno dei quali è necessario fornire separatamente i due giudizi, di gravità e di frequenza, su una scala a 6 punti per la frequenza (da 0=nessuna a 5=sempre) e a 5 per la gravità (da 1=irrilevante a 5=molto). Le aree esplorate dalla scala comprendono il comportamento, la qualità del pensiero, l’attività motoria e lo stato dell’umore.

m Beck-Rafaelsen Mania Scale – BRMAS (Beck e collaboratori, 1979). Composta da 11 item valutati su di una scala a 5 livelli di gravità accuratamente descritti, esplora il livello di attivazione psicofisica. La scala misura, infatti, sintomi della sfera psichica, come l’umore, i sentimenti di grandezza, l’attività intellettiva ed il comportamento sociale, e sintomi somatici come l’attività motoria, il sonno, la libido.
m Mania Rating Scale – MRS, (Young e collaboratori, 1978). Strutturata sulla BRMAS è composta da 11 item che esplorano accuratamente i sintomi chiave della patologia maniacale.
d. Scale di valutazione per la depressione bipolare
m la Hypomania Check List (HCL-32) di Angst J., Adolfsson R., Benazzi F., Gamma A., Hantouche E., Meyer T.D., et al., 2005 è un questionario in autosomministrazione, tradotto in diverse lingue, che comprende una lista di sintomi di tipo maniacale che il soggetto deve contrassegnare come “presenti” (o tipici) oppure “assenti“ (o non tipici). Il questionario comprende inoltre altri otto items che valutano la gravità e l’impatto dei sintomi di tipo eccitativo su diverse aree del funzionamento. Il punteggio totale viene ottenuto sommando i sintomi contrassegnati. Il questionario è stato sviluppato nell’ambito della ricerca di strumenti psicometrici per lo screening delle condizioni cliniche appartenenti allo spettro bipolare (Twiss J., Jones S., Anderson I.,2008). In particolare, il questionario è stato sviluppato come strumento di screening per l’ipomania, particolar- mente cruciale per la distinzione tra disturbo depressivo maggiore ricorrente e disturbo bipolare di tipo II.
m Il MDQ (Mood Disorder Questionnaire) BSDS (Hirschfeld et al., 2000) è un test per le versioni sottili di disturbo bipolare. Il questionario disturbi dell’umore (MDQ) è uno strumento di autovalutazione screening per una diagnosi ampia dello spettro bipolare (cioè, bipolare I [BD I], bipolare II [BD II], e non bipolare altrimenti specificato [BD NOS], secondo i criteri DSM-IV). Dispone di 13 domande che riguardano i sintomi di ipomania, il raggruppamento dei sintomi, e gli indicatori relativi alla compromissione della funzionalità della persona. Rispetto al colloquio strutturato Clinical per DSM-III-R (SCID), il MDQ presenta un’efficacia maggiore per una diagnosi di spettro bipolare.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il riconoscere lo SM come una condizione distinta sia dalla mania che dalla

depressione ha notevoli implicazioni tanto dal punto di vista teorico quanto sul piano pratico. Gli episodi misti sono più frequenti nelle donne e sembrano indicare un’evoluzione del disturbo bipolare meno favorevole di quanto avviene generalmente. Lo SM viene a costituire una terza polarità dell’umore con proprie caratteristiche e non può essere considerato semplicemente la somma di sintomi depressivi e maniacali. La simultanea presenza di elementi contropolari comporta una presentazione psicopatologica polimorfa ed una difficile identificazione e differenziazione diagnostica, soprattutto quando essa è contaminata da sintomi psicotici (Dell’osso, Pini, Tundo, Sarno, Musetti, Cassano, 2000). La difficoltà di individuare uno strumento diagnostico efficace e completo centra l’attenzione sull’expertise del professioni- sta che nel corso del colloquio clinico deve saper riconoscere la sintomatologia espressa per individuare poi un piano di trattamento efficace, farmacologico e psicoterapico che possa contenere e supportare nello stesso tempo il paziente.
Bibliografia:
Addington R.D., Addington J., Atkinson M., (1996). A psychometric comparison of the Calgary Depression Scale for Schizophrenia and the Hamilton Depression Rating Scale, Schizophrenia Research, 19:205.
Aitken R.C.B., (1969). Measurement of feelings using visual analogue scale, Procee- dings of Royal Society of Medicine, 62:989.
Aitken R.C.B., (1975). Assessment of depression, J Int Med Res 3(s).
Akiskal H.S., (1983). The bipolar spectrum: new concepts in classification and diagno- sis. In: Grinspoon L, ed. Psychiatry update: American Psychiatric Association annual re- view, Vol II. Washington, DC: AM PSYCHIATR PRESS; 271-92.
Akiskal H.S., Pinto O., (1999). The evolving bipolar spectrum. Prototypes I, II, III, and IV, Psychiatric Clinic North America. 22(3):517–34.
Akiskal HS, Rosenthal TL, Haykal RF, et al., (1980). Characterological depression. Arch Gen Psy-chiatry ; 37: 777-83.18.
Alarcon R.D., Walter-Ryan W.G., Rippetoe P.A., ( 1987). Affective spectrum disorders. Compr Psy-chiatry; 28: 292-308.19.

Altman E.G., Hedeker D.R. et al., (1994). The Clinician Administered Rating Scale for Mania (CARS-M):430 Development, reliability, and validity, Biological Psychiatry, 36:124. Altman E.G., Hedeker D.R. et al., (1997). The Altman Self-Rating Mania Scale. Biologi-
cal Psychiatry, 42:948. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders3rd Ed. Rev. (DSM-III-R). Washington, DC: APA; 1987.19. World Health Organization. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders. Clinical descriptions and diagnostic Guidelines. Geneva: WHO; 1992.GLISTATIMISTINÓOς3:1997; 179-188
American Psychiatric Association, (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-ders, 4th Ed. (DSM-IV). Washington, DC: APA;.
Angst J. Adolfsson R. Benazzi F. Gamma A. Hantouche E. Meyer TD. et al., (2005). The HCL-32: Towards a self-assessment tool for hypomanic symptoms in outpatients. Journal of Affective Disorders.;88(2):217-33.
Bauer M., Crits-Christoph P. et al., (1991). Independent assessment of manic and depres- sive symptoms by selfrating: Scale characteristics and implications for the study of mania, Archives of General Psychiatry, 48:807.
Bech P., Bolwig T.G. et al., (1975). Quantitative rating of manic state, Acta Psychiatrica Scandinavica, 52:1.
Bech P., Bolwig T.G. et al., (1979). The Bech-Rafaelsen Melancholia Scale and the Ha- milton Depression Scale, Acta Psychiatrica Scandinavica, 59:420.
Bech P., Gram L.F. et al., (1975). Quantitative rating of depressive states, Acta Psychia- trica Scandinavica, 51:161.
Bech P., Rafaelsen O.J. et al., (1978). The Mania Rating Scale: Scale construction and
90
As everio blandam fuga. Pos aliquiae nem quibus, il il ipient repereptatem net moluptia
inter-observer agreement, Neuropharm, 6:430. Beck A.T., Rush A. Shaw B.& Emery G., (1987). Terapia Cognitiva della depressione,

Boringhieri, Torino. Beck A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., & Emery, G., (1979). Cognitive therapy of depression,
New York, Guilford. Beck A.T., Ward C.H. et al., (1961). An inventory for measuring depression, Archives of
General Psychiatry, 4:561. Beigel A., Murphy D.L., Bunney W.E., (1971). The Maniac-State Rating Scale. Scale
construction, reliability, and validity, Archives of General Psychiatry, 25:256. Berner P, Gabriel E, Katschnig H, et al., (1983). Diagnostic criteria for schizophrenic and
affecti-ve psychoses. Vienna: World Psychiatric Association; 22. Blackburn I.M., London V.B., Ashworth C.M., (1977). A new scale for measuring mania.
Psychological Medicine, 7:453. Boyd J.H., Weissman M.M. et al., (1982). Screening for depression in a community sam-
ple. Archives of General Psychiatry, 39:1195. Bunney W.E., Murphy D.L., Goodwin F.K., Borge G.F., (1972). The “Switch Process”
in Manic-Depressive Illness. I. A Systematic Study of Sequential Behavioral Changes. Arch Gen Psy-chiatry; 27: 295-302.26.
Cardini A., Da Pozzo E., Abelli M., Panighini A., Pini S., Gesi C., Lari L., Daniele S., Cassano G.B., Martini C., (2010). Platelet uptake of GABA and glutamate in patients with bipolar disorder. Bipolar Disorder 14: 301-308.
Carney M.W.P., Roth M., Garside R.F., (1965). The diagnosis of depressive syndrome and the prediction of ECT response, Br J Psychiatry, 111:659.
Carroll B.J., Fielding J., Blashki T., (1973). Depression rating scales: A critical review, Archives of General Psychiatry, 28:361.
Carroll B.J., Feinberg M .et al., (1981). The Carroll Rating Scale for Depression: 1. De- velopment, reliability and validation, Brit J Psychiatry, 138:194.
Cassano G.B., Castrogiovanni P. ,(1982). Scala di Autovalutazione per la Depressione (SAD), In: Cassano G.B. (Ed.) “La Condizione Depressiva”, Masson Italia, Milano.

Cleary P., Guy W., (1977). Factor analyses of the Hamilton Depression Scale, In: Bertelli A. et al. (Eds.) “Evaluation of New Drugs in Clinical Psychopharmacology”, JR Prous - Publisher, Barcelona.
Cohen J., (1997). Assessment and treatment of dysthymia. The development of the Cor- nell Dysthymia Rating Scale, Eur Psychiatry, 12:190.
Conti L., (1999). Repertorio delle scale di valutazione in psichiatria, SEE - Firenze
Cronholm B., Ottosson J.-O. ,(1960). Experimental studies of the therapeutic action of electroconvulsive therapy in endogenous depression. The role of the electrical stimulation and of the seizure studied by variation of stimulus and modification by lidocaine of seizure discharge, Acta Psychiatrica Scandinavica 145(s):69.
Dell’osso L. , Pini S., Tundo A., Sarno N., Musetti L., Cssano G.Bb., (2000). Clinical Characteristics of Mania, Mixed Mania, and Depression with Psychotic Features. Com- prehensive Psychiatry; 41 (4): 1-7
Dunner D.L., Gershon E.S., Goodwin F.K., (1976). Heritable factors in the severity of affective illness. Biol Psychiat 11: 31–42
Dunner, D. L., Hensel, B. M. & Fieve, R. R., (1979). Bipolar illness: factors in drinking
91
At et as exerum, sum santis et utatis sitem doloriosanis doluptatus ra dolorib usantinis estendem
behaviour. American Journal of Psychiatry, Endicott J., Cohen J. et al., (1981). Hamilton Depression Rating Scale extracted from
regular and change versions of the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia, , 38:98.
31.Faravelli C., (1983). Le scale di valutazione in
psichiatria, Quaderni di Psichiatria, 2:97.
Faravelli C., Benvenuti P. et al., (1977). Costruzione e valutazione di una nuova scala di valutazione degli stati maniacali, Archivio di Psicologia Neurologica e di Psichiatria, 38:185.

Faravelli C., Poli E. et al., (1982). Costruzione e validazione di una nuova scala per la valutazione dei sintomi nucleari della depressione, Rivista di Psichiatria, 17:101.
Faravelli C., Poli E., Pazzagli A., (1979). La valutazione degli stati depressivi. II. Analisi della struttura fattoriale di quattro Rating Scales, Rassagna Studi di Psichiatria, 68:563.
Goodwin F.K., Jamison K.R., (1990). Manic-depressive illness. New York: Oxford Uni- versity 32.
Hakstian A.R., McLean P.D., (1989). Brief Screen for Depression, Psychological Asses- sment, 1:139.
Hamilton M., (1960). A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiat, 23:56.
Hamilton M. (1959). The assessment of anxiety states by rating, British Journal Social Clinical Psychology, 32:50.
Hamilton M., (1967). Development of a rating scale for primary depressive illness, Bri- tish Journal Social Clinical Psychology, 6:278.
Himmelhoch J., Coble P., Kupfer D., et al., (1976). Agitated psychotic depression asso- ciated withsevere hypomanic episode: a rare syndrome. Am J Psychiatry; 133: 765-71.33
Hirschfeld R., Williams J.B.W., Spitzer R.L., Calabrese J.R., Flynn L., Keck P.E., Lewis L., McElroy S.L., Post R.M., Rapport D.J., Russell J.M., Sachs G.S., Zajecka J., (2000). “Development and Validation of a Screening Instrument for Bipolar Spectrum Disorder: The Mood Disorder Questionnaire.” American Journal of Psychiatry 157:11 (November 2000) 1873-1875.
Horwath E., Johnson J., Klerman G.L., Weissman M.M., (1992). Depressive symptoms as relative and attributable risk factors for first-onset major depression. Arch Gen Psychiatry 49(10): 817-23.
Hudson JI, Pope HG., (1990). Affective spectrum disorder: Does antidepressant response identifya family of disorders with a common pathophysiology? Am J Psychiatry; 147: 552-

64.Janzarik W.D., (1959). Dynamische Grundkonstellationen in endogenen
Psychosen. Ber- lin-Gottin-gen-Heidelberg: Springer;.23.
Jouvent R., Frechette D. et al., (1980). Le ralentissement psychomoteur dans les états dépressifs: construction d’une échelle d’évaluation quantitative, Encéphale, 6:41.
Kellner R., (1986). The Brief Depression Rating Scale. In: Sartorius N, Ban TA (Eds.) “Assessment of Depression”, Springer-Verlag, New York.
Koukopoulos A., Faedda G., Proietti R., D’Amico S., De Pisa E., Simonetto C., (1992). A mixeddepressive syndrome. Encéphale; 18/1: 19-21.
Kraepelin E., (1905). Introduzione alla clinica psichiatrica. Milano: Società Editrice Li- braria;
92
As everio blandam fuga. Pos aliquiae nem quibus, il il ipient repereptatem net moluptia
Kraepelin E., (1981). Clinical psychiatry. A facsimile reproduction with an introduction by Eric T.Carlson. Scholars’ Facsimiles Reprints. New York: Delmar;
Kretschmer E., (1921). Körperbau und Charakter, Springer, Berlin,.
Légeron P., Rivière B. et al. (1993), The Anticipatory Cognitions Questionnaire (ACQ), L’Encéphale 19:3.
Leonhard, K. (1957). Aufteilung der Endogenen Psychosen. Berlin: Akademie-Verlag.
McElroy S.L., Keck P.E., Pope H.G., Hudson J.I., Faessa G.L., Swann A.C., (1992). Cli- nical and Re-search Implications of the Diagnosis of Dysphoric or Mixed Mania or Hypo- mania. Am J Psy-chiatry 149: 1633-44.27.
McElroy S.L., Strakowski S.M., Keck P.E., Tugrul K.L., West S.A., Lonczak H.S., (1995). Differencesand similarities in mixed and pure mania. Comprehen Psychiatry; 36 (3): 187-94.28.
Montgomery S., Asberg M., (1979). A new depression scale designed to be

sensitive to change, British Journal of Psychiatry, 134:382.
Neele, E., (1949). Die phasischen Psychosen nach ihrem Erscheinungs- und Erbbild. Leipzig: Barth.
Pancheri P., Carilli L., (1982). Standardizzazione e validazione di una nuova rating-scale per la valutazione della sintomatologia depressiva, Rivista di Psichiatria 17:1.
Perugi G, Akiskal H, Micheli C, et al., (1997). Validating clinical subtypes of bipolar mixed sta-tes. J Affect Disord (in press).
Petterson U, Fyro B, Sedvall G., (1973). A new scale for the longitudinal rating of manic states. Acta Psychiat Scand 49:248, 1973.
Post RM, Kopanda RT., (1976). Cocaine, kindling, and psychosis. Am J Psychiatry; 133:627-34.34.
Radloff L.S. (1977), The CES-D scale. A self-report depression scale for research in the general population, Appl Psychol Meas, 1:385.
Rhoades H.M., Overall J.E. ,(1983). The Hamilton Depression Scale: Factor scoring and profile classification, Psychopharmacology Bull, 19:91.
Rufin J.C., Ferreri M., (1984). Le diagramme HARD: Un nouvel outil d’evaluation des états dépressifs en pratique courrent, Br J Clin Pract, 2:31.
Rush A.J., Giles D.E. et al., (1985). The Inventory for Depressive Symptomatology (IDS): Preliminary findings, Psychiat Res, 18:65.
Sheehan D.V., Lecrubier Y., Sheehan H.K., Armorim P., Janavs J., Weiller E., Hergueta T., Baker R., Dunbar G.C., (1998). Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI): The development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM- IV e ICD-10. J Clin Psychiatry, 59 (suppl 20), 22-33.
Shugar G., Schertzer S. et al., (1992). Development, use, and factor analysis of a self- report inventory for mania, Comprehensive Psychiatry, 33:325.
Snaith R. P., Costantopoulos A.A. et al., (1978). A clinical scale for the self-assessment of irritability, British Journal of Psychiatry , 132:164.

Snaith R.P., Bridge G.W.K., Hamilton M., (1976). The Leeds Scales for the Self-Asses- sment of Anxiety and Depression, British Journal of Psychiatry, 128:156.
Snaith R.P., Hamilton M. et al., (1995). A scale for the assessment of the hedonic tone: the Snaith-Hamilton Pleasure Scale, Journal of Psychiatry ,167:99.
Spitzer R.L., Endicott J., (1978). Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia -
93
At et as exerum, sum santis et utatis sitem doloriosanis doluptatus ra dolorib usantinis estendem
Change Version (SADSC), New York State Psychiatric Institute, Biometrics Research, New York.
Spitzer RL, Endicott J, Robbins EL., (1981). Research Diagnostic Criteria (RDC) for a Selected Group of Function Disorders. New York: New York State Psychiatric Institute, Biometric Research.
Spitzer R.L., First M.B., Gibbon M., Williams J.M.W., (1995). The Structured Clinical Interview for DSM-III-R Personality Disorders (SCID-II). Part I: Description. Journal of Personality Disorders: Vol. 9, No. 2, pp. 83-91.
Svanborg P., Asberg M., (1994). A new self-rating scale for depression and anxiety states based on the Comprehensive Psychopathological Rating Scale, Acta Psychiatrica Scandina- vica , 89:21.
Twiss J., Jones S., Anderson I., (2008). Validation of the Mood Disorder Questionnaire for screening for bipolar disorder in a UK sample. Journal of Affective Disorders 110(1- 2):180-4.
Wechsler H., Grosser G.H., Busfield L.B. Jr,. (1963). The Depression Rating Scale. Ar- chive General of Psychiatry, 9:334.
Widlöcher D.J., (1983). Psychomotor retardation: clinical, theoretical, and psychometric aspects, Psychiat Clin North Amer, 6:27.
Willim G., (1976). ECDEU assessment manual for psychopharmacology. U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health Administration, National Institute of Mental Health, Psychopharmacology Research Branch, Division of Extramural Research

Programs in Rockville, Md.
2. WinokurG,ClaytonP,ReichT,(1969).Manic-
DepressiveIllness.St.Louis:CVMosby;
Winokur G., (1985). The validity of neurotic-reactive depression. New data and reapprai- sal. ArchGen Psychiatry; 42: 1116-22.20.
Young R.C., Biggs J.T. et al., (1978). A rating scale for mania: reliability, validity and sensitivity, Br J Psychiatry, 133:429.
Zigmond A.S., Snaith R.P., (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale, Acta Psychiat Scand, 67:361.
Zimmerman M., (1983). Self-report depression scales (letter), Archive General of Psy- chiatry, 40:1035.
Zimmerman M., Coryel W. et al., (1986). A self-report scale to diagnose major depressi- ve disorder, Archive of General Psychiatry, 43:1076.
Zung W.W.K.,(1965). A Self-Rating Depression Scale, Archivea of General Psychiatry, 12:63.
Zung W.W.K., (1972). The Depression Status Inventory: An adjiunct to the Self-rating Depression Scale, Journal of Clinical Psychology, 28:539.