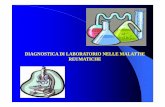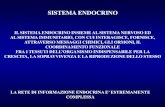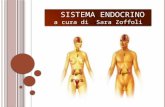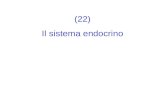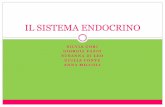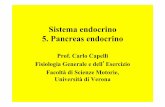Gotta (Endocrino Lez 28)
description
Transcript of Gotta (Endocrino Lez 28)

07-12-2012 Prof. Del Prato
IPERURICEMIE E GOTTA
Oggi parleremo di iperuricemie e di gotta.
Ci siamo dedicati in particolar modo al metabolismo glucidico (al metabolismo nel diabete mellito ed ai suoi aspetti), al metabolismo lipidico (e in particolar modo alle dislipidemie), e non abbiamo parlato di amminoacidi e di amminoacidopatie ma sono un capitolo abbastanza piccolo. Le malattie del metabolismo energetico, come obesità e magrezza, credo che vi siano state dette.
Esistono poi alterazioni a carico del metabolismo purinico, ed in particolare le iperuricemie e la gotta. Cosa sono le iperuricemie e perché ci interessano al fine di garantire la salute delle persone?
Le iperuricemie corrispondono ad un gruppo di malattie metaboliche relativamente comuni. Per iperuricemia intendiamo un’elevazione della concentrazione di acido urico nel sangue e non necessariamente possono dare manifestazioni ma, nel caso, hanno poi manifestazioni caratteristiche.
L’aumento di acido urico a livello circolante (o a livello di altri liquidi come vedremo poi) può essere causato da un eccesso di produzione (e per produzione dobbiamo ricordare il concetto di “pool”: ossia “quanto entra” e “quanto esce”) oppure da una diminuita escrezione. Quindi l’aumento può essere dovuto o a quanto ne entra se ne entra troppo, o a quanto ne esce se ne esce poco oppure alle due condizioni combinate.
Le purine sono le basi adenina e guanina legate a degli zuccheri, in particolare a dei pentosi come il ribosio, e associate a gruppi fosfato. Esse:
- sono le basi e i principali mattoncini di quello che poi è il DNA (e anche dell’RNA),- partecipano al metabolismo energetico con l’ATP,- partecipano ai sistemi di segnale intracellulare soprattutto a livello dei sistemi GMP dipendenti,- partecipano alla comunicazione tra cellule (perché l’adenosina funge da trasmettitore e da
segnale intercellulare in alcune condizioni).
Quindi le purine hanno un ruolo importante.
La gotta (e l’iperuricemia) è una cosa nota da molto tempo; la dottrina ippocratica intendeva che la gotta (e da essa deriva il nome di bigotta, che poi è l’espressione sintomatologica come quadro clinico più tipica della condizione di iperuricemia) fosse legata alla dottrina degli umori, indicando il fluire goccia goccia (da cui gotta) in un’articolazione, che poi da questo porta ad accumulo, rigonfiamento e artrite.
La cosa interessante è che la gotta ha anche un valore storico perché è stata la prima malattia delle società affluenti, cioè è stata la prima malattia del benessere (la gotta i poveri cristi non ce l’avevano mentre invece qualcun altro ce l’aveva).
Lo trovate già descritto in alcuni quadri e in alcune incisioni: il tipico Ricastro che continua a bere non sapendo che l’alcool è un fattore precipitante la gotta. Generalmente la gotta interveniva nel primo mattino dopo abbondanti libagioni, ovviamente con un grande senso di bruciore e di dolore.
Piero Cosimo de’ Medici era noto anche come “il gottoso”.

METABOLISMO DELL’ACIDO URICO
Passiamo ora a qualche nota più dottrinale.
La gotta è una malattia causata da un disordine nel metabolismo delle basi puriniche; quindi possiamo immaginare che, se c’è un eccesso di purine può esserci un aumento di acido urico. Una situazione in cui aumenta la quantità di basi è quando sostanzialmente c’è una grossa lisi cellulare. Tipicamente andremo nella gotta secondaria con episodi di iperuricemia o anche, eventualmente, di crisi gottose in soggetti trattati con antineoplastici -> quindi crisi blastica -> liberazione massiva di DNA -> liberazione massiva di purine e così via.
L’alterzione del metabolismo è caratterizzata ed è patognomicamente definita sulla base:
- di elevazioni di acido urico nel plasma - ed è, dal punto di vista sintomatologico, rappresentata dalla presenza di attacchi e accessi acuti
e intermittenti tipicamente di artrite, di gotta acuta, che poi può diventare gotta cronica.- Questo è dovuto alla deposizione di cristalli di acido urico, che svolgono un’azione flogistica e
infiammatoria a livello locale, precipitandone poi nell’infiammazione.Questi “accumuli” possono essere dapprima deposizioni, ma poi possono diventare accumuli all’interno delle articolazioni, o addirittura a livello di altri tessuti (in particolare i tessuti cartilaginei), a formare dei veri e propri ammassi di acido urico, con la formazione di estroflessioni: i cosiddetti tofi gottosi.
- La condizione associata soprattutto alla forma cronica è la nefropatia iperuremica o gottosa, che è caratterizza da vari aspetti che vedremo poi nel dettaglio.
Non c’è gotta senza iperuricemia ma non è altrettanto vero il contrario: non necessariamente tutte le iperuricemie danno gotta. In Europa, negli USA e anche in Italia si calcola che la prevalenza dell’iperuricemia (non della gotta) varia, a seconda delle stime, da un 3% ad un 10-12%; mentre se analizziamo la popolazione ospedalizzata questa aumenta notevolmente (ma questo è normale: il tipo di farmaci, il tipo di trattamento e il tipo di gravità possono aumentare questa frequenza). Però di questo 10% medio che in Europa e negli USA è interessato da un aumento della concentrazione circolante di acido urico, solo 1 su 20 (quindi solo lo 0,5%) ha mediamente un episodio di gotta.
La gotta è una patologia che colpisce soprattutto il sesso maschile e nel 5% dei casi colpisce le donne perlopiù dopo la menopausa. Questo è indicativo, infatti in menopausa di verificano delle alterazioni metaboliche di vario tipo, compreso l’aumento del peso corporeo, che possono facilitare alterazioni nel metabolismo delle purine, e quindi facilitare lo sviluppo di un’iperuricemie e eventualmente della gotta.
Il metabolismo dell’acido urico non è una cosa semplicissima: a partire dalle famose basi fino ad arrivare all’acido urico sono coinvolti almeno 10-11 passaggi (non pretendo che voi li sappiate).
La cosa importante da notare è che alcuni di questi passaggi sono determinati da (e sono sotto il controllo di) enzimi che possono essere coinvolti da alterazioni genetiche. Quindi deficit geneticamente determinati di alcune di queste funzioni enzimatiche possono portare ad un aumento della produzione di acido urico. Questo ve lo dico perché noi distinguiamo le iperuricemie congenite o primitive da quelle secondarie. Una delle forme primitive è dovuta ad un’alterazione della funzione enzimatica come al solito congenita e geneticamente determinata (vedremo almeno uno dei casi più tipici di queste condizioni).
Il tutto parte, come abbiamo detto, dall’associazione base-pentoso-fosfato, che portano alla formazione del 5-fosforibosilpirofosfato. Questa azione è catalizzata da un’enzima: la fosforibosilpirofosfato sintetasi (PRPP sintetasi), la quale è sotto il controllo di due meccanismi:
- La quantità di substrato (come spesso accade per le reazioni di tipo enzimatico), quindi c’è una induzione sulla base del substrato. Più c’è substrato più questa funziona, maggiore è la mia necrosi cellulare più questa si attiva e così via.

- E poi c’è un controllo negativo da parte dell’acido inosinico, che ha un effetto a feedback negativo sull’attivazione di questo enzima.
Non solo quindi questa condizione porta all’aumento della cascata che poi attraverso la formazione di ipoxantina determina acido urico, ma questa seconda parte della via enzimatica di formazione dell’acido urico può risentire di quella che è considerata una specie di via di recupero attraverso le azioni della ipoxantina-guanina fosforibosil transferasi, la quale comporta un recupero di ipoxantina alla formazione di acido inosinico e della guanina alla formazione di acido guaninico; i quali sono poi formazioni che possono portare alla sintesi di acidi nucleici.
Il concetto è che esistono molti di questi enzimi e che alcuni di questi enzimi possono essere direttamente alterati per mutazioni di tipo genetico (e queste possono far aumentare la sintesi di acido urico). La quantità di acido urico che si accumula a formare il pool di acido urico nell’organismo è dovuta:
- da una parte alla sintesi “de novo” (sintesi che avviene a livello di tutti i tessuti),- dall’introduzione di purine attraverso la dieta, - recupero enzimatico attraverso quei meccanismi che abbiamo appena visto (fosforibosil
transferasi),- l’acido urico poi viene a formarsi solo a livello di specifici tessuti (quindi le purine sono
sintetizzate in tutti i tessuti ma il processo metabolico/catabolico avviene sostanzialmente a livello di fegato e intestino, i quali sono dotati della presenza della xantina ossidasi, che è l’ultima tappa enzimatica che porta alla formazione di acido urico).
Il 70% di questo acido urico è escreto a livello del rene mentre la quota rimanente è escreta a livello intestinale.
Questo ci suggerisce un’altra cosa: se c’è un possibile accumulo di acido urico per difetto di escrezione chi gioca un ruolo principale (per effetto anche di altre patologie che possiamo facilmente immaginare) è il rene piuttosto che l’intestino.
Nel nostro organismo noi abbiamo circa 1gr (pool totale) di acido urico. Siccome soprattutto una volta si tendeva ad incidere su questo pool (soprattutto con la dieta) è anche opportuno immaginare e capire quali sono i diversi apporti. Noi sappiamo che:
- la sintesi endogena rende conto di circa il 70% del pool totale di acido urico,- con un altro 10% che è dovuto al ricircolo degli acidi nucleici- e con il restante 20% che deriva dall’alimentazione.
Quindi o voi forzate tremendamente l’alimentazione (cosa che siamo tutti bravissimi a fare quando ci mettiamo di buzzo buono) ma capite che comunque la riduzione è abbastanza limitata nel suo impatto perché anche se vado a zero riduco solo del 20% quello che è l’apporto a livello del pool dell’acido urico.
Questa quantità di pool miscibile (1000mg) di acido urico rimane in equilibrio perché a fronte di questa produzione c‘è un’escrezione che abbiamo già visto essere per il 70% a carico del rene mentre il rimanente viene eliminato attraverso la via intestinale.
La cosa interessante è cercare di capire cosa succede a livello renale per quel che riguarda l’escrezione di acido urico, perché questo ci fa anche rendere conto di un’altra grande complicanza dell’iperuricemia che è la nefropatia iperuricemia o gottosa. A livello del rene l’acido urico viene filtrato del 100% (quindi tutto quello che arriva viene filtrato), però a livello del tubulo prossimale tutto questo acido urico viene riassorbito (98-100%). Il problema è che l’acido urico, a differenza del glucosio, non è che una volta riassorbito non torna più ma a livello del tubulo più distale viene secreto per il 50%, e, sempre a livello del tubulo, viene nuovamente riassorbito per un 40% con una escrezione finale totale che è intorno al 6-12%.

L’acido urico esce e rientra, e riesce e rientra a livello del tubulo e soggiorna/staziona per un certo periodo a livello del tessuto interstiziale. Infatti la nefropatia uricemica o gottosa è una nefropatia tipicamente interstiziale, mentre tutte le altre nefropatie sono sostanzialmente glomerulari (che sia diabetica, membranosa o che sia autoimmune, interessa il glomerulo, questa invece interessa tipicamente l’interstizio, quindi è una forma un po’ particolare).
DOMANDA: nell’insufficienza renale c’è un compenso da parte dell’intestino oppure la quota rimane fissa? RISPOSTA: No, rimane più o meno fissa. Non c’è grande compenso.
Valori:
- Uricemia:o 3,5/6,8 mg/100ml nell’uomoo 2,5/6,0 mg/100ml nella donna (è più basso a causa della diversa composizione
muscolare ma tende ad aumentare nella post-menopausa per l’intervento di altri fattori di tipo metabolico che possono aumentare queste concentrazioni)
o Nel bambino tende ad essere più bassa (tra i 3,0/4,5 mg/100ml)o Con la pubertà comincia ad aumentare (in funzione anche della massa muscolare che si
sviluppa e del turn-over proteico che si viene a creare)
La cosa interessante è che questo valore massimale del range di normalità è prossimo al valore di precipitazione dell’acido urico.
- Soglia di solubilità: circa 7,0 mg/100ml a 37°
Quindi fino a 7,0 mg alla temperatura corporea di 37° rimane solubile, ma al di sopra di questa concentrazione va in sovra saturazione e tende a precipitare. Questo spiega anche perché è facile che per valori anche relativamente bassi di iperuricemia (anche se non è vero il contrario, infatti ci sono condizioni in cui l’acido urico è estremamente elevato ma non si hanno precipitazioni magari perché in circolo ci sono sostanze che hanno un qualche effetto solubilizzante che non sono presenti in tutti) però è abbastanza facile, dicevamo, che anche per concentrazioni di acido urico relativamente basse ci siano delle precipitazioni. Alcune precipitazioni in alcune aree particolari poi possono essere favorite da altri elementi di tipo chimico-fisico.
- Secrezione renale: 0,5/1 gr/die (in base alla dieta)
Se viene forzata la quantità di purine ingerite chiaramente il pool miscibile tende a mantenere un certo suo equilibrio e quindi viene aumentata la dismissione.
- Quantità totale: 1gr.
CLASSIFICAZIONE
Come possiamo distinguere le iperuricemie? Ci sono vari modi e vari tipi di classificazioni. Una è quella che distingue l’iperuricemia in base all’eziologia; quindi:
- Forme primarie:o Deficit di ipoxantina-guanina fosforibosil transferasi o Aumentata attività della fosforibosilpirofosfatasi (uno dei primi step)o Idiopatica
- Forme secondarie

Fanno parte delle forme secondarie una grande lista di condizioni, all’interno della quale possiamo fare dei raggruppamenti:
- Malattie mieloproliferative, malattie linfoproliferative, anemie citolitiche, psoriasi sono caratterizzate o da un’accelerata morte cellulare o da un aumentato turn-over cellulare. In questi casi aumenta la disponibilità di purine e quindi di acido urico.
- Poi ci sono condizioni che possono interferire con i sistemi di escrezione (quindi tutto quello che riguarda la patologia renale quindi insufficienza renale, intossicazione da piombo, e cosi via.
- Altre condizioni ancora ma un pochino diverse come le glicogenosi che possono essere associate ad iperuricemie.
- Poi ci sono sostanze che possono interferire soprattutto per quel che riguarda l’escrezione di acido urico, non ultimo l’alcool. L’alcool precipita l’evento iperuricemico o gottoso perché interferisce con il riassorbimento di acido urico; riduce quindi l’escrezione di acido urico favorendone la precipitazione a livello renale ma soprattutto riducendo l’escrezione aumenta il pool di acido urico favorendo così la comparsa del quadro clinico.
- Tra le altre cose bisogna ricorda che siccome l’acido urico compete con altri acidi a livello del sistema di riassorbimento tubulare quando voi avete quadri di acidosi come nel diabete (cheto acidosi), o nell’acidosi lattica si può andare incontro ad un evento di iperuricemia.
L’iperuricemia è il prerequisito cardinale della gotta, di solito ci deve essere un aumento del livello di acido urico. Questo aumento non deve necessariamente essere particolarmente elevato, poiché basta un modesto aumento della concentrazione di acido urico per entrare in quell’area di saturazione dell’acido urico che ne determina la precipitazione.
L’iperuricemia è presente non solo in circolo, ma anche a livello dei vari liquidi organici, per esempio è aumentata anche a livello dei liquidi interstiziali cosicché il pool totale possa andare da 1gr a 2/4gr. In questo caso (2/4gr) siamo di fronte ad un caso di gotta senza particolari accumuli (nelle sedi classiche), ma in casi in cui si passa da 1gr a 30gr l’acido si accumula in aree particolari che portano alla formazione di tofi.
Altra classificazione per l’iperuricemia è quella in cui si distingue:
- Eccessiva produzione di acido urico- Difetto di eliminazione- Combinazione dei due quadri
In condizioni di iperuricemia il plasma e i liquidi interstiziali sono sovra saturi, si ha la precipitazione e ciò rende l’iperuricemia sintomatica con i quadri caratteristici ed in particolare con i quadri di gotta.
Facciamo ancora una distinzione dal punto di vista classificativo per cui distinguiamo:
- Eccessiva produzione di acido urico:o Gotta primaria su base genetica (in questo caso molto spesso non ne troviamo
nemmeno la causa ma in altre condizioni siamo in grado di definire un difetto enzimatico specifico). La maggior parte delle forme idiopatiche familiari non hanno una causa ben definita ma molto probabilmente sono di origine poligenica (ma le alterazioni non sono state ancora completamente codificate)
o Gotte secondarie da aumentata produzione - Difetti di eliminazione- Combinazione di entrambe le condizioni.
Bisogna ricordare che se uno ha un difetto di escrezione e contemporaneamente ad un certo punto ha una crisi blastica il rischio che abbia un episodio gottoso aumenta di molto.

Gotta primaria di origine monogenica
Sono dovute in alcuni casi ad un’aumentata produzione della fosforibosilpirofosfatasi sintetasi (è il primo enzima, prende purine, ribosio e gruppi fosfato e da il via alla cascata che porta verso la formazione di acido urico), oppure al deficit di ipoxantina-guanina fosforibosiltransferasi (HGPRT), il quale si ricorda soprattutto perché legato alla sindrome di Lesch-Nyhan.
Poi c’è un’altra condizione, sempre monogenica, dovuta alla carenza di glucosio-6fosfato fosfatasi che determina la glicogenosi di tipo I e che, a causa dell’aumentata concentrazione di glucosio 6P intracellulare che, come tale, va a creare l’aumento di quel substrato che permette la formazione di acido urico.
Sindrome di Lesch-Nyhan
Se ne conoscono 2 forme: la forma completa e la forma incompleta.
E’ caratterizzata da iperuricemia, ma forse l’iperuricemia non è nemmeno il tratto più saliente perché questi soggetti sono caratterizzati dalla tendenza compulsiva all’autolesionismo e quindi si auto-infliggono mutilazioni. C’è una condizione neurologica caratterizzata da coree con ritardo mentale e con presenza di spasticità.
C’è poi la forma incompleta in cui abbiamo iperuricemia ma c’è assenza, sostanzialmente, delle manifestazioni neurologiche che caratterizzano invece la forma completa della sindrome di Lesch-Nyhan, nota anche come sindrome di Kelley-Seegmiller.
MANIFESTAZIONI CLINICHE:
- Aumento delle concentrazioni circolanti di acido urico (iperuricemia asintomatica)- Artrite gottosa acuta (di solito caratterizza la prima manifestazione: generalmente è
monoarticolare e più frequentemente interessa le piccole/medie articolazioni piuttosto che le grosse articolazioni –> questa è una cosa da tenere ben presente perché permette la diagnosi differenziale rispetto ad altre artriti di tipo infiammatorio)
- Gotta intercritica (condizione di iperuricemia tra un evento gottoso e l’altro)- Artrite gottosa cronica (evolve da un’artrite gottosa acuta ed è caratterizzata dalla presenza di
depositi tofacei , il che vuol dire che c’è un’iperuricemia che data almeno 15-20 anni)- Nefropatia gottosa e urolitiasi (caratterizzata da depositi interstiziali di cristalli di urato nel
parenchima renale).
Iperuricemia asintomatica
Il primo quadro è quello dell’iperuricemia che può anche essere totalmente asintomatica.
Questa è la condizione più frequente e viene spesso scoperta casualmente (funzione renale normale e tutto tranquillo ma per caso negli esami del sangue compare l’aumento di acido urico).
Il 10% della popolazione ha un’iperuricemia ma solamente 1 su 20 sviluppa un quadro clinicamente manifesto.

Il rischio di nefrolitiasi aumenta invece in funzione dell’aumento dell’uricemia e in funzione anche dell’acido urico eliminato.
In una fase strettamente iniziale è estremamente difficile distinguere una nefropatia uratica perché sostanzialmente è una condizione asintomatica (se anche fosse la causa del modesto aumento della pressione diventa difficile capire se quell’ipertensione è determinata dal danno renale dovuto alla presenza di acido urico). Noi sappiamo che i soggetti che sono iperuricemici molto spesso hanno anche altre alterazioni metaboliche frequentemente associate ad un aumento della pressione (come la sindrome metabolica).
Artrite gottosa
L’altro quadro è invece quello dell’artrite gottosa .
Ha una prevalenza dell’ 1-2 % e la probabilità che si verifichi un attacco artritico gottoso dipende dai livelli e dalla durata dell’iperuricemia. Tanto maggiore è la durata e tanto più elevata è la concentrazione di acido urico, più facile è che ci sia una precipitazione. Questa precipitazione è più frequente a livello dei tessuti poco vascolarizzati (come cartilagini, tendini e legamenti), o più distali (che sono più freddi). Questa è una cosa importante perché la temperatura e la poca vascolarizzazione comportano variazioni del ph, e sia la bassa temperatura sia il basso ph comportano la precipitazione.
Questo ci dice anche quali sono i fattori che possono favorire la comparsa di un attacco acuto di gotta, e perché soprattutto vengono interessate le articolazioni distali, cioè perché sono le meno irrorate (quindi quelle in cui il ph tende ad abbassarsi un pochino di più). A livello urinario prima o poi con un ph=5 c’è una precipitazione importante mentre a ph=7 può esserci acido urico senza che questo precipiti.
Quindi ci sono dei fattori precipitanti che sono legati da un lato alla temperatura e dall’altro all’abbassamento del ph. In queste condizioni la sovra saturazione e la precipitazione avviene per valori che sono quasi la metà di quelli normali (con 4mg/dl a 30° si ha già la precipitazione dell’acido urico).
Cristalli di urato monosodico si depositano a formare strutture a forma di ago nelle cartilagini e nei legamenti, e in queste condizioni e in fase più avanzata possono essere interessate anche le articolazioni centrali. Gli accumuli a questi livelli possono portare alla formazione dei cosiddetti tofi gottosi (i quali sono visibili anche a livello radiologico).
(foto) Questi sono i tipici aghi di acido urico. Possiamo vedere come siano dei veri e proprio aghi.
Questi aghi hanno una proprietà: precipitando hanno una capacità flogistica molto elevata. Nelle condizioni di iperuricemia precipitano gli aghi di acido urico, i quali attivano il complemento e richiamano neutrofili. Questi neutrofili a loro volta attivano il processo fagocitotico con lisi del neutrofilo stesso, e, quando si lisa il neutrofilo sostanzialmente avviene il rilascio di enzimi lisosomiali e quindi attivazione dei processi locali di lisi e infiammazione. Allo stesso tempo la fagocitosi monocitaria dei cristalli di acido urico comporta la tipica liberazione dei fattori infiammatori (TNF-α, interleuchine e così via) con tutto quello che comporta in termini di attivazione locale.
Siamo di fronte ad un tipico quadro infiammatorio; i vecchi clinici scrivevano che è caratterizzato dalla triade rubor, calor e functio lesa. Quindi rossore, calore e funzionalità alterata.
L’artrite quindi:
- È causata da questi microcristalli di urato che generano una risposta infiammatoria. - È più frequente nei maschi (generalmente solo il 5% delle donne).- Si manifesta nella IV-V decade (generalmente dopo i primi 20/30 anni di iperuricemia).- Il primo episodio è di solito monoarticolare.

- Nel 50% dei casi è interessata la prima articolazione metatarso-falangea con il cosiddetto quadro di podagra
- Altre articolazioni che possono essere interessate sono caviglia, ginocchia e polso (ma di solito la più comune è quella metatarso-falangea)
Quindi davanti ad un paziente che si lamenta per il dolore alla prima articolazione pensate sempre ad un attacco gottoso.
Il quadro si presenta di solito in modo acuto e improvviso, può essere scatenato da microtraumi oppure da alimenti ricchi di purine (come accade dopo una grande mangiata, soprattutto se abbondantemente innaffiata da alcolici, una combinazione tipica) o ancora da condizioni di stress di vario tipo.
Il dolore è mono- o poli-articolare (ma molto più spesso mono-articolare), è acuto e spesso ha insorgenza notturna. Ha insorgenza notturna perché siccome c’è un rallentamento nella circolazione, il che comporta una riduzione del ph a livello distale, e c’è una minor temperatura locale è facilitata la precipitazione.7
È un dolore piuttosto importante. Ci sono i segni dell’infiammazione acuta (rubor, calor e functio lesa).
Le manifestazioni più frequenti sono:
- Poliartrite monoarticolare- Borsiti- Tendiniti- Entesiti- Depositi tofacei- Ecc..
Le sedi più colpite le abbiamo già dette.
Può essere accompagnata da un quadro flogistico infiammatorio generalizzato con aumento della temperatura, tachicardia e, talvolta, leucocitosi.
L’evoluzione è di solito self-limiting, nel senso che nel giro di pochi giorni può risolversi (almeno inizialmente) per poi tornare con periodi intercritici sempre più ravvicinati. Questa è un’evoluzione sostanzialmente costante, per cui le lesioni possono anche diventare permanenti. Ovviamente se c’è un deposito importante ci può essere un rimaneggiamento osseo e quindi ci può anche essere un’alterazione ancor più permanente della funzione.
Questo è il quadro tipico.
(foto) Qui si vede male ma c’è un rigonfiamento arrossato.
Qui invece il rigonfiamento è più evidente
Qui invece si possono osservare i cristalli di acido urico, cosa importante perché molto spesso si deve anche ricorrere (se l’articolazione non è quella tipica) ad un’analisi del liquido sinoviale. Ovviamente la presenza dei cristalli di acido urico diventa patognomonica.
Qui ancora si vede un cristallo inglobato all’interno di un monocita.
I fattori scatenanti sono:
- Sforzi fisici prolungati- Traumi articolari (il trauma articolare aumenta l’attivazione flogistica locale e fa da innesco)- Eccessi alimentari- Abuso di alcool (che inibisce la secrezione di acido urico)

[Ricordate anche che la birra è associata ad un maggior rischio di iperuricemia probabilmente perché contiene guanosina e quindi oltre all’effetto dell’alcool abbiamo un aumento di substrato per l’attivazione della sintesi di acido urico. La birra inoltre è maggiormente associata a pance gonfie in un certo modo e quindi ad alterazioni metaboliche che possono favorire l’insorgenza di questa condizione]
- Digiuno prolungato- Alcuni farmaci (come i diuretici, in quanto questi ultimi determinano sostanzialmente
un’iperuricemia da aumentato flusso a livello distale con l’incapacità di recupero dell’acido urico in termini di riassorbimento)
DIAGNOSI
La diagnosi si fa soprattutto osservando i segni (sospetto su base clinica): gli attacchi sono tipici e le stessa localizzazione può essere tipica.
Questa situazione è inoltre sostenuta da una concentrazione di acido urico elevata, anche se non necessariamente c’è iperuricemia in corso di attacco gottoso (nel 30% dei casi non c’è).
In alcune condizioni si può ricorrere all’agoaspirato per prelevare liquido sinoviale, o eventualmente se non è il primo attacco ma se gli attacchi si sono già ripetuti più volte - l’anamnesi aiuta, ma ancor più dell’anamnesi - aiuta trovare un corpo gottoso. Un corpo gottoso diventa patognomonico del fatto che quell’attacco articolare è su base iperuricemia.
La rapida risposta alla colchicina: infatti con la colchicina inibisco il ciclo cellulare con blocco cellulare riducendo quindi l’apporto di acido urico che così genera velocemente questo effetto. Quindi la colchicina riconosce ma permette anche di curarla velocemente.
Poi ci può essere nella radiografia la presenza di tofi o di rimaneggiamento osseo anche se non è particolarmente specifica.
DIAGNOSI DIFFERENZIALE
Siamo di fronte ad un interessamento artritico e dobbiamo quindi considerare per quel che riguarda la diagnosi differenziale:
- Artriti acute- Artriti infettive- Pseudo gotta- Sindrome di Reiter- Alterazioni iniziali di processi reumatologici- Sindromi di natura connettivitica (ci sono altri segni che non sono presenti nell’attacco acuto di
gotta o nell’artrite gottosa)
La diagnosi si può anche far con l’analisi del liquido sinoviale ma la diagnosi di gotta è abbastanza facile da fare se ci si pensa con un po’ di attenzione.
Gotta intercritica
Abbiamo detto che tra un attacco acuto e l’altro siamo di fronte ad una fase definita gotta intercritica. È una condizione in cui il paziente è perfettamente asintomatico ma continua ad essere iperuricemico, quindi un soggetto potenzialmente a rischio. Questi soggetti vanno trattati ed è necessaria una prevenzione.

Dopo il primo attacco il 7% dei soggetti può rimanere con questo unico attacco isolato, però la stragrande maggioranza (62% dei casi) tende ad avere nuovi attacchi nell’arco del primo anno. Il restante 31% ha attacchi anche in seguito, ritardati nel tempo.
Aver avuto un primo evento di artrite gottosa è un grosso fattore di predizione per un altro episodio di artrite gottosa.
Gotta cronica tofacea
Con il progredire dell’iperuricemia nel tempo e con le concentrazioni di acido urico particolarmente elevate si può manifestare la gotta cronica tofacea.
Nei pazienti non trattati la formazione dei tofi rappresenta l’evoluzione naturale della gotta.
Se non si fa nulla per bloccare la situazione nel soggetto iperuricemico, il pool (che aumenta fino a 30gr) va a depositarsi nelle zone dove è più facile che si depositi (cioè dove i tessuti sono poco vascolarizzati, dove il ph è più basso, e dove ho anche ipossiemia), e quindi soprattutto a livello delle cartilagini.
I tofi sono degli ammassi di cristalli di urato monosodico immersi in una matrice amorfa. Si possono anche rompere e quando lo fanno liberano del materiale gessoso e biancastro (che si sfarina in cristalli). Di solito si presentano come formazioni nodulari, asimmetriche e non dolenti (il tessuto è amorfo quindi non c’è tessuto attivo localmente). È un accumulo di questo pool in eccesso. La cute è tesa, lucida e sottile (ovviamente può rompersi e ulcerarsi dando emissioni di questo contenuto biancastro di tipo gessoso).
(foto) Questi sono alcuni esempi, se ne vedono ormai pochissimi in realtà.
Questi sono in sede della prima articolazione metatarso-falangea.
Qui a livello del gomito e delle mani.
Si possono osservare anche a livello radiologico gli accumuli di acido urico organizzati a formare i tofi.
Qui li vedete a livello delle cartilagini. È una sede tipica, in corso di attacco acuto di gotta quindi bisogna andarli a cercare a livello di elice e antelice (sembrano dei “bozzettini” ma in realtà sono tofi gottosi da accumulo di acido urico). Sono quelli che oggi si vedono più di frequente; non si vedono più grandi cose come quelle che vi ho mostrato prima a livello delle articolazioni delle mani o a livello tendineo.
Qui vedete ancora alcuni esempi, e possiamo osservare poi cosa succede come alterazione di tipo osseo dovuta all’infiammazione cronica da artirte gottosa che il tofo gottoso può portare in sede di deposito. Qui vedete il deposito iniziale e poi vedete invece la progressione della patologia con distruzione dell’osso.
A livello della mano esiste anche il quadro di podagra.
Nefropatia gottosa
L’altro grande impatto della patologia gottosa è quello a livello renale.
La nefropatia può presentare almeno tre quadri:
- La nefropatia uratica

- La nefrolitiasi- L’urolitiasi
Abbiamo quindi la nefropatia interstiziale (è la conseguenza del deposito di urato monosodico nell’interstizio) e il risultato della precipitazione a livello del filtrato di acido urico.
Questa è l’unica nefropatia interstiziale o comunque la principale nefropatia interstiziale (le altre sono tutte di tipo glomerulare o tubulare). La conseguenza è la progressiva flogosi (e abbiamo visto cosa questa situazione scatena a livello articolare con il deposito di cristalli di acido urico -> così fa anche a livello del rene).
Clinicamente si presenta:
- Con proteinuria di solito modesta e spesso intermittente- Con o senza microematuria- Con aumento della creatinina
Sono quadri abbastanza aspecifici; è difficile stabilire, davanti ad un quadro di questo tipo, che realmente si tratta di iperuricemia (sappiamo infatti che la stessa insufficienza renale può dare un’iperuricemia per difetto di escrezione). Quindi è difficile dire se l’iperuricemia è la causa o l’effetto. Ci può essere una perdita di capacità della concentrazione delle urine e quindi un quadro di ipostenuria (e poi ovviamente anche un quadro di insufficienza renale).
Però il quadro più tipico e frequente è la calcolosi renale.
È frequente in soggetti con gotta. Soggetti che hanno avuto già episodi artritici possono avere più frequentemente la calcolosi renale.
In circa 1/3 dei pazienti con coliche queste possono anche precedere di anni il primo attacco gottoso però quando c’è stata la prima manifestazione gottosa il quadro diventa ancor più frequente.
I fattori predisponenti sono sempre gli stessi: le concentrazioni elevate e un ph basso.
Se alcalinizzo le urine prevengo la precipitazione dell’acido urico.
Un ultimo aspetto è che l’acido urico è, secondo alcune interpretazioni e risultati, un fattore di rischio cardiovascolare.
(slide) Queste sono la mortalità (tra tutte le cause) e la mortalità per eventi cardiaci e vascolari in soggetti normouricemici e in soggetti con iperuricemia gottosa. Tanto più grave è il quadro gottoso e iperuricemico, tanto maggiore è la prevalenza e il rischio di mortalità generale e di mortalità cardiovascolare.
Se l’acido urico di per se comporti un qualche rischio è ancora dibattuto; si discute sul fatto che l’acido urico si possa depositare a livello dei fasci di His (interferendo quindi con la propagazione del segnale a livello cardiaco)o se ci siano altri meccanismi attraverso i quali l’acido urico interviene sullo stress ossidativo favorendolo.
I soggetti con gotta rispetto ai soggetti non gottosi hanno un rischio di scopmenso cardiaco molto più elevato.
Forse questo acido urico comporta anche un deficit per quel che riguarda il metabolismo energetico a livello cardiaco per cui la mia cellula diventa meno capace di attività contrattile.

TERAPIA
È bene ricordare quali sono gli alimenti particolarmente ricchi di purine:
- Animelle (sostanzialmente il timo dell’animale)- Molluschi- Acciughe- Pesce azzurro (è tanto decantato ma contiene quantità abbastanza importanti di purine)- Estratti di carne- Lievito- Sgombro- Salmone- Aragosta- E altri alimenti ancora..
Questi hanno un contenuto più alto di purine mentre gli alimenti a contenuto più basso dobbiamo andarli a ricercare nell’ambito dei vegetali.