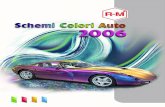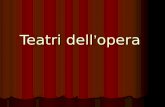Gl_ret-stil-met
-
Upload
antonio-rebelo -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of Gl_ret-stil-met

7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 18
GLOSSARIO RETORICO-STILISTICO METRICO
Figura retorica che consiste nel ricorrere per dimostrarelrsquoimpossibilitagrave di un evento alla descrizione di un altro acui lo si subordina ritenuto impossibile Es Virg Buc I59-63 Ante leves ergo pascentur in aequore cervi et fre-ta destituent nudos in litore piscis ante pererratis ambo-rum finibus exul aut Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrim quam nostro illius labatur pectorevoltus
Dal gr aoidoacutes Egrave il cantore omerico che celebra le gestadegli eroi accompagnandosi con la lira
Termine greco indicante laquocausa origineraquo La poesia etio-logica (aggettivo derivante da aacuteition) risale alle origini diriti cerimonie nomi di luoghi fornendone una spiegazio-ne fantastica Ad esempio lrsquoEacute cale di Callimaco che narradi come Teseo volle onorare la vecchia Eacutecale che lrsquoavevagenerosamente ospitato nel suo modesto casolare egrave unaacuteition percheacute tutta la narrazione serve a spiegarelrsquoorigine del culto di Zeus Ecaleacuteio I racconti eziologiciquasi sempre sono il frutto di unrsquoerudizione preziosa eraffinata e fioriscono soprattutto in etagrave ellenistica
Ripetizione dello stesso suono (di preferenza consonanti-co) allrsquoinizio di due o piugrave parole legate dal senso se egrave al-lrsquointerno di parola si preferisce definirla para-allitterazio-ne Es Plauto Miles 363 perire propera
Consiste nel cominciare un costrutto senza portarlo atermine (lasciandolo in tal modo in sospeso) per usarneun altro in tal modo si rompe la regolaritagrave sintattica delperiodo Lrsquoesempio piugrave frequente egrave il cambiamento delsoggetto Es Lucr II 342-347 Praeterea genus humanum
mutaeque natantes squamigerum pecudes et laeta ar-menta feraeque et variae volucres laetantia quae locaaquarum concelebrant circum ripas fontisque lacusque
Anacoluto
Allitterazione
Aacuteition
Aeacutedo
Adacute ynaton et quae pervolgant nemora avia pervolitantes quorumunum quidvis generatim sumere perge
Poesiole di varia etagrave e provenienza pubblicate nel 1554dallrsquoumanista Henri Estienne impropriamente attribuitead Anacreonte Si tratta di composizioni frivole sullequali i poeti del Seicento e Settecento europeo ricrearo-no liriche sdolcinate al pari del modello
Vedi Reduplicatio
Ripetizione di uno o piugrave elementi allrsquoinizio di frasi o versisuccessivi per conferire enfasi agli elementi stessi EsCic Cat I 8 nihil agis nihil moliris nihil cogitas
Accostamento che contrappone due elementi parole ofrasi o concetti o immagini di senso opposto Es SallBC 37 3 bonis invident malos extollunt vetera oderenova exoptant
Figura con la quale si sostituisce un nome proprio famo-so con altro comune che lo caratterizza per qualitagrave oproprietagrave universalmente note (es Liv Ab urbe conditain cui con urbs si indica Roma) o viceversa si indica conun nome proprio famoso persona o cosa che ne posseg-gono le caratteristiche (es Cic Pro Cael in cui con il no-me Medea Palatina si indica Clodia)
(laquoin comuneraquo) Si ha quando una stessa parola egrave per ilsenso comune a due espressioni vicine Es Or Carm I 55 s quotiens fidem mutatosque deos flebit in cui mutatossi riferisce oltre che a deos anche a fidem
Vedi ReticenzaAposiopeacutesi
Apograve koinuacute
Anacreontiche
Anadiplogravesi
Anafora
Antitesi
Antonomasia
E RELATIVO ALLA TERMINOLOGIA DEL GENERE LIRICO
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 28
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 332
Si dice di elemento a sorpresa inserito nel discorso alloscopo di provocare determinati effetti (comico satiricoecc) Es Catullo 13 3 s si tecum attuleris bonam atquemagnam cenam
Mancanza di congiunzioni coordinative nellrsquounione di pa-role o frasi Es Plauto Miles 69 orant ambiunt obsecrant
Figura che consiste nella somiglianza di suono fra parolediverse in particolare fra parole che presentano conso-nanti diverse e vocali uguali Es Virg Aen II 9 suadent-que cadentia hellip
La definizione di laquobucolicaraquo deriva dal termine greco perindicare i pastori bukoacuteloi e fu usata per la prima voltaper descrivere gli idilli (vedi Idillio) di Teocrito iniziatoredel genere della poesia pastorale
Oltre al distico elegiaco nei carmi di Catullo troviamousati il verso falecio il trimetro giambico puro il trimetrogiambico archilocheo e quello ipponatteo (detto anchezoppo o scazonte) il tetrametro giambico catalettico ilgalliambo il gliconeo e il ferecrateo il priapeolrsquoasclepiadeo maggiore e la strofe saffica minore Di que-sti riportiamo lo schema solo dei versi dei carmi riportatinella presente antologia
Falecio
983215 acute 983215 ˘ 983215 acute ˘˘ 983215 acute 983215 983215 acute 983215
Es Passer mortuus est | meae puellae passer deliciae | meae puellae
Trimetro giambico puro
˘ 983215 acute 983215 983215 983215 983215 983215 ˘
Catullo 4 1-2 Phaselus ı lle| quem videtis hospitesaıt fuısse | navium celerrimus
Trimetro giambico ipponat teo
983215 ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute 983215 ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute 983215 acute 983215 ˘
Catullo 8 1-2 Miser Catulle | desinas ineptı reet quod vides perı sse | perditum ducas
Strofe saffica minore(v schema nella metrica oraziana)Catullo 51 1-4 I lle mı par esse | deo videtur
ılle sı fas e st | superare dıvosquı sedens adversus | identidem te spectat et audit
Disposizione incrociata di quattro elementi collegati fraloro semanticamente o morfologicamente secondo laforma della lettera greca c (pr chi ) da cui prende il no-
Chiasmo
Catulliani (metri)
Bucolica (poesia)
Assonanza (o omofonia)
Asindeto
Aprosdoacuteketon (laquoinattesoraquo) me Es Cic Cat I 3 civem perniciosum acerbissimumhostem
La climax (laquoscalaraquo) consiste in una progressione che gra-datamente cresce di intensitagrave (climax ascendente) o de-cresce (climax discendente o anticlimax ) La laquoscalaraquo puograve
riguardare elementi di ritmo (lrsquoaccostamento ad esempiodi parole di lunghezza crescente) o di senso es SallBC 9 2 Iurgia discordias simultates cum hostibus exer-cebant Plauto Miles 69 orant ambiunt exobsecrant
Canto dedicato al dio Dioniso Da canto corale in onoredi Dioniso (soprattutto nella festa ateniese delle GrandiDionisie dove si svolgeva un importante agone ditiram-bico) divenne presto compatibile con altre divinitagrave(Apollo Atena) fino a laquolaicizzarsiraquo e a rappresentare ingenerale il laquocanto corale della cittagraveraquo
Termine dei grammatici latini per indicare le singolecomposizioni di cui constano le Bucoliche di Virgilio [vBucolica poesia]
(dal fr enjamber laquooltrepassare in campo altruiraquo) Si haenjambement quando la fine del verso non coincide conla fine di frase o di sintagma ma uno o piugrave elementi so-no nel verso seguente si ha cosigrave una laquodilatazioneraquo del-lrsquoimmagine o del pensiero espresso nel primo verso EsVirg Georg IV 140 s primus abundare et spumantia co- gere pressis mella favis
Lrsquoelegia (da eacutelegos laquolamento funebreraquo) era una composi-zione in distici elegiaci cioegrave formati da esametro e pen-tametro Il contenuto era vario anche se alcuni gramma-tici antichi attribuendo a eacutelegos il significato di laquocantofunebreraquo hanno sostenuto lrsquoorigine trenodica (da thre-nos laquocanto funebreraquo) Lrsquoelegia tratta di argomenti diver-si esortativi amorosi patriottici politici militari gnomi-ci In etagrave ellenistica si attenua lrsquoelemento personale perlasciare il posto allrsquoaspetto erudito e mitologico Nella let-teratura latina lrsquoelegia di imitazione alessandrina espri-
me contenuti legati alla passione drsquoamore al desideriodella pace e della vita semplice
Talora lrsquoesametro forma col pentametro una coppia dimetri (distico) detta distico elegiaco percheacute rappresentail metro tipico dellrsquoelegia
Omissione di uno o piugrave elementi della frase facilmente ri-cavabili dal contesto Es Sall BC 31 7 (dixit ) ea fami-lia ortum
Consiste nello scambio di funzioni grammaticali fra dueparti del discorso Es Or Carm I 37 7 regina dementis
Enagravellage
Ellissi
Elegiaco (distico)
Elegia
Enjambement
Egravegloga
Ditirambo
Climax (o gradatio )
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 38
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 333
ruinas in cui dementis (= dementes) concorda con rui-nas ma egrave riferito a regina
Canto in onore di uomini
Si ha unrsquoendiadi quando si esprime un unico concettoper mezzo di due termini coordinati fra loro Es Virg Aen IV 18 thalami taedaeque per indicare le nozze
Espressione sentenziosa che contiene una considerazionegenerale tratta dagli avvenimenti narrati Es Virg AenIV 412 Improbe Amor quid non mortalia pectora cogis
Ripetizione di una parola o di un gruppo di parole alla fi-ne di versi o frasi successivi Es Catullo 3 3 s passer mortuus est meae puellae Passer deliciae meae puel-lae
Da epigragravepho (laquoscrivo suraquo tombe oggetti) era in origineunrsquoiscrizione funebre o commemorativa Allrsquouso epigraficodeve il tratto distintivo della brevitagrave che conservograve anchequando assunse diversa funzione Ebbe fortuna durantelrsquoEllenismo quando servigrave a fissare in pochi versi scritti informa raffinata unrsquoemozione unrsquoimpressione una scenaquotidiana Oltre alla fulminea brevitagrave caratterizzalrsquoepigramma la ricerca di un finale ( pointe) arguto e inat-teso
Poema epico di piccola dimensione che narra le vicendeper lo piugrave di natura amorosa di un eroe o di unrsquoeroinadel mito Esemplare in tal senso fu lrsquoEacute cale di CallimacoNellrsquoepillio hanno rilievo i sentimenti umani comuni so-prattutto lrsquoamore Sono frequenti le descrizioni minuzio-se della quotidianitagrave seguite da digressioni erudite spes-so a carattere eziologico cioegrave volte a cercare le origini diusanze culti tradizioni Anche lrsquoEacute cale egrave un agraveition percheacutetutta la narrazione serve a spiegare lrsquoorigine del culto diZeus Ecalegraveio
Canto in onore del vincitore ai giochi sportivi
Canto in onore degli sposi eseguito davanti al talamocioegrave alla stanza nuziale
Gli epiteti sono espressioni per lo piugrave aggettivi attribuitiinnanzi tutto agli dei nella poesia epica e lirica Spessosono puramente esornativi (epiteto ornans) e servono acostituire una data unitagrave metrica ma talora corrispon-
dono a un preciso impiego cultuale Un porsquo diverso egrave ildiscorso dellrsquoepiteto omerico che si lega al discorso dellaformularitagrave (vedi p 334) e della poesia orale (vedi Glos-
Encomio
Epigraveteto
Epitalagravemio
Epinicio
Epillio
Epigramma
Epigravefora
Epifonema
Endigraveadi
sario del volume di laquoEpicaraquo) In tal caso lrsquoepiteto attri-buito a un eroe (Achille pieveloce) o a un evento(lrsquoaurora dalle rosee dita) egrave tratto da un repertorio di ele-menti laquomodulariraquo memorizzati dallrsquoaedo che gli consen-tiva di produrre su richiesta dellrsquouditorio una composizio-ne estemporanea
Dal gr epos laquoparola racconto canto poetico poemaraquoDesigna tanto il singolo poema epico quanto un insiemeo ciclo di poemi (ad esempio lrsquoepos omerico) Indica an-che il complesso delle leggende nazionali di una lettera-tura o di un popolo Lrsquoepica greca egrave rappresentata es-senzialmente dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea Il verso dellrsquoepicaegrave lrsquoesametro che si identifica con lrsquoepica al punto che gliepe (plur di epos) sono appunto gli esametri
Lrsquoesametro giagrave usato nella poesia greca da Omero egrave ilverso dellrsquoepica e per questo egrave detto anche verso eroico
Fu usato anche nella poesia didascalica in quella bucoli-ca e nella satiraEgrave costituito da sei piedi (in questo caso anche metri) dat-tilici di cui i primi quattro possono essere dattili o spon-dei il quinto egrave generalmente un dattilo il sesto unospondeo o un trocheoSchema
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ 983215 acute ˘ 983215
Espressione pronunciata con una certa enfasi ad indicarediversi stati drsquoanimo (sdegno ammirazione ecc) Nellalingua scritta segno di tale tono egrave il punto esclamativoEs Cic Cat I 2 O tempora o mores
Vedi Proemio
Associazione maschile consorteria politica gruppo diuomini (per lo piugrave aristocratici) legati da giuramento ecostituito sullrsquouguaglianza dello stile di vita sulla coinci-denza degli scopi politici sullrsquoomogeneitagrave culturale
Consiste nellrsquouso di una parola o di un gruppo di parole
che sostituisce altra parola o gruppo al fine di esprimerein modo meno crudo o comunque attenuare un con-cetto sgradevole
(laquosi concluderaquo) Termine usato per indicare lrsquoultima o leultime parole di un testo o di un verso il suo opposto egrave iltermine incipit (v) Ad es in Virg Aen II 293 Sacra suosque tibi commendat Troia Penates si dice che sacra ePenates sono rispettivamente in incipit e in explicit posi-zioni entrambe di forte rilievo
Si tratta dellrsquouso di due o piugrave parole che hanno la stessaradice Es Plauto Miles 309 facinus fecit 959 pulchram pulchritudinem
Figura etimologica
Explicit
Eufemismo
Epos
Esametro
Esclamazione
Esordio
Eteria
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 48
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 334
Vedi Agraveition
Consiste nellrsquoaffidare al gioco dei suoni lrsquoevocazione diun oggetto o di unrsquoazione Es Virg Buc I 55 saepe levi somnum suadebit inire susurro in cui il ripetersi della si-
bilante evoca il ronzio delle api
Tecnica artigianale di composizione poetica propria dellrsquoe-pica omerica e della lirica arcaica basata sullrsquoassemblaggiodi laquoformuleraquo Si tratta di espressioni stereotipate (adesempio lrsquoaggettivo standard come laquoAchille piegrave veloceraquo olaquolrsquoAurora dalle dita-di-rosaraquo) metricamente e sintattica-mente definite che ricorrono invariate in diversi punti del-la stessa opera o di opere diverse Lo scopo era di agevola-re la memorizzazione nellrsquoambito di una cultura orale
Ripetizione immediata di una parola o di in gruppo di pa-role Es Plauto Miles 313 Sceledre Sceledre
Egrave formato da tre metri giambici corrisponde quindi al tri-metro giambico nome greco di questo verso Il senariolatino a differenza del trimetro giambico greco ammet-te alcune sostituzioni del giambo quali il tribraco (˘˘ ˘)[sostituzione razionale] lo spondeo ( 983215983215 ) il dattilo ( 983215˘˘)lrsquoanapesto (˘˘ 983215 ) il proceleusmatico (˘˘˘˘) [sostituzioni ir-razionali]Schema
˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute
Ter Adelf 1 Postqua m poe ta se nsit scrı ptura m sua m
Altri versi sonobull il settenario giambico ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ndash ˘bull lrsquoottonario giambico ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash ˘bull il dimetro giambico acatalettico ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute
Egrave il metro di una forma di poesia diffusa nella IoniadrsquoAsia e insulare Egrave comunemente denominato laquotrimetrogiambicoraquo percheacute formato di tre laquometriraquo cioegrave di trecoppie di giambi Vedi giambico (senario) Lrsquoesecuzione
era affidata a un recitativo ( parakatalogheacute) con accom-pagnamento di aulo Caratterizza il giambo il gusto perla beffa lo scherno lrsquoinvettiva ma i contenuti sono vari(biografici didattici morali politici erotici)
Indica lrsquoespressione concisa di una veritagrave comunemente ac-cettata Le gnoacutemai piugrave famose erano quelle incise nel tem-pio di Delfi (ad esempio gnoacutethi sautoacuten laquoconosci te stessoraquo)
Vedi Climax
Parola che si trova attestata una volta sola o in un autoreo in unrsquoepoca o nellrsquointero sistema di una lingua
Eziologica (poesia)
Hapax (legoacutemenon)
Gradatio
Fonosimbolismo
Gnome
Giambo
Giambico (senario)
Geminatio
Formularitagrave
Inversione temporale di due avvenimenti cosigrave che si diceprima ciograve che logicamente dovrebbe essere detto dopoEs Virg Aen IV 6 s Postera Phoebea lustrabat lampadeterras umentemque Aurora polo dimoverat umbram
Dal gr eid yllion laquoquadrettoraquo definizione data in etagrave ro-mana alle composizioni di Teocrito che rappresentanoscene di vita rurale idealizzata
Canto eseguito nelle cerimonie nuziali
Termine usato per indicare la prima o le prime parole diun testo o di un verso il suo opposto egrave il termine explicit (vedi)
Canto di preghiera agli dei
Consiste nel porre una domanda in cui egrave implicita la ri-sposta stessa positiva o negativa Es Cic De leg I 14 42 si omnes Athenienses delectarentur tyrannicis legibusnum idcirco eae leges iustae haberentur
Secondo alcuni egrave un tipo di enallage quella piugrave frequen-te dellrsquoaggettivo secondo altri egrave da identificare conlrsquoenallage stessa Es Or Carm IV 7 19 manus avidas
heredis = manus avidi heredis
Consiste nel dividere gli elementi di uno stesso grupposintattico con lrsquoinserimento di altri cosigrave da porre in rilievole parti separate Es Or Epist I 8 1 Celso gaudere et bene rem gerere Albinovano
laquoEsagerazioneraquo nellrsquoesprimere un concetto oltre i limitidella verosimiglianza sia in piugrave che in meno Es Or SatI 9 10 s cum sudor ad imos manaret talos
Figura con la quale si dice il contrario di ciograve che si vuolefar intendere Es Virg Aen IV 379 s Scilicet is superislabor est ea cura quietos sollicitat
Vedi Lira
Sappiamo che oggi egrave impossibile leggere i versi latini co-me li leggevano gli antichi dato che noi non percepiamogli stessi elementi di ritmo che essi percepivano (quantitagraveecc) Per evitare tuttavia di perdere completamente il
senso del ritmo poetico leggendo la poesia come la pro-sa scegliamo di laquoutilizzare un ldquonostrordquo normale trattodistintivo (lrsquoaccento tonico) come sostitutivo consapevol-
Hysteron proteron
Lettura metrica (dei versi)
Kiacutetharis
Ironia
Iperbole
Ipegraverbato
Ipagravellage
Interrogazione retorica
Inno
Idillio
Imeneacuteo
Incipit (laquocominciaraquo)
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 58
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 335
mente assunto a puro valore simbolico di un tratto di-stintivo che il nostro sistema linguistico non possiederaquo(Milanese) Poniamo perciograve un apice ( acute ) sulle sillabe chefungono da laquoelementi-guidaraquo e le leggiamo con il nostrotipo di accento che egrave accento intensivo In tal modo use-remo in piena consapevolezza una lettura convenziona-le che laquoanche se non riproduce quella degli antichi con-
serva almeno in parte e ci permette di percepire i trattifondamentali dei ritmi originari trasponendoli in modulia noi accessibiliraquo (Scialuga)
La lira era lo strumento tipico dellrsquoaedo omerico Avevacorde verticali di uguale lunghezza ricavate da budello otendini di animali che venivano pizzicate con la mano si-nistra e percosse col pleacutektron il plettro appunto tenutonella mano destra Alla base un guscio di tartaruga euna struttura lignea fungevano da cassa di risonanzaOgni corda veniva accordata e produceva una sola notaLa phoacuterminx o kiacutetharis egrave una lira molto semplice dotata
forse di sole tre o cinque corde A Terpandro (VII secaC) si deve lrsquointroduzione di sette corde
Per gli antichi indica la poesia cantata con accompagna-mento della lira o altri strumenti a corda (kiacutetharis baacuterbi-ton phoacutermings ecc) Si distingueva dallrsquoelegia e dal giambo forme poetiche accompagnate da strumenti afiato come lrsquoaulo La lirica monodica consisteva in unlaquocanto a soloraquo la lirica corale era eseguita da un corodanzante o da un solista a cui rispondeva un coro
Consiste nellrsquoaffermare un concetto attraverso la nega-zione del suo contrario Es Lucr VI 1250 Nec poterat quisquam reperiri
Fu definita anticamente come laquoparagone abbreviatoraquo inquanto opera sulla base della similaritagrave individuando unelemento di intersezione fra due termini si opera cosigrave unospostamento da un significato proprio ad uno figurato EsPlauto Miles 987 Quae haec celox laquoqual egrave questa barcaveloceraquo dove con celox si indica lrsquoancella veloce comeuna nave leggera (lrsquoelemento di intersezione egrave dato dalla
velocitagrave comune sia allrsquoancella sia alla nave leggera)
Figura retorica che opera sulla base della contiguitagrave con-cettuale (spaziale causale temporale ecc) si sostituiscecioegrave un termine con un altro operando uno spostamentoda un campo semantico ad altro vicino Es Catullo 8 3 fulsere quondam candidi tibi soles dove soles sta per dies
Vedi Catulliani (metri)
Orazio usograve lrsquoesametro nelle Satire e nelle Epistole men-tre nelle Odi traspose i versi eolici della lirica greca Taleoperazione iniziata dai poetae novi fu condotta siste-
Metri oraziani
Metri catulliani
Metonimia
Metafora
Litote
Lirica
Lira
maticamente da Orazio che volle ricreare nella lirica lati-na i ritmi e lo spirito dei modelli greci Caratteristicheprincipali dei versi della lirica eolica erano lrsquoisosillabismo ela base libera Orazio adattandoli meglio alla sensibilitagraveritmica dei Romani apportograve qualche modificazione qua-li la sostituzione delle sillabe di quantitagrave variabile con sil-labe lunghe e lrsquointroduzione di cesure fisse
Riportiamo lo schema dei versi e delle strofe usati daOrazio nei carmi presenti nellrsquoantologia rinunciando aduna loro descrizione in base ai piedi usati date le diverseinterpretazioni a riguardo
Asclepiadei minori
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Or Carm III 30 E acute xegı monumentum aere perenniusregal ıque situ pyramidum altiusquod non ımber edax non aquilo ımpotens possit dıruere aut ınnumerabilis
Asclepiadei m aggiori
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Or Carm I 11 1-4Tu ne quaesierıs | scı re nefas | quem mihi quem tibi fı nem dı dederınt | Leuconoe | nec Babyloniostemptarıs numeros | U acute t melius | quıcquid erıt patiSeu plures hiemes | seu tribuıt | Iuppiter ultimam
Lrsquoasclepiadeo maggiore e lrsquoasclepiadeo minore si posso-no trovare come negli esempi riportati usati stichica-mente (in greco stı chos laquoversoraquo) vale a dire in serie op-pure variamente combinati nelle strofe asclepiadee (I IIIII IV V) con il gliconeo e il ferecrateo
Gliconeo
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Ferecrateo
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215
Egrave presente nellrsquoantologia la strofe asclepiadea III
Strofe asclepiadea III
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ 983215983215 acute ˘ 983215 ˘ asclepiadeo minore 983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘ asclepiadeo minore
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ferecrateo
macr 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘ gliconeo
Or Carm III 13 1-4O fons Bandusiae | splendidior vitrodulci dıgne mero | non sine floribuscras donaberis haedocuı frons turgida cornibus
Lrsquoelemento ritmico del verso latino egrave costituito dal ripe-
tersi regolare di successioni di sillabe brevi e sillabe lun-ghe Quando queste successioni obbediscono a schemiprecisi fornendo determinate figure metriche si hanno
Metrica
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 68
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 336
delle cellule ritmiche elementari dette tradizionalmentepiediI piedi principali sono i seguentitrocheo
983215 tribraco
˘ ˘ ˘giambo
˘ 983215 spondeo
983215 983215dattilo 983215 ˘anapesto
˘ ˘ 983215 proceleusmatico
˘ ˘ ˘ ˘cretico
983215 983215 coriambo
983215 ˘ 983215
Significa laquoimitazioneraquo e designa il modo drsquointendere lapoesia e lrsquoarte degli autori antichi Per Simonide (VI-Vsec aC) la poesia egrave una laquoimmagine della cosaraquo unrsquoimi-tazione anche di emozioni e stati drsquoanimo Ogni formadrsquoarte sia essa poetica pittorica musicale o coreutica egravesentita dai greci come imitazione e gli artisti sono tutti
considerati laquoimitatoriraquo da Platone (Rep 373b)
laquoI miti sono narrazioni tramandate dalla tradizione percheacutecontengono valori importanti per la comunitagrave o percheacute co-stituiscono racconti di particolare rilevanza narrativaraquo(Howatson) Se si riferiscono a personaggi reali che hannooperato in luoghi reali e riportano gli eventi in forma ab-bastanza realistica (ad esempio le vicende dei sette re diRoma) si possono definire leggende I contenuti del mitosono vari e possono riguardare lrsquoorgine del mondo e dellaTerra le forme del culto le istituzioni degli uomini Hannocarattere laquoapertoraquo nel senso che si prestano a essere nar-rati secondo varie versioni e ad accogliere mille inserimentie variazioni Costituiscono lrsquoantefatto della storiografia (apartire dalle genealogie mitiche di dei e eroi) ma anchedella scienza e della filosofia (a partire dai grandi miti co-smologici) Le maggiori fonti mitiche sono per noi OmeroEsiodo ma anche i poeti ellenistici come Callimaco per iquali il mito per lo piugrave ripreso in una variante poco notadiviene un ornamento prezioso della narrazione LeMetamorfosi di Ovidio furono il maggiore veicolo di tra-smissione del patrimonio mitico antico nei secoliCome sostiene lrsquoantropologo Altan lrsquoesperienza mitica egravefondamentale per le popolazioni antiche e preletterate
immuni dagli effetti indotti nei ceti colti dal razionali-smo greco e presso le quali le operazioni canoniche delpensiero definito razionale (classificazione numerazio-ne spazialitagrave temporalitagrave causalitagrave) assumono conno-tati diversi da quelli assunti nella tradizione occidentaleLrsquoaffermazione del pensiero razionale ha comportatoche il mito divenisse sinonimo di menzogna Il terminem acute ythos originariamente non antitetico rispetto a logos(con cui poteva coesistere nel composto mythologialaquocomplesso di raccontiraquo) in seguito agli sviluppi della fi-losofia greca diviene lrsquoopposto del logos o discorso ra-zionale e il mito egrave confinato nella sfera della pre-razio-nalitagrave anzi dellrsquoirrazionalitagrave considerato antitetico alla
scienza retaggio di tempi oscuri dominati dalla paura edalla superstizione In realtagrave secondo le vedute piugrave re-centi il mito era la forma del sapere collettivo dei popo-
Mito
Migravemesi
li prestorici Nel loro orizzonte culturale laquoil patrimonio disapere collettivo economico tecnologico politico so-ciale e religioso in cui si articola la cultura si manifestaglobalmente come mitologia nella quale sono ancorafra loro indistinte quelle forme che storicamente assu-meranno un significato autonomo nelle diverse specia-lizzazioni disciplinari proprie della cultura in senso mo-
derno occidentaleraquo (Altan)
Studio dei miti ma anche complesso dei miti di una cer-ta cultura o epoca
Figlie di Zeus e Mnemogravesine la dea della memoria Nei poe-mi omerici dove allietano i banchetti degli dei sono in unnumero imprecisato che perograve giagrave alla fine dellrsquoOdissea(XXIV 60) si precisa in nove numero che con la Teogonia diEsiodo diviene definitivo Esiodo ne elenca anche i nomi eassegna loro la funzione che saragrave canonica di ispirare i
poeti nella composizione di un poema Le specifiche funzio-ni delle Muse si preciseranno solo in etagrave ellenistica Calligraveopesaragrave preposta allrsquoepica Clio alla storia Melpogravemene allapoesia tragica Eutegraverpe alla musica col flauto Egraverato allapoesia lirica Tersigravecore alla lirica corale e alla danza Uragraveniaallrsquoastronomia Taligravea alla commedia Poligravemnia alla pantomi-ma Le sedi di culto delle Muse piugrave famose furono la Piegraveriaai piedi dellrsquoOlimpo e Ascra in Beozia
Nella poesia greca arcaica la mousikeacute egrave la poesia intesacome connubio di parole e musica La musica era parteintegrante della vita sociale greca Quasi ogni forma poe-tica era accompagnata dalla musica La rilevanza eticadella musica era sostenuta da Platone convinto che lamusica influenzasse in modo permanente il carattere e leattitudini dellrsquouomo e da Aristotele
Da odeacute laquocantoraquo Composizione lirica di forma metrica estrofica varia A Roma si usograve il termine carmen
Egrave un tipo di omoteleuto che si ha quando piugrave parole hannola stessa terminazione derivante da uguali forme di flessione
Ripetizione dello stesso suono alla fine di piugrave parole vici-ne della stessa frase Es Virg Buc IV 50 s Aspice con-vexo nutantem pondere mundum terrasque tractusquemaris caelumque profundum dove i due versi terminanocon lo stesso suono
Formazione di un vocabolo il cui suono imita un rumorenaturale Es Plauto Miles 311 mussitabo il verbo mussitolaquoborbottareraquo riprende il suono mu del borbottio delparlare sommessamente
Vedi Metri orazianiOraziani (metri)
Onomatopea
Omoteleuto
Omeoptoto
Ode
Musica
Muse
Mitologia
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 78
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 337
Accostamento di parole di senso opposto Es Or Ep I11 28 strenua inertia
Festivitagrave pubblica a sfondo religioso durante la quale sisvolgevano gare poetiche e musicali
Letteralmente laquoscherziraquo Poesie di carattere privato edisimpegnato di mero intrattenimento tipiche della cultu-ra ellenistica A Roma scrissero paacuteignia (latinamente nu- gae) soprattutto i poeti del circolo neoterico ( poetae novi )
Vedi Lira
Si ha quando gli elementi di due o piugrave frasi sono dispostinello stesso ordine cosigrave da corrispondersi simmetrica-mente Es Sall BC 5 4 cuius lubet rei simulator ac dis- simulator alieni adpetens sui profusus
Consiste nellrsquoaccostare due parole di suono simile ma disignificato diverso Es Catullo 3 13 At vobis male sitmalae tenebrae
Canto intonato da un coro di fanciulle
Termine della retorica greca indicante il carattere dipassionalitagrave e drammaticitagrave proprio dellrsquoepica e dellatragedia Secondo N Frye il pathos egrave la lotta mortaledellrsquoeroe
Canto dedicato ad Apollo
Il pentametro egrave un verso mai usato da solo formato dal-lrsquounione di due metagrave versi (emistichi ) separate da una pau-sa fissa una dieresi ciascuna delle quali egrave composta di duedattili e mezzo Sono quindi sei piedi dattilici catalettici in
syllabam che terminano cioegrave con una sola sillaba Nellaprima metagrave al posto dei dattili si possono trovare deglispondei nella seconda non sono possibili sostituzioniSchema
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute 983215 acute ˘˘ 983215 acute ˘˘ 983215 ˘
Catullo 85Odi et amo | Quare id faciam | fortasse requiris Nescio sed fieri | sentio et excrucior
Termine inglese impiegato di frequente per indicare laprestazione artistica del poeta lirico o epico
Si ha quando per evitare di designare una persona o didire una cosa direttamente si usa un giro di parole
Ossimoro
Perifrasi
Performance
Pentametro
Peana
Pathos
Partenio
Paronomasia
Parallelismo
Phoacuterminx
Paacuteignia
Paneg yris
Egrave il personaggio che nella lirica si esprime in prima perso-na Non necessariamente coincide con lrsquoio dellrsquoautore
Da poikiacutello laquorendo varioraquo Egrave la capacitagrave del poeta di va-riare a tempo debito in rapporto allrsquooccasione toni temi
strutture metriche del canto soddisfacendo alle attese dichi ascolta
Egrave la laquopuntaraquo cioegrave il finale arguto e inatteso soprattuttodellrsquoepigramma ( fulmen in clausula)
Ripetizione di una stessa parola espressa a breve distanzain piugrave casi grammaticali Es Catullo 2 2 s quicum lude-re quem in sinu tenere cui
Si ha quando piugrave elementi di una frase o piugrave frasi sonouniti da piugrave congiunzioni Es Sall BC 3 1 et qui fecereet qui scripsere
Figura con la quale si dice sia pure brevemente una cosache al contempo si dichiara di non voler dire Es Cic CatI 3 Nam illa nimis antiqua praetereo quod C Servilius
Termine della filologia tedesca (dal lat praeambulum) Egraveuno schema retorico consistente nella rassegna degli al-
trui generi di vita cui egrave contrapposto il proprio del qualesi rivendica la superiore validitagrave Cosigrave ad esempio Saffocontrapponendosi allrsquoopinione dominante sostiene chela cosa piugrave bella non sono le flotte e gli eserciti malaquoquello che ognuno amaraquo
Tipo di esordio tipico del poema epico Il proemio poeticosecondo alcuni autori sembra sovrapponibile allrsquoexordiumdei genera dicendi Questo oltre al compito ovvio di ini-ziare (exordium est principium orationis Rhet Her 1 34) ha il compito di disporre favorevolmente lrsquouditorio neiconfronti dellrsquooratore e dellrsquoargomento ( per quod [= exor-
dium] animus auditoris constituitur ad audiendum)
Figura mediante la quale si fa parlare come se fosse pre-sente un personaggio lontano o defunto o la personifica-zione di cosa inanimata o astratta Es Cic Pro Caelio laprosopopea di Appio Claudio Cieco Cic Cat I 17-18 e27-29 la prosopopea della patria
Proemio dei poemi classici comprendente la presentazio-ne dellrsquoargomento lrsquoinvocazione alla Musa eventual-mente la dedica
Egrave il poeta epico o lirico inteso come laquocucitore di cantiraquo
Persona loquens
Rapsogravedo (rhapsodoacutes)
Protasi
Prosopopea
Proemio
Priagravemel
Preterizione
Polisindeto
Poliptoto
Pointe
Poikiliacutea
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 88
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 338
Ripetizione di una o piugrave parole conclusive della frase pre-cedente in quella seguente Es Cic Cat I 1 vivitVivit
Ripetizione di una sequenza tra un periodo e lrsquoaltro di
una composizione ritornello Egrave un procedimento checonferisce unitagrave psicologica e tematica al testo poetico omusicale
Si ha rejet quando una parola si trova isolata allrsquoinizio diun verso pur facendo parte per il senso del verso prece-dente Es Virg Georg I 463 sol tibi signa dabit Solemquis dicere falsum audeat
Si ha quando si interrompe allrsquoimprovviso la frase la-sciandone tuttavia intendere il senso
Termine tedesco indicante la struttura laquoad anelloraquo dellacomposizione cioegrave basata sul ritorno alla fine di ele-menti che figuravano in principio
Canto eseguito durante un banchetto dai convitati chenel canto si cedono la parola in ordine laquoobliquoraquo dondeil nome
Vedi Giambico (senario)
Paragone fra due immagini introdotto da espressioni co-me ut ita talis qualis ceu ecc Es Virg Georg IV499 Dixit et ex oculis subito ceu fumus in auras com-mixtus tenuis fugit
Egrave quel genere di riunione maschile che in Grecia seguivail pasto serale ed era dedicata al bere al progetto politi-co e militare allrsquoeros allrsquoascolto della poesia e piugrave tardianche al discorso filosofico A simposio si riunivano grup-
pi legati da giuramento (eteriacutee) e costituiti sullrsquouguaglian-za dello stile di vita sulla coincidenza degli scopi politicisullrsquoomogeneitagrave culturale
Particolare tipo di metonimia anche con la sineddocheinfatti si ha la trasposizione da un significato proprio adaltro figurato in particolare in un rapporto di quantitagrave(parte per il tutto singolare per plurale ecc) Es Virg Aen II 276 vel Danaum Phrygios iaculatus puppibusignis dove puppes indica le navi
Consiste nellrsquoassociare piugrave termini appartenenti a perce-zioni sensoriali diverse (visive uditive tattili olfattive gu-stative) in unrsquounica espressione
Reduplicatio
Sinestesia
Sineddoche
Simposio (sympoacutesion )
Similitudine
Senario giambico
Scolio
Ringkomposition
Reticenza
Rejet
Refrain
Il Lord ha definito i laquotemiraquo della poesia orale comelaquogruppi di idee regolarmente usate nel raccontare unastoria nello stile formulaico del canto tradizionaleraquoNellrsquoOdissea le numerose descrizioni stereotipiche del-lrsquoaccoglienza ospitale offerta a un visitatore costituisconoun laquotemaraquo orale Nella narrativa germanica le descrizio-
ni in cui la schiera dei nobili si riunisce intorno al re abanchettare a bere e a vantarsi delle proprie gesta co-stituisce analogamente un laquotemaraquo di quella tradizione(R Scholes - R Kellogg)
Comunitagrave paideutico-cultuale femminile in parte simileallrsquoeterigravea maschile con finalitagrave educativa Qui le fanciulledi nobile famiglia compivano la loro educazione nellamusica nel canto nella danza nellrsquoarte di ornarsi e ve-stirsi in modo conforme al loro rango Era un ideale diperfezione da conseguire anche attraverso pratiche litur-giche incentrate sul culto di Afrodite
Si ha quando una parola composta viene separata neisuoi elementi attraverso lrsquointerposizione di altri elementiEs Virg Georg III 381 Hyperboreo septem subiecta trio-ni dove septemtrioni egrave separato in septem e trioni attra-verso lrsquointerposizione di subiecta
Canto funebre
Nella retorica classica i koinoacutei topoi (loci communes) eranoargomenti adatti ad essere sviluppati al servizio drsquouna tesiin vari generi di discorso Il loro assieme costituiva a dettadi Quintiliano la argomentorum sedes La memoria era in-fatti concepita come uno spazio nei cui luoghi (topoi loci )si situano le idee a questi luoghi ricorre lrsquooratore quandocerca argomenti adatti alle situazioni e alle parti del discor-so Nel Medioevo ndash estintisi il discorso politico e quello giu-diziario ndash la retorica estende lrsquouso dei topoi a tutti i tipi ditesto essi divengono dei clicheacutes di generale utilizzabilitagraveletteraria e si estendono a tutti i settori della vita che pos-sono essere abbracciati e modellati dalla letteratura Cosigravela retorica costituisce un magazzino vi si trovano le idee di
carattere piugrave generale tali da poter essere usate in tutti idiscorsi e gli scritti P Zumthor insiste sul carattere compo-sito dei topoi laquomateriali di reimpiego (come si potrebberodire per analogia le opere dellrsquoarchitettura romana) risul-tato di qualche bricolage arcaico i cui prodotti si sono apoco a poco arricchiti e affinati nello stesso tempo in cui siconsolidavanoraquo
Consiste nel collegare due o piugrave termini con un elementoche egrave appropriato per uno solo la forma di zeugma piugravefrequente fa dipendere da un unico verbo piugrave oggettiche richiederebbero ciascuno un verbo specifico Es Or
Carm I 1 19-21 Est qui nec veteris pocula Massici nec partem solido demere de die spernit dove spernit ha peroggetto sia pocula sia lrsquoinfinito demere
Tema
Zegraveugma
Topos
Treno
Tmesi
Tigraveaso

7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 28
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 332
Si dice di elemento a sorpresa inserito nel discorso alloscopo di provocare determinati effetti (comico satiricoecc) Es Catullo 13 3 s si tecum attuleris bonam atquemagnam cenam
Mancanza di congiunzioni coordinative nellrsquounione di pa-role o frasi Es Plauto Miles 69 orant ambiunt obsecrant
Figura che consiste nella somiglianza di suono fra parolediverse in particolare fra parole che presentano conso-nanti diverse e vocali uguali Es Virg Aen II 9 suadent-que cadentia hellip
La definizione di laquobucolicaraquo deriva dal termine greco perindicare i pastori bukoacuteloi e fu usata per la prima voltaper descrivere gli idilli (vedi Idillio) di Teocrito iniziatoredel genere della poesia pastorale
Oltre al distico elegiaco nei carmi di Catullo troviamousati il verso falecio il trimetro giambico puro il trimetrogiambico archilocheo e quello ipponatteo (detto anchezoppo o scazonte) il tetrametro giambico catalettico ilgalliambo il gliconeo e il ferecrateo il priapeolrsquoasclepiadeo maggiore e la strofe saffica minore Di que-sti riportiamo lo schema solo dei versi dei carmi riportatinella presente antologia
Falecio
983215 acute 983215 ˘ 983215 acute ˘˘ 983215 acute 983215 983215 acute 983215
Es Passer mortuus est | meae puellae passer deliciae | meae puellae
Trimetro giambico puro
˘ 983215 acute 983215 983215 983215 983215 983215 ˘
Catullo 4 1-2 Phaselus ı lle| quem videtis hospitesaıt fuısse | navium celerrimus
Trimetro giambico ipponat teo
983215 ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute 983215 ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute 983215 acute 983215 ˘
Catullo 8 1-2 Miser Catulle | desinas ineptı reet quod vides perı sse | perditum ducas
Strofe saffica minore(v schema nella metrica oraziana)Catullo 51 1-4 I lle mı par esse | deo videtur
ılle sı fas e st | superare dıvosquı sedens adversus | identidem te spectat et audit
Disposizione incrociata di quattro elementi collegati fraloro semanticamente o morfologicamente secondo laforma della lettera greca c (pr chi ) da cui prende il no-
Chiasmo
Catulliani (metri)
Bucolica (poesia)
Assonanza (o omofonia)
Asindeto
Aprosdoacuteketon (laquoinattesoraquo) me Es Cic Cat I 3 civem perniciosum acerbissimumhostem
La climax (laquoscalaraquo) consiste in una progressione che gra-datamente cresce di intensitagrave (climax ascendente) o de-cresce (climax discendente o anticlimax ) La laquoscalaraquo puograve
riguardare elementi di ritmo (lrsquoaccostamento ad esempiodi parole di lunghezza crescente) o di senso es SallBC 9 2 Iurgia discordias simultates cum hostibus exer-cebant Plauto Miles 69 orant ambiunt exobsecrant
Canto dedicato al dio Dioniso Da canto corale in onoredi Dioniso (soprattutto nella festa ateniese delle GrandiDionisie dove si svolgeva un importante agone ditiram-bico) divenne presto compatibile con altre divinitagrave(Apollo Atena) fino a laquolaicizzarsiraquo e a rappresentare ingenerale il laquocanto corale della cittagraveraquo
Termine dei grammatici latini per indicare le singolecomposizioni di cui constano le Bucoliche di Virgilio [vBucolica poesia]
(dal fr enjamber laquooltrepassare in campo altruiraquo) Si haenjambement quando la fine del verso non coincide conla fine di frase o di sintagma ma uno o piugrave elementi so-no nel verso seguente si ha cosigrave una laquodilatazioneraquo del-lrsquoimmagine o del pensiero espresso nel primo verso EsVirg Georg IV 140 s primus abundare et spumantia co- gere pressis mella favis
Lrsquoelegia (da eacutelegos laquolamento funebreraquo) era una composi-zione in distici elegiaci cioegrave formati da esametro e pen-tametro Il contenuto era vario anche se alcuni gramma-tici antichi attribuendo a eacutelegos il significato di laquocantofunebreraquo hanno sostenuto lrsquoorigine trenodica (da thre-nos laquocanto funebreraquo) Lrsquoelegia tratta di argomenti diver-si esortativi amorosi patriottici politici militari gnomi-ci In etagrave ellenistica si attenua lrsquoelemento personale perlasciare il posto allrsquoaspetto erudito e mitologico Nella let-teratura latina lrsquoelegia di imitazione alessandrina espri-
me contenuti legati alla passione drsquoamore al desideriodella pace e della vita semplice
Talora lrsquoesametro forma col pentametro una coppia dimetri (distico) detta distico elegiaco percheacute rappresentail metro tipico dellrsquoelegia
Omissione di uno o piugrave elementi della frase facilmente ri-cavabili dal contesto Es Sall BC 31 7 (dixit ) ea fami-lia ortum
Consiste nello scambio di funzioni grammaticali fra dueparti del discorso Es Or Carm I 37 7 regina dementis
Enagravellage
Ellissi
Elegiaco (distico)
Elegia
Enjambement
Egravegloga
Ditirambo
Climax (o gradatio )
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 38
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 333
ruinas in cui dementis (= dementes) concorda con rui-nas ma egrave riferito a regina
Canto in onore di uomini
Si ha unrsquoendiadi quando si esprime un unico concettoper mezzo di due termini coordinati fra loro Es Virg Aen IV 18 thalami taedaeque per indicare le nozze
Espressione sentenziosa che contiene una considerazionegenerale tratta dagli avvenimenti narrati Es Virg AenIV 412 Improbe Amor quid non mortalia pectora cogis
Ripetizione di una parola o di un gruppo di parole alla fi-ne di versi o frasi successivi Es Catullo 3 3 s passer mortuus est meae puellae Passer deliciae meae puel-lae
Da epigragravepho (laquoscrivo suraquo tombe oggetti) era in origineunrsquoiscrizione funebre o commemorativa Allrsquouso epigraficodeve il tratto distintivo della brevitagrave che conservograve anchequando assunse diversa funzione Ebbe fortuna durantelrsquoEllenismo quando servigrave a fissare in pochi versi scritti informa raffinata unrsquoemozione unrsquoimpressione una scenaquotidiana Oltre alla fulminea brevitagrave caratterizzalrsquoepigramma la ricerca di un finale ( pointe) arguto e inat-teso
Poema epico di piccola dimensione che narra le vicendeper lo piugrave di natura amorosa di un eroe o di unrsquoeroinadel mito Esemplare in tal senso fu lrsquoEacute cale di CallimacoNellrsquoepillio hanno rilievo i sentimenti umani comuni so-prattutto lrsquoamore Sono frequenti le descrizioni minuzio-se della quotidianitagrave seguite da digressioni erudite spes-so a carattere eziologico cioegrave volte a cercare le origini diusanze culti tradizioni Anche lrsquoEacute cale egrave un agraveition percheacutetutta la narrazione serve a spiegare lrsquoorigine del culto diZeus Ecalegraveio
Canto in onore del vincitore ai giochi sportivi
Canto in onore degli sposi eseguito davanti al talamocioegrave alla stanza nuziale
Gli epiteti sono espressioni per lo piugrave aggettivi attribuitiinnanzi tutto agli dei nella poesia epica e lirica Spessosono puramente esornativi (epiteto ornans) e servono acostituire una data unitagrave metrica ma talora corrispon-
dono a un preciso impiego cultuale Un porsquo diverso egrave ildiscorso dellrsquoepiteto omerico che si lega al discorso dellaformularitagrave (vedi p 334) e della poesia orale (vedi Glos-
Encomio
Epigraveteto
Epitalagravemio
Epinicio
Epillio
Epigramma
Epigravefora
Epifonema
Endigraveadi
sario del volume di laquoEpicaraquo) In tal caso lrsquoepiteto attri-buito a un eroe (Achille pieveloce) o a un evento(lrsquoaurora dalle rosee dita) egrave tratto da un repertorio di ele-menti laquomodulariraquo memorizzati dallrsquoaedo che gli consen-tiva di produrre su richiesta dellrsquouditorio una composizio-ne estemporanea
Dal gr epos laquoparola racconto canto poetico poemaraquoDesigna tanto il singolo poema epico quanto un insiemeo ciclo di poemi (ad esempio lrsquoepos omerico) Indica an-che il complesso delle leggende nazionali di una lettera-tura o di un popolo Lrsquoepica greca egrave rappresentata es-senzialmente dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea Il verso dellrsquoepicaegrave lrsquoesametro che si identifica con lrsquoepica al punto che gliepe (plur di epos) sono appunto gli esametri
Lrsquoesametro giagrave usato nella poesia greca da Omero egrave ilverso dellrsquoepica e per questo egrave detto anche verso eroico
Fu usato anche nella poesia didascalica in quella bucoli-ca e nella satiraEgrave costituito da sei piedi (in questo caso anche metri) dat-tilici di cui i primi quattro possono essere dattili o spon-dei il quinto egrave generalmente un dattilo il sesto unospondeo o un trocheoSchema
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ 983215 acute ˘ 983215
Espressione pronunciata con una certa enfasi ad indicarediversi stati drsquoanimo (sdegno ammirazione ecc) Nellalingua scritta segno di tale tono egrave il punto esclamativoEs Cic Cat I 2 O tempora o mores
Vedi Proemio
Associazione maschile consorteria politica gruppo diuomini (per lo piugrave aristocratici) legati da giuramento ecostituito sullrsquouguaglianza dello stile di vita sulla coinci-denza degli scopi politici sullrsquoomogeneitagrave culturale
Consiste nellrsquouso di una parola o di un gruppo di parole
che sostituisce altra parola o gruppo al fine di esprimerein modo meno crudo o comunque attenuare un con-cetto sgradevole
(laquosi concluderaquo) Termine usato per indicare lrsquoultima o leultime parole di un testo o di un verso il suo opposto egrave iltermine incipit (v) Ad es in Virg Aen II 293 Sacra suosque tibi commendat Troia Penates si dice che sacra ePenates sono rispettivamente in incipit e in explicit posi-zioni entrambe di forte rilievo
Si tratta dellrsquouso di due o piugrave parole che hanno la stessaradice Es Plauto Miles 309 facinus fecit 959 pulchram pulchritudinem
Figura etimologica
Explicit
Eufemismo
Epos
Esametro
Esclamazione
Esordio
Eteria
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 48
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 334
Vedi Agraveition
Consiste nellrsquoaffidare al gioco dei suoni lrsquoevocazione diun oggetto o di unrsquoazione Es Virg Buc I 55 saepe levi somnum suadebit inire susurro in cui il ripetersi della si-
bilante evoca il ronzio delle api
Tecnica artigianale di composizione poetica propria dellrsquoe-pica omerica e della lirica arcaica basata sullrsquoassemblaggiodi laquoformuleraquo Si tratta di espressioni stereotipate (adesempio lrsquoaggettivo standard come laquoAchille piegrave veloceraquo olaquolrsquoAurora dalle dita-di-rosaraquo) metricamente e sintattica-mente definite che ricorrono invariate in diversi punti del-la stessa opera o di opere diverse Lo scopo era di agevola-re la memorizzazione nellrsquoambito di una cultura orale
Ripetizione immediata di una parola o di in gruppo di pa-role Es Plauto Miles 313 Sceledre Sceledre
Egrave formato da tre metri giambici corrisponde quindi al tri-metro giambico nome greco di questo verso Il senariolatino a differenza del trimetro giambico greco ammet-te alcune sostituzioni del giambo quali il tribraco (˘˘ ˘)[sostituzione razionale] lo spondeo ( 983215983215 ) il dattilo ( 983215˘˘)lrsquoanapesto (˘˘ 983215 ) il proceleusmatico (˘˘˘˘) [sostituzioni ir-razionali]Schema
˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute
Ter Adelf 1 Postqua m poe ta se nsit scrı ptura m sua m
Altri versi sonobull il settenario giambico ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ndash ˘bull lrsquoottonario giambico ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash ˘bull il dimetro giambico acatalettico ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute
Egrave il metro di una forma di poesia diffusa nella IoniadrsquoAsia e insulare Egrave comunemente denominato laquotrimetrogiambicoraquo percheacute formato di tre laquometriraquo cioegrave di trecoppie di giambi Vedi giambico (senario) Lrsquoesecuzione
era affidata a un recitativo ( parakatalogheacute) con accom-pagnamento di aulo Caratterizza il giambo il gusto perla beffa lo scherno lrsquoinvettiva ma i contenuti sono vari(biografici didattici morali politici erotici)
Indica lrsquoespressione concisa di una veritagrave comunemente ac-cettata Le gnoacutemai piugrave famose erano quelle incise nel tem-pio di Delfi (ad esempio gnoacutethi sautoacuten laquoconosci te stessoraquo)
Vedi Climax
Parola che si trova attestata una volta sola o in un autoreo in unrsquoepoca o nellrsquointero sistema di una lingua
Eziologica (poesia)
Hapax (legoacutemenon)
Gradatio
Fonosimbolismo
Gnome
Giambo
Giambico (senario)
Geminatio
Formularitagrave
Inversione temporale di due avvenimenti cosigrave che si diceprima ciograve che logicamente dovrebbe essere detto dopoEs Virg Aen IV 6 s Postera Phoebea lustrabat lampadeterras umentemque Aurora polo dimoverat umbram
Dal gr eid yllion laquoquadrettoraquo definizione data in etagrave ro-mana alle composizioni di Teocrito che rappresentanoscene di vita rurale idealizzata
Canto eseguito nelle cerimonie nuziali
Termine usato per indicare la prima o le prime parole diun testo o di un verso il suo opposto egrave il termine explicit (vedi)
Canto di preghiera agli dei
Consiste nel porre una domanda in cui egrave implicita la ri-sposta stessa positiva o negativa Es Cic De leg I 14 42 si omnes Athenienses delectarentur tyrannicis legibusnum idcirco eae leges iustae haberentur
Secondo alcuni egrave un tipo di enallage quella piugrave frequen-te dellrsquoaggettivo secondo altri egrave da identificare conlrsquoenallage stessa Es Or Carm IV 7 19 manus avidas
heredis = manus avidi heredis
Consiste nel dividere gli elementi di uno stesso grupposintattico con lrsquoinserimento di altri cosigrave da porre in rilievole parti separate Es Or Epist I 8 1 Celso gaudere et bene rem gerere Albinovano
laquoEsagerazioneraquo nellrsquoesprimere un concetto oltre i limitidella verosimiglianza sia in piugrave che in meno Es Or SatI 9 10 s cum sudor ad imos manaret talos
Figura con la quale si dice il contrario di ciograve che si vuolefar intendere Es Virg Aen IV 379 s Scilicet is superislabor est ea cura quietos sollicitat
Vedi Lira
Sappiamo che oggi egrave impossibile leggere i versi latini co-me li leggevano gli antichi dato che noi non percepiamogli stessi elementi di ritmo che essi percepivano (quantitagraveecc) Per evitare tuttavia di perdere completamente il
senso del ritmo poetico leggendo la poesia come la pro-sa scegliamo di laquoutilizzare un ldquonostrordquo normale trattodistintivo (lrsquoaccento tonico) come sostitutivo consapevol-
Hysteron proteron
Lettura metrica (dei versi)
Kiacutetharis
Ironia
Iperbole
Ipegraverbato
Ipagravellage
Interrogazione retorica
Inno
Idillio
Imeneacuteo
Incipit (laquocominciaraquo)
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 58
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 335
mente assunto a puro valore simbolico di un tratto di-stintivo che il nostro sistema linguistico non possiederaquo(Milanese) Poniamo perciograve un apice ( acute ) sulle sillabe chefungono da laquoelementi-guidaraquo e le leggiamo con il nostrotipo di accento che egrave accento intensivo In tal modo use-remo in piena consapevolezza una lettura convenziona-le che laquoanche se non riproduce quella degli antichi con-
serva almeno in parte e ci permette di percepire i trattifondamentali dei ritmi originari trasponendoli in modulia noi accessibiliraquo (Scialuga)
La lira era lo strumento tipico dellrsquoaedo omerico Avevacorde verticali di uguale lunghezza ricavate da budello otendini di animali che venivano pizzicate con la mano si-nistra e percosse col pleacutektron il plettro appunto tenutonella mano destra Alla base un guscio di tartaruga euna struttura lignea fungevano da cassa di risonanzaOgni corda veniva accordata e produceva una sola notaLa phoacuterminx o kiacutetharis egrave una lira molto semplice dotata
forse di sole tre o cinque corde A Terpandro (VII secaC) si deve lrsquointroduzione di sette corde
Per gli antichi indica la poesia cantata con accompagna-mento della lira o altri strumenti a corda (kiacutetharis baacuterbi-ton phoacutermings ecc) Si distingueva dallrsquoelegia e dal giambo forme poetiche accompagnate da strumenti afiato come lrsquoaulo La lirica monodica consisteva in unlaquocanto a soloraquo la lirica corale era eseguita da un corodanzante o da un solista a cui rispondeva un coro
Consiste nellrsquoaffermare un concetto attraverso la nega-zione del suo contrario Es Lucr VI 1250 Nec poterat quisquam reperiri
Fu definita anticamente come laquoparagone abbreviatoraquo inquanto opera sulla base della similaritagrave individuando unelemento di intersezione fra due termini si opera cosigrave unospostamento da un significato proprio ad uno figurato EsPlauto Miles 987 Quae haec celox laquoqual egrave questa barcaveloceraquo dove con celox si indica lrsquoancella veloce comeuna nave leggera (lrsquoelemento di intersezione egrave dato dalla
velocitagrave comune sia allrsquoancella sia alla nave leggera)
Figura retorica che opera sulla base della contiguitagrave con-cettuale (spaziale causale temporale ecc) si sostituiscecioegrave un termine con un altro operando uno spostamentoda un campo semantico ad altro vicino Es Catullo 8 3 fulsere quondam candidi tibi soles dove soles sta per dies
Vedi Catulliani (metri)
Orazio usograve lrsquoesametro nelle Satire e nelle Epistole men-tre nelle Odi traspose i versi eolici della lirica greca Taleoperazione iniziata dai poetae novi fu condotta siste-
Metri oraziani
Metri catulliani
Metonimia
Metafora
Litote
Lirica
Lira
maticamente da Orazio che volle ricreare nella lirica lati-na i ritmi e lo spirito dei modelli greci Caratteristicheprincipali dei versi della lirica eolica erano lrsquoisosillabismo ela base libera Orazio adattandoli meglio alla sensibilitagraveritmica dei Romani apportograve qualche modificazione qua-li la sostituzione delle sillabe di quantitagrave variabile con sil-labe lunghe e lrsquointroduzione di cesure fisse
Riportiamo lo schema dei versi e delle strofe usati daOrazio nei carmi presenti nellrsquoantologia rinunciando aduna loro descrizione in base ai piedi usati date le diverseinterpretazioni a riguardo
Asclepiadei minori
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Or Carm III 30 E acute xegı monumentum aere perenniusregal ıque situ pyramidum altiusquod non ımber edax non aquilo ımpotens possit dıruere aut ınnumerabilis
Asclepiadei m aggiori
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Or Carm I 11 1-4Tu ne quaesierıs | scı re nefas | quem mihi quem tibi fı nem dı dederınt | Leuconoe | nec Babyloniostemptarıs numeros | U acute t melius | quıcquid erıt patiSeu plures hiemes | seu tribuıt | Iuppiter ultimam
Lrsquoasclepiadeo maggiore e lrsquoasclepiadeo minore si posso-no trovare come negli esempi riportati usati stichica-mente (in greco stı chos laquoversoraquo) vale a dire in serie op-pure variamente combinati nelle strofe asclepiadee (I IIIII IV V) con il gliconeo e il ferecrateo
Gliconeo
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Ferecrateo
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215
Egrave presente nellrsquoantologia la strofe asclepiadea III
Strofe asclepiadea III
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ 983215983215 acute ˘ 983215 ˘ asclepiadeo minore 983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘ asclepiadeo minore
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ferecrateo
macr 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘ gliconeo
Or Carm III 13 1-4O fons Bandusiae | splendidior vitrodulci dıgne mero | non sine floribuscras donaberis haedocuı frons turgida cornibus
Lrsquoelemento ritmico del verso latino egrave costituito dal ripe-
tersi regolare di successioni di sillabe brevi e sillabe lun-ghe Quando queste successioni obbediscono a schemiprecisi fornendo determinate figure metriche si hanno
Metrica
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 68
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 336
delle cellule ritmiche elementari dette tradizionalmentepiediI piedi principali sono i seguentitrocheo
983215 tribraco
˘ ˘ ˘giambo
˘ 983215 spondeo
983215 983215dattilo 983215 ˘anapesto
˘ ˘ 983215 proceleusmatico
˘ ˘ ˘ ˘cretico
983215 983215 coriambo
983215 ˘ 983215
Significa laquoimitazioneraquo e designa il modo drsquointendere lapoesia e lrsquoarte degli autori antichi Per Simonide (VI-Vsec aC) la poesia egrave una laquoimmagine della cosaraquo unrsquoimi-tazione anche di emozioni e stati drsquoanimo Ogni formadrsquoarte sia essa poetica pittorica musicale o coreutica egravesentita dai greci come imitazione e gli artisti sono tutti
considerati laquoimitatoriraquo da Platone (Rep 373b)
laquoI miti sono narrazioni tramandate dalla tradizione percheacutecontengono valori importanti per la comunitagrave o percheacute co-stituiscono racconti di particolare rilevanza narrativaraquo(Howatson) Se si riferiscono a personaggi reali che hannooperato in luoghi reali e riportano gli eventi in forma ab-bastanza realistica (ad esempio le vicende dei sette re diRoma) si possono definire leggende I contenuti del mitosono vari e possono riguardare lrsquoorgine del mondo e dellaTerra le forme del culto le istituzioni degli uomini Hannocarattere laquoapertoraquo nel senso che si prestano a essere nar-rati secondo varie versioni e ad accogliere mille inserimentie variazioni Costituiscono lrsquoantefatto della storiografia (apartire dalle genealogie mitiche di dei e eroi) ma anchedella scienza e della filosofia (a partire dai grandi miti co-smologici) Le maggiori fonti mitiche sono per noi OmeroEsiodo ma anche i poeti ellenistici come Callimaco per iquali il mito per lo piugrave ripreso in una variante poco notadiviene un ornamento prezioso della narrazione LeMetamorfosi di Ovidio furono il maggiore veicolo di tra-smissione del patrimonio mitico antico nei secoliCome sostiene lrsquoantropologo Altan lrsquoesperienza mitica egravefondamentale per le popolazioni antiche e preletterate
immuni dagli effetti indotti nei ceti colti dal razionali-smo greco e presso le quali le operazioni canoniche delpensiero definito razionale (classificazione numerazio-ne spazialitagrave temporalitagrave causalitagrave) assumono conno-tati diversi da quelli assunti nella tradizione occidentaleLrsquoaffermazione del pensiero razionale ha comportatoche il mito divenisse sinonimo di menzogna Il terminem acute ythos originariamente non antitetico rispetto a logos(con cui poteva coesistere nel composto mythologialaquocomplesso di raccontiraquo) in seguito agli sviluppi della fi-losofia greca diviene lrsquoopposto del logos o discorso ra-zionale e il mito egrave confinato nella sfera della pre-razio-nalitagrave anzi dellrsquoirrazionalitagrave considerato antitetico alla
scienza retaggio di tempi oscuri dominati dalla paura edalla superstizione In realtagrave secondo le vedute piugrave re-centi il mito era la forma del sapere collettivo dei popo-
Mito
Migravemesi
li prestorici Nel loro orizzonte culturale laquoil patrimonio disapere collettivo economico tecnologico politico so-ciale e religioso in cui si articola la cultura si manifestaglobalmente come mitologia nella quale sono ancorafra loro indistinte quelle forme che storicamente assu-meranno un significato autonomo nelle diverse specia-lizzazioni disciplinari proprie della cultura in senso mo-
derno occidentaleraquo (Altan)
Studio dei miti ma anche complesso dei miti di una cer-ta cultura o epoca
Figlie di Zeus e Mnemogravesine la dea della memoria Nei poe-mi omerici dove allietano i banchetti degli dei sono in unnumero imprecisato che perograve giagrave alla fine dellrsquoOdissea(XXIV 60) si precisa in nove numero che con la Teogonia diEsiodo diviene definitivo Esiodo ne elenca anche i nomi eassegna loro la funzione che saragrave canonica di ispirare i
poeti nella composizione di un poema Le specifiche funzio-ni delle Muse si preciseranno solo in etagrave ellenistica Calligraveopesaragrave preposta allrsquoepica Clio alla storia Melpogravemene allapoesia tragica Eutegraverpe alla musica col flauto Egraverato allapoesia lirica Tersigravecore alla lirica corale e alla danza Uragraveniaallrsquoastronomia Taligravea alla commedia Poligravemnia alla pantomi-ma Le sedi di culto delle Muse piugrave famose furono la Piegraveriaai piedi dellrsquoOlimpo e Ascra in Beozia
Nella poesia greca arcaica la mousikeacute egrave la poesia intesacome connubio di parole e musica La musica era parteintegrante della vita sociale greca Quasi ogni forma poe-tica era accompagnata dalla musica La rilevanza eticadella musica era sostenuta da Platone convinto che lamusica influenzasse in modo permanente il carattere e leattitudini dellrsquouomo e da Aristotele
Da odeacute laquocantoraquo Composizione lirica di forma metrica estrofica varia A Roma si usograve il termine carmen
Egrave un tipo di omoteleuto che si ha quando piugrave parole hannola stessa terminazione derivante da uguali forme di flessione
Ripetizione dello stesso suono alla fine di piugrave parole vici-ne della stessa frase Es Virg Buc IV 50 s Aspice con-vexo nutantem pondere mundum terrasque tractusquemaris caelumque profundum dove i due versi terminanocon lo stesso suono
Formazione di un vocabolo il cui suono imita un rumorenaturale Es Plauto Miles 311 mussitabo il verbo mussitolaquoborbottareraquo riprende il suono mu del borbottio delparlare sommessamente
Vedi Metri orazianiOraziani (metri)
Onomatopea
Omoteleuto
Omeoptoto
Ode
Musica
Muse
Mitologia
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 78
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 337
Accostamento di parole di senso opposto Es Or Ep I11 28 strenua inertia
Festivitagrave pubblica a sfondo religioso durante la quale sisvolgevano gare poetiche e musicali
Letteralmente laquoscherziraquo Poesie di carattere privato edisimpegnato di mero intrattenimento tipiche della cultu-ra ellenistica A Roma scrissero paacuteignia (latinamente nu- gae) soprattutto i poeti del circolo neoterico ( poetae novi )
Vedi Lira
Si ha quando gli elementi di due o piugrave frasi sono dispostinello stesso ordine cosigrave da corrispondersi simmetrica-mente Es Sall BC 5 4 cuius lubet rei simulator ac dis- simulator alieni adpetens sui profusus
Consiste nellrsquoaccostare due parole di suono simile ma disignificato diverso Es Catullo 3 13 At vobis male sitmalae tenebrae
Canto intonato da un coro di fanciulle
Termine della retorica greca indicante il carattere dipassionalitagrave e drammaticitagrave proprio dellrsquoepica e dellatragedia Secondo N Frye il pathos egrave la lotta mortaledellrsquoeroe
Canto dedicato ad Apollo
Il pentametro egrave un verso mai usato da solo formato dal-lrsquounione di due metagrave versi (emistichi ) separate da una pau-sa fissa una dieresi ciascuna delle quali egrave composta di duedattili e mezzo Sono quindi sei piedi dattilici catalettici in
syllabam che terminano cioegrave con una sola sillaba Nellaprima metagrave al posto dei dattili si possono trovare deglispondei nella seconda non sono possibili sostituzioniSchema
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute 983215 acute ˘˘ 983215 acute ˘˘ 983215 ˘
Catullo 85Odi et amo | Quare id faciam | fortasse requiris Nescio sed fieri | sentio et excrucior
Termine inglese impiegato di frequente per indicare laprestazione artistica del poeta lirico o epico
Si ha quando per evitare di designare una persona o didire una cosa direttamente si usa un giro di parole
Ossimoro
Perifrasi
Performance
Pentametro
Peana
Pathos
Partenio
Paronomasia
Parallelismo
Phoacuterminx
Paacuteignia
Paneg yris
Egrave il personaggio che nella lirica si esprime in prima perso-na Non necessariamente coincide con lrsquoio dellrsquoautore
Da poikiacutello laquorendo varioraquo Egrave la capacitagrave del poeta di va-riare a tempo debito in rapporto allrsquooccasione toni temi
strutture metriche del canto soddisfacendo alle attese dichi ascolta
Egrave la laquopuntaraquo cioegrave il finale arguto e inatteso soprattuttodellrsquoepigramma ( fulmen in clausula)
Ripetizione di una stessa parola espressa a breve distanzain piugrave casi grammaticali Es Catullo 2 2 s quicum lude-re quem in sinu tenere cui
Si ha quando piugrave elementi di una frase o piugrave frasi sonouniti da piugrave congiunzioni Es Sall BC 3 1 et qui fecereet qui scripsere
Figura con la quale si dice sia pure brevemente una cosache al contempo si dichiara di non voler dire Es Cic CatI 3 Nam illa nimis antiqua praetereo quod C Servilius
Termine della filologia tedesca (dal lat praeambulum) Egraveuno schema retorico consistente nella rassegna degli al-
trui generi di vita cui egrave contrapposto il proprio del qualesi rivendica la superiore validitagrave Cosigrave ad esempio Saffocontrapponendosi allrsquoopinione dominante sostiene chela cosa piugrave bella non sono le flotte e gli eserciti malaquoquello che ognuno amaraquo
Tipo di esordio tipico del poema epico Il proemio poeticosecondo alcuni autori sembra sovrapponibile allrsquoexordiumdei genera dicendi Questo oltre al compito ovvio di ini-ziare (exordium est principium orationis Rhet Her 1 34) ha il compito di disporre favorevolmente lrsquouditorio neiconfronti dellrsquooratore e dellrsquoargomento ( per quod [= exor-
dium] animus auditoris constituitur ad audiendum)
Figura mediante la quale si fa parlare come se fosse pre-sente un personaggio lontano o defunto o la personifica-zione di cosa inanimata o astratta Es Cic Pro Caelio laprosopopea di Appio Claudio Cieco Cic Cat I 17-18 e27-29 la prosopopea della patria
Proemio dei poemi classici comprendente la presentazio-ne dellrsquoargomento lrsquoinvocazione alla Musa eventual-mente la dedica
Egrave il poeta epico o lirico inteso come laquocucitore di cantiraquo
Persona loquens
Rapsogravedo (rhapsodoacutes)
Protasi
Prosopopea
Proemio
Priagravemel
Preterizione
Polisindeto
Poliptoto
Pointe
Poikiliacutea
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 88
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 338
Ripetizione di una o piugrave parole conclusive della frase pre-cedente in quella seguente Es Cic Cat I 1 vivitVivit
Ripetizione di una sequenza tra un periodo e lrsquoaltro di
una composizione ritornello Egrave un procedimento checonferisce unitagrave psicologica e tematica al testo poetico omusicale
Si ha rejet quando una parola si trova isolata allrsquoinizio diun verso pur facendo parte per il senso del verso prece-dente Es Virg Georg I 463 sol tibi signa dabit Solemquis dicere falsum audeat
Si ha quando si interrompe allrsquoimprovviso la frase la-sciandone tuttavia intendere il senso
Termine tedesco indicante la struttura laquoad anelloraquo dellacomposizione cioegrave basata sul ritorno alla fine di ele-menti che figuravano in principio
Canto eseguito durante un banchetto dai convitati chenel canto si cedono la parola in ordine laquoobliquoraquo dondeil nome
Vedi Giambico (senario)
Paragone fra due immagini introdotto da espressioni co-me ut ita talis qualis ceu ecc Es Virg Georg IV499 Dixit et ex oculis subito ceu fumus in auras com-mixtus tenuis fugit
Egrave quel genere di riunione maschile che in Grecia seguivail pasto serale ed era dedicata al bere al progetto politi-co e militare allrsquoeros allrsquoascolto della poesia e piugrave tardianche al discorso filosofico A simposio si riunivano grup-
pi legati da giuramento (eteriacutee) e costituiti sullrsquouguaglian-za dello stile di vita sulla coincidenza degli scopi politicisullrsquoomogeneitagrave culturale
Particolare tipo di metonimia anche con la sineddocheinfatti si ha la trasposizione da un significato proprio adaltro figurato in particolare in un rapporto di quantitagrave(parte per il tutto singolare per plurale ecc) Es Virg Aen II 276 vel Danaum Phrygios iaculatus puppibusignis dove puppes indica le navi
Consiste nellrsquoassociare piugrave termini appartenenti a perce-zioni sensoriali diverse (visive uditive tattili olfattive gu-stative) in unrsquounica espressione
Reduplicatio
Sinestesia
Sineddoche
Simposio (sympoacutesion )
Similitudine
Senario giambico
Scolio
Ringkomposition
Reticenza
Rejet
Refrain
Il Lord ha definito i laquotemiraquo della poesia orale comelaquogruppi di idee regolarmente usate nel raccontare unastoria nello stile formulaico del canto tradizionaleraquoNellrsquoOdissea le numerose descrizioni stereotipiche del-lrsquoaccoglienza ospitale offerta a un visitatore costituisconoun laquotemaraquo orale Nella narrativa germanica le descrizio-
ni in cui la schiera dei nobili si riunisce intorno al re abanchettare a bere e a vantarsi delle proprie gesta co-stituisce analogamente un laquotemaraquo di quella tradizione(R Scholes - R Kellogg)
Comunitagrave paideutico-cultuale femminile in parte simileallrsquoeterigravea maschile con finalitagrave educativa Qui le fanciulledi nobile famiglia compivano la loro educazione nellamusica nel canto nella danza nellrsquoarte di ornarsi e ve-stirsi in modo conforme al loro rango Era un ideale diperfezione da conseguire anche attraverso pratiche litur-giche incentrate sul culto di Afrodite
Si ha quando una parola composta viene separata neisuoi elementi attraverso lrsquointerposizione di altri elementiEs Virg Georg III 381 Hyperboreo septem subiecta trio-ni dove septemtrioni egrave separato in septem e trioni attra-verso lrsquointerposizione di subiecta
Canto funebre
Nella retorica classica i koinoacutei topoi (loci communes) eranoargomenti adatti ad essere sviluppati al servizio drsquouna tesiin vari generi di discorso Il loro assieme costituiva a dettadi Quintiliano la argomentorum sedes La memoria era in-fatti concepita come uno spazio nei cui luoghi (topoi loci )si situano le idee a questi luoghi ricorre lrsquooratore quandocerca argomenti adatti alle situazioni e alle parti del discor-so Nel Medioevo ndash estintisi il discorso politico e quello giu-diziario ndash la retorica estende lrsquouso dei topoi a tutti i tipi ditesto essi divengono dei clicheacutes di generale utilizzabilitagraveletteraria e si estendono a tutti i settori della vita che pos-sono essere abbracciati e modellati dalla letteratura Cosigravela retorica costituisce un magazzino vi si trovano le idee di
carattere piugrave generale tali da poter essere usate in tutti idiscorsi e gli scritti P Zumthor insiste sul carattere compo-sito dei topoi laquomateriali di reimpiego (come si potrebberodire per analogia le opere dellrsquoarchitettura romana) risul-tato di qualche bricolage arcaico i cui prodotti si sono apoco a poco arricchiti e affinati nello stesso tempo in cui siconsolidavanoraquo
Consiste nel collegare due o piugrave termini con un elementoche egrave appropriato per uno solo la forma di zeugma piugravefrequente fa dipendere da un unico verbo piugrave oggettiche richiederebbero ciascuno un verbo specifico Es Or
Carm I 1 19-21 Est qui nec veteris pocula Massici nec partem solido demere de die spernit dove spernit ha peroggetto sia pocula sia lrsquoinfinito demere
Tema
Zegraveugma
Topos
Treno
Tmesi
Tigraveaso

7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 38
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 333
ruinas in cui dementis (= dementes) concorda con rui-nas ma egrave riferito a regina
Canto in onore di uomini
Si ha unrsquoendiadi quando si esprime un unico concettoper mezzo di due termini coordinati fra loro Es Virg Aen IV 18 thalami taedaeque per indicare le nozze
Espressione sentenziosa che contiene una considerazionegenerale tratta dagli avvenimenti narrati Es Virg AenIV 412 Improbe Amor quid non mortalia pectora cogis
Ripetizione di una parola o di un gruppo di parole alla fi-ne di versi o frasi successivi Es Catullo 3 3 s passer mortuus est meae puellae Passer deliciae meae puel-lae
Da epigragravepho (laquoscrivo suraquo tombe oggetti) era in origineunrsquoiscrizione funebre o commemorativa Allrsquouso epigraficodeve il tratto distintivo della brevitagrave che conservograve anchequando assunse diversa funzione Ebbe fortuna durantelrsquoEllenismo quando servigrave a fissare in pochi versi scritti informa raffinata unrsquoemozione unrsquoimpressione una scenaquotidiana Oltre alla fulminea brevitagrave caratterizzalrsquoepigramma la ricerca di un finale ( pointe) arguto e inat-teso
Poema epico di piccola dimensione che narra le vicendeper lo piugrave di natura amorosa di un eroe o di unrsquoeroinadel mito Esemplare in tal senso fu lrsquoEacute cale di CallimacoNellrsquoepillio hanno rilievo i sentimenti umani comuni so-prattutto lrsquoamore Sono frequenti le descrizioni minuzio-se della quotidianitagrave seguite da digressioni erudite spes-so a carattere eziologico cioegrave volte a cercare le origini diusanze culti tradizioni Anche lrsquoEacute cale egrave un agraveition percheacutetutta la narrazione serve a spiegare lrsquoorigine del culto diZeus Ecalegraveio
Canto in onore del vincitore ai giochi sportivi
Canto in onore degli sposi eseguito davanti al talamocioegrave alla stanza nuziale
Gli epiteti sono espressioni per lo piugrave aggettivi attribuitiinnanzi tutto agli dei nella poesia epica e lirica Spessosono puramente esornativi (epiteto ornans) e servono acostituire una data unitagrave metrica ma talora corrispon-
dono a un preciso impiego cultuale Un porsquo diverso egrave ildiscorso dellrsquoepiteto omerico che si lega al discorso dellaformularitagrave (vedi p 334) e della poesia orale (vedi Glos-
Encomio
Epigraveteto
Epitalagravemio
Epinicio
Epillio
Epigramma
Epigravefora
Epifonema
Endigraveadi
sario del volume di laquoEpicaraquo) In tal caso lrsquoepiteto attri-buito a un eroe (Achille pieveloce) o a un evento(lrsquoaurora dalle rosee dita) egrave tratto da un repertorio di ele-menti laquomodulariraquo memorizzati dallrsquoaedo che gli consen-tiva di produrre su richiesta dellrsquouditorio una composizio-ne estemporanea
Dal gr epos laquoparola racconto canto poetico poemaraquoDesigna tanto il singolo poema epico quanto un insiemeo ciclo di poemi (ad esempio lrsquoepos omerico) Indica an-che il complesso delle leggende nazionali di una lettera-tura o di un popolo Lrsquoepica greca egrave rappresentata es-senzialmente dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea Il verso dellrsquoepicaegrave lrsquoesametro che si identifica con lrsquoepica al punto che gliepe (plur di epos) sono appunto gli esametri
Lrsquoesametro giagrave usato nella poesia greca da Omero egrave ilverso dellrsquoepica e per questo egrave detto anche verso eroico
Fu usato anche nella poesia didascalica in quella bucoli-ca e nella satiraEgrave costituito da sei piedi (in questo caso anche metri) dat-tilici di cui i primi quattro possono essere dattili o spon-dei il quinto egrave generalmente un dattilo il sesto unospondeo o un trocheoSchema
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ 983215 acute ˘ 983215
Espressione pronunciata con una certa enfasi ad indicarediversi stati drsquoanimo (sdegno ammirazione ecc) Nellalingua scritta segno di tale tono egrave il punto esclamativoEs Cic Cat I 2 O tempora o mores
Vedi Proemio
Associazione maschile consorteria politica gruppo diuomini (per lo piugrave aristocratici) legati da giuramento ecostituito sullrsquouguaglianza dello stile di vita sulla coinci-denza degli scopi politici sullrsquoomogeneitagrave culturale
Consiste nellrsquouso di una parola o di un gruppo di parole
che sostituisce altra parola o gruppo al fine di esprimerein modo meno crudo o comunque attenuare un con-cetto sgradevole
(laquosi concluderaquo) Termine usato per indicare lrsquoultima o leultime parole di un testo o di un verso il suo opposto egrave iltermine incipit (v) Ad es in Virg Aen II 293 Sacra suosque tibi commendat Troia Penates si dice che sacra ePenates sono rispettivamente in incipit e in explicit posi-zioni entrambe di forte rilievo
Si tratta dellrsquouso di due o piugrave parole che hanno la stessaradice Es Plauto Miles 309 facinus fecit 959 pulchram pulchritudinem
Figura etimologica
Explicit
Eufemismo
Epos
Esametro
Esclamazione
Esordio
Eteria
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 48
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 334
Vedi Agraveition
Consiste nellrsquoaffidare al gioco dei suoni lrsquoevocazione diun oggetto o di unrsquoazione Es Virg Buc I 55 saepe levi somnum suadebit inire susurro in cui il ripetersi della si-
bilante evoca il ronzio delle api
Tecnica artigianale di composizione poetica propria dellrsquoe-pica omerica e della lirica arcaica basata sullrsquoassemblaggiodi laquoformuleraquo Si tratta di espressioni stereotipate (adesempio lrsquoaggettivo standard come laquoAchille piegrave veloceraquo olaquolrsquoAurora dalle dita-di-rosaraquo) metricamente e sintattica-mente definite che ricorrono invariate in diversi punti del-la stessa opera o di opere diverse Lo scopo era di agevola-re la memorizzazione nellrsquoambito di una cultura orale
Ripetizione immediata di una parola o di in gruppo di pa-role Es Plauto Miles 313 Sceledre Sceledre
Egrave formato da tre metri giambici corrisponde quindi al tri-metro giambico nome greco di questo verso Il senariolatino a differenza del trimetro giambico greco ammet-te alcune sostituzioni del giambo quali il tribraco (˘˘ ˘)[sostituzione razionale] lo spondeo ( 983215983215 ) il dattilo ( 983215˘˘)lrsquoanapesto (˘˘ 983215 ) il proceleusmatico (˘˘˘˘) [sostituzioni ir-razionali]Schema
˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute
Ter Adelf 1 Postqua m poe ta se nsit scrı ptura m sua m
Altri versi sonobull il settenario giambico ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ndash ˘bull lrsquoottonario giambico ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash ˘bull il dimetro giambico acatalettico ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute
Egrave il metro di una forma di poesia diffusa nella IoniadrsquoAsia e insulare Egrave comunemente denominato laquotrimetrogiambicoraquo percheacute formato di tre laquometriraquo cioegrave di trecoppie di giambi Vedi giambico (senario) Lrsquoesecuzione
era affidata a un recitativo ( parakatalogheacute) con accom-pagnamento di aulo Caratterizza il giambo il gusto perla beffa lo scherno lrsquoinvettiva ma i contenuti sono vari(biografici didattici morali politici erotici)
Indica lrsquoespressione concisa di una veritagrave comunemente ac-cettata Le gnoacutemai piugrave famose erano quelle incise nel tem-pio di Delfi (ad esempio gnoacutethi sautoacuten laquoconosci te stessoraquo)
Vedi Climax
Parola che si trova attestata una volta sola o in un autoreo in unrsquoepoca o nellrsquointero sistema di una lingua
Eziologica (poesia)
Hapax (legoacutemenon)
Gradatio
Fonosimbolismo
Gnome
Giambo
Giambico (senario)
Geminatio
Formularitagrave
Inversione temporale di due avvenimenti cosigrave che si diceprima ciograve che logicamente dovrebbe essere detto dopoEs Virg Aen IV 6 s Postera Phoebea lustrabat lampadeterras umentemque Aurora polo dimoverat umbram
Dal gr eid yllion laquoquadrettoraquo definizione data in etagrave ro-mana alle composizioni di Teocrito che rappresentanoscene di vita rurale idealizzata
Canto eseguito nelle cerimonie nuziali
Termine usato per indicare la prima o le prime parole diun testo o di un verso il suo opposto egrave il termine explicit (vedi)
Canto di preghiera agli dei
Consiste nel porre una domanda in cui egrave implicita la ri-sposta stessa positiva o negativa Es Cic De leg I 14 42 si omnes Athenienses delectarentur tyrannicis legibusnum idcirco eae leges iustae haberentur
Secondo alcuni egrave un tipo di enallage quella piugrave frequen-te dellrsquoaggettivo secondo altri egrave da identificare conlrsquoenallage stessa Es Or Carm IV 7 19 manus avidas
heredis = manus avidi heredis
Consiste nel dividere gli elementi di uno stesso grupposintattico con lrsquoinserimento di altri cosigrave da porre in rilievole parti separate Es Or Epist I 8 1 Celso gaudere et bene rem gerere Albinovano
laquoEsagerazioneraquo nellrsquoesprimere un concetto oltre i limitidella verosimiglianza sia in piugrave che in meno Es Or SatI 9 10 s cum sudor ad imos manaret talos
Figura con la quale si dice il contrario di ciograve che si vuolefar intendere Es Virg Aen IV 379 s Scilicet is superislabor est ea cura quietos sollicitat
Vedi Lira
Sappiamo che oggi egrave impossibile leggere i versi latini co-me li leggevano gli antichi dato che noi non percepiamogli stessi elementi di ritmo che essi percepivano (quantitagraveecc) Per evitare tuttavia di perdere completamente il
senso del ritmo poetico leggendo la poesia come la pro-sa scegliamo di laquoutilizzare un ldquonostrordquo normale trattodistintivo (lrsquoaccento tonico) come sostitutivo consapevol-
Hysteron proteron
Lettura metrica (dei versi)
Kiacutetharis
Ironia
Iperbole
Ipegraverbato
Ipagravellage
Interrogazione retorica
Inno
Idillio
Imeneacuteo
Incipit (laquocominciaraquo)
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 58
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 335
mente assunto a puro valore simbolico di un tratto di-stintivo che il nostro sistema linguistico non possiederaquo(Milanese) Poniamo perciograve un apice ( acute ) sulle sillabe chefungono da laquoelementi-guidaraquo e le leggiamo con il nostrotipo di accento che egrave accento intensivo In tal modo use-remo in piena consapevolezza una lettura convenziona-le che laquoanche se non riproduce quella degli antichi con-
serva almeno in parte e ci permette di percepire i trattifondamentali dei ritmi originari trasponendoli in modulia noi accessibiliraquo (Scialuga)
La lira era lo strumento tipico dellrsquoaedo omerico Avevacorde verticali di uguale lunghezza ricavate da budello otendini di animali che venivano pizzicate con la mano si-nistra e percosse col pleacutektron il plettro appunto tenutonella mano destra Alla base un guscio di tartaruga euna struttura lignea fungevano da cassa di risonanzaOgni corda veniva accordata e produceva una sola notaLa phoacuterminx o kiacutetharis egrave una lira molto semplice dotata
forse di sole tre o cinque corde A Terpandro (VII secaC) si deve lrsquointroduzione di sette corde
Per gli antichi indica la poesia cantata con accompagna-mento della lira o altri strumenti a corda (kiacutetharis baacuterbi-ton phoacutermings ecc) Si distingueva dallrsquoelegia e dal giambo forme poetiche accompagnate da strumenti afiato come lrsquoaulo La lirica monodica consisteva in unlaquocanto a soloraquo la lirica corale era eseguita da un corodanzante o da un solista a cui rispondeva un coro
Consiste nellrsquoaffermare un concetto attraverso la nega-zione del suo contrario Es Lucr VI 1250 Nec poterat quisquam reperiri
Fu definita anticamente come laquoparagone abbreviatoraquo inquanto opera sulla base della similaritagrave individuando unelemento di intersezione fra due termini si opera cosigrave unospostamento da un significato proprio ad uno figurato EsPlauto Miles 987 Quae haec celox laquoqual egrave questa barcaveloceraquo dove con celox si indica lrsquoancella veloce comeuna nave leggera (lrsquoelemento di intersezione egrave dato dalla
velocitagrave comune sia allrsquoancella sia alla nave leggera)
Figura retorica che opera sulla base della contiguitagrave con-cettuale (spaziale causale temporale ecc) si sostituiscecioegrave un termine con un altro operando uno spostamentoda un campo semantico ad altro vicino Es Catullo 8 3 fulsere quondam candidi tibi soles dove soles sta per dies
Vedi Catulliani (metri)
Orazio usograve lrsquoesametro nelle Satire e nelle Epistole men-tre nelle Odi traspose i versi eolici della lirica greca Taleoperazione iniziata dai poetae novi fu condotta siste-
Metri oraziani
Metri catulliani
Metonimia
Metafora
Litote
Lirica
Lira
maticamente da Orazio che volle ricreare nella lirica lati-na i ritmi e lo spirito dei modelli greci Caratteristicheprincipali dei versi della lirica eolica erano lrsquoisosillabismo ela base libera Orazio adattandoli meglio alla sensibilitagraveritmica dei Romani apportograve qualche modificazione qua-li la sostituzione delle sillabe di quantitagrave variabile con sil-labe lunghe e lrsquointroduzione di cesure fisse
Riportiamo lo schema dei versi e delle strofe usati daOrazio nei carmi presenti nellrsquoantologia rinunciando aduna loro descrizione in base ai piedi usati date le diverseinterpretazioni a riguardo
Asclepiadei minori
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Or Carm III 30 E acute xegı monumentum aere perenniusregal ıque situ pyramidum altiusquod non ımber edax non aquilo ımpotens possit dıruere aut ınnumerabilis
Asclepiadei m aggiori
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Or Carm I 11 1-4Tu ne quaesierıs | scı re nefas | quem mihi quem tibi fı nem dı dederınt | Leuconoe | nec Babyloniostemptarıs numeros | U acute t melius | quıcquid erıt patiSeu plures hiemes | seu tribuıt | Iuppiter ultimam
Lrsquoasclepiadeo maggiore e lrsquoasclepiadeo minore si posso-no trovare come negli esempi riportati usati stichica-mente (in greco stı chos laquoversoraquo) vale a dire in serie op-pure variamente combinati nelle strofe asclepiadee (I IIIII IV V) con il gliconeo e il ferecrateo
Gliconeo
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Ferecrateo
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215
Egrave presente nellrsquoantologia la strofe asclepiadea III
Strofe asclepiadea III
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ 983215983215 acute ˘ 983215 ˘ asclepiadeo minore 983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘ asclepiadeo minore
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ferecrateo
macr 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘ gliconeo
Or Carm III 13 1-4O fons Bandusiae | splendidior vitrodulci dıgne mero | non sine floribuscras donaberis haedocuı frons turgida cornibus
Lrsquoelemento ritmico del verso latino egrave costituito dal ripe-
tersi regolare di successioni di sillabe brevi e sillabe lun-ghe Quando queste successioni obbediscono a schemiprecisi fornendo determinate figure metriche si hanno
Metrica
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 68
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 336
delle cellule ritmiche elementari dette tradizionalmentepiediI piedi principali sono i seguentitrocheo
983215 tribraco
˘ ˘ ˘giambo
˘ 983215 spondeo
983215 983215dattilo 983215 ˘anapesto
˘ ˘ 983215 proceleusmatico
˘ ˘ ˘ ˘cretico
983215 983215 coriambo
983215 ˘ 983215
Significa laquoimitazioneraquo e designa il modo drsquointendere lapoesia e lrsquoarte degli autori antichi Per Simonide (VI-Vsec aC) la poesia egrave una laquoimmagine della cosaraquo unrsquoimi-tazione anche di emozioni e stati drsquoanimo Ogni formadrsquoarte sia essa poetica pittorica musicale o coreutica egravesentita dai greci come imitazione e gli artisti sono tutti
considerati laquoimitatoriraquo da Platone (Rep 373b)
laquoI miti sono narrazioni tramandate dalla tradizione percheacutecontengono valori importanti per la comunitagrave o percheacute co-stituiscono racconti di particolare rilevanza narrativaraquo(Howatson) Se si riferiscono a personaggi reali che hannooperato in luoghi reali e riportano gli eventi in forma ab-bastanza realistica (ad esempio le vicende dei sette re diRoma) si possono definire leggende I contenuti del mitosono vari e possono riguardare lrsquoorgine del mondo e dellaTerra le forme del culto le istituzioni degli uomini Hannocarattere laquoapertoraquo nel senso che si prestano a essere nar-rati secondo varie versioni e ad accogliere mille inserimentie variazioni Costituiscono lrsquoantefatto della storiografia (apartire dalle genealogie mitiche di dei e eroi) ma anchedella scienza e della filosofia (a partire dai grandi miti co-smologici) Le maggiori fonti mitiche sono per noi OmeroEsiodo ma anche i poeti ellenistici come Callimaco per iquali il mito per lo piugrave ripreso in una variante poco notadiviene un ornamento prezioso della narrazione LeMetamorfosi di Ovidio furono il maggiore veicolo di tra-smissione del patrimonio mitico antico nei secoliCome sostiene lrsquoantropologo Altan lrsquoesperienza mitica egravefondamentale per le popolazioni antiche e preletterate
immuni dagli effetti indotti nei ceti colti dal razionali-smo greco e presso le quali le operazioni canoniche delpensiero definito razionale (classificazione numerazio-ne spazialitagrave temporalitagrave causalitagrave) assumono conno-tati diversi da quelli assunti nella tradizione occidentaleLrsquoaffermazione del pensiero razionale ha comportatoche il mito divenisse sinonimo di menzogna Il terminem acute ythos originariamente non antitetico rispetto a logos(con cui poteva coesistere nel composto mythologialaquocomplesso di raccontiraquo) in seguito agli sviluppi della fi-losofia greca diviene lrsquoopposto del logos o discorso ra-zionale e il mito egrave confinato nella sfera della pre-razio-nalitagrave anzi dellrsquoirrazionalitagrave considerato antitetico alla
scienza retaggio di tempi oscuri dominati dalla paura edalla superstizione In realtagrave secondo le vedute piugrave re-centi il mito era la forma del sapere collettivo dei popo-
Mito
Migravemesi
li prestorici Nel loro orizzonte culturale laquoil patrimonio disapere collettivo economico tecnologico politico so-ciale e religioso in cui si articola la cultura si manifestaglobalmente come mitologia nella quale sono ancorafra loro indistinte quelle forme che storicamente assu-meranno un significato autonomo nelle diverse specia-lizzazioni disciplinari proprie della cultura in senso mo-
derno occidentaleraquo (Altan)
Studio dei miti ma anche complesso dei miti di una cer-ta cultura o epoca
Figlie di Zeus e Mnemogravesine la dea della memoria Nei poe-mi omerici dove allietano i banchetti degli dei sono in unnumero imprecisato che perograve giagrave alla fine dellrsquoOdissea(XXIV 60) si precisa in nove numero che con la Teogonia diEsiodo diviene definitivo Esiodo ne elenca anche i nomi eassegna loro la funzione che saragrave canonica di ispirare i
poeti nella composizione di un poema Le specifiche funzio-ni delle Muse si preciseranno solo in etagrave ellenistica Calligraveopesaragrave preposta allrsquoepica Clio alla storia Melpogravemene allapoesia tragica Eutegraverpe alla musica col flauto Egraverato allapoesia lirica Tersigravecore alla lirica corale e alla danza Uragraveniaallrsquoastronomia Taligravea alla commedia Poligravemnia alla pantomi-ma Le sedi di culto delle Muse piugrave famose furono la Piegraveriaai piedi dellrsquoOlimpo e Ascra in Beozia
Nella poesia greca arcaica la mousikeacute egrave la poesia intesacome connubio di parole e musica La musica era parteintegrante della vita sociale greca Quasi ogni forma poe-tica era accompagnata dalla musica La rilevanza eticadella musica era sostenuta da Platone convinto che lamusica influenzasse in modo permanente il carattere e leattitudini dellrsquouomo e da Aristotele
Da odeacute laquocantoraquo Composizione lirica di forma metrica estrofica varia A Roma si usograve il termine carmen
Egrave un tipo di omoteleuto che si ha quando piugrave parole hannola stessa terminazione derivante da uguali forme di flessione
Ripetizione dello stesso suono alla fine di piugrave parole vici-ne della stessa frase Es Virg Buc IV 50 s Aspice con-vexo nutantem pondere mundum terrasque tractusquemaris caelumque profundum dove i due versi terminanocon lo stesso suono
Formazione di un vocabolo il cui suono imita un rumorenaturale Es Plauto Miles 311 mussitabo il verbo mussitolaquoborbottareraquo riprende il suono mu del borbottio delparlare sommessamente
Vedi Metri orazianiOraziani (metri)
Onomatopea
Omoteleuto
Omeoptoto
Ode
Musica
Muse
Mitologia
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 78
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 337
Accostamento di parole di senso opposto Es Or Ep I11 28 strenua inertia
Festivitagrave pubblica a sfondo religioso durante la quale sisvolgevano gare poetiche e musicali
Letteralmente laquoscherziraquo Poesie di carattere privato edisimpegnato di mero intrattenimento tipiche della cultu-ra ellenistica A Roma scrissero paacuteignia (latinamente nu- gae) soprattutto i poeti del circolo neoterico ( poetae novi )
Vedi Lira
Si ha quando gli elementi di due o piugrave frasi sono dispostinello stesso ordine cosigrave da corrispondersi simmetrica-mente Es Sall BC 5 4 cuius lubet rei simulator ac dis- simulator alieni adpetens sui profusus
Consiste nellrsquoaccostare due parole di suono simile ma disignificato diverso Es Catullo 3 13 At vobis male sitmalae tenebrae
Canto intonato da un coro di fanciulle
Termine della retorica greca indicante il carattere dipassionalitagrave e drammaticitagrave proprio dellrsquoepica e dellatragedia Secondo N Frye il pathos egrave la lotta mortaledellrsquoeroe
Canto dedicato ad Apollo
Il pentametro egrave un verso mai usato da solo formato dal-lrsquounione di due metagrave versi (emistichi ) separate da una pau-sa fissa una dieresi ciascuna delle quali egrave composta di duedattili e mezzo Sono quindi sei piedi dattilici catalettici in
syllabam che terminano cioegrave con una sola sillaba Nellaprima metagrave al posto dei dattili si possono trovare deglispondei nella seconda non sono possibili sostituzioniSchema
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute 983215 acute ˘˘ 983215 acute ˘˘ 983215 ˘
Catullo 85Odi et amo | Quare id faciam | fortasse requiris Nescio sed fieri | sentio et excrucior
Termine inglese impiegato di frequente per indicare laprestazione artistica del poeta lirico o epico
Si ha quando per evitare di designare una persona o didire una cosa direttamente si usa un giro di parole
Ossimoro
Perifrasi
Performance
Pentametro
Peana
Pathos
Partenio
Paronomasia
Parallelismo
Phoacuterminx
Paacuteignia
Paneg yris
Egrave il personaggio che nella lirica si esprime in prima perso-na Non necessariamente coincide con lrsquoio dellrsquoautore
Da poikiacutello laquorendo varioraquo Egrave la capacitagrave del poeta di va-riare a tempo debito in rapporto allrsquooccasione toni temi
strutture metriche del canto soddisfacendo alle attese dichi ascolta
Egrave la laquopuntaraquo cioegrave il finale arguto e inatteso soprattuttodellrsquoepigramma ( fulmen in clausula)
Ripetizione di una stessa parola espressa a breve distanzain piugrave casi grammaticali Es Catullo 2 2 s quicum lude-re quem in sinu tenere cui
Si ha quando piugrave elementi di una frase o piugrave frasi sonouniti da piugrave congiunzioni Es Sall BC 3 1 et qui fecereet qui scripsere
Figura con la quale si dice sia pure brevemente una cosache al contempo si dichiara di non voler dire Es Cic CatI 3 Nam illa nimis antiqua praetereo quod C Servilius
Termine della filologia tedesca (dal lat praeambulum) Egraveuno schema retorico consistente nella rassegna degli al-
trui generi di vita cui egrave contrapposto il proprio del qualesi rivendica la superiore validitagrave Cosigrave ad esempio Saffocontrapponendosi allrsquoopinione dominante sostiene chela cosa piugrave bella non sono le flotte e gli eserciti malaquoquello che ognuno amaraquo
Tipo di esordio tipico del poema epico Il proemio poeticosecondo alcuni autori sembra sovrapponibile allrsquoexordiumdei genera dicendi Questo oltre al compito ovvio di ini-ziare (exordium est principium orationis Rhet Her 1 34) ha il compito di disporre favorevolmente lrsquouditorio neiconfronti dellrsquooratore e dellrsquoargomento ( per quod [= exor-
dium] animus auditoris constituitur ad audiendum)
Figura mediante la quale si fa parlare come se fosse pre-sente un personaggio lontano o defunto o la personifica-zione di cosa inanimata o astratta Es Cic Pro Caelio laprosopopea di Appio Claudio Cieco Cic Cat I 17-18 e27-29 la prosopopea della patria
Proemio dei poemi classici comprendente la presentazio-ne dellrsquoargomento lrsquoinvocazione alla Musa eventual-mente la dedica
Egrave il poeta epico o lirico inteso come laquocucitore di cantiraquo
Persona loquens
Rapsogravedo (rhapsodoacutes)
Protasi
Prosopopea
Proemio
Priagravemel
Preterizione
Polisindeto
Poliptoto
Pointe
Poikiliacutea
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 88
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 338
Ripetizione di una o piugrave parole conclusive della frase pre-cedente in quella seguente Es Cic Cat I 1 vivitVivit
Ripetizione di una sequenza tra un periodo e lrsquoaltro di
una composizione ritornello Egrave un procedimento checonferisce unitagrave psicologica e tematica al testo poetico omusicale
Si ha rejet quando una parola si trova isolata allrsquoinizio diun verso pur facendo parte per il senso del verso prece-dente Es Virg Georg I 463 sol tibi signa dabit Solemquis dicere falsum audeat
Si ha quando si interrompe allrsquoimprovviso la frase la-sciandone tuttavia intendere il senso
Termine tedesco indicante la struttura laquoad anelloraquo dellacomposizione cioegrave basata sul ritorno alla fine di ele-menti che figuravano in principio
Canto eseguito durante un banchetto dai convitati chenel canto si cedono la parola in ordine laquoobliquoraquo dondeil nome
Vedi Giambico (senario)
Paragone fra due immagini introdotto da espressioni co-me ut ita talis qualis ceu ecc Es Virg Georg IV499 Dixit et ex oculis subito ceu fumus in auras com-mixtus tenuis fugit
Egrave quel genere di riunione maschile che in Grecia seguivail pasto serale ed era dedicata al bere al progetto politi-co e militare allrsquoeros allrsquoascolto della poesia e piugrave tardianche al discorso filosofico A simposio si riunivano grup-
pi legati da giuramento (eteriacutee) e costituiti sullrsquouguaglian-za dello stile di vita sulla coincidenza degli scopi politicisullrsquoomogeneitagrave culturale
Particolare tipo di metonimia anche con la sineddocheinfatti si ha la trasposizione da un significato proprio adaltro figurato in particolare in un rapporto di quantitagrave(parte per il tutto singolare per plurale ecc) Es Virg Aen II 276 vel Danaum Phrygios iaculatus puppibusignis dove puppes indica le navi
Consiste nellrsquoassociare piugrave termini appartenenti a perce-zioni sensoriali diverse (visive uditive tattili olfattive gu-stative) in unrsquounica espressione
Reduplicatio
Sinestesia
Sineddoche
Simposio (sympoacutesion )
Similitudine
Senario giambico
Scolio
Ringkomposition
Reticenza
Rejet
Refrain
Il Lord ha definito i laquotemiraquo della poesia orale comelaquogruppi di idee regolarmente usate nel raccontare unastoria nello stile formulaico del canto tradizionaleraquoNellrsquoOdissea le numerose descrizioni stereotipiche del-lrsquoaccoglienza ospitale offerta a un visitatore costituisconoun laquotemaraquo orale Nella narrativa germanica le descrizio-
ni in cui la schiera dei nobili si riunisce intorno al re abanchettare a bere e a vantarsi delle proprie gesta co-stituisce analogamente un laquotemaraquo di quella tradizione(R Scholes - R Kellogg)
Comunitagrave paideutico-cultuale femminile in parte simileallrsquoeterigravea maschile con finalitagrave educativa Qui le fanciulledi nobile famiglia compivano la loro educazione nellamusica nel canto nella danza nellrsquoarte di ornarsi e ve-stirsi in modo conforme al loro rango Era un ideale diperfezione da conseguire anche attraverso pratiche litur-giche incentrate sul culto di Afrodite
Si ha quando una parola composta viene separata neisuoi elementi attraverso lrsquointerposizione di altri elementiEs Virg Georg III 381 Hyperboreo septem subiecta trio-ni dove septemtrioni egrave separato in septem e trioni attra-verso lrsquointerposizione di subiecta
Canto funebre
Nella retorica classica i koinoacutei topoi (loci communes) eranoargomenti adatti ad essere sviluppati al servizio drsquouna tesiin vari generi di discorso Il loro assieme costituiva a dettadi Quintiliano la argomentorum sedes La memoria era in-fatti concepita come uno spazio nei cui luoghi (topoi loci )si situano le idee a questi luoghi ricorre lrsquooratore quandocerca argomenti adatti alle situazioni e alle parti del discor-so Nel Medioevo ndash estintisi il discorso politico e quello giu-diziario ndash la retorica estende lrsquouso dei topoi a tutti i tipi ditesto essi divengono dei clicheacutes di generale utilizzabilitagraveletteraria e si estendono a tutti i settori della vita che pos-sono essere abbracciati e modellati dalla letteratura Cosigravela retorica costituisce un magazzino vi si trovano le idee di
carattere piugrave generale tali da poter essere usate in tutti idiscorsi e gli scritti P Zumthor insiste sul carattere compo-sito dei topoi laquomateriali di reimpiego (come si potrebberodire per analogia le opere dellrsquoarchitettura romana) risul-tato di qualche bricolage arcaico i cui prodotti si sono apoco a poco arricchiti e affinati nello stesso tempo in cui siconsolidavanoraquo
Consiste nel collegare due o piugrave termini con un elementoche egrave appropriato per uno solo la forma di zeugma piugravefrequente fa dipendere da un unico verbo piugrave oggettiche richiederebbero ciascuno un verbo specifico Es Or
Carm I 1 19-21 Est qui nec veteris pocula Massici nec partem solido demere de die spernit dove spernit ha peroggetto sia pocula sia lrsquoinfinito demere
Tema
Zegraveugma
Topos
Treno
Tmesi
Tigraveaso

7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 48
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 334
Vedi Agraveition
Consiste nellrsquoaffidare al gioco dei suoni lrsquoevocazione diun oggetto o di unrsquoazione Es Virg Buc I 55 saepe levi somnum suadebit inire susurro in cui il ripetersi della si-
bilante evoca il ronzio delle api
Tecnica artigianale di composizione poetica propria dellrsquoe-pica omerica e della lirica arcaica basata sullrsquoassemblaggiodi laquoformuleraquo Si tratta di espressioni stereotipate (adesempio lrsquoaggettivo standard come laquoAchille piegrave veloceraquo olaquolrsquoAurora dalle dita-di-rosaraquo) metricamente e sintattica-mente definite che ricorrono invariate in diversi punti del-la stessa opera o di opere diverse Lo scopo era di agevola-re la memorizzazione nellrsquoambito di una cultura orale
Ripetizione immediata di una parola o di in gruppo di pa-role Es Plauto Miles 313 Sceledre Sceledre
Egrave formato da tre metri giambici corrisponde quindi al tri-metro giambico nome greco di questo verso Il senariolatino a differenza del trimetro giambico greco ammet-te alcune sostituzioni del giambo quali il tribraco (˘˘ ˘)[sostituzione razionale] lo spondeo ( 983215983215 ) il dattilo ( 983215˘˘)lrsquoanapesto (˘˘ 983215 ) il proceleusmatico (˘˘˘˘) [sostituzioni ir-razionali]Schema
˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute ˘ 983215 acute
Ter Adelf 1 Postqua m poe ta se nsit scrı ptura m sua m
Altri versi sonobull il settenario giambico ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ndash ˘bull lrsquoottonario giambico ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash ˘bull il dimetro giambico acatalettico ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute ˘ ndash acute
Egrave il metro di una forma di poesia diffusa nella IoniadrsquoAsia e insulare Egrave comunemente denominato laquotrimetrogiambicoraquo percheacute formato di tre laquometriraquo cioegrave di trecoppie di giambi Vedi giambico (senario) Lrsquoesecuzione
era affidata a un recitativo ( parakatalogheacute) con accom-pagnamento di aulo Caratterizza il giambo il gusto perla beffa lo scherno lrsquoinvettiva ma i contenuti sono vari(biografici didattici morali politici erotici)
Indica lrsquoespressione concisa di una veritagrave comunemente ac-cettata Le gnoacutemai piugrave famose erano quelle incise nel tem-pio di Delfi (ad esempio gnoacutethi sautoacuten laquoconosci te stessoraquo)
Vedi Climax
Parola che si trova attestata una volta sola o in un autoreo in unrsquoepoca o nellrsquointero sistema di una lingua
Eziologica (poesia)
Hapax (legoacutemenon)
Gradatio
Fonosimbolismo
Gnome
Giambo
Giambico (senario)
Geminatio
Formularitagrave
Inversione temporale di due avvenimenti cosigrave che si diceprima ciograve che logicamente dovrebbe essere detto dopoEs Virg Aen IV 6 s Postera Phoebea lustrabat lampadeterras umentemque Aurora polo dimoverat umbram
Dal gr eid yllion laquoquadrettoraquo definizione data in etagrave ro-mana alle composizioni di Teocrito che rappresentanoscene di vita rurale idealizzata
Canto eseguito nelle cerimonie nuziali
Termine usato per indicare la prima o le prime parole diun testo o di un verso il suo opposto egrave il termine explicit (vedi)
Canto di preghiera agli dei
Consiste nel porre una domanda in cui egrave implicita la ri-sposta stessa positiva o negativa Es Cic De leg I 14 42 si omnes Athenienses delectarentur tyrannicis legibusnum idcirco eae leges iustae haberentur
Secondo alcuni egrave un tipo di enallage quella piugrave frequen-te dellrsquoaggettivo secondo altri egrave da identificare conlrsquoenallage stessa Es Or Carm IV 7 19 manus avidas
heredis = manus avidi heredis
Consiste nel dividere gli elementi di uno stesso grupposintattico con lrsquoinserimento di altri cosigrave da porre in rilievole parti separate Es Or Epist I 8 1 Celso gaudere et bene rem gerere Albinovano
laquoEsagerazioneraquo nellrsquoesprimere un concetto oltre i limitidella verosimiglianza sia in piugrave che in meno Es Or SatI 9 10 s cum sudor ad imos manaret talos
Figura con la quale si dice il contrario di ciograve che si vuolefar intendere Es Virg Aen IV 379 s Scilicet is superislabor est ea cura quietos sollicitat
Vedi Lira
Sappiamo che oggi egrave impossibile leggere i versi latini co-me li leggevano gli antichi dato che noi non percepiamogli stessi elementi di ritmo che essi percepivano (quantitagraveecc) Per evitare tuttavia di perdere completamente il
senso del ritmo poetico leggendo la poesia come la pro-sa scegliamo di laquoutilizzare un ldquonostrordquo normale trattodistintivo (lrsquoaccento tonico) come sostitutivo consapevol-
Hysteron proteron
Lettura metrica (dei versi)
Kiacutetharis
Ironia
Iperbole
Ipegraverbato
Ipagravellage
Interrogazione retorica
Inno
Idillio
Imeneacuteo
Incipit (laquocominciaraquo)
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 58
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 335
mente assunto a puro valore simbolico di un tratto di-stintivo che il nostro sistema linguistico non possiederaquo(Milanese) Poniamo perciograve un apice ( acute ) sulle sillabe chefungono da laquoelementi-guidaraquo e le leggiamo con il nostrotipo di accento che egrave accento intensivo In tal modo use-remo in piena consapevolezza una lettura convenziona-le che laquoanche se non riproduce quella degli antichi con-
serva almeno in parte e ci permette di percepire i trattifondamentali dei ritmi originari trasponendoli in modulia noi accessibiliraquo (Scialuga)
La lira era lo strumento tipico dellrsquoaedo omerico Avevacorde verticali di uguale lunghezza ricavate da budello otendini di animali che venivano pizzicate con la mano si-nistra e percosse col pleacutektron il plettro appunto tenutonella mano destra Alla base un guscio di tartaruga euna struttura lignea fungevano da cassa di risonanzaOgni corda veniva accordata e produceva una sola notaLa phoacuterminx o kiacutetharis egrave una lira molto semplice dotata
forse di sole tre o cinque corde A Terpandro (VII secaC) si deve lrsquointroduzione di sette corde
Per gli antichi indica la poesia cantata con accompagna-mento della lira o altri strumenti a corda (kiacutetharis baacuterbi-ton phoacutermings ecc) Si distingueva dallrsquoelegia e dal giambo forme poetiche accompagnate da strumenti afiato come lrsquoaulo La lirica monodica consisteva in unlaquocanto a soloraquo la lirica corale era eseguita da un corodanzante o da un solista a cui rispondeva un coro
Consiste nellrsquoaffermare un concetto attraverso la nega-zione del suo contrario Es Lucr VI 1250 Nec poterat quisquam reperiri
Fu definita anticamente come laquoparagone abbreviatoraquo inquanto opera sulla base della similaritagrave individuando unelemento di intersezione fra due termini si opera cosigrave unospostamento da un significato proprio ad uno figurato EsPlauto Miles 987 Quae haec celox laquoqual egrave questa barcaveloceraquo dove con celox si indica lrsquoancella veloce comeuna nave leggera (lrsquoelemento di intersezione egrave dato dalla
velocitagrave comune sia allrsquoancella sia alla nave leggera)
Figura retorica che opera sulla base della contiguitagrave con-cettuale (spaziale causale temporale ecc) si sostituiscecioegrave un termine con un altro operando uno spostamentoda un campo semantico ad altro vicino Es Catullo 8 3 fulsere quondam candidi tibi soles dove soles sta per dies
Vedi Catulliani (metri)
Orazio usograve lrsquoesametro nelle Satire e nelle Epistole men-tre nelle Odi traspose i versi eolici della lirica greca Taleoperazione iniziata dai poetae novi fu condotta siste-
Metri oraziani
Metri catulliani
Metonimia
Metafora
Litote
Lirica
Lira
maticamente da Orazio che volle ricreare nella lirica lati-na i ritmi e lo spirito dei modelli greci Caratteristicheprincipali dei versi della lirica eolica erano lrsquoisosillabismo ela base libera Orazio adattandoli meglio alla sensibilitagraveritmica dei Romani apportograve qualche modificazione qua-li la sostituzione delle sillabe di quantitagrave variabile con sil-labe lunghe e lrsquointroduzione di cesure fisse
Riportiamo lo schema dei versi e delle strofe usati daOrazio nei carmi presenti nellrsquoantologia rinunciando aduna loro descrizione in base ai piedi usati date le diverseinterpretazioni a riguardo
Asclepiadei minori
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Or Carm III 30 E acute xegı monumentum aere perenniusregal ıque situ pyramidum altiusquod non ımber edax non aquilo ımpotens possit dıruere aut ınnumerabilis
Asclepiadei m aggiori
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Or Carm I 11 1-4Tu ne quaesierıs | scı re nefas | quem mihi quem tibi fı nem dı dederınt | Leuconoe | nec Babyloniostemptarıs numeros | U acute t melius | quıcquid erıt patiSeu plures hiemes | seu tribuıt | Iuppiter ultimam
Lrsquoasclepiadeo maggiore e lrsquoasclepiadeo minore si posso-no trovare come negli esempi riportati usati stichica-mente (in greco stı chos laquoversoraquo) vale a dire in serie op-pure variamente combinati nelle strofe asclepiadee (I IIIII IV V) con il gliconeo e il ferecrateo
Gliconeo
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Ferecrateo
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215
Egrave presente nellrsquoantologia la strofe asclepiadea III
Strofe asclepiadea III
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ 983215983215 acute ˘ 983215 ˘ asclepiadeo minore 983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘ asclepiadeo minore
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ferecrateo
macr 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘ gliconeo
Or Carm III 13 1-4O fons Bandusiae | splendidior vitrodulci dıgne mero | non sine floribuscras donaberis haedocuı frons turgida cornibus
Lrsquoelemento ritmico del verso latino egrave costituito dal ripe-
tersi regolare di successioni di sillabe brevi e sillabe lun-ghe Quando queste successioni obbediscono a schemiprecisi fornendo determinate figure metriche si hanno
Metrica
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 68
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 336
delle cellule ritmiche elementari dette tradizionalmentepiediI piedi principali sono i seguentitrocheo
983215 tribraco
˘ ˘ ˘giambo
˘ 983215 spondeo
983215 983215dattilo 983215 ˘anapesto
˘ ˘ 983215 proceleusmatico
˘ ˘ ˘ ˘cretico
983215 983215 coriambo
983215 ˘ 983215
Significa laquoimitazioneraquo e designa il modo drsquointendere lapoesia e lrsquoarte degli autori antichi Per Simonide (VI-Vsec aC) la poesia egrave una laquoimmagine della cosaraquo unrsquoimi-tazione anche di emozioni e stati drsquoanimo Ogni formadrsquoarte sia essa poetica pittorica musicale o coreutica egravesentita dai greci come imitazione e gli artisti sono tutti
considerati laquoimitatoriraquo da Platone (Rep 373b)
laquoI miti sono narrazioni tramandate dalla tradizione percheacutecontengono valori importanti per la comunitagrave o percheacute co-stituiscono racconti di particolare rilevanza narrativaraquo(Howatson) Se si riferiscono a personaggi reali che hannooperato in luoghi reali e riportano gli eventi in forma ab-bastanza realistica (ad esempio le vicende dei sette re diRoma) si possono definire leggende I contenuti del mitosono vari e possono riguardare lrsquoorgine del mondo e dellaTerra le forme del culto le istituzioni degli uomini Hannocarattere laquoapertoraquo nel senso che si prestano a essere nar-rati secondo varie versioni e ad accogliere mille inserimentie variazioni Costituiscono lrsquoantefatto della storiografia (apartire dalle genealogie mitiche di dei e eroi) ma anchedella scienza e della filosofia (a partire dai grandi miti co-smologici) Le maggiori fonti mitiche sono per noi OmeroEsiodo ma anche i poeti ellenistici come Callimaco per iquali il mito per lo piugrave ripreso in una variante poco notadiviene un ornamento prezioso della narrazione LeMetamorfosi di Ovidio furono il maggiore veicolo di tra-smissione del patrimonio mitico antico nei secoliCome sostiene lrsquoantropologo Altan lrsquoesperienza mitica egravefondamentale per le popolazioni antiche e preletterate
immuni dagli effetti indotti nei ceti colti dal razionali-smo greco e presso le quali le operazioni canoniche delpensiero definito razionale (classificazione numerazio-ne spazialitagrave temporalitagrave causalitagrave) assumono conno-tati diversi da quelli assunti nella tradizione occidentaleLrsquoaffermazione del pensiero razionale ha comportatoche il mito divenisse sinonimo di menzogna Il terminem acute ythos originariamente non antitetico rispetto a logos(con cui poteva coesistere nel composto mythologialaquocomplesso di raccontiraquo) in seguito agli sviluppi della fi-losofia greca diviene lrsquoopposto del logos o discorso ra-zionale e il mito egrave confinato nella sfera della pre-razio-nalitagrave anzi dellrsquoirrazionalitagrave considerato antitetico alla
scienza retaggio di tempi oscuri dominati dalla paura edalla superstizione In realtagrave secondo le vedute piugrave re-centi il mito era la forma del sapere collettivo dei popo-
Mito
Migravemesi
li prestorici Nel loro orizzonte culturale laquoil patrimonio disapere collettivo economico tecnologico politico so-ciale e religioso in cui si articola la cultura si manifestaglobalmente come mitologia nella quale sono ancorafra loro indistinte quelle forme che storicamente assu-meranno un significato autonomo nelle diverse specia-lizzazioni disciplinari proprie della cultura in senso mo-
derno occidentaleraquo (Altan)
Studio dei miti ma anche complesso dei miti di una cer-ta cultura o epoca
Figlie di Zeus e Mnemogravesine la dea della memoria Nei poe-mi omerici dove allietano i banchetti degli dei sono in unnumero imprecisato che perograve giagrave alla fine dellrsquoOdissea(XXIV 60) si precisa in nove numero che con la Teogonia diEsiodo diviene definitivo Esiodo ne elenca anche i nomi eassegna loro la funzione che saragrave canonica di ispirare i
poeti nella composizione di un poema Le specifiche funzio-ni delle Muse si preciseranno solo in etagrave ellenistica Calligraveopesaragrave preposta allrsquoepica Clio alla storia Melpogravemene allapoesia tragica Eutegraverpe alla musica col flauto Egraverato allapoesia lirica Tersigravecore alla lirica corale e alla danza Uragraveniaallrsquoastronomia Taligravea alla commedia Poligravemnia alla pantomi-ma Le sedi di culto delle Muse piugrave famose furono la Piegraveriaai piedi dellrsquoOlimpo e Ascra in Beozia
Nella poesia greca arcaica la mousikeacute egrave la poesia intesacome connubio di parole e musica La musica era parteintegrante della vita sociale greca Quasi ogni forma poe-tica era accompagnata dalla musica La rilevanza eticadella musica era sostenuta da Platone convinto che lamusica influenzasse in modo permanente il carattere e leattitudini dellrsquouomo e da Aristotele
Da odeacute laquocantoraquo Composizione lirica di forma metrica estrofica varia A Roma si usograve il termine carmen
Egrave un tipo di omoteleuto che si ha quando piugrave parole hannola stessa terminazione derivante da uguali forme di flessione
Ripetizione dello stesso suono alla fine di piugrave parole vici-ne della stessa frase Es Virg Buc IV 50 s Aspice con-vexo nutantem pondere mundum terrasque tractusquemaris caelumque profundum dove i due versi terminanocon lo stesso suono
Formazione di un vocabolo il cui suono imita un rumorenaturale Es Plauto Miles 311 mussitabo il verbo mussitolaquoborbottareraquo riprende il suono mu del borbottio delparlare sommessamente
Vedi Metri orazianiOraziani (metri)
Onomatopea
Omoteleuto
Omeoptoto
Ode
Musica
Muse
Mitologia
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 78
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 337
Accostamento di parole di senso opposto Es Or Ep I11 28 strenua inertia
Festivitagrave pubblica a sfondo religioso durante la quale sisvolgevano gare poetiche e musicali
Letteralmente laquoscherziraquo Poesie di carattere privato edisimpegnato di mero intrattenimento tipiche della cultu-ra ellenistica A Roma scrissero paacuteignia (latinamente nu- gae) soprattutto i poeti del circolo neoterico ( poetae novi )
Vedi Lira
Si ha quando gli elementi di due o piugrave frasi sono dispostinello stesso ordine cosigrave da corrispondersi simmetrica-mente Es Sall BC 5 4 cuius lubet rei simulator ac dis- simulator alieni adpetens sui profusus
Consiste nellrsquoaccostare due parole di suono simile ma disignificato diverso Es Catullo 3 13 At vobis male sitmalae tenebrae
Canto intonato da un coro di fanciulle
Termine della retorica greca indicante il carattere dipassionalitagrave e drammaticitagrave proprio dellrsquoepica e dellatragedia Secondo N Frye il pathos egrave la lotta mortaledellrsquoeroe
Canto dedicato ad Apollo
Il pentametro egrave un verso mai usato da solo formato dal-lrsquounione di due metagrave versi (emistichi ) separate da una pau-sa fissa una dieresi ciascuna delle quali egrave composta di duedattili e mezzo Sono quindi sei piedi dattilici catalettici in
syllabam che terminano cioegrave con una sola sillaba Nellaprima metagrave al posto dei dattili si possono trovare deglispondei nella seconda non sono possibili sostituzioniSchema
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute 983215 acute ˘˘ 983215 acute ˘˘ 983215 ˘
Catullo 85Odi et amo | Quare id faciam | fortasse requiris Nescio sed fieri | sentio et excrucior
Termine inglese impiegato di frequente per indicare laprestazione artistica del poeta lirico o epico
Si ha quando per evitare di designare una persona o didire una cosa direttamente si usa un giro di parole
Ossimoro
Perifrasi
Performance
Pentametro
Peana
Pathos
Partenio
Paronomasia
Parallelismo
Phoacuterminx
Paacuteignia
Paneg yris
Egrave il personaggio che nella lirica si esprime in prima perso-na Non necessariamente coincide con lrsquoio dellrsquoautore
Da poikiacutello laquorendo varioraquo Egrave la capacitagrave del poeta di va-riare a tempo debito in rapporto allrsquooccasione toni temi
strutture metriche del canto soddisfacendo alle attese dichi ascolta
Egrave la laquopuntaraquo cioegrave il finale arguto e inatteso soprattuttodellrsquoepigramma ( fulmen in clausula)
Ripetizione di una stessa parola espressa a breve distanzain piugrave casi grammaticali Es Catullo 2 2 s quicum lude-re quem in sinu tenere cui
Si ha quando piugrave elementi di una frase o piugrave frasi sonouniti da piugrave congiunzioni Es Sall BC 3 1 et qui fecereet qui scripsere
Figura con la quale si dice sia pure brevemente una cosache al contempo si dichiara di non voler dire Es Cic CatI 3 Nam illa nimis antiqua praetereo quod C Servilius
Termine della filologia tedesca (dal lat praeambulum) Egraveuno schema retorico consistente nella rassegna degli al-
trui generi di vita cui egrave contrapposto il proprio del qualesi rivendica la superiore validitagrave Cosigrave ad esempio Saffocontrapponendosi allrsquoopinione dominante sostiene chela cosa piugrave bella non sono le flotte e gli eserciti malaquoquello che ognuno amaraquo
Tipo di esordio tipico del poema epico Il proemio poeticosecondo alcuni autori sembra sovrapponibile allrsquoexordiumdei genera dicendi Questo oltre al compito ovvio di ini-ziare (exordium est principium orationis Rhet Her 1 34) ha il compito di disporre favorevolmente lrsquouditorio neiconfronti dellrsquooratore e dellrsquoargomento ( per quod [= exor-
dium] animus auditoris constituitur ad audiendum)
Figura mediante la quale si fa parlare come se fosse pre-sente un personaggio lontano o defunto o la personifica-zione di cosa inanimata o astratta Es Cic Pro Caelio laprosopopea di Appio Claudio Cieco Cic Cat I 17-18 e27-29 la prosopopea della patria
Proemio dei poemi classici comprendente la presentazio-ne dellrsquoargomento lrsquoinvocazione alla Musa eventual-mente la dedica
Egrave il poeta epico o lirico inteso come laquocucitore di cantiraquo
Persona loquens
Rapsogravedo (rhapsodoacutes)
Protasi
Prosopopea
Proemio
Priagravemel
Preterizione
Polisindeto
Poliptoto
Pointe
Poikiliacutea
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 88
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 338
Ripetizione di una o piugrave parole conclusive della frase pre-cedente in quella seguente Es Cic Cat I 1 vivitVivit
Ripetizione di una sequenza tra un periodo e lrsquoaltro di
una composizione ritornello Egrave un procedimento checonferisce unitagrave psicologica e tematica al testo poetico omusicale
Si ha rejet quando una parola si trova isolata allrsquoinizio diun verso pur facendo parte per il senso del verso prece-dente Es Virg Georg I 463 sol tibi signa dabit Solemquis dicere falsum audeat
Si ha quando si interrompe allrsquoimprovviso la frase la-sciandone tuttavia intendere il senso
Termine tedesco indicante la struttura laquoad anelloraquo dellacomposizione cioegrave basata sul ritorno alla fine di ele-menti che figuravano in principio
Canto eseguito durante un banchetto dai convitati chenel canto si cedono la parola in ordine laquoobliquoraquo dondeil nome
Vedi Giambico (senario)
Paragone fra due immagini introdotto da espressioni co-me ut ita talis qualis ceu ecc Es Virg Georg IV499 Dixit et ex oculis subito ceu fumus in auras com-mixtus tenuis fugit
Egrave quel genere di riunione maschile che in Grecia seguivail pasto serale ed era dedicata al bere al progetto politi-co e militare allrsquoeros allrsquoascolto della poesia e piugrave tardianche al discorso filosofico A simposio si riunivano grup-
pi legati da giuramento (eteriacutee) e costituiti sullrsquouguaglian-za dello stile di vita sulla coincidenza degli scopi politicisullrsquoomogeneitagrave culturale
Particolare tipo di metonimia anche con la sineddocheinfatti si ha la trasposizione da un significato proprio adaltro figurato in particolare in un rapporto di quantitagrave(parte per il tutto singolare per plurale ecc) Es Virg Aen II 276 vel Danaum Phrygios iaculatus puppibusignis dove puppes indica le navi
Consiste nellrsquoassociare piugrave termini appartenenti a perce-zioni sensoriali diverse (visive uditive tattili olfattive gu-stative) in unrsquounica espressione
Reduplicatio
Sinestesia
Sineddoche
Simposio (sympoacutesion )
Similitudine
Senario giambico
Scolio
Ringkomposition
Reticenza
Rejet
Refrain
Il Lord ha definito i laquotemiraquo della poesia orale comelaquogruppi di idee regolarmente usate nel raccontare unastoria nello stile formulaico del canto tradizionaleraquoNellrsquoOdissea le numerose descrizioni stereotipiche del-lrsquoaccoglienza ospitale offerta a un visitatore costituisconoun laquotemaraquo orale Nella narrativa germanica le descrizio-
ni in cui la schiera dei nobili si riunisce intorno al re abanchettare a bere e a vantarsi delle proprie gesta co-stituisce analogamente un laquotemaraquo di quella tradizione(R Scholes - R Kellogg)
Comunitagrave paideutico-cultuale femminile in parte simileallrsquoeterigravea maschile con finalitagrave educativa Qui le fanciulledi nobile famiglia compivano la loro educazione nellamusica nel canto nella danza nellrsquoarte di ornarsi e ve-stirsi in modo conforme al loro rango Era un ideale diperfezione da conseguire anche attraverso pratiche litur-giche incentrate sul culto di Afrodite
Si ha quando una parola composta viene separata neisuoi elementi attraverso lrsquointerposizione di altri elementiEs Virg Georg III 381 Hyperboreo septem subiecta trio-ni dove septemtrioni egrave separato in septem e trioni attra-verso lrsquointerposizione di subiecta
Canto funebre
Nella retorica classica i koinoacutei topoi (loci communes) eranoargomenti adatti ad essere sviluppati al servizio drsquouna tesiin vari generi di discorso Il loro assieme costituiva a dettadi Quintiliano la argomentorum sedes La memoria era in-fatti concepita come uno spazio nei cui luoghi (topoi loci )si situano le idee a questi luoghi ricorre lrsquooratore quandocerca argomenti adatti alle situazioni e alle parti del discor-so Nel Medioevo ndash estintisi il discorso politico e quello giu-diziario ndash la retorica estende lrsquouso dei topoi a tutti i tipi ditesto essi divengono dei clicheacutes di generale utilizzabilitagraveletteraria e si estendono a tutti i settori della vita che pos-sono essere abbracciati e modellati dalla letteratura Cosigravela retorica costituisce un magazzino vi si trovano le idee di
carattere piugrave generale tali da poter essere usate in tutti idiscorsi e gli scritti P Zumthor insiste sul carattere compo-sito dei topoi laquomateriali di reimpiego (come si potrebberodire per analogia le opere dellrsquoarchitettura romana) risul-tato di qualche bricolage arcaico i cui prodotti si sono apoco a poco arricchiti e affinati nello stesso tempo in cui siconsolidavanoraquo
Consiste nel collegare due o piugrave termini con un elementoche egrave appropriato per uno solo la forma di zeugma piugravefrequente fa dipendere da un unico verbo piugrave oggettiche richiederebbero ciascuno un verbo specifico Es Or
Carm I 1 19-21 Est qui nec veteris pocula Massici nec partem solido demere de die spernit dove spernit ha peroggetto sia pocula sia lrsquoinfinito demere
Tema
Zegraveugma
Topos
Treno
Tmesi
Tigraveaso

7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 58
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 335
mente assunto a puro valore simbolico di un tratto di-stintivo che il nostro sistema linguistico non possiederaquo(Milanese) Poniamo perciograve un apice ( acute ) sulle sillabe chefungono da laquoelementi-guidaraquo e le leggiamo con il nostrotipo di accento che egrave accento intensivo In tal modo use-remo in piena consapevolezza una lettura convenziona-le che laquoanche se non riproduce quella degli antichi con-
serva almeno in parte e ci permette di percepire i trattifondamentali dei ritmi originari trasponendoli in modulia noi accessibiliraquo (Scialuga)
La lira era lo strumento tipico dellrsquoaedo omerico Avevacorde verticali di uguale lunghezza ricavate da budello otendini di animali che venivano pizzicate con la mano si-nistra e percosse col pleacutektron il plettro appunto tenutonella mano destra Alla base un guscio di tartaruga euna struttura lignea fungevano da cassa di risonanzaOgni corda veniva accordata e produceva una sola notaLa phoacuterminx o kiacutetharis egrave una lira molto semplice dotata
forse di sole tre o cinque corde A Terpandro (VII secaC) si deve lrsquointroduzione di sette corde
Per gli antichi indica la poesia cantata con accompagna-mento della lira o altri strumenti a corda (kiacutetharis baacuterbi-ton phoacutermings ecc) Si distingueva dallrsquoelegia e dal giambo forme poetiche accompagnate da strumenti afiato come lrsquoaulo La lirica monodica consisteva in unlaquocanto a soloraquo la lirica corale era eseguita da un corodanzante o da un solista a cui rispondeva un coro
Consiste nellrsquoaffermare un concetto attraverso la nega-zione del suo contrario Es Lucr VI 1250 Nec poterat quisquam reperiri
Fu definita anticamente come laquoparagone abbreviatoraquo inquanto opera sulla base della similaritagrave individuando unelemento di intersezione fra due termini si opera cosigrave unospostamento da un significato proprio ad uno figurato EsPlauto Miles 987 Quae haec celox laquoqual egrave questa barcaveloceraquo dove con celox si indica lrsquoancella veloce comeuna nave leggera (lrsquoelemento di intersezione egrave dato dalla
velocitagrave comune sia allrsquoancella sia alla nave leggera)
Figura retorica che opera sulla base della contiguitagrave con-cettuale (spaziale causale temporale ecc) si sostituiscecioegrave un termine con un altro operando uno spostamentoda un campo semantico ad altro vicino Es Catullo 8 3 fulsere quondam candidi tibi soles dove soles sta per dies
Vedi Catulliani (metri)
Orazio usograve lrsquoesametro nelle Satire e nelle Epistole men-tre nelle Odi traspose i versi eolici della lirica greca Taleoperazione iniziata dai poetae novi fu condotta siste-
Metri oraziani
Metri catulliani
Metonimia
Metafora
Litote
Lirica
Lira
maticamente da Orazio che volle ricreare nella lirica lati-na i ritmi e lo spirito dei modelli greci Caratteristicheprincipali dei versi della lirica eolica erano lrsquoisosillabismo ela base libera Orazio adattandoli meglio alla sensibilitagraveritmica dei Romani apportograve qualche modificazione qua-li la sostituzione delle sillabe di quantitagrave variabile con sil-labe lunghe e lrsquointroduzione di cesure fisse
Riportiamo lo schema dei versi e delle strofe usati daOrazio nei carmi presenti nellrsquoantologia rinunciando aduna loro descrizione in base ai piedi usati date le diverseinterpretazioni a riguardo
Asclepiadei minori
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Or Carm III 30 E acute xegı monumentum aere perenniusregal ıque situ pyramidum altiusquod non ımber edax non aquilo ımpotens possit dıruere aut ınnumerabilis
Asclepiadei m aggiori
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Or Carm I 11 1-4Tu ne quaesierıs | scı re nefas | quem mihi quem tibi fı nem dı dederınt | Leuconoe | nec Babyloniostemptarıs numeros | U acute t melius | quıcquid erıt patiSeu plures hiemes | seu tribuıt | Iuppiter ultimam
Lrsquoasclepiadeo maggiore e lrsquoasclepiadeo minore si posso-no trovare come negli esempi riportati usati stichica-mente (in greco stı chos laquoversoraquo) vale a dire in serie op-pure variamente combinati nelle strofe asclepiadee (I IIIII IV V) con il gliconeo e il ferecrateo
Gliconeo
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘
Ferecrateo
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215
Egrave presente nellrsquoantologia la strofe asclepiadea III
Strofe asclepiadea III
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ 983215983215 acute ˘ 983215 ˘ asclepiadeo minore 983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘ asclepiadeo minore
983215 acute 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ferecrateo
macr 983215 983215 acute ˘ ˘ 983215 acute ˘ 983215 ˘ gliconeo
Or Carm III 13 1-4O fons Bandusiae | splendidior vitrodulci dıgne mero | non sine floribuscras donaberis haedocuı frons turgida cornibus
Lrsquoelemento ritmico del verso latino egrave costituito dal ripe-
tersi regolare di successioni di sillabe brevi e sillabe lun-ghe Quando queste successioni obbediscono a schemiprecisi fornendo determinate figure metriche si hanno
Metrica
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 68
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 336
delle cellule ritmiche elementari dette tradizionalmentepiediI piedi principali sono i seguentitrocheo
983215 tribraco
˘ ˘ ˘giambo
˘ 983215 spondeo
983215 983215dattilo 983215 ˘anapesto
˘ ˘ 983215 proceleusmatico
˘ ˘ ˘ ˘cretico
983215 983215 coriambo
983215 ˘ 983215
Significa laquoimitazioneraquo e designa il modo drsquointendere lapoesia e lrsquoarte degli autori antichi Per Simonide (VI-Vsec aC) la poesia egrave una laquoimmagine della cosaraquo unrsquoimi-tazione anche di emozioni e stati drsquoanimo Ogni formadrsquoarte sia essa poetica pittorica musicale o coreutica egravesentita dai greci come imitazione e gli artisti sono tutti
considerati laquoimitatoriraquo da Platone (Rep 373b)
laquoI miti sono narrazioni tramandate dalla tradizione percheacutecontengono valori importanti per la comunitagrave o percheacute co-stituiscono racconti di particolare rilevanza narrativaraquo(Howatson) Se si riferiscono a personaggi reali che hannooperato in luoghi reali e riportano gli eventi in forma ab-bastanza realistica (ad esempio le vicende dei sette re diRoma) si possono definire leggende I contenuti del mitosono vari e possono riguardare lrsquoorgine del mondo e dellaTerra le forme del culto le istituzioni degli uomini Hannocarattere laquoapertoraquo nel senso che si prestano a essere nar-rati secondo varie versioni e ad accogliere mille inserimentie variazioni Costituiscono lrsquoantefatto della storiografia (apartire dalle genealogie mitiche di dei e eroi) ma anchedella scienza e della filosofia (a partire dai grandi miti co-smologici) Le maggiori fonti mitiche sono per noi OmeroEsiodo ma anche i poeti ellenistici come Callimaco per iquali il mito per lo piugrave ripreso in una variante poco notadiviene un ornamento prezioso della narrazione LeMetamorfosi di Ovidio furono il maggiore veicolo di tra-smissione del patrimonio mitico antico nei secoliCome sostiene lrsquoantropologo Altan lrsquoesperienza mitica egravefondamentale per le popolazioni antiche e preletterate
immuni dagli effetti indotti nei ceti colti dal razionali-smo greco e presso le quali le operazioni canoniche delpensiero definito razionale (classificazione numerazio-ne spazialitagrave temporalitagrave causalitagrave) assumono conno-tati diversi da quelli assunti nella tradizione occidentaleLrsquoaffermazione del pensiero razionale ha comportatoche il mito divenisse sinonimo di menzogna Il terminem acute ythos originariamente non antitetico rispetto a logos(con cui poteva coesistere nel composto mythologialaquocomplesso di raccontiraquo) in seguito agli sviluppi della fi-losofia greca diviene lrsquoopposto del logos o discorso ra-zionale e il mito egrave confinato nella sfera della pre-razio-nalitagrave anzi dellrsquoirrazionalitagrave considerato antitetico alla
scienza retaggio di tempi oscuri dominati dalla paura edalla superstizione In realtagrave secondo le vedute piugrave re-centi il mito era la forma del sapere collettivo dei popo-
Mito
Migravemesi
li prestorici Nel loro orizzonte culturale laquoil patrimonio disapere collettivo economico tecnologico politico so-ciale e religioso in cui si articola la cultura si manifestaglobalmente come mitologia nella quale sono ancorafra loro indistinte quelle forme che storicamente assu-meranno un significato autonomo nelle diverse specia-lizzazioni disciplinari proprie della cultura in senso mo-
derno occidentaleraquo (Altan)
Studio dei miti ma anche complesso dei miti di una cer-ta cultura o epoca
Figlie di Zeus e Mnemogravesine la dea della memoria Nei poe-mi omerici dove allietano i banchetti degli dei sono in unnumero imprecisato che perograve giagrave alla fine dellrsquoOdissea(XXIV 60) si precisa in nove numero che con la Teogonia diEsiodo diviene definitivo Esiodo ne elenca anche i nomi eassegna loro la funzione che saragrave canonica di ispirare i
poeti nella composizione di un poema Le specifiche funzio-ni delle Muse si preciseranno solo in etagrave ellenistica Calligraveopesaragrave preposta allrsquoepica Clio alla storia Melpogravemene allapoesia tragica Eutegraverpe alla musica col flauto Egraverato allapoesia lirica Tersigravecore alla lirica corale e alla danza Uragraveniaallrsquoastronomia Taligravea alla commedia Poligravemnia alla pantomi-ma Le sedi di culto delle Muse piugrave famose furono la Piegraveriaai piedi dellrsquoOlimpo e Ascra in Beozia
Nella poesia greca arcaica la mousikeacute egrave la poesia intesacome connubio di parole e musica La musica era parteintegrante della vita sociale greca Quasi ogni forma poe-tica era accompagnata dalla musica La rilevanza eticadella musica era sostenuta da Platone convinto che lamusica influenzasse in modo permanente il carattere e leattitudini dellrsquouomo e da Aristotele
Da odeacute laquocantoraquo Composizione lirica di forma metrica estrofica varia A Roma si usograve il termine carmen
Egrave un tipo di omoteleuto che si ha quando piugrave parole hannola stessa terminazione derivante da uguali forme di flessione
Ripetizione dello stesso suono alla fine di piugrave parole vici-ne della stessa frase Es Virg Buc IV 50 s Aspice con-vexo nutantem pondere mundum terrasque tractusquemaris caelumque profundum dove i due versi terminanocon lo stesso suono
Formazione di un vocabolo il cui suono imita un rumorenaturale Es Plauto Miles 311 mussitabo il verbo mussitolaquoborbottareraquo riprende il suono mu del borbottio delparlare sommessamente
Vedi Metri orazianiOraziani (metri)
Onomatopea
Omoteleuto
Omeoptoto
Ode
Musica
Muse
Mitologia
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 78
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 337
Accostamento di parole di senso opposto Es Or Ep I11 28 strenua inertia
Festivitagrave pubblica a sfondo religioso durante la quale sisvolgevano gare poetiche e musicali
Letteralmente laquoscherziraquo Poesie di carattere privato edisimpegnato di mero intrattenimento tipiche della cultu-ra ellenistica A Roma scrissero paacuteignia (latinamente nu- gae) soprattutto i poeti del circolo neoterico ( poetae novi )
Vedi Lira
Si ha quando gli elementi di due o piugrave frasi sono dispostinello stesso ordine cosigrave da corrispondersi simmetrica-mente Es Sall BC 5 4 cuius lubet rei simulator ac dis- simulator alieni adpetens sui profusus
Consiste nellrsquoaccostare due parole di suono simile ma disignificato diverso Es Catullo 3 13 At vobis male sitmalae tenebrae
Canto intonato da un coro di fanciulle
Termine della retorica greca indicante il carattere dipassionalitagrave e drammaticitagrave proprio dellrsquoepica e dellatragedia Secondo N Frye il pathos egrave la lotta mortaledellrsquoeroe
Canto dedicato ad Apollo
Il pentametro egrave un verso mai usato da solo formato dal-lrsquounione di due metagrave versi (emistichi ) separate da una pau-sa fissa una dieresi ciascuna delle quali egrave composta di duedattili e mezzo Sono quindi sei piedi dattilici catalettici in
syllabam che terminano cioegrave con una sola sillaba Nellaprima metagrave al posto dei dattili si possono trovare deglispondei nella seconda non sono possibili sostituzioniSchema
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute 983215 acute ˘˘ 983215 acute ˘˘ 983215 ˘
Catullo 85Odi et amo | Quare id faciam | fortasse requiris Nescio sed fieri | sentio et excrucior
Termine inglese impiegato di frequente per indicare laprestazione artistica del poeta lirico o epico
Si ha quando per evitare di designare una persona o didire una cosa direttamente si usa un giro di parole
Ossimoro
Perifrasi
Performance
Pentametro
Peana
Pathos
Partenio
Paronomasia
Parallelismo
Phoacuterminx
Paacuteignia
Paneg yris
Egrave il personaggio che nella lirica si esprime in prima perso-na Non necessariamente coincide con lrsquoio dellrsquoautore
Da poikiacutello laquorendo varioraquo Egrave la capacitagrave del poeta di va-riare a tempo debito in rapporto allrsquooccasione toni temi
strutture metriche del canto soddisfacendo alle attese dichi ascolta
Egrave la laquopuntaraquo cioegrave il finale arguto e inatteso soprattuttodellrsquoepigramma ( fulmen in clausula)
Ripetizione di una stessa parola espressa a breve distanzain piugrave casi grammaticali Es Catullo 2 2 s quicum lude-re quem in sinu tenere cui
Si ha quando piugrave elementi di una frase o piugrave frasi sonouniti da piugrave congiunzioni Es Sall BC 3 1 et qui fecereet qui scripsere
Figura con la quale si dice sia pure brevemente una cosache al contempo si dichiara di non voler dire Es Cic CatI 3 Nam illa nimis antiqua praetereo quod C Servilius
Termine della filologia tedesca (dal lat praeambulum) Egraveuno schema retorico consistente nella rassegna degli al-
trui generi di vita cui egrave contrapposto il proprio del qualesi rivendica la superiore validitagrave Cosigrave ad esempio Saffocontrapponendosi allrsquoopinione dominante sostiene chela cosa piugrave bella non sono le flotte e gli eserciti malaquoquello che ognuno amaraquo
Tipo di esordio tipico del poema epico Il proemio poeticosecondo alcuni autori sembra sovrapponibile allrsquoexordiumdei genera dicendi Questo oltre al compito ovvio di ini-ziare (exordium est principium orationis Rhet Her 1 34) ha il compito di disporre favorevolmente lrsquouditorio neiconfronti dellrsquooratore e dellrsquoargomento ( per quod [= exor-
dium] animus auditoris constituitur ad audiendum)
Figura mediante la quale si fa parlare come se fosse pre-sente un personaggio lontano o defunto o la personifica-zione di cosa inanimata o astratta Es Cic Pro Caelio laprosopopea di Appio Claudio Cieco Cic Cat I 17-18 e27-29 la prosopopea della patria
Proemio dei poemi classici comprendente la presentazio-ne dellrsquoargomento lrsquoinvocazione alla Musa eventual-mente la dedica
Egrave il poeta epico o lirico inteso come laquocucitore di cantiraquo
Persona loquens
Rapsogravedo (rhapsodoacutes)
Protasi
Prosopopea
Proemio
Priagravemel
Preterizione
Polisindeto
Poliptoto
Pointe
Poikiliacutea
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 88
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 338
Ripetizione di una o piugrave parole conclusive della frase pre-cedente in quella seguente Es Cic Cat I 1 vivitVivit
Ripetizione di una sequenza tra un periodo e lrsquoaltro di
una composizione ritornello Egrave un procedimento checonferisce unitagrave psicologica e tematica al testo poetico omusicale
Si ha rejet quando una parola si trova isolata allrsquoinizio diun verso pur facendo parte per il senso del verso prece-dente Es Virg Georg I 463 sol tibi signa dabit Solemquis dicere falsum audeat
Si ha quando si interrompe allrsquoimprovviso la frase la-sciandone tuttavia intendere il senso
Termine tedesco indicante la struttura laquoad anelloraquo dellacomposizione cioegrave basata sul ritorno alla fine di ele-menti che figuravano in principio
Canto eseguito durante un banchetto dai convitati chenel canto si cedono la parola in ordine laquoobliquoraquo dondeil nome
Vedi Giambico (senario)
Paragone fra due immagini introdotto da espressioni co-me ut ita talis qualis ceu ecc Es Virg Georg IV499 Dixit et ex oculis subito ceu fumus in auras com-mixtus tenuis fugit
Egrave quel genere di riunione maschile che in Grecia seguivail pasto serale ed era dedicata al bere al progetto politi-co e militare allrsquoeros allrsquoascolto della poesia e piugrave tardianche al discorso filosofico A simposio si riunivano grup-
pi legati da giuramento (eteriacutee) e costituiti sullrsquouguaglian-za dello stile di vita sulla coincidenza degli scopi politicisullrsquoomogeneitagrave culturale
Particolare tipo di metonimia anche con la sineddocheinfatti si ha la trasposizione da un significato proprio adaltro figurato in particolare in un rapporto di quantitagrave(parte per il tutto singolare per plurale ecc) Es Virg Aen II 276 vel Danaum Phrygios iaculatus puppibusignis dove puppes indica le navi
Consiste nellrsquoassociare piugrave termini appartenenti a perce-zioni sensoriali diverse (visive uditive tattili olfattive gu-stative) in unrsquounica espressione
Reduplicatio
Sinestesia
Sineddoche
Simposio (sympoacutesion )
Similitudine
Senario giambico
Scolio
Ringkomposition
Reticenza
Rejet
Refrain
Il Lord ha definito i laquotemiraquo della poesia orale comelaquogruppi di idee regolarmente usate nel raccontare unastoria nello stile formulaico del canto tradizionaleraquoNellrsquoOdissea le numerose descrizioni stereotipiche del-lrsquoaccoglienza ospitale offerta a un visitatore costituisconoun laquotemaraquo orale Nella narrativa germanica le descrizio-
ni in cui la schiera dei nobili si riunisce intorno al re abanchettare a bere e a vantarsi delle proprie gesta co-stituisce analogamente un laquotemaraquo di quella tradizione(R Scholes - R Kellogg)
Comunitagrave paideutico-cultuale femminile in parte simileallrsquoeterigravea maschile con finalitagrave educativa Qui le fanciulledi nobile famiglia compivano la loro educazione nellamusica nel canto nella danza nellrsquoarte di ornarsi e ve-stirsi in modo conforme al loro rango Era un ideale diperfezione da conseguire anche attraverso pratiche litur-giche incentrate sul culto di Afrodite
Si ha quando una parola composta viene separata neisuoi elementi attraverso lrsquointerposizione di altri elementiEs Virg Georg III 381 Hyperboreo septem subiecta trio-ni dove septemtrioni egrave separato in septem e trioni attra-verso lrsquointerposizione di subiecta
Canto funebre
Nella retorica classica i koinoacutei topoi (loci communes) eranoargomenti adatti ad essere sviluppati al servizio drsquouna tesiin vari generi di discorso Il loro assieme costituiva a dettadi Quintiliano la argomentorum sedes La memoria era in-fatti concepita come uno spazio nei cui luoghi (topoi loci )si situano le idee a questi luoghi ricorre lrsquooratore quandocerca argomenti adatti alle situazioni e alle parti del discor-so Nel Medioevo ndash estintisi il discorso politico e quello giu-diziario ndash la retorica estende lrsquouso dei topoi a tutti i tipi ditesto essi divengono dei clicheacutes di generale utilizzabilitagraveletteraria e si estendono a tutti i settori della vita che pos-sono essere abbracciati e modellati dalla letteratura Cosigravela retorica costituisce un magazzino vi si trovano le idee di
carattere piugrave generale tali da poter essere usate in tutti idiscorsi e gli scritti P Zumthor insiste sul carattere compo-sito dei topoi laquomateriali di reimpiego (come si potrebberodire per analogia le opere dellrsquoarchitettura romana) risul-tato di qualche bricolage arcaico i cui prodotti si sono apoco a poco arricchiti e affinati nello stesso tempo in cui siconsolidavanoraquo
Consiste nel collegare due o piugrave termini con un elementoche egrave appropriato per uno solo la forma di zeugma piugravefrequente fa dipendere da un unico verbo piugrave oggettiche richiederebbero ciascuno un verbo specifico Es Or
Carm I 1 19-21 Est qui nec veteris pocula Massici nec partem solido demere de die spernit dove spernit ha peroggetto sia pocula sia lrsquoinfinito demere
Tema
Zegraveugma
Topos
Treno
Tmesi
Tigraveaso

7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 68
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 336
delle cellule ritmiche elementari dette tradizionalmentepiediI piedi principali sono i seguentitrocheo
983215 tribraco
˘ ˘ ˘giambo
˘ 983215 spondeo
983215 983215dattilo 983215 ˘anapesto
˘ ˘ 983215 proceleusmatico
˘ ˘ ˘ ˘cretico
983215 983215 coriambo
983215 ˘ 983215
Significa laquoimitazioneraquo e designa il modo drsquointendere lapoesia e lrsquoarte degli autori antichi Per Simonide (VI-Vsec aC) la poesia egrave una laquoimmagine della cosaraquo unrsquoimi-tazione anche di emozioni e stati drsquoanimo Ogni formadrsquoarte sia essa poetica pittorica musicale o coreutica egravesentita dai greci come imitazione e gli artisti sono tutti
considerati laquoimitatoriraquo da Platone (Rep 373b)
laquoI miti sono narrazioni tramandate dalla tradizione percheacutecontengono valori importanti per la comunitagrave o percheacute co-stituiscono racconti di particolare rilevanza narrativaraquo(Howatson) Se si riferiscono a personaggi reali che hannooperato in luoghi reali e riportano gli eventi in forma ab-bastanza realistica (ad esempio le vicende dei sette re diRoma) si possono definire leggende I contenuti del mitosono vari e possono riguardare lrsquoorgine del mondo e dellaTerra le forme del culto le istituzioni degli uomini Hannocarattere laquoapertoraquo nel senso che si prestano a essere nar-rati secondo varie versioni e ad accogliere mille inserimentie variazioni Costituiscono lrsquoantefatto della storiografia (apartire dalle genealogie mitiche di dei e eroi) ma anchedella scienza e della filosofia (a partire dai grandi miti co-smologici) Le maggiori fonti mitiche sono per noi OmeroEsiodo ma anche i poeti ellenistici come Callimaco per iquali il mito per lo piugrave ripreso in una variante poco notadiviene un ornamento prezioso della narrazione LeMetamorfosi di Ovidio furono il maggiore veicolo di tra-smissione del patrimonio mitico antico nei secoliCome sostiene lrsquoantropologo Altan lrsquoesperienza mitica egravefondamentale per le popolazioni antiche e preletterate
immuni dagli effetti indotti nei ceti colti dal razionali-smo greco e presso le quali le operazioni canoniche delpensiero definito razionale (classificazione numerazio-ne spazialitagrave temporalitagrave causalitagrave) assumono conno-tati diversi da quelli assunti nella tradizione occidentaleLrsquoaffermazione del pensiero razionale ha comportatoche il mito divenisse sinonimo di menzogna Il terminem acute ythos originariamente non antitetico rispetto a logos(con cui poteva coesistere nel composto mythologialaquocomplesso di raccontiraquo) in seguito agli sviluppi della fi-losofia greca diviene lrsquoopposto del logos o discorso ra-zionale e il mito egrave confinato nella sfera della pre-razio-nalitagrave anzi dellrsquoirrazionalitagrave considerato antitetico alla
scienza retaggio di tempi oscuri dominati dalla paura edalla superstizione In realtagrave secondo le vedute piugrave re-centi il mito era la forma del sapere collettivo dei popo-
Mito
Migravemesi
li prestorici Nel loro orizzonte culturale laquoil patrimonio disapere collettivo economico tecnologico politico so-ciale e religioso in cui si articola la cultura si manifestaglobalmente come mitologia nella quale sono ancorafra loro indistinte quelle forme che storicamente assu-meranno un significato autonomo nelle diverse specia-lizzazioni disciplinari proprie della cultura in senso mo-
derno occidentaleraquo (Altan)
Studio dei miti ma anche complesso dei miti di una cer-ta cultura o epoca
Figlie di Zeus e Mnemogravesine la dea della memoria Nei poe-mi omerici dove allietano i banchetti degli dei sono in unnumero imprecisato che perograve giagrave alla fine dellrsquoOdissea(XXIV 60) si precisa in nove numero che con la Teogonia diEsiodo diviene definitivo Esiodo ne elenca anche i nomi eassegna loro la funzione che saragrave canonica di ispirare i
poeti nella composizione di un poema Le specifiche funzio-ni delle Muse si preciseranno solo in etagrave ellenistica Calligraveopesaragrave preposta allrsquoepica Clio alla storia Melpogravemene allapoesia tragica Eutegraverpe alla musica col flauto Egraverato allapoesia lirica Tersigravecore alla lirica corale e alla danza Uragraveniaallrsquoastronomia Taligravea alla commedia Poligravemnia alla pantomi-ma Le sedi di culto delle Muse piugrave famose furono la Piegraveriaai piedi dellrsquoOlimpo e Ascra in Beozia
Nella poesia greca arcaica la mousikeacute egrave la poesia intesacome connubio di parole e musica La musica era parteintegrante della vita sociale greca Quasi ogni forma poe-tica era accompagnata dalla musica La rilevanza eticadella musica era sostenuta da Platone convinto che lamusica influenzasse in modo permanente il carattere e leattitudini dellrsquouomo e da Aristotele
Da odeacute laquocantoraquo Composizione lirica di forma metrica estrofica varia A Roma si usograve il termine carmen
Egrave un tipo di omoteleuto che si ha quando piugrave parole hannola stessa terminazione derivante da uguali forme di flessione
Ripetizione dello stesso suono alla fine di piugrave parole vici-ne della stessa frase Es Virg Buc IV 50 s Aspice con-vexo nutantem pondere mundum terrasque tractusquemaris caelumque profundum dove i due versi terminanocon lo stesso suono
Formazione di un vocabolo il cui suono imita un rumorenaturale Es Plauto Miles 311 mussitabo il verbo mussitolaquoborbottareraquo riprende il suono mu del borbottio delparlare sommessamente
Vedi Metri orazianiOraziani (metri)
Onomatopea
Omoteleuto
Omeoptoto
Ode
Musica
Muse
Mitologia
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 78
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 337
Accostamento di parole di senso opposto Es Or Ep I11 28 strenua inertia
Festivitagrave pubblica a sfondo religioso durante la quale sisvolgevano gare poetiche e musicali
Letteralmente laquoscherziraquo Poesie di carattere privato edisimpegnato di mero intrattenimento tipiche della cultu-ra ellenistica A Roma scrissero paacuteignia (latinamente nu- gae) soprattutto i poeti del circolo neoterico ( poetae novi )
Vedi Lira
Si ha quando gli elementi di due o piugrave frasi sono dispostinello stesso ordine cosigrave da corrispondersi simmetrica-mente Es Sall BC 5 4 cuius lubet rei simulator ac dis- simulator alieni adpetens sui profusus
Consiste nellrsquoaccostare due parole di suono simile ma disignificato diverso Es Catullo 3 13 At vobis male sitmalae tenebrae
Canto intonato da un coro di fanciulle
Termine della retorica greca indicante il carattere dipassionalitagrave e drammaticitagrave proprio dellrsquoepica e dellatragedia Secondo N Frye il pathos egrave la lotta mortaledellrsquoeroe
Canto dedicato ad Apollo
Il pentametro egrave un verso mai usato da solo formato dal-lrsquounione di due metagrave versi (emistichi ) separate da una pau-sa fissa una dieresi ciascuna delle quali egrave composta di duedattili e mezzo Sono quindi sei piedi dattilici catalettici in
syllabam che terminano cioegrave con una sola sillaba Nellaprima metagrave al posto dei dattili si possono trovare deglispondei nella seconda non sono possibili sostituzioniSchema
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute 983215 acute ˘˘ 983215 acute ˘˘ 983215 ˘
Catullo 85Odi et amo | Quare id faciam | fortasse requiris Nescio sed fieri | sentio et excrucior
Termine inglese impiegato di frequente per indicare laprestazione artistica del poeta lirico o epico
Si ha quando per evitare di designare una persona o didire una cosa direttamente si usa un giro di parole
Ossimoro
Perifrasi
Performance
Pentametro
Peana
Pathos
Partenio
Paronomasia
Parallelismo
Phoacuterminx
Paacuteignia
Paneg yris
Egrave il personaggio che nella lirica si esprime in prima perso-na Non necessariamente coincide con lrsquoio dellrsquoautore
Da poikiacutello laquorendo varioraquo Egrave la capacitagrave del poeta di va-riare a tempo debito in rapporto allrsquooccasione toni temi
strutture metriche del canto soddisfacendo alle attese dichi ascolta
Egrave la laquopuntaraquo cioegrave il finale arguto e inatteso soprattuttodellrsquoepigramma ( fulmen in clausula)
Ripetizione di una stessa parola espressa a breve distanzain piugrave casi grammaticali Es Catullo 2 2 s quicum lude-re quem in sinu tenere cui
Si ha quando piugrave elementi di una frase o piugrave frasi sonouniti da piugrave congiunzioni Es Sall BC 3 1 et qui fecereet qui scripsere
Figura con la quale si dice sia pure brevemente una cosache al contempo si dichiara di non voler dire Es Cic CatI 3 Nam illa nimis antiqua praetereo quod C Servilius
Termine della filologia tedesca (dal lat praeambulum) Egraveuno schema retorico consistente nella rassegna degli al-
trui generi di vita cui egrave contrapposto il proprio del qualesi rivendica la superiore validitagrave Cosigrave ad esempio Saffocontrapponendosi allrsquoopinione dominante sostiene chela cosa piugrave bella non sono le flotte e gli eserciti malaquoquello che ognuno amaraquo
Tipo di esordio tipico del poema epico Il proemio poeticosecondo alcuni autori sembra sovrapponibile allrsquoexordiumdei genera dicendi Questo oltre al compito ovvio di ini-ziare (exordium est principium orationis Rhet Her 1 34) ha il compito di disporre favorevolmente lrsquouditorio neiconfronti dellrsquooratore e dellrsquoargomento ( per quod [= exor-
dium] animus auditoris constituitur ad audiendum)
Figura mediante la quale si fa parlare come se fosse pre-sente un personaggio lontano o defunto o la personifica-zione di cosa inanimata o astratta Es Cic Pro Caelio laprosopopea di Appio Claudio Cieco Cic Cat I 17-18 e27-29 la prosopopea della patria
Proemio dei poemi classici comprendente la presentazio-ne dellrsquoargomento lrsquoinvocazione alla Musa eventual-mente la dedica
Egrave il poeta epico o lirico inteso come laquocucitore di cantiraquo
Persona loquens
Rapsogravedo (rhapsodoacutes)
Protasi
Prosopopea
Proemio
Priagravemel
Preterizione
Polisindeto
Poliptoto
Pointe
Poikiliacutea
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 88
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 338
Ripetizione di una o piugrave parole conclusive della frase pre-cedente in quella seguente Es Cic Cat I 1 vivitVivit
Ripetizione di una sequenza tra un periodo e lrsquoaltro di
una composizione ritornello Egrave un procedimento checonferisce unitagrave psicologica e tematica al testo poetico omusicale
Si ha rejet quando una parola si trova isolata allrsquoinizio diun verso pur facendo parte per il senso del verso prece-dente Es Virg Georg I 463 sol tibi signa dabit Solemquis dicere falsum audeat
Si ha quando si interrompe allrsquoimprovviso la frase la-sciandone tuttavia intendere il senso
Termine tedesco indicante la struttura laquoad anelloraquo dellacomposizione cioegrave basata sul ritorno alla fine di ele-menti che figuravano in principio
Canto eseguito durante un banchetto dai convitati chenel canto si cedono la parola in ordine laquoobliquoraquo dondeil nome
Vedi Giambico (senario)
Paragone fra due immagini introdotto da espressioni co-me ut ita talis qualis ceu ecc Es Virg Georg IV499 Dixit et ex oculis subito ceu fumus in auras com-mixtus tenuis fugit
Egrave quel genere di riunione maschile che in Grecia seguivail pasto serale ed era dedicata al bere al progetto politi-co e militare allrsquoeros allrsquoascolto della poesia e piugrave tardianche al discorso filosofico A simposio si riunivano grup-
pi legati da giuramento (eteriacutee) e costituiti sullrsquouguaglian-za dello stile di vita sulla coincidenza degli scopi politicisullrsquoomogeneitagrave culturale
Particolare tipo di metonimia anche con la sineddocheinfatti si ha la trasposizione da un significato proprio adaltro figurato in particolare in un rapporto di quantitagrave(parte per il tutto singolare per plurale ecc) Es Virg Aen II 276 vel Danaum Phrygios iaculatus puppibusignis dove puppes indica le navi
Consiste nellrsquoassociare piugrave termini appartenenti a perce-zioni sensoriali diverse (visive uditive tattili olfattive gu-stative) in unrsquounica espressione
Reduplicatio
Sinestesia
Sineddoche
Simposio (sympoacutesion )
Similitudine
Senario giambico
Scolio
Ringkomposition
Reticenza
Rejet
Refrain
Il Lord ha definito i laquotemiraquo della poesia orale comelaquogruppi di idee regolarmente usate nel raccontare unastoria nello stile formulaico del canto tradizionaleraquoNellrsquoOdissea le numerose descrizioni stereotipiche del-lrsquoaccoglienza ospitale offerta a un visitatore costituisconoun laquotemaraquo orale Nella narrativa germanica le descrizio-
ni in cui la schiera dei nobili si riunisce intorno al re abanchettare a bere e a vantarsi delle proprie gesta co-stituisce analogamente un laquotemaraquo di quella tradizione(R Scholes - R Kellogg)
Comunitagrave paideutico-cultuale femminile in parte simileallrsquoeterigravea maschile con finalitagrave educativa Qui le fanciulledi nobile famiglia compivano la loro educazione nellamusica nel canto nella danza nellrsquoarte di ornarsi e ve-stirsi in modo conforme al loro rango Era un ideale diperfezione da conseguire anche attraverso pratiche litur-giche incentrate sul culto di Afrodite
Si ha quando una parola composta viene separata neisuoi elementi attraverso lrsquointerposizione di altri elementiEs Virg Georg III 381 Hyperboreo septem subiecta trio-ni dove septemtrioni egrave separato in septem e trioni attra-verso lrsquointerposizione di subiecta
Canto funebre
Nella retorica classica i koinoacutei topoi (loci communes) eranoargomenti adatti ad essere sviluppati al servizio drsquouna tesiin vari generi di discorso Il loro assieme costituiva a dettadi Quintiliano la argomentorum sedes La memoria era in-fatti concepita come uno spazio nei cui luoghi (topoi loci )si situano le idee a questi luoghi ricorre lrsquooratore quandocerca argomenti adatti alle situazioni e alle parti del discor-so Nel Medioevo ndash estintisi il discorso politico e quello giu-diziario ndash la retorica estende lrsquouso dei topoi a tutti i tipi ditesto essi divengono dei clicheacutes di generale utilizzabilitagraveletteraria e si estendono a tutti i settori della vita che pos-sono essere abbracciati e modellati dalla letteratura Cosigravela retorica costituisce un magazzino vi si trovano le idee di
carattere piugrave generale tali da poter essere usate in tutti idiscorsi e gli scritti P Zumthor insiste sul carattere compo-sito dei topoi laquomateriali di reimpiego (come si potrebberodire per analogia le opere dellrsquoarchitettura romana) risul-tato di qualche bricolage arcaico i cui prodotti si sono apoco a poco arricchiti e affinati nello stesso tempo in cui siconsolidavanoraquo
Consiste nel collegare due o piugrave termini con un elementoche egrave appropriato per uno solo la forma di zeugma piugravefrequente fa dipendere da un unico verbo piugrave oggettiche richiederebbero ciascuno un verbo specifico Es Or
Carm I 1 19-21 Est qui nec veteris pocula Massici nec partem solido demere de die spernit dove spernit ha peroggetto sia pocula sia lrsquoinfinito demere
Tema
Zegraveugma
Topos
Treno
Tmesi
Tigraveaso

7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 78
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 337
Accostamento di parole di senso opposto Es Or Ep I11 28 strenua inertia
Festivitagrave pubblica a sfondo religioso durante la quale sisvolgevano gare poetiche e musicali
Letteralmente laquoscherziraquo Poesie di carattere privato edisimpegnato di mero intrattenimento tipiche della cultu-ra ellenistica A Roma scrissero paacuteignia (latinamente nu- gae) soprattutto i poeti del circolo neoterico ( poetae novi )
Vedi Lira
Si ha quando gli elementi di due o piugrave frasi sono dispostinello stesso ordine cosigrave da corrispondersi simmetrica-mente Es Sall BC 5 4 cuius lubet rei simulator ac dis- simulator alieni adpetens sui profusus
Consiste nellrsquoaccostare due parole di suono simile ma disignificato diverso Es Catullo 3 13 At vobis male sitmalae tenebrae
Canto intonato da un coro di fanciulle
Termine della retorica greca indicante il carattere dipassionalitagrave e drammaticitagrave proprio dellrsquoepica e dellatragedia Secondo N Frye il pathos egrave la lotta mortaledellrsquoeroe
Canto dedicato ad Apollo
Il pentametro egrave un verso mai usato da solo formato dal-lrsquounione di due metagrave versi (emistichi ) separate da una pau-sa fissa una dieresi ciascuna delle quali egrave composta di duedattili e mezzo Sono quindi sei piedi dattilici catalettici in
syllabam che terminano cioegrave con una sola sillaba Nellaprima metagrave al posto dei dattili si possono trovare deglispondei nella seconda non sono possibili sostituzioniSchema
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute ˘˘ ndash
983215 acute 983215 acute ˘˘ 983215 acute ˘˘ 983215 ˘
Catullo 85Odi et amo | Quare id faciam | fortasse requiris Nescio sed fieri | sentio et excrucior
Termine inglese impiegato di frequente per indicare laprestazione artistica del poeta lirico o epico
Si ha quando per evitare di designare una persona o didire una cosa direttamente si usa un giro di parole
Ossimoro
Perifrasi
Performance
Pentametro
Peana
Pathos
Partenio
Paronomasia
Parallelismo
Phoacuterminx
Paacuteignia
Paneg yris
Egrave il personaggio che nella lirica si esprime in prima perso-na Non necessariamente coincide con lrsquoio dellrsquoautore
Da poikiacutello laquorendo varioraquo Egrave la capacitagrave del poeta di va-riare a tempo debito in rapporto allrsquooccasione toni temi
strutture metriche del canto soddisfacendo alle attese dichi ascolta
Egrave la laquopuntaraquo cioegrave il finale arguto e inatteso soprattuttodellrsquoepigramma ( fulmen in clausula)
Ripetizione di una stessa parola espressa a breve distanzain piugrave casi grammaticali Es Catullo 2 2 s quicum lude-re quem in sinu tenere cui
Si ha quando piugrave elementi di una frase o piugrave frasi sonouniti da piugrave congiunzioni Es Sall BC 3 1 et qui fecereet qui scripsere
Figura con la quale si dice sia pure brevemente una cosache al contempo si dichiara di non voler dire Es Cic CatI 3 Nam illa nimis antiqua praetereo quod C Servilius
Termine della filologia tedesca (dal lat praeambulum) Egraveuno schema retorico consistente nella rassegna degli al-
trui generi di vita cui egrave contrapposto il proprio del qualesi rivendica la superiore validitagrave Cosigrave ad esempio Saffocontrapponendosi allrsquoopinione dominante sostiene chela cosa piugrave bella non sono le flotte e gli eserciti malaquoquello che ognuno amaraquo
Tipo di esordio tipico del poema epico Il proemio poeticosecondo alcuni autori sembra sovrapponibile allrsquoexordiumdei genera dicendi Questo oltre al compito ovvio di ini-ziare (exordium est principium orationis Rhet Her 1 34) ha il compito di disporre favorevolmente lrsquouditorio neiconfronti dellrsquooratore e dellrsquoargomento ( per quod [= exor-
dium] animus auditoris constituitur ad audiendum)
Figura mediante la quale si fa parlare come se fosse pre-sente un personaggio lontano o defunto o la personifica-zione di cosa inanimata o astratta Es Cic Pro Caelio laprosopopea di Appio Claudio Cieco Cic Cat I 17-18 e27-29 la prosopopea della patria
Proemio dei poemi classici comprendente la presentazio-ne dellrsquoargomento lrsquoinvocazione alla Musa eventual-mente la dedica
Egrave il poeta epico o lirico inteso come laquocucitore di cantiraquo
Persona loquens
Rapsogravedo (rhapsodoacutes)
Protasi
Prosopopea
Proemio
Priagravemel
Preterizione
Polisindeto
Poliptoto
Pointe
Poikiliacutea
7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 88
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 338
Ripetizione di una o piugrave parole conclusive della frase pre-cedente in quella seguente Es Cic Cat I 1 vivitVivit
Ripetizione di una sequenza tra un periodo e lrsquoaltro di
una composizione ritornello Egrave un procedimento checonferisce unitagrave psicologica e tematica al testo poetico omusicale
Si ha rejet quando una parola si trova isolata allrsquoinizio diun verso pur facendo parte per il senso del verso prece-dente Es Virg Georg I 463 sol tibi signa dabit Solemquis dicere falsum audeat
Si ha quando si interrompe allrsquoimprovviso la frase la-sciandone tuttavia intendere il senso
Termine tedesco indicante la struttura laquoad anelloraquo dellacomposizione cioegrave basata sul ritorno alla fine di ele-menti che figuravano in principio
Canto eseguito durante un banchetto dai convitati chenel canto si cedono la parola in ordine laquoobliquoraquo dondeil nome
Vedi Giambico (senario)
Paragone fra due immagini introdotto da espressioni co-me ut ita talis qualis ceu ecc Es Virg Georg IV499 Dixit et ex oculis subito ceu fumus in auras com-mixtus tenuis fugit
Egrave quel genere di riunione maschile che in Grecia seguivail pasto serale ed era dedicata al bere al progetto politi-co e militare allrsquoeros allrsquoascolto della poesia e piugrave tardianche al discorso filosofico A simposio si riunivano grup-
pi legati da giuramento (eteriacutee) e costituiti sullrsquouguaglian-za dello stile di vita sulla coincidenza degli scopi politicisullrsquoomogeneitagrave culturale
Particolare tipo di metonimia anche con la sineddocheinfatti si ha la trasposizione da un significato proprio adaltro figurato in particolare in un rapporto di quantitagrave(parte per il tutto singolare per plurale ecc) Es Virg Aen II 276 vel Danaum Phrygios iaculatus puppibusignis dove puppes indica le navi
Consiste nellrsquoassociare piugrave termini appartenenti a perce-zioni sensoriali diverse (visive uditive tattili olfattive gu-stative) in unrsquounica espressione
Reduplicatio
Sinestesia
Sineddoche
Simposio (sympoacutesion )
Similitudine
Senario giambico
Scolio
Ringkomposition
Reticenza
Rejet
Refrain
Il Lord ha definito i laquotemiraquo della poesia orale comelaquogruppi di idee regolarmente usate nel raccontare unastoria nello stile formulaico del canto tradizionaleraquoNellrsquoOdissea le numerose descrizioni stereotipiche del-lrsquoaccoglienza ospitale offerta a un visitatore costituisconoun laquotemaraquo orale Nella narrativa germanica le descrizio-
ni in cui la schiera dei nobili si riunisce intorno al re abanchettare a bere e a vantarsi delle proprie gesta co-stituisce analogamente un laquotemaraquo di quella tradizione(R Scholes - R Kellogg)
Comunitagrave paideutico-cultuale femminile in parte simileallrsquoeterigravea maschile con finalitagrave educativa Qui le fanciulledi nobile famiglia compivano la loro educazione nellamusica nel canto nella danza nellrsquoarte di ornarsi e ve-stirsi in modo conforme al loro rango Era un ideale diperfezione da conseguire anche attraverso pratiche litur-giche incentrate sul culto di Afrodite
Si ha quando una parola composta viene separata neisuoi elementi attraverso lrsquointerposizione di altri elementiEs Virg Georg III 381 Hyperboreo septem subiecta trio-ni dove septemtrioni egrave separato in septem e trioni attra-verso lrsquointerposizione di subiecta
Canto funebre
Nella retorica classica i koinoacutei topoi (loci communes) eranoargomenti adatti ad essere sviluppati al servizio drsquouna tesiin vari generi di discorso Il loro assieme costituiva a dettadi Quintiliano la argomentorum sedes La memoria era in-fatti concepita come uno spazio nei cui luoghi (topoi loci )si situano le idee a questi luoghi ricorre lrsquooratore quandocerca argomenti adatti alle situazioni e alle parti del discor-so Nel Medioevo ndash estintisi il discorso politico e quello giu-diziario ndash la retorica estende lrsquouso dei topoi a tutti i tipi ditesto essi divengono dei clicheacutes di generale utilizzabilitagraveletteraria e si estendono a tutti i settori della vita che pos-sono essere abbracciati e modellati dalla letteratura Cosigravela retorica costituisce un magazzino vi si trovano le idee di
carattere piugrave generale tali da poter essere usate in tutti idiscorsi e gli scritti P Zumthor insiste sul carattere compo-sito dei topoi laquomateriali di reimpiego (come si potrebberodire per analogia le opere dellrsquoarchitettura romana) risul-tato di qualche bricolage arcaico i cui prodotti si sono apoco a poco arricchiti e affinati nello stesso tempo in cui siconsolidavanoraquo
Consiste nel collegare due o piugrave termini con un elementoche egrave appropriato per uno solo la forma di zeugma piugravefrequente fa dipendere da un unico verbo piugrave oggettiche richiederebbero ciascuno un verbo specifico Es Or
Carm I 1 19-21 Est qui nec veteris pocula Massici nec partem solido demere de die spernit dove spernit ha peroggetto sia pocula sia lrsquoinfinito demere
Tema
Zegraveugma
Topos
Treno
Tmesi
Tigraveaso

7232019 Gl_ret-stil-met
httpslidepdfcomreaderfullglret-stil-met 88
Glossario retorico-stilistico metrico e relativo alla terminologia del genere lirico 338
Ripetizione di una o piugrave parole conclusive della frase pre-cedente in quella seguente Es Cic Cat I 1 vivitVivit
Ripetizione di una sequenza tra un periodo e lrsquoaltro di
una composizione ritornello Egrave un procedimento checonferisce unitagrave psicologica e tematica al testo poetico omusicale
Si ha rejet quando una parola si trova isolata allrsquoinizio diun verso pur facendo parte per il senso del verso prece-dente Es Virg Georg I 463 sol tibi signa dabit Solemquis dicere falsum audeat
Si ha quando si interrompe allrsquoimprovviso la frase la-sciandone tuttavia intendere il senso
Termine tedesco indicante la struttura laquoad anelloraquo dellacomposizione cioegrave basata sul ritorno alla fine di ele-menti che figuravano in principio
Canto eseguito durante un banchetto dai convitati chenel canto si cedono la parola in ordine laquoobliquoraquo dondeil nome
Vedi Giambico (senario)
Paragone fra due immagini introdotto da espressioni co-me ut ita talis qualis ceu ecc Es Virg Georg IV499 Dixit et ex oculis subito ceu fumus in auras com-mixtus tenuis fugit
Egrave quel genere di riunione maschile che in Grecia seguivail pasto serale ed era dedicata al bere al progetto politi-co e militare allrsquoeros allrsquoascolto della poesia e piugrave tardianche al discorso filosofico A simposio si riunivano grup-
pi legati da giuramento (eteriacutee) e costituiti sullrsquouguaglian-za dello stile di vita sulla coincidenza degli scopi politicisullrsquoomogeneitagrave culturale
Particolare tipo di metonimia anche con la sineddocheinfatti si ha la trasposizione da un significato proprio adaltro figurato in particolare in un rapporto di quantitagrave(parte per il tutto singolare per plurale ecc) Es Virg Aen II 276 vel Danaum Phrygios iaculatus puppibusignis dove puppes indica le navi
Consiste nellrsquoassociare piugrave termini appartenenti a perce-zioni sensoriali diverse (visive uditive tattili olfattive gu-stative) in unrsquounica espressione
Reduplicatio
Sinestesia
Sineddoche
Simposio (sympoacutesion )
Similitudine
Senario giambico
Scolio
Ringkomposition
Reticenza
Rejet
Refrain
Il Lord ha definito i laquotemiraquo della poesia orale comelaquogruppi di idee regolarmente usate nel raccontare unastoria nello stile formulaico del canto tradizionaleraquoNellrsquoOdissea le numerose descrizioni stereotipiche del-lrsquoaccoglienza ospitale offerta a un visitatore costituisconoun laquotemaraquo orale Nella narrativa germanica le descrizio-
ni in cui la schiera dei nobili si riunisce intorno al re abanchettare a bere e a vantarsi delle proprie gesta co-stituisce analogamente un laquotemaraquo di quella tradizione(R Scholes - R Kellogg)
Comunitagrave paideutico-cultuale femminile in parte simileallrsquoeterigravea maschile con finalitagrave educativa Qui le fanciulledi nobile famiglia compivano la loro educazione nellamusica nel canto nella danza nellrsquoarte di ornarsi e ve-stirsi in modo conforme al loro rango Era un ideale diperfezione da conseguire anche attraverso pratiche litur-giche incentrate sul culto di Afrodite
Si ha quando una parola composta viene separata neisuoi elementi attraverso lrsquointerposizione di altri elementiEs Virg Georg III 381 Hyperboreo septem subiecta trio-ni dove septemtrioni egrave separato in septem e trioni attra-verso lrsquointerposizione di subiecta
Canto funebre
Nella retorica classica i koinoacutei topoi (loci communes) eranoargomenti adatti ad essere sviluppati al servizio drsquouna tesiin vari generi di discorso Il loro assieme costituiva a dettadi Quintiliano la argomentorum sedes La memoria era in-fatti concepita come uno spazio nei cui luoghi (topoi loci )si situano le idee a questi luoghi ricorre lrsquooratore quandocerca argomenti adatti alle situazioni e alle parti del discor-so Nel Medioevo ndash estintisi il discorso politico e quello giu-diziario ndash la retorica estende lrsquouso dei topoi a tutti i tipi ditesto essi divengono dei clicheacutes di generale utilizzabilitagraveletteraria e si estendono a tutti i settori della vita che pos-sono essere abbracciati e modellati dalla letteratura Cosigravela retorica costituisce un magazzino vi si trovano le idee di
carattere piugrave generale tali da poter essere usate in tutti idiscorsi e gli scritti P Zumthor insiste sul carattere compo-sito dei topoi laquomateriali di reimpiego (come si potrebberodire per analogia le opere dellrsquoarchitettura romana) risul-tato di qualche bricolage arcaico i cui prodotti si sono apoco a poco arricchiti e affinati nello stesso tempo in cui siconsolidavanoraquo
Consiste nel collegare due o piugrave termini con un elementoche egrave appropriato per uno solo la forma di zeugma piugravefrequente fa dipendere da un unico verbo piugrave oggettiche richiederebbero ciascuno un verbo specifico Es Or
Carm I 1 19-21 Est qui nec veteris pocula Massici nec partem solido demere de die spernit dove spernit ha peroggetto sia pocula sia lrsquoinfinito demere
Tema
Zegraveugma
Topos
Treno
Tmesi
Tigraveaso