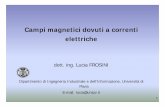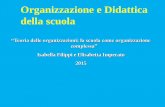Frosini, F - Gramsci Dopo Laclau. Politica, Verità e Le Due Contingenze
-
Upload
pablo-monta -
Category
Documents
-
view
9 -
download
1
description
Transcript of Frosini, F - Gramsci Dopo Laclau. Politica, Verità e Le Due Contingenze
-
quaderni dellespressione
NOME DEL PROPRIETARIO
Cronopio
-
Basso, Frosini, Illuminati, Marcucci,Morfino, Pinzolo, Raspa, Tomba,
Vinale, Visentin
Verit,ideologia e
politica
a cura diFabio Frosini e Adriano Vinale
32
-
5Indice
Introduzione 7
Venanzio Raspa, La realt della menzogna 9
Adriano Vinale, Lordine democratico del discorso 33
Luca Basso, Politica e contingenza in Marx: il 1848 53
Augusto Illuminati, Career opportunities: dal lavorosans phrase alla flessibilit 71
Luca Pinzolo, Carl Schmitt e il gemello immaginario.Spunti per una decostruzione del politico 91
Massimiliano Tomba, Modernit capitalistica come in-versione. Note su feticismo e fantasmagoria in Marx 119
Fabio Frosini, Gramsci dopo Laclau: politica, verit ele due contingenze 137
Nicola Marcucci, Il posto della critica. La dominazio-ne tra sociologia e politica secondo Luc Boltanski 165
Vittorio Morfino, Individuale e transindividuale daSimondon ad Althusser 183
Stefano Visentin, Verit e visibilit della politica inRancire e Badiou 205
Volume pubblicato con un contributo del MIUR Fondi PRIN2006 (Universit di Urbino) e Fondi PRIN 2007 (Universit di Sa-lerno)
2009 Edizioni CronopioCalata Trinit Maggiore, 4 80134 NapoliTel./fax 0815518778www.cronopio.ite-mail: [email protected]
ISBN 978-88-89446-_____
4
-
Fabio Frosini
Gramsci dopo Laclau:politica, verit e le due contingenze
Gramsci dopo Laclau
Discutere di Gramsci dopo Laclau, implica almeno due presup-posti, che opportuno dichiarare subito: anzitutto, che la ricostru-zione del concetto di egemonia proposto da Laclau contiene degliaspetti che vale la pena discutere; ma anche, in secondo luogo, chequella ricostruzione non rende completamente ragione del pensie-ro di Gramsci, che in qualche modo (e si tratter di vedere in qua-le modo) sporge oltre di essa e chiede di essere oggi ulteriormenteelaborato. Ci detto, non si tratter, peraltro, di contrapporre ste-rilmente unimpostazione a unaltra, una filosofia a unaltra, comese questo potesse offrire qualche risposta a qualche domanda. Ilmio punto di partenza infatti che Laclau formula delle questionirealmente insediate nel corpus del marxismo, e quindi anche nelpensiero di Gramsci, e lo fa in un linguaggio che egli chiama post-marxista1 che non deve impedire di scorgere la realt e limpor-tanza di quelle questioni, oltre ovviamente a obbligarci a calcola-re il peculiare effetto di distorsione a esse procurato dal fatto diessere formulate in quel particolare linguaggio. Regredendo ancoraun po, va precisato che se di distorsione si pu parlare, essa non vaopposta al linguaggio letterale che nomina le cose, a un metalin-guaggio neutro, o a un linguaggio naturale o universale, o come losi preferisca chiamare. Dietro la distorsione non c nessuna nomi-
137
1 Cfr. Ernesto Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time,Verso, London-New York 1990, pp. 97-132.
gioni e i propri diritti. Marx aveva ben chiaro che quei diritti sonougualmente suggellati dalla legge dello scambio delle merci e che lalotta tra questi diritti uguali si iscrive totalmente nella storia dellaproduzione capitalistica. Non esiste un giusto salario; giustapu essere chiamata solo linterruzione del rapporto salariale equindi del continuum della guerra civile tra le classi67. QuandoMarx destituisce di senso la questione del giusto salario non in-tende cancellare la questione del giusto, ma salvarla denunciandolossimoro del suo accostamento al salario.
136
67 Cfr. Massimiliamo Tomba, Another kind of Gewalt: Beyond Law. Re-Reading Walter Benjamin, , in Historical Materialism, 17, 2009, 1, pp. 126-144.
-
ne leggendo le sue pagine, in cui, anche quando non appare diretta-mente, il riferimento alle categorie centrali dei Quaderni del carce-re si fa sempre sentire, e che testimoniano di una lettura mai bana-le, mai stereotipata, ma personalissima e accurata (anche se, peresplicita ammissione di Laclau, almeno in parte mediata dai contri-buti di Chantal Mouffe4). Daltra parte, Gramsci non lunico tas-sello nella formazione di Laclau. Laltro, importante elemento daconsiderare (anche questo del resto in connessione con Althusser)un certo uso di Lacan, che gi in Hegemony and Socialist Strategysi combina con gli spunti del post-strutturalismo e del decostruzio-nismo. Ora, sul piano cronologico si pu dire che da Hegemonyand Socialist Strategy (1985) a New Reflections on the Revolutionof Our Time (1990) a Emancipation(s) (1996), fino a On PopulistReason (2005), litinerario di Laclau si snodato come un progres-sivo approfondimento della svolta rappresentata dal libro del 1985,scritto in collaborazione con Chantal Mouffe; un approfondimen-to che lo ha condotto a valorizzare sempre di pi il ricorso allostrumentario teorico lacaniano5, e a sfumare o riformulare in unanuova luce quello alle categorie di matrice economica e politica, de-rivate dal marxismo. Insomma, se vero che grazie a Laclau il ter-mine e il concetto di egemonia ha conosciuto e conosce unastraordinaria fortuna fuori dei confini del mondo gramsciano insenso stretto (si pensi alluso che se ne fa oggi nei subaltern studies,approccio incomprensibile senza la mediazione rappresentata daHall, che a sua volta profondamente debitore di Laclau, anche sea un livello di maggiore linearit concettuale6), altrettanto vero
139
4 Cfr. Ernesto Laclau, Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism Fascism Populism, Verso, London 1977, pp. 141-142n.; Ernesto Laclau,Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Demo-cratic Politics, Verso, London and New York 20012 (19851), p. 89 (n. 13).
5 Cfr. Jason Glynos, Yannis Stavrakakis, Encounters of the real kind: sus-sing out the limits of Laclaus embrace of Lacan, in S. Critchley, O. Marchart(eds.), Laclau. A critical reader, Routledge, London and New York 2004, pp.201-216.
6 Cfr. Stuart Hall, Il soggetto e la differenza. Per unarcheologia degli stu-di culturali e postcoloniali, trad. it. Meltemi, Roma 2006, pp. 81 s. (anti-essen-zialismo), 90 s., 324 n. 6 (articolazione), 106, 112, 303 ss., 318 (dislocazione),201 s., 217 s., 220, 222, 225 (classi), 205 s. (egemonia), 216 (soggetto), 251-253(contingenza del significato, riferendosi a Derrida), 290, 311, 317 (esterno co-stitutivo), 315, 317, 320 (identit), 317 s. (universale, sutura).
nazione diretta, che sta, piuttosto, oltre di essa, e va pensata comeeffetto moltiplicato piuttosto che come causa unitaria. In breve, ciche tenter di fare un passaggio attraverso Laclau, affinch emer-ga dallinterno del suo approccio (e non dallesterno di una con-trapposizione) quanto di Gramsci rimane, in questo approccio, percos dire senza rendiconto (e questo ci condurr anche a verificareci che, di questo margine non rendicontato, presente nello stes-so post-marxismo di Laclau, nella forma di uninterna incon-gruenza). In questo quadro, parlare di distorsione equivale a parla-re di una prospettiva, dalla quale le questioni sono formulate, e de-gli effetti prodotti da questa strategia. Solo qui, sul terreno deglieffetti, dovr e potr essere valutato il contributo di Laclau allalettura di Gramsci.
Un certo ordine
Tentiamo di porre le cose in un qualche ordine, iniziando daquello cronologico. Linteressamento di Laclau a Gramsci nasce(come egli ricorda) alla met degli anni Sessanta2, sullo sfondo del-lesperienza politica in Argentina (Laclau militava nel Partido So-cialista de la Izquierda Nacional) e dinnanzi ai problemi teorici po-sti nel dibattito teorico del marxismo. Allora (e non solo allora)Gramsci era in Argentina una lettura quasi obbligatoria, come loera nellInghilterra in cui Laclau si trasfer nel 1969 con laiuto diEric J. Hobsbawm. Qui, in particolare, Gramsci voleva dire cultu-ral studies, una corrente che decoll proprio verso la met degli an-ni Sessanta. Ma questa costellazione interna a un marxismo forte-mente votato allantieconomicismo, allo studio della specifica fun-zione delle superstrutture e della cultura, del ruolo degli intellettua-li, della politica, ecc. inevitabilmente rinvia a unaltra figura, nonperfettamente assimilabile a quella di Gramsci ed esterna ai riferi-menti anglosassoni: parliamo ovviamente di Althusser e in partico-lare di quel salutare cataclisma rappresentato da Pour Marx (1965)3.
Quella di Laclau dunque una formazione, in cui un passaggioattraverso Gramsci quasi naturale. Di ci si ha la chiara percezio-
138
2 Ivi, p. 199.3 Cfr. ivi, pp. 178 e 199.
-
mersi in un processo simbolico al di qua del quale non si pu in-dividuare nessun significato letterale capace di ridurli a momen-ti necessari di una legge immanente12. La logica della surdetermi-nazione stabilisce il carattere costitutivamente incompleto, apertoe politicamente negoziabile di ogni identit, in quanto la presen-za di alcuni oggetti negli altri impedisce la fissazione delle loro ri-spettive identit13, la loro letteralizzazione. La non oltrepassabilitdel simbolico rende conto di ci, che essere e discorso non so-no separabili (il modo di essere, cio la forma, luniversale, sem-pre stabilito dentro un discorso)14: di conseguenza la societ e gliagenti sociali non hanno nessuna essenza ultima e stabile, e le lo-ro regolarit stanno semplicemente nelle relative e precarie forme difissazione che accompagnano lo stabilimento di un certo ordine15.
Il nesso di questo ragionamento con il concetto gramsciano diegemonia immediato: egemonia una forma della politica (in uncerto senso, che verr spiegato in seguito, la forma specificamentemoderna), perch la societ non oggettivabile in leggi naturali, npu essere costretta in unimmutabile tradizione; o detto altrimen-ti: la politica non calcolo o amministrazione o scienza, maappunto egemonia (strategia), perch una scienza descrittiva dellasociet impossibile, dato che linsieme dei processi simbolici non rappresentabile in unimmagine univoca, non riducibile a unsenso letterale oggettivo, a leggi.
Cos, prendendo le mosse dallinterno del marxismo, la nozio-ne di egemonia sar pienamente sviluppabile solo a condizione diabbandonare lequivalenza tra economia e oggettivit, o meglio lastessa logica essenzialistica, fondazionale, che porta a individuare inuna qualche istanza del sociale un punto non ulteriormente condi-
141
del 1963 e pubblicato nellagosto dello stesso anno. Cfr. E. Laclau, C. Mouffe,Hegemony and Socialist Strategy, cit., p. 98.
12 Ibidem.13 Ivi, p. 104.14 Cfr. la dettagliata discussione di questi problemi in E. Laclau, New Re-
flections on the Revolution of Our Time, cit., pp. 105-112, che una rispostaalle critiche mosse a Hegemony and Socialist Strategy da Norman Geras (Post-Marxism?, in New Left Review, ***, 1987, 163). Essa pu valere anche co-me risposta alla banalizzazione e ridicolizzazione di Terry Eagleton, Che coslideologia (1991), trad. it. il Saggiatore, Milano 1993, pp. 282-287.
15 E. Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, cit., p. 98.
che in questo passaggio esso ha conosciuto una progressiva trasfor-mazione, che ne ha modificato elementi portanti, adattandolo sem-pre meglio a un universo di pensiero post-moderno.
Egemonia e surdeterminazione
Quella di egemonia la nozione-chiave del post-marxismo diLaclau, la nuova logica politica di cui ricostruisce in Hegemonyand Socialist Strategy una genealogia nel discorso marxista7, che nemostra al contempo la necessit e limpossibilit: da una parte, tut-to il discorso marxista, nel suo costante confronto con il problemadella politica, la ricerca di una forma di pensiero capace di sfuggi-re alle aporie derivanti sia dalla pretesa di trattare la societ/storiacome un corpo naturale, sia dal dualismo (struttura/azione, ogget-tivit/soggetto) conseguente al tentativo di reintrodurre la politicain questo quadro chiuso; dallaltra, questa stessa dinamica rende ilproblema insolubile, dato che il rafforzamento del momento poli-tico dovr sempre implicare un contestuale indebolimento di quel-lo economico, ma mai la sua scomparsa, essendo la realt, per ilmarxismo, sempre e comunque dualistica in ragione delloggettivi-smo che lo percorre8.
Gramsci , nella ricostruzione di Laclau, il culmine di questa im-possibile ricerca: nei Quaderni del carcere si trova tanto la messa indiscussione definitiva delleconomicismo, quanto il fallimento deltentativo di oltrepassare il suo orizzonte9. Lo stesso accade in Al-thusser. Laccostamento a Gramsci di questultimo10 reso possibi-le dalla limitazione della sua importanza alla nozione di surdeter-minazione11, in base alla quale i rapporti sociali sono sempre im-
140
7 E. Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, cit., cap. 2 (pp.47-90).
8 Cfr. ivi, pp. 75 s.9 Cfr. ivi, pp. 65-71.10 Che Laclau trova nel fortunato libro di Christine Buci-Glucksmann,
Gramsci et ltat. Pour une thorie matrialiste de la philosophie, Fayard, Pa-ris 1975. Cfr. E. Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, cit., p.89 (n. 10).
11 Vale a dire, a ci che precede la svolta rappresentata dal saggio Sur ladialectique matrialiste (De lingalit des origines), scritto nellaprile-maggio
-
politica di emancipazioni (necessariamente plurali)18. Quali sonole condizioni di una politica emancipatoria nel mondo attuale?Questa listanza pratico-politica che muove la ricerca, istanza cheper immediatamente si articola nel tentativo di dare risposta a unaserie di problemi che concretamente si pongono, e che la teoria nonriesce a fronteggiare. In unintervista rilasciata nel 1988, Laclau hadichiarato che nella sua esperienza politica in Argentina durantegli anni Sessanta che apprese la sua prima lezione di egemonia;e poco oltre afferma:
Non ho avuto bisogno di leggere i testi post-strutturalisti per capire co-sa fossero la cerniera, limene, il significante fluttuante o la me-tafisica della presenza: lho appreso, piuttosto, attraverso la mia espe-rienza pratica come attivista politico a Buenos Aires. Cos, quando og-gi leggo Della grammatologia, S/Z, o gli Scritti di Lacan gli esempi chesempre mi saltano in testa non sono tratti da testi filosofici o letterari;ma provengono da una discussione in un sindacato argentino, da unoscontro di slogan opposti in una dimostrazione, o da un dibattito du-rante un congresso di partito. Durante tutta la sua vita, Joyce tornatoalla sua prima esperienza dublinese; nel mio caso, sono quegli anni dilotta politica in Argentina durante gli anni Sessanta, ci che sempre mitorna in mente come punto di riferimento e termine di paragone19.
La particolare situazione della lotta politica in Argentina alla fi-ne degli anni Cinquanta con la presenza del peronismo, di uno-ligarchia liberale incapace di conquistare legemonia, di una carat-terizzazione nazionalistica dei partiti di sinistra20 determina lesi-genza di venire a capo della logica specifica delle ideologie e delladinamica degli antagonismi politici: Tutto ci che ho tentato dipensare teoricamente in seguito la diaspora delle posizioni sog-gettive, la ricomposizione egemonica delle identit frammentate, la
143
18 Ivi, p. 225, e ovviamente cfr. Ernesto Laclau, Emancipation(s), Verso,London and New York 1996.
19 E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., p. 200.Cfr. Oliver Marchart, Politics and the Ontological Difference. On the strictlyphilosophical in Laclaus work, in Laclau. A critical reader, cit., pp. 54-72, qui55: Despite its crystal-clear and logical argumentative procedures, [...] thevery nature of his thought is decisively strategic.
20 Cfr. E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., pp.197-200.
zionato, da cui prendere le mosse per spiegare tutto il resto. Ege-monia designa pertanto linsieme di processi e strategie che conti-nuamente ri/articolano politicamente la societ, costituendo a par-tire da s stessi, senza nessun riferimento o vincolo oggettivo, lasegmentazione politica della societ. I processi egemonici non sonoil riflesso di un ordine a essi esterno, ma lespressione dellimpossi-bilit di ordinare una volta per tutte la societ. lirrappresenta-bilit scientifica della societ, ci che fa s che essa sia rappresenta-bile solo politicamente, cio progettabile attraverso un interventostrategico che, partendo da una serie di elementi che sono ordinatiin una determinata maniera, costruisce una serie differente, senzache il primo ordinamento, n il secondo, siano in nessun modo og-gettivamente radicati in unessenza o legge di sviluppo della socie-t. La politica insomma la costruzione di un ordine contingente,ed evento contingente essa stessa (non detto che questi due or-dini di questioni siano identici o conciliabili), in quanto non sololordine nuovo avrebbe potuto essere diverso, ma la stessa nuovaegemonia avrebbe potuto n affermarsi, n essere formulata.
Pratica politica e teoria
A questo punto occorre arrestarsi e fare unosservazione gene-rale. Nei suoi diversi interventi teorici, e nel variare dei riferimenticulturali e delle categorie utilizzate, Laclau mantiene fermo almenoun elemento: lesigenza di formulare una logica della politica, chenon la renda debitrice a unistanza pi profonda16, e che pertantosia in grado di comprendere e di accompagnare una possibile poli-tica di democrazia radicale17 o, come pi tardi lha precisata, una
142
16 Questa esigenza antimetafisica gi presente in un libro marxistacome Politics and Ideology in Marxist Theory, cit., del 1977, di cui cfr. sopra-tutto la polemica contro la nozione althusseriana di istanze nel cap. 2 (TheSpecificity of the Political) e lo sviluppo del concetto di egemonia nel cap. 3(Fascism and Ideology).
17 Cfr. E. Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, cit., pp.176-193. Si ricordi per che la formulazione della politica in termini di demo-crazia radicale, che compare nellultima parte del libro [Hegemony and Socia-list Strategy], fondamentalmente un suo [di Chantal Mouffe] contributo (E.Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., p. 180).
-
nuovi movimenti sociali (pacifismo, ecologismo, femminismo) eal loro linguaggio (locale/globale, differenza, ecc.), in New Reflec-tions on the Revolution of Our Time (1990) quello ai processi di de-mocratizzazione post-1989 (presentati con un ottimismo presto ri-velatosi immotivato), ecc. Sarebbe per ingeneroso ridurre il pen-siero politico di Laclau a un commento rapsodico e occasionale del-lattualit. Piuttosto, mi pare che si debba ragionare allinverso, eindividuare il modo in cui unistanza rimasta immutata dagli anniSessanta si appella a movimenti politici che di volta in volta appaio-no esserne i pi adatti interlocutori. Lo stesso discorso va fatto peril linguaggio e le categorie utilizzate da Laclau, che vanno sempretradotte in quella logica della contingenza, che esse devonopoter supportare.
Interrogarsi circa la ragione, per la quale Laclau ha ritenuto dipoter individuare nel post-strutturalismo lo spazio adeguato aesprimere quella esigenza politica23, rischia di essere semplicemen-te ozioso, riducendosi alla constatazione del coincidere nella cultu-ra europea di una crisi (il marxismo) e di unaffermazione (il deco-struzionismo). Peggio ancora, rischia di cadere in quella concezio-ne razionalistica e infine idealistica24 della conoscenza, che stabili-sce un nesso di continuit necessario tra una filosofia e una politica.Invece, quella interrogazione diventa teoricamente e politicamentedirimente, se si converte nellindividuazione del modo in cui quellinguaggio concretamente assolve alla propria funzione politica.Solo in questo modo sar del resto possibile rispettare le afferma-zioni di Laclau citate sopra, relative al fatto che i testi del decostru-zionismo sono delle spiegazioni di unesperienza politica che anco-ra, a distanza di anni, continua a reclamare di essere pensata.
Pensare la contingenza
Come pensare la contingenza? Lapparato categoriale post-strutturalistico costituisce un orizzonte, che rende possibile un in-sieme di operazioni teorico-discorsive nascenti dallintrinseca in-
145
23 Cfr. E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., pp.207 s.
24 Ivi, p. 191.
ricostituzione delle identit sociali mediante limmaginario politico tutto questo, qualcosa che ho appreso in quegli anni di attivi-smo politico21. Ma questa logica pu essere sviluppata in modonon limitativo, debole o contraddittorio, solo se quelle specificitargentine non vengono pensate come aberrazioni (o eccezioni) ri-spetto a un modello generale e tipico, in cui vi invece corrispon-denza tra classi, partiti e ideologie. Non si tratta neanche di elabo-rare un modello di determinazione tanto flessibile e sofisticato, daprevedere le deviazioni dalla regola come altrettante forme di rego-larit. Si tratta invece di partire dalla congiuntura particolare e, spo-gliandola della categoria di particolarit, leggerla alla luce di tut-taltro sistema concettuale, che giustifichi e spieghi quel caso indi-viduale rinunciando al ricorso al metro delluniversale. In une-spressione: sviluppare una logica della contingenza.
Ci che Laclau ha fatto e questo spiega anche la variazioneconcettuale nel corso degli anni stato costruire una logica dellacontingenza allo scopo di rendere pensabile, e quindi strategica-mente progettabile, ci che il marxismo non riusciva a pensare n aprogettare22. Tutto questo ha ovviamente comportato il pagamentodi una serie di pedaggi politici allo spirito del tempo (ma del resto,chi non lo fa?): in Hegemony and Socialist Strategy il riferimento ai
144
21 Ivi, p. 180.22 Laclau assume che il marxismo sia coestensivo al socialismo e al comu-
nismo della Seconda e Terza Internazionale, che cio non abbia senso interro-garsi sul marxismo al di fuori del legame diretto o indiretto con la storia delmovimento operaio. La stessa ricostruzione presente in Hegemony and Socia-list Strategy, scandita sui dibattiti tra i maggiori teorici della Seconda e TerzaInternazionale, testimonia di questo approccio. Esso si pu accettare, in quan-to mette in rilievo il fatto che la teoria marxista ha uno statuto di assoluta pe-culiarit, in quanto necessariamente deve fondersi con un movimento di mas-sa; ma diventa limitativo, nel momento in cui a) considera secondarie le alter-native (anche perdenti e isolate) presenti nella storia del marxismo (o dei mar-xismi?), finendo per assecondare una sorta di primato epistemologico del pre-sente, contro cui del resto Laclau combatte (cfr. p. es. New Reflections on theRevolution of Our Time, cit., pp. 118-121); b) spinge a trascurare un approfon-dito confronto con Marx, privilegiando limmagine oggettivistica che della suaopera hanno dato Engels e lo stesso Marx (cfr. ivi, pp. 181 s. e sopratutto, informa semplificata e quasi caricaturale, Ernesto Laclau, Articulation du sens etlimites de la mtaphore, in Archives de philosophie, 70, 2007, 4, pp. 599-624,qui 615 s.), come se il momento althusseriano, a cui Laclau deve moltissimo,non ci fosse mai stato.
-
sit, dallaltra il disordine completo: insomma, una regola generalealla quale possano essere sottoposti.
Dire che la societ un sistema costitutivamente incompleto,sta a indicare in primo luogo il fatto che le forme di chiusura nonscaturiscono dal suo interno, su di un piano di immanenza (e sonopertanto arbitrarie); dallaltra che forme di chiusura si devono dare,una volta che vi sia societ, e che quindi non possibile n las-soluta fissit, n lassoluta non fissit29. Se dunque lo strutturali-smo aiuta a pensare il carattere non sostanziale dellidentit di ogniunit, risolvendola nel sistema di differenze che la costituiscono,si pu sfuggire allultima ricomparsa dellessenzialismo (che pro-prio lidea strutturalistica di un sistema chiuso), appellandosi aquelle correnti da Heidegger a Wittgenstein a Derrida che han-no insistito sullimpossibilit di fissare dei significati ultimi30.
La costituzione di ordini sar, si detto, esterna agli elementiche vengono disposti nel sistema di differenze. Laclau la chiamaarticolazione, con ci intendendo ogni pratica che stabilisca unarelazione tra elementi, in modo che la loro identit venga modifica-ta come risultato della pratica articolatoria31. La pratica articolato-ria d luogo a un discorso, in quanto riesca con successo a costi-tuire una totalit strutturata, un ordine32. Questo passaggio pernon mai completo: esattamente come il significante non si lasciamai esaurire nel significato in ragione della trascendenza di que-stultimo, allo stesso modo lordine, come tutti gli ordini possibili,non riduce a s la contingenza in quanto non ne conseguenza im-manente. Il discorso non una totalit priva di un fuori; piutto-sto, si presenta come totalizzante e sistematico, grazie alla produ-zione di significanti privilegiati, che fissano il significato di una ca-tena significante33 che Laclau chiama punti nodali34 ma vie-ne costantemente sommerso [...] dallinfinit del campo della dis-corsivit35.
147
29 Ibidem.30 Ibidem. Cfr. ivi, pp. 112 s.31 Ivi, p. 105.32 Ibidem.33 Ivi, p. 112.34 Questi traducono i lacaniani points de capiton.35 E. Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, cit., p. 113.
stabilit della relazione significante/significato25. Il post-struttura-lismo prende le mosse dal carattere arbitrario del nesso significan-te/significato, e lo conduce alle sue estreme conseguenze; in primoluogo, allaffermazione ontologica di una struttura assente:
La critica dello strutturalismo implic una rottura con [la] concezionedi uno spazio strutturale pienamente costituito, ma al contempo rifiu-t qualsiasi ritorno a una concezione delle unit [semiologiche] comeentit distinte, in modo fisso e nomenclatorio, dal riferimento a un og-getto. Ne risult la concezione di uno spazio relazionale incapace dicostituirsi come tale di un campo dominato dal desiderio di unastruttura che, sempre, finiva per per risultare assente. Il segno il no-me di una scissione, di una sutura impossibile tra significante e signifi-cato26.
I rapporti sociali essendo sempre surdeterminati, dunque inve-stiti in un discorso ideologico, in un processo di significazione, sidar di conseguenza unimpossibilit di pensare la societ come to-talit chiusa, percorsa da leggi oggettive relative a puri e isolabilifatti. Occorre rinunciare alla concezione della societ come to-talit che fonda i propri processi parziali, al modo di Hegel, e con-siderare invece il carattere di apertura del sociale come fondamen-to costitutivo o essenza negativa dellesistente, e i diversi ordinisociali come dei precari e in ultima istanza fallaci tentativi di addo-mesticare il campo delle differenze27. Le varie strutture di ordinepolitico non rispecchiano una scala scritta in modo immanente nel-la societ, n esprimono tendenze oggettivamente presenti, n infi-ne attualizzano in modi differenti un Ordine . Piuttosto, la neces-sit esiste solo come una parziale limitazione del campo della con-tingenza28, e daltra parte questultima non un altro nome, rove-sciato, negativo, dellOrdine. I segni (unit di significante e signifi-cato) si danno, mentre ci che non si d , da una parte, la loro fis-
146
25 Ibidem.26 E. Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, cit., p. 113. Il
rinvio, dobbligo, a U. Eco, La struttura assente. Introduzione alla ricerca se-miologica, Bompiani, Milano 1980 (19681), nella cui parte quarta si trova unaricostruzione accurata della crisi dello strutturalismo, e in particolare nel cap.5 (pp. 323-360) delle posizioni di Lacan, Derrida e Foucault.
27 E. Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, cit., pp. 95 s.28 Ivi, p. 111.
-
differenziale dei momenti interni a un sistema significativo (a undiscorso), mediante listituzione di unequivalenza tra alcuni diessi, in modo da far loro perdere le rispettive specificit, facendoloro riguadagnare il carattere fluttuante di elementi esterni al siste-ma stesso41.
Lesempio addotto quello di un paese colonizzato, in cui tut-ta una serie di tratti colore della pelle, modo di vestire, lingua, abi-tudini rende evidente ogni giorno ai colonizzati la presenza delpotere coloniale: ognuno di questi contenuti , agli occhi dei colo-nizzati, equivalente allaltro, e perde cos la propria specificit, inun collasso generalizzato della logica della significazione. Lequi-valenza crea pertanto un secondo significato che, sebbene parassi-tario del primo, lo sovverte: le differenze si cancellano reciproca-mente nella misura in cui vengono utilizzate per esprimere qualco-sa di identico soggiacente a tutte42. Questo qualcosa non puovviamente essere una determinazione positiva interna (dato che inquesto caso sarebbe sottoposta al sistema delle differenze), maqualcosa di esterno, che per non pu essere un oggetto positiva-mente esprimibile per differenza43, ma precisamente un oggetto ne-gativo, anzi al limite la negativit in quanto tale, cio lopposizionepolitica al dominio dei colonizzatori come limite del sistema dif-ferenziale istituito dal colonialismo. Nella catena di equivalenze,lidentit positiva del sistema colonialismo viene dissolta, e rim-piazzata da unidentit negativa: colonizzatore = anti-colonizza-to44. Una volta istituita questa catena di equivalenze (che pu soloaversi nella forma della sua diffusione nellimmaginario comune deicolonizzati), si formato un antagonismo che mostra il limite del-loggettivit rappresentata dal sociale sistemato nel discorso co-loniale45.
149
41 Ivi, p. 127.42 Ibidem.43 In questo caso la relazione tra le due polarit potrebbe essere costrui-
ta in maniera diretta e positiva, ci che renderebbe impossibile la completacancellazione delle differenze (ibidem).
44 Ivi, pp. 127 s.45 Sullantagonismo come limite del sociale/delloggettivit cfr. ivi, pp.
122-127.
Punti nodali
La nozione di punti nodali la chiave per intendere il concettodi articolazione, e quindi lintera concezione della contingenza cheLaclau mette allopera in Hegemony and Socialist Strategy. Comesi costituisce e quale funzione svolge un punto nodale? Esso unalimitazione della produttivit del significare36, cio una parzialefissazione del significato del sociale entro un sistema organizzatodi differenze37. Ma dato che, come si visto, qualsiasi limitazionedel campo infinito della discorsivit presuppone lintervento di unelemento esterno a ci che viene ridotto alla logica delle differenze,il punto nodale, per essere il centro organizzatore di un sistema didifferenze, non potr cadere a sua volta sotto la logica che alimen-ta e garantisce. In altre parole, la produzione di uno spazio ordina-to di differenze poggia sullesistenza funzionante di un punto ir-riducibile a quel sistema di differenze, un punto che, rispetto a es-se, rappresenta pertanto il campo infinito della discorsivit, dun-que la dissoluzione di quello stesso ordine da esso posto in opera38.La costituzione di un sistema ordinato di differenze pertanto unastruttura fin dallinizio scissa, in quanto lordine reso possibileprecisamente da ci che lo rende impossibile.
Il punto nodale pu difatti supportare la propria funzio-ne aggregante e ordinante, solo in quanto un significante investi-to di un significato irriducibile alla logica differenziale, dunque al-la logica stessa della significazione. Infatti, lunico esempio dipunto nodale presente in Hegemony and Socialist Strategy, quello dellimporsi del principio democratico della libert e del-leguaglianza come nuova matrice dellimmaginario sociale39.Questa decisiva mutazione nellimmaginario politico delle socie-t occidentali ebbe luogo duecento anni or sono, e pu essere cosdescritta: la logica dellequivalenza fu trasformata nello strumentofondamentale di produzione del sociale40. Per logica dellequiva-lenza, Laclau intende un processo di dissoluzione del carattere
148
36 Ivi, p. 112.37 Ivi, p. 135.38 Cfr. gli sviluppi contenuti in E. Laclau, Emancipation(s), cit., pp. 36-46.39 E. Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, cit., pp. 154 s.40 Ivi, p. 155.
-
Questultimo punto mi sembra di importanza decisiva. Infattilintera concezione della contingenza ne dipende, perch, come sivede, lesteriorit (trascendenza) del momento che articola rispettoa quello che viene articolato scaturisce storicamente da una trasfor-mazione della struttura dellimmaginario sociale comune: infatti ilrivoluzionamento della logica teologico-politica e laffermazioneche il potere deriva solo dal popolo50, ci che rende allo stessotempo possibile e necessaria la politica come egemonia, essendo ilpopolo esso stesso una catena di equivalenze e, al contempo, unpunto nodale, che tale, in quanto domina e pervade limmagina-rio sociale. Detto in altro modo: Laclau individua nella serie stori-ca di trasformazioni che si riassumono nellidea di tempi moder-ni, e nella serie di lotte che si condensano nella Rivoluzione fran-cese, il processo storico reale che rende possibile/necessaria una lo-gica della contingenza (non in quanto escogitazione arbitraria, main quanto logica della realt). Si potrebbe quindi dire, nei suoi stes-si termini, che il principio della contingenza (trascendenza nel rap-porto di articolazione) sorge come effetto immanente del processodi lotte e trasformazioni che hanno condotto allaffermarsidellimmaginario egualitario51.
Insisto sul termine immaginario, perch esso decisivo perintendere il modo in cui Laclau pensa il costituirsi degli orizzontistorici di evidenza, e quindi di verit-oggettivit. La trasformazio-ne dellimmaginario la chiave per intendere la genesi della moder-nit, e quindi laffermarsi generalizzato della logica della contin-genza. Ma limmaginario a sua volta immanente alle trasformazio-ni materiali che i rapporti sociali hanno subto nel corso degli ulti-mi due secoli. Limmaginario egualitario allo stesso tempo il rias-sunto politico di una serie di lotte politiche e sociali per lemanci-pazione, il riassunto sociale di una serie di trasformazioni dei rap-porti sociali, e il terreno della pensabilit di queste lotte e di questetrasformazioni. Esso infatti, in quanto fondato sulla logica delle-quivalenza, lopposto di ogni forma di essenzialismo52.
151
50 Ivi, p. 155.51 Ivi, p. 160.52 E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., p. 187.
Immaginario egualitario
A un certo punto della storia, dunque, la logica dellequivalenza stata socialmente posta alla base dellarticolazione della societ:ci accaduto in quellampio movimento di emancipazione che haprodotto la moderna societ occidentale, cio quella organizzazio-ne sociale che revoca in questione tutte le differenze prima con-siderate naturali; nella quale tutte le identit vengono a essereconsiderate come articolate e prodotte, e non chiuse e date per tra-dizione. Solo in questo spazio il sociale (differenza) viene prodottomediante lequivalenza (antagonismo), il positivo fondato sul ne-gativo, il sistema poggia insomma sulla propria stessa impossibilit.Infatti in una comunit contadina medioevale, larea disponibilealle articolazioni differenziali minima, e pertanto non vi sono for-me egemoniche di articolazione: c il passaggio brusco da praticheripetitive entro un sistema chiuso di differenze, a equivalenze fron-tali e assolute, quando la comunit si trova a essere minacciata46.Catene di equivalenza possono darsi anche nella societ feudale (sipensi al millenarismo, che lantagonismo nella sua forma pipura47, in quanto rappresenta il limite del sociale come alternativatotale al sociale stesso48), ma solo nella societ post-feudale possonoesserci punti nodali, cio mediazioni sempre in atto tra equiva-lenza e differenza, identificazione reale di stabilit e instabilit,di conservazione e innovazione. Quella moderna insomma unasociet che, a differenza di quelle tradizionali, costruisce la propriaidentit e la propria struttura gerarchica nella (e non: nonostante la)trasformazione continua di tutti i rapporti e nella (e non: nonostan-te la) continua messa in discussione di tutte le gerarchie date. La po-litica come egemonia espressione di questa forma di organizzazio-ne sociale, in cui le differenze sono tali, solo in quanto vengono at-tivamente articolate da una politica che continuamente risegmentauno spazio fondamentalmente equivalente49.
150
46 Ivi, p. 138.47 Ivi, p. 136.48 Cfr. ivi, pp. 129 s.49 Ecco perch la forma egemonica di politica diventa dominante allini-
zio dei tempi moderni, quando la riproduzione delle differenti aree sociali haluogo in condizioni che cambiano in permanenza, ci che costantemente ri-chiede la costruzione di nuovi sistemi di differenza (ivi, p. 138).
-
versante si identifica con i rapporti sociali (con la storia stessa delletrasformazioni e delle lotte), dallaltro versante sconfina nei concet-ti che permettono epocalmente di pensare trasformazioni e lotte.Limmaginario insomma, in Hegemony and Socialist Strategy, ladimensione pratico-politica del pensiero, ci che ne assicura la cor-rispondenza alla realt non in termini di rispecchiamento, ma di ve-rit-efficacia. anche, si pu aggiungere, il luogo in cui oggettivite verit si congiungono, perch loggettivit cessa di essere un pro-cesso puramente differenziale, inglobando al suo interno la logicadellequivalenza e quindi diventando capace di esprimere realmen-te, politicamente, le istanze veritative (di costituzione pratica di ve-rit) presenti nellantagonismo.
Ora, come conciliare tutto questo con il ricorso al post-struttu-ralismo e al decostruzionismo? Non vi , in Hegemony and Socia-list Strategy, unalmeno residuale incoerenza tra marxismo e deco-struzionismo? Sembra di s, se in New Reflections on the Revolutionof Our Time, pubblicato nel 1990 e costituito da una serie di messea punto rispetto al libro del 1985 Laclau sente il bisogno di rifor-mulare positivamente i concetti precedentemente ricavati in negati-vo da un esercizio di decostruzione del marxismo55, introducendouna categoria, quella di dislocazione, destinata a rendere contotanto dellantagonismo, quanto delle trasformazioni dellimmagina-rio. Ora insomma, con il ricorso alla dislocazione, si persegue lob-biettivo di ricondurre a una medesima logica sia lantagonismo, siail terreno storico sul quale, nelle societ contemporanee, prolifera-no i conflitti56, sia infine limmaginario sociale, ivi inclusi i proget-ti di ricostruzione politica delle identit sociali57. Limmaginarionon spiega pi nulla, non un concetto utile a periodizzare leepoche: questa funzione viene ora assegnata alla dislocazione.
Con dislocazione Laclau designa il carattere sempre sposta-to, sempre disidentico a s, di ogni identit. La dislocazione lacaratteristica di ogni sistema di differenze, in quanto non sutura-bile, cio in quanto dipende per la sua esistenza da un fuori cheal contempo lo rende possibile e nega la sua identit58. La nozione
153
55 Cfr. E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., p. 4.56 Ivi, pp. 4 s.57 Ivi, p. 5.58 Ivi, p. 39.
Dislocazione
Mi pare che il nesso tra limmaginario e, da una parte, la mate-rialit delle lotte e dei rapporti sociali, dallaltra la costituzione dispazi di pensabilit, sia uno dei luoghi maggiormente importanti,ma anche maggiormente problematici, di un libro come Hegemonyand Socialist Strategy. Limmaginario infatti occupa due luoghi di-stinti nellargomentazione: un concetto descrittivo, grosso modoequivalente a ideologia (immaginario il luogo in cui si conden-sano socialmente le pratiche di articolazione del potere)53, ma an-che un concetto analitico, in quanto permette di pensare la distin-zione tra fasi storiche differenti. Infatti, come si gi visto, Laclauparla di una decisiva mutazione avvenuta nellimmaginario po-litico delle societ occidentali [...] duecento anni orsono54, muta-zione che concerne linterna struttura (la forma e non solo il conte-nuto) dellimmaginario stesso: cambia infatti il rapporto tra logicadellequivalenza e logica della differenza, in modo che sorge la pos-sibilit di due cose strettamente correlate: la democrazia e la critica.In effetti, ci che Laclau chiama immaginario democratico, unimmaginario compenetrato dal principio della critica come critica dimassa; unideologia che non pi soltanto ideologia, ma ha inizia-to a essere filosofia (o teoria).
Questa idea di modernit , mi pare, di matrice illuministica: ineffetti la mutazione della forma dellimmaginario fa pensare al mu-tamento del rapporto tra pubblico e ragione presupposto dal-la kantiana uscita dallo stato di minorit. Ma non qui, credo, ilsuo significato pi profondo. Esso risiede invece, a mio avviso, nelpeculiare statuto bifronte dellimmaginario: da un lato, le sue tra-sformazioni individuano la genesi storica del pensiero della contin-genza; dallaltro esso rende conto teoricamente della saldatura deiprocessi di trasformazione sociale con la loro pensabilit. In quan-to tale, limmaginario un territorio dai confini indefiniti: da un
152
53 ci che in precedenza Laclau chiamava doxa o discorso di sensocomune, come luogo in cui si condensa linsieme di articolazioni in cuiconsiste il potere; a cui va raffrontata una teoria come processo critico checonduce alla purificazione di ogni concetto e che consiste nel rompere queilegami tra concetti che sono il mero residuo di opinione e costume (E. Laclau,Politics and Ideology in Marxist Theory, cit., p. 7).
54 E. Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, cit., p. 155.
-
differenza da Hegemony and Socialist Strategy, designa ora un mi-to che si sia distaccato radicalmente dalla letteralit delle sue riven-dicazioni iniziali, e sia diventato lorizzonte illimitato di iscrizio-ne di ogni rivendicazione sociale e di ogni possibile dislocazione63.Limmaginario insomma un mito epocalmente affermatosi comesuperficie di iscrizione generale di molteplici miti. Esempi di imma-ginario sociale sono il millennio cristiano, la concezione illumini-stica e positivistica del progresso, la societ comunista [...]: in quan-to modi di rappresentazione dellautentica forma della pienezza,sono collocati al di l della precariet e delle dislocazioni tipiche delmondo degli oggetti64. Mentre un mito tende a ricostruire unog-gettivit nel vuoto di una dislocazione determinata, un immagina-rio la stessa forma delloggettivit priva di qualsiasi oggetto de-terminato.
Mito e politica
La politica si d necessariamente nella forma del mito. Per mi-to non occorre intendere la riemersione di qualcosa di primitivoe irrazionale nelle societ moderne65: al contrario, il mito costi-tutivo di ogni possibile societ essendo lo spazio mitico, quelloformato come principio di riordinamento degli elementi dislocatidi una struttura66. Quindi nel capitalismo contemporaneo, essen-do il grado di dislocazione altissimo, lo spazio del mito cresce e nondiminuisce67.
Il mito sorge infatti nel fallimento di unoggettivit struttura-le68, l dove la rappresentabilit cessa, dando luogo allevento69irrappresentabile, pura temporalit opposta allo spazio dellaripetibilit e, quindi, dei significati strutturati: in una parola, dellarappresentazione70. Ma la politica al contempo una risposta agli
155
63 Ivi, p. 64. E cfr. ivi, pp. 78 s.64 Ibidem.65 Ivi, p. 67.66 Ibidem.67 Ibidem.68 Ibidem.69 Ivi, p. 44.70 Cfr. ivi, pp. 41 s.
di dislocazione una generalizzazione della nozione di punti no-dali: essa estende ora a qualsiasi sistema sociale la struttura contin-gente che, in Hegemony and Socialist Strategy emergeva come pe-culiarmente legata allet moderna. Si tratter quindi di distinguerediversi gradi di dislocazione, e si potr dire che quanto minore es-so , tanto maggiore sar lefficacia della logica della differenza; eviceversa, quanto maggiore, tanto maggiore sar il peso della logicadellequivalenza. Cos, limporsi della modernit capitalistica puessere visto come una generalizzazione delle relazioni dislocato-rie, ci che comporta un triplice effetto: 1) il ritmo accelerato del-le trasformazioni storiche conduce a una maggiore consapevolezzadi massa della storicit dellessere degli oggetti; 2) quanto pi unastruttura dislocata, tanto maggiore lo spazio lasciato libero alledecisioni da essa non determinate, con conseguente crescita delruolo del soggetto; 3) la dislocazione di una struttura compor-ta una moltiplicazione dei centri di potere, in quanto si moltiplica-no gli antagonismi59.
Come si vede, la logica della dislocazione rende ragione del for-marsi di quel terreno peculiarmente moderno, in cui lantagonismosi generalizza e la logica dellequivalenza diventa dominante. Oraper il dominio della logica dellequivalenza non d luogo a un cor-tocircuito tra immaginario e teoria, perch esso stesso effetto del-la dislocazione, che, mentre produce gli antagonismi, dissolvendologgettivit del sociale, forma il terreno su cui pu collocarsi unarisposta che tenti di ricostituire quella oggettivit, quella rappresen-tabilit, in termini necessariamente esterni a ci che rappresenta-bile entro la struttura stessa.
Questa risposta il mito60, il cui successo, la cui cristallizza-zione, d luogo a una nuova oggettivit. Se la dislocazione c sem-pre stata, vi sempre stato mito, vi sempre stato il processo di ri-costituzione delloggettivit sociale a partire dal suo esterno costi-tutivo61, vi sempre stata egemonia62; di conseguenza il passag-gio alla modernit non segna una discontinuit radicale, non intro-duce una nuova forma. Il termine immaginario, a sua volta, a
154
59 Ivi, pp. 39 s.60 Cfr. ivi, p. 61.61 Ivi, p. 59. Cfr. ivi, p. 50.62 Lefficacia del mito essenzialmente egemonica (ivi, p. 61).
-
na il sistema solo rinunciando a s stessa (cristallizzandosi in mito).Rimane allora il problema di individuare il luogo in precedenza oc-cupato dallimmaginario egualitario. Tale posto sembra per certiaspetti scomparso: ora infatti il momento hegelo-marxista, lIl-luminismo, le grandi narrazioni del secolo XIX e i totalitarismidel XX vengono considerati altrettante forme di eliminazione diun autentico pensiero della dislocazione, e di riduzione della realtal grandioso schema di una spazialit pura74 (ordine senza trau-mi, privo di politica). Ma dallaltra parte Laclau si pone realmenteil problema se il riconoscimento del carattere mitico o contingen-te delle configurazioni spaziali [...] non implichi gi una certaesteriorit rispetto a quello spazio mitico e, per estensione, a ognispazio75. E si chiede: Se ogni rappresentazione implica la spazia-lit, il riconoscimento della natura mitica di ogni spazio non impli-ca forse la rinuncia a qualsiasi intelligibilit del luogo dal quale untale riconoscimento viene fatto?76. In altre parole: se ogni rappre-sentazione assume forma mitica, come rappresentare politicamentela dissoluzione di questa stessa forma? Ci fa problema, non inquanto sia in gioco il singolo teorico, che pensa la propria funzio-ne come decostruzione, ma in quanto sia in gioco una dissoluzionein atto, cio una dissoluzione di massa della forma-mito (quelmovimento che in precedenza Laclau individuava nellimmaginarioegualitario). In quanto si pensi alla politica di massa, alla politicareale, inevitabile riferirsi a un momento costruttivo, ri-ordinativo,costitutivo di ordine. Ed qui che, in qualche modo, riemerge la fi-gura dellimmaginario democratico, anche se con contenuti e formedifferenti. Laclau pensa a una cultura di massa della precariet, cheprenda le mosse dal fatto che non esiste altra universalit, che nonsia quella costruita in modo pragmatico e precario da quel proces-so di circolazione che stabilisce unequivalenza tra una serie cre-scente di rivendicazioni77. Questa cultura sarebbe capace di rap-presentarsi senza cadere nel mito, se riuscisse a tenere costantemen-te aperto, al suo interno, il rapporto tra ordine ed evento alla lucedi uno storicismo radicale:
157
74 E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., p. 75.75 Ivi, p. 68.76 Ibidem.77 Ivi, p. 80.
effetti destabilizzanti, traumatici della dislocazione: una criticadella mancanza di strutturazione che si accompagna allordine do-minante71. Quindi deve assumere la forma spazializzata del mito,cio di unoggettivit alternativa (per esempio il socialismo comecritica degli effetti socialmente distruttivi dello sviluppo capitalisti-co, e come rappresentazione di una societ ordinata). Ci d luogoa un paradosso: la libert esiste perch la societ non riesce a co-stituirsi come un ordine sociale oggettivo; ma ogni agire socialetende alla costituzione di quelloggetto impossibile, e quindi versoleliminazione della condizione stessa della libert72. La logica del-la dislocazione rende conto di questa doppia faccia dellazione po-litica, e funziona rispetto a essa come un sostrato sempre presente si potrebbe dire eternamente presente la cui presenza per so-lo negativa: lirriducibile ambiguit dei significati. La dislocazione pertanto la storicit stessa, ci che pi tardi Laclau individuer nelreale lacaniano, come nucleo traumatico resistente alla simbo-lizzazione, il cui unico accesso al livello della rappresentazione si dattraverso contenuti ontici che esso si incorpora, senza attribuirsi inmodo necessario a nessuno di essi73. Esattamente come il reale,la dislocazione non ha una storia, ma rende possibile la storicit inquanto causa una continua rimessa in gioco dei significati (delsimbolico), senza che ci sia dovuto a un ordine sottostante, alquale questa rimessa in gioco debba necessariamente rispondere. Ela politica la forma eminente della storicit (della temporalit), inquanto sposta nellagire organizzato lambivalenza fondamentaledella dislocazione: interviene su di un ordine in nome dellordine.
In questo modo Laclau introduce unimportante novit rispet-to a Hegemony and Socialist Strategy: l si affermava che il rappor-to tra sistema e suo limite viene nella modernit internalizzato: nonvi pi una sequela di differenze che in alcuni momenti si rovescia-no bruscamente in equivalenze, ma un permanente e mobile intrec-cio di gerarchia ed egualitarismo; qui invece la struttura della stori-cit viene individuata nella dislocazione come fondamento negati-vo che prolunga i suoi effetti ambivalenti in una politica che riordi-
156
71 Ivi, p. 62.72 Ivi, p. 44.73 Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Zizek, Contingency, Hegemony,
Universality. Contemporary Dialogues on the Left, Verso, London and NewYork 2000, p. 184.
-
Questioni metafisiche
Secondo Laclau, larticolazione politica del sociale sorge da an-tagonismi, senza per esserne una conseguenza. Cos, il passaggiodi una classe da corporativa a egemonica afferma riprenden-do una fondamentale distinzione gramsciana non dovuto alle-laborazione coerente di un contenuto al principio presente in ma-niera confusa, ma al fatto che la dualit della rappresentazione[corporativa ed egemonica, scil.] stata presente fin dallinizio; per-ch ogni spazio mitico esterno alla dislocazione che pretende disuturare; e perch ogni gruppo, da questo punto di vista, esternoalle proprie stesse rivendicazioni81. Su questa base, scrive altroveLaclau, si pu dire che gli atti che istituiscono il legame sociale so-no decisioni contingenti che presuppongono relazioni di potere82.Pertanto, luniversalizzazione della rappresentazione non altroche una riorganizzazione del legame sociale dislocato, a partire daun mito non dipendente da esso, che lo istituisce ex novo.
Ma in che modo si rapporta questa riorganizzazione al suopresupposto, alle relazioni di potere? Laclau risponde che una relazione di condizionamento, che precisamente rende alcuneforze sociali, in determinate congiunture, pi capaci di altre di or-ganizzare unegemonia. Questo per, aggiunge, non un ritornoalla vecchia concezione delleffettivit (effectivity) storica delleforze sociali, perch quelle collocazioni strutturali ineguali, alcu-ne delle quali rappresentano punti di alta concentrazione del pote-re, sono esse stesse il risultato di processi, in cui la logica della dif-ferenza e la logica dellequivalenza si surdeterminano reciproca-mente83. Gli antagonismi non sono dunque tutti uguali: essi acqui-stano il proprio significato dal modo in cui si rapportano, come aun proprio presupposto, a unineguaglianza o irregolarit(unevenness) del sociale che , a sua volta, il prodotto di un sistemaegemonico. Questo per equivale a dire che anche il carattere ine-guale del sociale prodotto in ultima istanza di un atto di deci-sione contingente di cui si persa la traccia, che si cristallizzatoin potere: il potere semplicemente la traccia della contingenza,il punto in cui loggettivit rivela lalienazione radicale da cui de-
159
81 E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., pp. 64 s.82 E. Laclau, Emancipation(s), cit., p. 81.83 Ivi, p. 43.
Riformulare i valori dellIlluminismo in direzione di uno storicismoradicale e rinunciare ai suoi fondamenti epistemologici e ontologici, si-gnifica dunque espandere le potenzialit democratiche di quella tradi-zione, abbandonando al contempo le tendenze totalitarie nascenti dal-la rioccupazione, da essa realizzata, del fondamento delluniversalismoapocalittico78.
E altrove afferma: I valori universali dellIlluminismo [...] nondevono essere abbandonati; vanno invece presentati come costru-zioni sociali pragmatiche anzich come espressioni di unesigenzairrinunciabile della ragione79. La domanda da porre , a questopunto, se questo ideale di un pragmatismo di massa renda contodella radicalit della stessa analisi della politica condotta da Laclau;se cio tale ideale non sia una troppo rapida estensione dellattitudi-ne del pensatore professionale a quel popolo, di cui per altro ver-so si riconosce sia linaggirabilit politica ( il centro delle logicheequivalenziali), sia il carattere inevitabilmente immaginario, equindi ideologico (resiste, anche nelle sue varianti democratiche, aunarticolazione che sfugga al mito, ed pertanto sempre passibi-le di articolazioni democratiche e populiste)80. Questo punto con-duce a unulteriore domanda: il passaggio dallimmaginario comeluogo della mediazione in atto di differenza ed equivalenza, allim-maginario come superficie di iscrizione delloggettivit mitica, conla connessa regressione del momento di costituzione di verit dallaprassi collettiva allevento irrappresentabile, non corrisponde forsea una riqualificazione della contingenza? Questultima consistevanel carattere non necessario del nesso tra i momenti del sociale, inultima analisi: nel suo carattere politico. Ma questa politicit non eraarbitraria: essa non interveniva mai su di uno spazio liscio, ma sem-pre gi segmentato dalle configurazioni teorico-pratiche dellimma-ginario. Assegnando invece la contingenza allevento, questa seg-mentazione va perduta, dato che quando accediamo a essa, siamo gidentro il mito. Se nel primo caso la contingenza equivaleva a una di-versa necessit, ora invece essa si d solo come arbitrio assoluto.
158
78 Ivi, p. 83. Rioccupazione (reoccupation) traduce la Umbesetzung dicui parla Hans Blumenberg in Die Legitimitt der Neuzeit. Cfr. E. Laclau,New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., pp. 74 ss.
79 E. Laclau, Emancipation(s), cit., pp. 103 s.80 Cfr. Ernesto Laclau, On Populist Reason, Verso, London and New
York 2005, pp. 125-128, 164-171.
-
suo stesso annullamento (scrive infatti Laclau che attraverso ladislocazione il tempo superato dallo spazio88). Quando ci collo-chiamo dentro la risposta alla dislocazione, dentro il mito, siamogi in un terreno di sedimentazione e di ordine.
A ben vedere, questa concezione interstiziale e dileguante dellalibert il modo in cui Laclau mette al riparo la contingenza daqualsiasi contaminazione sostanzialistica. Ma di quale contingenzasi tratta precisamente? Si visto che lideologia non solamente non in rapporto con il tempo, ma non ne porta neanche in s la trac-cia, se non nella forma, come si visto, dellalienazione radicale.Il mito non esprime altro che potere, differenza, ineguaglianza,mentre la libert si eventualizza trascendendo le configurazioniimmaginarie date, in quanto ogni composizione organizzativa una caduta nelluniverso delloggettivit differenziale. Insomma,legemonia la forma in cui la politica coincide con la lotta per lalibert, ma la libert si pu dare solo nel margine dellegemoniastessa. Una volta contrapposte oggettivit e verit, su questo secon-do versante si ritrova solamente la nuda e immotivata decisione89.Se infatti levento temporalit pura, esso non pu essere modula-to secondo una pluralit di congiunture, ma semplicemente, o ci sa-r per intero, o sar del tutto assente. Qui dunque la contingenzanon va pi pensata come la non-necessit (= diversa necessit) diuna certa articolazione di elementi, quanto piuttosto come la po-tenza, conferita a un soggetto da un malfunzionamento dellor-dine della rappresentazione, di dare inizio a un nuovo ordine, dun-que di decidere arbitrariamente. Se nel primo caso abbiamo a chefare con una nozione di contingenza risultante dalla rilettura mo-derna di Lucrezio (Machiavelli, Spinoza), in questo secondo caso losfondo mi pare essere il pensiero di Carl Schmitt, una figura sullaquale peraltro Laclau tace completamente90.
161
88 Ivi, p. 42, cors. mio.89 Cfr. anche E. Laclau, Articulation du sens et limites de la mtaphore, cit.,
p. 614.90 Il nome di Schmitt non ricorre, a mia conoscenza, in nessuno scritto di
Laclau (nessun riferimento a esso si trova in Laclau. A critical reader, cit.),mentre Chantal Mouffe si pi volte soffermata sulla logica dellamico/nemi-co (cfr. The Democratic Paradox, Verso, London and New York 2000, cap. 2).Anche D. Tarizzo (Introduzione a La ragione populista, trad. it. Laterza, Ro-ma-Bari 2008, pp. VII-XXXIII, qui XVI s.) fa riferimento a Schmitt in meritoalla definizione del politico e (ivi, p. XX) della neutralizzazione.
finita. In questo senso loggettivit lessere degli oggetti non altro che la forma sedimentata del potere, in altre parole, un poterele cui tracce sono state cancellate84.
Allaltro estremo delloggettivit-alienazione, abbiamo la dislo-cazione come autentica forma della temporalit85, che, intesa cor-rettamente lesatto opposto dello spazio86. Il tempo non dun-que diacronia: la diacronia infatti un tentativo di cogliere il sensodi una successione, dunque una forma di spazio. Il tempo, in sstesso, invece da pensare come dislocazione della struttura, ciocome un suo malfunzionamento [...], un malfunzionamento irrap-presentabile in termini spaziali: in una parola, come evento87.
Ne risulta la serie seguente: dislocazione ? antagonismo ? tem-po-libert-evento ? decisione contingente ? mito ? potere ? oggetti-vit-spazio ? ineguaglianza del sociale ? dislocazione. Questa serie il circuito dellegemonia, in cui logica della differenza (delline-guaglianza) e logica dellequivalenza (delleguaglianza) sempre siintrecciano. Anche nei due estremi (nellestrema alienazione del-loggettivit del sociale, e nel punto in cui il tempo-libert-even-to d luogo alla decisione) vi in realt un intreccio, dato che le-vento una spazializzazione del tempo (il mito come racconto del-lOrdine), e loggettivit ordinata poggia sullassenza di ordine (sudi un significante vuoto). Ora, ci che qui rilevante, non lappa-rente recupero di categorie otto-novecentesche (soggetto : oggetto= atto : fatto), in realt completamente tradotte in una problemati-ca nuova; quanto piuttosto lidentificazione di oggettivit, spazio epotere. Ne segue che lintreccio relativo delle due dinamiche alledue estremit della serie non equivalente: la politica si concentratutta nel nesso di tempo, libert ed evento, dunque nella decisio-ne. Infatti lo spazio non pu contenere relazioni di eguaglianza,quindi leguaglianza, di cui la catena equivalenziale portatrice,vive solo nellinterstizio tra la dislocazione e latto di decisione.La dislocazione d luogo alla libert, la cui realizzazione per il
160
84 E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., p. 60.Qui Laclau utilizza esplicitamente la tematica husserliana della sedimentazio-ne/riattivazione. Cfr. ivi, pp. 33 s.; E. Laclau, Articulation du sens et limi-tes de la mtaphore, cit., p. 613.
85 E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., p. 41.86 Ibidem.87 Ivi, p. 42.
-
in cui la libert/verit si rifugiata nel ridotto della Differenza/As-senza/Alterit, la reazione pu variare dal disincantato lasciar es-sere al pessimismo disperato, fino magari a un neo-libertino dis-prezzo per il volgo. Va detto che latteggiamento di Laclau non ri-sponde a nessuno di questi schemi: il suo ottimismo politico94poggia su di una persistente fiducia nella ragione e nellemancipa-zione delle masse95. Il suo pi recente libro, sulla ragione populi-stica, tutto il contrario dellaccettazione del circolo vizioso de-mocrazia-demagogia: la messa a fuoco della sfida decisiva dellademocrazia nellepoca delle masse, nella convinzione (che potreb-be essere senzaltro estesa a Gramsci) che
non vediamo pi in noi stessi le successive incarnazioni dello spiritoassoluto Scienza, Classe, Partito ma i poveri uomini e donne chepensano e agiscono in un presente sempre transeunte e limitato; maquella stessa limitazione la condizione della nostra forza: noi in tan-to possiamo essere noi stessi e considerarci i costruttori del mondo,solo in quanto gli di sono morti. Non c pi un Logos, a noi ester-no, il cui messaggio ci tocchi decifrare negli interstizi di un mondoopaco96.
Questi riferimenti chiamano in causa il ruolo politico dellim-maginario egualitario che, come abbiamo visto, lopposto diogni forma di essenzialismo97. Questo immaginario, ancora inNew Reflections (1990), pensato come porta girevole del nessoteoria/pratica, cio come struttura dellapparenza nella quale si
163
naudi, Torino 1996, pp. 197-237, in partic. pp. 217 ss.), che non casualmente ri-prende e trascina fino al presente la prospettiva libertina della riduzione delpopolo a plebe e della separazione tra verit e sfera pubblica. Si pensi, per ave-re un termine di paragone adeguato, come nel 1973 trattava invece la questio-ne Furio Jesi, Mito, ISEDI, Milano 1973, in partic. i riferimenti al duplice vol-to, oscuro e luminoso, dellIlluminismo, come esperienza gnoseologica deldelimitare, del dire fin qui noi siamo (Rilke) (pp. 103 s.).
94 E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., p. 82.95 Si vedano le obiezioni che su questo punto gli muove ora Davide Tariz-
zo, assai pi propenso di Laclau ad ammettere che luniverso nevrotico diLaclau-Lacan sia stato rimpiazzato da un universo psicotico e perverso, incui non ci sono pi neanche i punti nodali. Cfr. lIntroduzione a La ragionepopulista, cit., pp. XXII-XXVI.
96 E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., p. 189.97 Ivi, p. 187.
Lalternativa sembra netta: nel primo caso che lo sfondo me-tafisico di un certo materialismo e immanentismo moderno a cuiappartiene anche Gramsci91 si d legame contingente, solo se si dcongiuntura, dunque irregolarit e ineguaglianza della superficiedel sociale; nel secondo invece la contingenza c solo se quella ir-regolarit viene rimessa in movimento e sciolta nellevento, seviene ricondotta alla pienezza della temporalit pura, a quella irrap-presentabilit radicale, dentro la quale solamente pensabile la de-cisione. Lalternativa tra una contingenza pensata come pluralitdei tempi in spazi diversi ma correlati, dunque reciprocamente im-manenti (traducibili), e una pensata come antitesi tra Tempo delladecisione e spazi dellordine, dove il Tempo (necessariamente singo-lare) e gli spazi (strutturalmente plurali) sono reciprocamente tra-scendenti, e gli spazi si correlano solo per via differenziale e nonper catene di equivalenze92.
Possiamo a questo punto riprendere la domanda formulata nelcap. 4, relativa al modo in cui il linguaggio del post-strutturalismoconcretamente assolve alla propria funzione politica nel pensiero diLaclau. Evidentemente, quel linguaggio risponde a una profonda,storica sfiducia nelle possibilit della politica come terreno delle-mancipazione delle masse: dopo una rapida parentesi (segnata dal-lascesa dei partiti di massa e quindi della partecipazione politica),le masse tornano sotto le protettive dinamiche passionali orchestra-te dai sapienti facitori di miti93. Dinnanzi a questo stato di cose,
162
91 Ho tentato di argomentare questo punto nel mio La religione delluo-mo moderno. Politica e verit nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci,in corso di stampa presso leditore Carocci di Roma.
92 Il modello laclauiano di esteriorit sembra rispecchiare la strutturaschmittiana della decisione (Dal punto di vista del contenuto della norma chesta a fondamento ogni momento decisionale costitutivo specifico qualcosa dinuovo e di esterno. In senso normativo, la decisione nata da un nulla, C.Schmitt, Teologia politica, in Id., Le categorie del politico. Saggi di teoria poli-tica, trad. it. il Mulino, Bologna 1972, p. 56), pi ancora che la dicotomia hei-deggeriana ontico/ontologico, a cui Laclau rinvia. Se vero infatti che la deci-sione il momento del soggetto prima della soggettivazione (J. Butler, E.Laclau, S. Zizek, Contingency, Hegemony, Universality, cit., p. 79), essa acca-de grazie allisolamento del soggetto stesso, per cui oppone singolarit e mon-do (al modo di Kierkegaard: cfr. ibidem), e non, come in Heidegger, esistenzaquotidiana e apertura dellesserci.
93 Questo modo di vedere viene perfettamente espresso, p. es., da CarloGinzburg (Mito, in I Greci. Storia Cultura Societ, dir. da S. Settis, Vol. I, Ei-
-
Nicola Marcucci
IL posto della critica. La dominazionetra sociologia e politica secondo Luc Boltanski
A scuola contro la scuola
Il progetto di sociologia critica elaborato da Luc Boltanski si sviluppato in oltre quarantanni di ricerca a partire dalla met deglianni 60. In una prima fase della sua riflessione, Boltanski aderiscealla sociologia critica di Pierre Bourdieu di cui allievo e con il qua-le firma diversi tra testi e articoli, per maturare poi, a partire dallamet degli anni Ottanta, una riflessione autonoma sullo statuto del-la teoria sociologica.
Uno dei testi pi significativi del primo periodo sicuramenteLa production de lidologie dominante. Questo lungo articolo ven-ne pubblicato nel 1976 sulla rivista Actes de la Recherche en Scien-ces Sociales. La rivista, inizialmente apparsa sotto forma di fanzinedelle scienze sociali, vede la luce, su iniziativa di Bourdieu e del suolaboratorio di ricerca, nel 1975.
Il saggio ha un valore paradigmatico per la definizione bourdie-siana del concetto di dominazione. Che cos unideologia dominan-te? Che rapporto intrattiene con la classe dominante e come questapu essere a sua volta definita? Queste le domande a cui il saggio cer-ca di rispondere interpretando la filosofia sociale implicita presenta-ta in un corpo di testi e materiali come atti di convegni, riviste, di-zionari e immagini coeve alla grande pianificazione liberale che loStato francese intraprese a cavallo tra il dopoguerra e la met deglianni 70, e che ebbero la funzione primaria [...] di esprimere e diprodurre lintegrazione logica e morale della classe dominante1. Si
165
produce la verit effettuale della cosa: Dato che nessuna forza lincarnazione delluniversale in s e per s, una volont collettivariuscir a consolidare la sua egemonia, solo se riuscir ad apparireagli altri gruppi come la forza che in grado di garantire la miglio-re sistemazione sociale al fine di assicurare ed espandere ununiver-salit che la trascende98. Leffetto di universalit poggia sullappa-rire della volont collettiva agli altri gruppi sociali: tale apparenza un sinonimo del funzionamento dellimmaginario egualitario. Es-so anche qui (come nel libro sulla Ragione populista) un immagi-nario che trova le sue origini nella Rivoluzione francese e nel suopeuple volitivo99. Questultima espressione di Tarizzo, e indivi-dua a suo modo di vedere un preciso limite razionalistico (e ioaggiungerei: giacobino) nellintero approccio di Laclau. In questepagine ho tentato di individuare in esso, al contrario, una potenzia-lit tenuta a freno dal linguaggio post-strutturalistico. Ora, qualeche ne sia la valutazione, come collocare questo immaginario egua-litario nello spazio del mito (in una relazione che non sia di puraesclusione)? Come articolarlo con la decisione? Non si scontranoqui due logiche, entrambe presenti in Laclau, quella costitutivadella rivoluzione permanente e quella della differenza semiologi-ca/ontologica, come modi alternativi di pensare limpossibilit dichiudere il sociale?
lo stesso Laclau che invita a porre questa domanda, quandonella concezione marxiana della rivoluzione permanente indivi-dua un approccio irriducibile a quello, parimenti presente in Marx,legato alla concezione della stadialit economicistica100: un ap-proccio, alla luce del quale non lo stadio relativo dello sviluppoci che crea la congiuntura rivoluzionaria, ma la dislocazionedella struttura101: forze pratiche attualmente in tensione.
164
98 Ivi, p. 81, cors. mio.99 Tarizzo, Introduzione, cit., p. XX.100 E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, cit., p. 45.
Ancora una volta torniamo alla militanza politica come matrice delle riflessio-ni teoriche: il partito al quale appartenevo, aveva un orientamento di tipo net-tamente nazionalistico e la sua strategia era una riformulazione della cosidettarivoluzione permanente (ivi, p. 198).
101 Ivi, p. 46. Cfr. anche E. Laclau, On Populist Reason, cit., pp. 125 s. 1 Luc Boltanski, Pierre Bourdieu, La production de lidologie dominante,