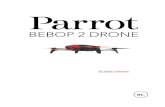filippottonieri.2.pdf
-
Upload
pinkmayflower -
Category
Documents
-
view
8 -
download
4
Transcript of filippottonieri.2.pdf
-
Giacomo Leopardi - Operette morali (1827)
Detti memorabili di Filippo OttonieriCapitolo secondo
Detti memorabili di Filippo Ottonieri -
Capitolo primo
Detti memorabili di Filippo Ottonieri -
Capitolo terzo
Non ammetteva distinzione dai negozi ai trastulli; e sempre che era stato occupato in qualunque cosa, per grave che ella fosse, diceva dessersi trastullato. Solo se talvolta era stato qualche poco dora senza occupazione, confessava non avere avuto in quellintervallo alcun passatempo.
Diceva che i diletti pi veri che abbia la nostra vita, sono quelli che nascono dalle immaginazioni false; e che i fanciulli trovano il tutto anche nel niente, gli uomini il niente nel tutto.
Assomigliava ciascuno de piaceri chiamati comunemente reali, a un carciofo di cui, volendo arrivare alla castagna, bisognasse prima rodere e trangugiare tutte le foglie. E soggiungeva che questi tali carciofi sono anche rarissimi; che altri in gran numero se ne trovano, simili a questi nel di fuori, ma dentro senza castagna; e che esso, potendosi difficilmente adattare a ingoiarsi le foglie, era contento per lo pi di astenersi dagli uni e dagli altri.
Rispondendo a uno che linterrog, qual fosse il peggior momento della vita umana, disse: eccetto il tempo del dolore, come eziandio del timore, io per me crederei che i peggiori momenti fossero quelli del piacere: perch la speranza e la rimembranza di questi momenti, le quali occupano il resto della vita, sono cose migliori e pi dolci assai degli stessi diletti. E paragonava universalmente i piaceri umani agli odori: perch giudicava che questi sogliano lasciare maggior desiderio di s, che qualunque altra sensazione, parlando proporzionatamente al diletto; e di tutti i sensi delluomo, il pi lontano da potere esser fatto pago dai propri piaceri, stimava che fosse lodorato. Anche paragonava gli odori allaspettativa de beni; dicendo che quelle cose odorifere che sono buone a mangiare, o a gustare in qualunque modo, ordinariamente vincono collodore il sapore; perch gustati piacciono meno cha odorarli, o meno di quel che dallodore si stimerebbe. E narrava che talvolta gli era avvenuto di sopportare impazientemente lindugio di qualche bene, che egli era gi certo di conseguire; e ci non per grande avidit che sentisse di detto bene, ma per timore di scemarsene il godimento con fare intorno a questo troppe immaginazioni, che glielo rappresentassero molto maggiore di quello che egli sarebbe riuscito. E che intanto aveva fatta ogni diligenza, per divertire la mente dal pensiero di quel bene, come si fa dai pensieri de mali.
Pagina 1 di 3
02/03/2014
-
Diceva altres che ognuno di noi, da che viene al mondo, come uno che si corica in un letto duro e disagiato: dove subito posto, sentendosi stare incomodamente, comincia a rivolgersi sulluno e sullaltro fianco, e mutar luogo e giacitura a ogni poco; e dura cos tutta la notte, sempre sperando di poter prendere alla fine un poco di sonno, e alcune volte credendo essere in punto di addormentarsi; finch venuta lora, senza essersi mai riposato, si leva.
Osservando insieme con alcuni altri certe api occupate nelle loro faccende, disse: beate voi se non intendete la vostra infelicit.
Non credeva che si potesse n contare tutte le miserie degli uomini, n deplorarne una sola bastantemente.
A quella questione di Orazio, come avvenga che nessuno contento del proprio stato, rispondeva: la cagione , che nessuno stato felice. Non meno i sudditi che i principi, non meno i poveri che i ricchi, non meno i deboli che i potenti, se fossero felici, sarebbero contentissimi della loro sorte, e non avrebbero invidia allaltrui: perocch gli uomini non sono pi incontentabili, che sia qualunque altro genere: ma non si possono appagare se non della felicit. Ora, essendo sempre infelici, che maraviglia che non sieno mai contenti?
Notava che posto caso che uno si trovasse nel pi felice stato di questa terra, senza che egli si potesse promettere di avanzarlo in nessuna parte e in nessuna guisa; si pu quasi dire che questi sarebbe il pi misero di tutti gli uomini. Anche i pi vecchi hanno disegni e speranze di migliorar condizione in qualche maniera. E ricordava un luogo di Senofonte[1], dove consiglia che avendosi a comperare un terreno, si compri di quelli che sono male coltivati; perch, dice, un terreno che non per darti pi frutto di quello che d, non ti rallegra tanto, quanto farebbe se tu lo vedessi andare di bene in meglio; e tutti quegli averi che noi veggiamo che vengono vantaggiando, ci danno molto pi contento che gli altri.
Allincontro notava che niuno stato cos misero, il quale non possa peggiorare; e che nessun mortale, per infelicissimo che sia, pu consolarsi n vantarsi, dicendo essere in tanta infelicit, che ella non comporti accrescimento. Ancorch la speranza non abbia termine, i beni degli uomini sono terminati; anzi a un di presso il ricco e il povero, il signore e il servo, se noi compensiamo le qualit del loro stato colle assuefazioni e coi desiderii loro, si trovano avere generalmente una stessa quantit di bene. Ma la natura non ha posto alcun termine ai nostri mali; e quasi la stessa immaginativa non pu fingere alcuna tanta calamit, che non si verifichi di presente, o gi non sia stata verificata, o per ultimo non si possa verificare, in qualcuno della nostra specie. Per tanto, laddove la maggior parte degli uomini non hanno in verit che sperare alcuno aumento della quantit di bene che posseggono; a niuno mai nello spazio di questa vita, pu mancar materia non vana di timore: e se la fortuna presto si riduce in grado, che ella veramente non ha virt di beneficarci da vantaggio, non perde per in alcun tempo la facolt di offenderci con danni nuovi e tali da vincere e rompere la stessa fermezza della disperazione.
Pagina 2 di 3
02/03/2014
-
Ridevasi spesse volte di quei filosofi che stimarono che luomo si possa sottrarre dalla potest della fortuna, disprezzando e riputando come altrui tutti i beni e i mali che non in sua propria mano il conseguire o evitare, il mantenere o liberarsene; e non riponendo la beatitudine e linfelicit propria in altro, che in quel che dipende totalmente da esso lui. Sopra la quale opinione, tra le altre cose, diceva: lasciamo stare che se anche fu mai persona che cogli altri vivesse da vero e perfetto filosofo, nessuno visse n vive in tal modo seco medesimo; e che tanto possibile non curarsi delle cose proprie pi che delle altrui, quanto curarsi delle altrui come fossero proprie. Ma dato che quella disposizione danimo che dicono questi filosofi, non solo fosse possibile, che non , ma si trovasse qui vera ed attuale in uno di noi; vi fosse anche pi perfetta che essi non dicono, confermata e connaturata da uso lunghissimo, sperimentata in mille casi; forse perci la beatitudine e linfelicit di questo tale, non sarebbero in potere della fortuna? Non soggiacerebbe alla fortuna quella stessa disposizione danimo, che questi presumono che ce ne debba sottrarre? La ragione delluomo non e sottoposta tutto giorno a infiniti accidenti? innumerabili morbi che recano stupidit, delirio, frenesia, furore, scempiaggine, cento altri generi di pazzia breve o durevole, temporale o perpetua; non la possono turbare, debilitare, stravolgere, estinguere? La memoria, conservatrice della sapienza, non si va sempre logorando e scemando dalla giovanezza in gi? quanti nella vecchiaia tornano fanciulli di mente! e quasi tutti perdono il vigore dello spirito in quella et. Come eziandio per qualunque mala disposizione del corpo, anco salva ed intera ogni facolt dellintelletto e della memoria, il coraggio e la costanza sogliono, quando pi, quando meno, languire; e non di rado si spengono. In fine, grande stoltezza confessare che il nostro corpo soggetto alle cose che non sono in facolt nostra, e contuttoci negare che lanimo, il quale dipende dal corpo quasi in tutto, soggiaccia necessariamente a cosa alcuna fuori che a noi medesimi. E conchiudeva, che luomo tutto intero, e sempre, e irrepugnabilmente, in potest della fortuna.
Dimandato a che nascano gli uomini, rispose per ischerzo: a conoscere quanto sia pi spediente il non esser nato.
Note
1. Oeconom. cap. 20, 23.
Pagina 3 di 3
02/03/2014