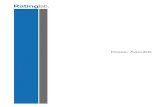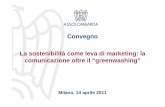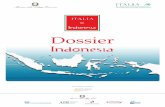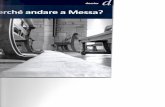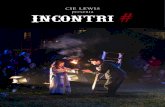Dossier greenwashing
-
Upload
gianluca-donato -
Category
Marketing
-
view
2.728 -
download
1
description
Transcript of Dossier greenwashing

La nuova ecologia aprile 200944
dossier
Solo il 20% dei consumatori in Gran Bretagna si fida delle promozioni che decantano le qualità ambien-tali di prodotti e servizi. È quanto emerge da un
rapporto, realizzato due anni fa, dall’autorevolissima as-sociazione Consumers International. Ma da cosa scaturi-sce questa sfiducia? Uno dei principali imputati si chiama greenwashing: un fenomeno in ascesa che rischia di com-promettere gli sforzi di ogni singola organizzazione diretti allo sviluppo di prodotti più sostenibili.
Il neologismo è stato coniato nel ’91 dalla rivista in-dipendente americana Mother Jones e unisce il con-cetto di green (“verde”, inteso in senso ecologico) e di
whitewashing (“dissimulare”, “nascondere”, “riabilitare”) per indicare la tendenza ad attribuire indebitamente ad aziende o prodotti, imprecisate virtù ambientali con l’in-tenzione di crearne un’immagine positiva. Le origini di questa strategia risalgono agli anni ’70, quando la tecnica era utilizzata prevalentemente per nascondere o rimedia-re a veri e propri disastri ambientali causati da parte di organizzazioni che operavano senza il minimo riguardo per l’ambiente. Oggi questo fenomeno, con la rinnovata at-tenzione alla sostenibilità ambientale scatenata dalla crisi che stiamo attraversando, rischia di esplodere indebolendo le iniziative genuine che molte aziende attuano per miglio-rare la loro sostenibilità e che rappresentano la maggiore opportunità per risolvere i problemi ambientali che stiamo affrontando. Un’esplosione che non è solo il risultato di un atteggiamento opportunista ma anche, e in larga parte, della mancanza di competenze in materia ambientale da parte di quanti realizzano gli annunci pubblicitari.
All’Asa (l’Autorità britannica sugli standard pubbli-citari) se ne sono accorti e per contenere il fenomeno hanno avviato corsi di formazione per i dirigenti
aziendali e seminari di confronto tra enti privati e ong, sempre con il supporto di esperti indipendenti e speciali-sti del settore. La stessa Asa ha realizzato nel 2008 uno
studio che ha coinvolto in Inghilterra quotidiani, periodici, siti web, canali televisivi e stazioni radio, evidenziando come le richieste d’intervento per sanzionare pubblicità ingannevoli a carattere ambientale stiano crescendo ra-pidamente negli ultimi anni. Nel 2006, l’Autorità aveva ricevuto 117 richieste relative a 83 pubblicità, ma nel 2007 queste erano già più che quadruplicate diventando 561 relative a 410 annunci promozionali. Dall’indagine emer-geva che la percentuale di violazioni riscontrate riguarda-va soprattutto la carta stampata, dove spesso ritroviamo frasi come «amico dell’ambiente», «totalmente biodegra-dabile» o «ecologico», affermazioni da evitare considerato che la produzione di un qualsiasi bene implica un impatto, per quanto minimo, sull’ambiente. E pensare, che già nel 2000, le linee guida pubblicate dalla Comunità europea sulla realizzazione e valutazione delle asserzioni ambien-tali sostenevano che tali affermazioni, essendo vaghe e non specifiche, non dovevano essere effettuate.
Le cose, purtroppo, non vanno meglio se, anziché guar-dare le promozioni, osserviamo i prodotti presenti ne-gli scaffali dei negozi. Nel novembre 2007 una nota
società di marketing ambientale canadese, Terrachoice Inc., realizzando un’indagine in un grande centro commer-ciale, individuava ben 1.018 prodotti riportanti asserzioni ambientali. Fin qui tutto bene, se non fosse che analizzan-do queste asserzioni alla luce della norma internazionale di riferimento, la Iso 14021, ben 1.017 la violavano in uno o più punti, offrendo quindi un’informazione scorretta o fuorviante. Dalla ricerca la società ricavava una preziosa lista, i “sei peccati del greenwashing” (v. box a pag 50). Di questi il trade-off nascosto (ovvero mettere in luce una qua-lità ambientale nascondendo altri problemi), la vaghezza e l’assenza di prova coprivano ben il 94% dei casi.
Anche alla luce di questi clamorosi risultati si sono mosse lo scorso anno sia le autorità canadesi che quelle degli Usa. In Canada, il Competition Bureau
Messaggi ambigui e marchi alla ricerca di una riabilitazione ambientale. Così il greenwashing rischia di rovinare il mercato dei prodotti davvero sostenibili. Come difendersi di Gianluca Donato illustrazioni di valeria de caterini
Gianluca Donato è Sustainability Specialist di Abb, multinazionale del comparto elettromeccanico. Ingegnere esperto di sistemi di gestione e comunicazione ambientale ha partecipato a progetti di qualificazione ambientale di prodotto. Ha contribuito allo sviluppo dello standard Iso 14025 e del sistema Epd internazionale. È fondatore di Assoscai.

aprile 2009 La nuova ecologia 45
“Il termine è stato coniato nel ’91 negli Usa. Ma il fenomeno dilaga fino in Gran Bretagna. Ed è ora
di prendere provvedimenti anche da noi’

La nuova ecologia aprile 200946
ha redatto ferree linee guida a cui dovranno attenersi tut-te le aziende per non ingannare i consumatori incorrendo in sanzioni amministrative e nei casi più gravi persino penali. Le linee guida canadesi stabiliscono l’onere della prova per le asserzioni ambientali da parte delle imprese che le sostengono. Si pone l’accento, inoltre, sull’impor-tanza di utilizzare affermazioni chiare, specifiche, veri-ficate e sostanziate, ovvero basate ancora una volta sui pilastri della norma Iso 14021. Negli Usa, dov’è attesa un’ondata di pubblicità “verdi” favorita anche dal green new deal dell’era Obama, si sta muovendo la Federal tra-de commission (Ftc) per rinnovare la propria Green guide for consumers risalente ormai al 1998. In Italia il pro-blema non ha ancora riscosso molta attenzione. Sarebbe utilissimo affrontarlo sia formando le imprese verso una maggiore consapevolezza dei criteri di sostenibilità, sia i comunicatori sul senso di molte espressioni ormai diffuse ma utilizzate non sempre a proposito. E sia i consumatori perché imparino a valutare, grazie a etichette e strumenti di verifica adeguati ai tempi, l’effettiva qualità ambientale dei prodotti che acquistano. l
Seduzioni pericoloseAntonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino: «In Italia poca attenzione. Ma i consumatori non devono farsi abbindolare»
«Se anche un’automobile è “ecologica”, questa parola perde il suo significato». il greenwashing è una pratica che tenta di sedurre il consumatore. Diventa dunque sempre più importante una corretta informazione sui prodotti. Ne abbiamo parlato con antonio longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino.
Molte pubblicità accusate di greenwashing sono di automobili. Gli slogan: “fueled by nature”, a basse emissioni, ecologiche, “high performance, law emission, zero guilt”. Cosa pensa di questo fenomeno?È un’azione di accaparramento della simpatia dei clienti, sperando che poi si traduca in scelta di acquisto. Da qualche anno questo tipo di scelta pubblicitaria interessa un po’ tutte le produzioni a “rischio”, cioè quelle che possono provocare danni all’ambiente, pericoli per la salute, reazioni d’indignazione sociale. Quindi, le aziende automobilistiche esaltano il risparmio del carburante e la riduzione delle emissioni nocive: i produttori
di birra valorizzano il basso tenore alcolico, l’azienda di abbigliamento o di giocattoli comunica che le magliette o i palloni non vengono lavorati da bambini. Nelle premesse, cioè nei contenuti sostanziali, sono apprezzabili ma l’intento di sedurre il consumatore è discutibile.Secondo la British Advertising Standard Authority la Shell si è resa responsabile di greenwashing per aver usato l’aggettivo “sostenibile” in una campagna pubblicitaria per un progetto petrolifero in Canada. Ci sono esempi simili di segnalazioni in Italia?abbiamo avuto un caso clamoroso con una grande catena della distribuzione che ha lanciato il primo sacchetto di plastica
“totalmente biodegradabile”. in realtà questa qualità era molto discutibile e proprio legambiente e il Movimento Difesa del Cittadino hanno denunciato la pubblicità all’autorità garante del mercato, ottenendo una condanna e una sanzione del gruppo che poi ha modificato la comunicazione. Ma è un’esperienza quotidiana vedere manifesti 4 x 4 e spot pubblicitari con grandi di automobili accostate alla splendida campagna toscana o addirittura alle immacolate nevi dell’Himalaya…e le maggiori aziende energetiche stanno puntando molto sui messaggi dell’energia pulita e alternativa. Il consumerismo italiano è mobilitato in qualche modo nei confronti di fenomeni simili?C’è disattenzione o sottovalutazione del fenomeno. il consumerismo italiano, oltre a essere culturalmente impreparato a questo tipo di mobilitazione, almeno in questa fase è tutto preso da altre emergenze, i prezzi in primo luogo.I consumatori allora come possono difendersi?Difendersi dalla suggestione non è semplice, perché tocca corde profonde di sensibilità culturale e sociale. e non si può certo imporre con una normativa la scelta dei messaggi pubblicitari. Gli sforzi delle associazioni dei consumatori vanno in direzione di una maggiore informazione sulle caratteristiche e la qualità dei prodotti. Senza farsi abbindolare dalle immagini, dalle parole suggestive e spesso anche dalle musiche new age usate per questi spot. (Sabrina Bergamini)
‘per Il consumerismo italiano oggi ci sono tutt’ altre emergenze. a cominciare dai prezzi’Assoscai, un’associazione
di imprese nata per creare un stretto connubio tra competitività e qualità ambientale, ha sviluppato un sistema di qualificazione che aiuta le imprese a promuovere i propri prodotti senza il rischio di incappare in pratiche di greenwashing. Il sistema basato sull’applicazione dello standard internazionale Iso 14021 accompagna le imprese nella scelta degli elementi, e quindi delle asserzioni ambientali, caratterizzanti il prodotto. In questo modo le
imprese sono da un lato indirizzate verso l’innovazione ambientale e dall’altro facilitati nella promozione di soluzioni ambientalmente preferibili. L’associazione in quest’azione è sostenuta da Enea e dal consorzio universitario C.e.si.s.p.. La prima etichetta Assoscai è stata realizzata da un’impresa italiana, la Palm spa di Viadana (Mo), che produce pallet in legno certificato.
Etichetta ambientale
Quanto comunicato dall’etichetta è responsabilità di Palm S.p.A. www.palm.it
Approvvigionamenti Non contiene materiale riciclato
•
Legno proveniente da foreste a gestione certifi cata •
Impatti dei trasporti delle materie prime non valutati •
Processo produttivo 100% dell’energia elettrica acquistata generata da fonte rinnovabile
•
Non viene autoprodotta energia termica da fonte rinnovabile
•
Fine VitaRiutilizzabile•
Riciclabile•
Recuperabile come energia•
Mitigazione/riduzione degli impattiProgettato per l’uso specifi co e la riduzione delle risorse utilizzate
•
www.assoscai.it
Prodotto
PALLET in legno PF 1155 PEFC (115x115)Produttore
PALM S.p.A.Reg. n. AC001/01
1
2
3
3 2 1
Etichette sincereUn’associazione di imprese ha creato un sistema di qualificazione che, sulla base dell’Iso 14021, aiuta a scegliere le migliori asserzioni ambientali

aprile 2009 La nuova ecologia 47
Marketing Miopia, Harvard Business Review 28) secondo cui il marketing verde deve soddisfare due obiettivi: mi-gliorare la qualità ambientale e soddisfare il consumatore. Tralasciare uno dei due si definisce come miopia del marke-ting verde. Molti esempi potrebbero essere addotti, ma uno su tutti può far capire il legame fra economia e ambiente. General Motors e Ford fra gli anni ‘90 ed i primi del 2000 hanno posto sul mercato auto elettriche pubblicizzandone le doti “ambientali”. I consumatori non erano pronti a un drastico cambiamento delle loro abitudini dovuto a conti-nue ricariche e a diverse performance degli automezzi. E così i prodotti sono stati ritirati dal mercato. Attualmente, invece, alcuni modelli “ibridi” stanno raccogliendo un buon successo anche perché non impongono grosse variazioni dalle abitudini. L’economia con le sue leggi, pertanto, non avvantaggia automaticamente la soluzione ambientalmente migliore ma quella percepita con un “trade-off” opportuno. Le leve attraverso cui definire il trade-off sono:• Efficienzaedefficacia:caratteristichechegarantiscano
risparmi di energia e di risorse;• Saluteesicurezza:caratteristichechesianopercepite
come “sane” e che forniscano maggiori garanzie perce-pite;
• Simboliestatus:caratteristicheverdichebeneviden-zino l’appartenenza a un gruppo o il raggiungimento di uno status.
Il progressivo interesse dei media verso i temi ambien-tali, cambiamento climatico in primis, ha dato spazio a iniziative di marketing delle aziende come mai si
era notato prima. I settori dell’automotive, dell’energia e dell’agroalimentare si sono dimostrati fra i più attivi e ri-cettivi e hanno attivato campagne pubblicitarie incentrate proprio sul tema dell’energia e dell’ambiente. Anche i colos-si dell’advertising internazionale come Havas e Wpp hanno fatto scattare la corsa alla trasformazione verde.
Per comprendere come gli esperti di marketing intro-ducano l’ambiente nelle loro teorie è utile richiamare il concetto di “miopia del marketing verde” (T. Levitt,
Tenere insieme i vantaggi per l’ambiente e quelli personali. Così il trade-off ambientale centra l’obiettivo. Lo snodo del Green public procurement
di Enrico Cancila
Enrico Cancila, economista esperto in gestione dell’ambiente, ha collaborato con la Commissione europea, con il ministero dell’Ambiente e con varie Regioni italiane. é stato membro del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit italiano. Attualmente è responsabile dell’area sviluppo sostenibile della società In house Eervet, Emilia- Romagna Valorizzazione economica del territorio.

La nuova ecologia aprile 200948
Ottenere che queste leve del marketing verde possa-no essere spese in coerenza sia con l’innovazione e la performance ambientale che con la credibilità dell’in-
formazione, costituisce il vero elemento qualificante di una politica ambientale duratura per un’azienda. Gli strumenti volontari, in particolare, potrebbero essere utili motori per trainare dinamiche virtuose, ma anch’essi devono ragionare su come comunicare il loro valore aggiunto ai clienti. È sin-tomatico il caso del marchio Energy star dell’Epa (l’Agenzia statunitense per l’ambiente) che veniva unito inizialmente al messaggio “Epa, prevenzione dell’inquinamento”, ambi-guo e focalizzato sull’inquinamento anziché sui benefici del consumatore. E poi, nella sue ultime release, “Saving The Earth, Saving your Money” (Salvando la Terra, salvando il tuo denaro) o “Money isn’t all you’re saving” (“Il denaro non è tutto ciò che stai salvando”), riuscendo a bilanciare i benefici per l’ambiente a quelli per i consumatori.
Concentrandoci sulla sostenibilità delle produzioni, è evidente l’importanza di creare un collegamento tra innovazione tecnologica, performance ambientale e
visibilità sul mercato. Non è banale la corrispondenza fra questi tre tasselli ed è l’ultimo elemento di una strategia win-win a farli coincidere. Il mercato, come si diceva, può non avvantaggiare ciò che è meglio per l’ambiente e proprio per questo una spinta che porti a far coincidere i tre tasselli è necessaria. Questa potrebbe venire da indirizzi di mer-cato come quelli che sempre più emergono nell’ambito del Green public procurement (Gpp) e dall’incontro fra le attese dei consumatori e la proposta delle imprese.
Nella diffusione delle pratiche di Gpp un ruolo fonda-mentale sarà ricoperto da chi si occupa di marketing nelle imprese che appartengono ai settori coinvolti
dal Piano d’azione nazionale, ovvero, arredi materiali da costruzione, manutenzione delle strade, gestione del verde pubblico, illuminazione e riscaldamento, elettronica, tessile, cancelleria e ristorazione. Questi dovranno riuscire a far dialogare sui temi ambientali i propri uffici commerciali con gli uffici acquisti della Pubblica amministrazione utilizzan-do al meglio gli strumenti volontari messi a loro disposi-zione dalla Comunità europea, come l’Ecolabel, o da altre organizzazioni. Queste aziende dovranno investire nella co-municazione delle proprietà ambientali dei propri prodotti verso l’esterno senza però tralasciare l’interno. Infatti, nei primi bandi “verdi”, non sono mancati casi di imprese con prodotti a catalogo opportunamente qualificati di cui però non erano in grado di richiedere il riconoscimento delle qua-lità ambientali. l
Sostenibilità e modelli di sviluppo coerenti hanno conquistato uno spazio nell’agenda dei media, dei decisori, dell’opinione pubblica. Anche in tempi di
crisi il messaggio di responsabilità ambientale che si ac-compagna alla comunicazione su prodotti o su campagne aziendali rimane evidente. A volte sono messaggi credibi-li, a volte un po’ meno ma tutti testimoniano che le azien-de hanno ormai colto l’esigenza di indirizzare i loro sforzi di comunicazione (e si spera non solo quelli) a favore della responsabilità ambientale.
La domanda d’informazione sulla sostenibilità aumenta. Ma non sempre chi fa comunicazione ambientale migliora la propria reputazione
di Maurizio Maione
‘Gli strumenti volontari generano dinamiche virtuose. se comunicano il valore aggiunto’

aprile 2009 La nuova ecologia 49
bugie in vetrinaL’ambiguità di certe campagne penalizza l’intero comparto del green business. Parla David Willans, responsabile di Futerra
Fiori che escono dai comignoli delle fabbriche, Suv immersi in paradisi incontaminati, centrali nucleari come oasi. Dalle reclame sembrerebbe che le imprese “amiche dell’ambiente” si siano moltiplicate. per difendersi dalle ambiguità degli annunci promozionali Futerra, agenzia di comunicazione britannica che si occupa di ambiente e responsabilità sociale, ha proposto un decalogo anti greenwashing (sul sito futerra.co.uk). David Willans ne è il responsabile strategico.
Come definirebbe il greenwashing? Come una tecnica comunicativa che serve ad indurre in errore il pubblico, sottolineando le credenziali ambientali di una persona, una società o un prodotto quando queste, in realtà, sono infondate o irrilevanti. il termine si è imposto all’inizio degli anni ‘90. all’epoca le pubblicità non
intendevano lanciare un vero e proprio messaggio ambientale, d’altro canto era ancora fresco il ricordo di disastri ecologici come quello di Bhopal, la città indiana dove nel 1984 esplose una fabbrica di pesticidi. le aziende, affiancando il proprio logo a delfini piroettanti o a foreste rigogliose, volevano solo comunicare l’idea di essere “eco-friendly”. Che dimensione ha il fenomeno? Nel mercato la domanda crea l’offerta e quindi la pubblicità viene orientata secondo i gusti
degli utenti. ebbene il consumo “etico” dal 2002 a oggi è aumentato dell’83%. è evidente che non si tratta più di un settore di nicchia. per questo le aziende sono sempre più tentate di “accontentare” queste nuove esigenze anche mentendo. il caso più eclatante è stato quello della Shell che nel 2007 aveva firmato un disegno stilizzato in cui uscivano fiorellini colorati dalle ciminiere di una fabbrica (La Nuova Ecologia ne aveva parlato ad aprile 2008, ndr). Come si misurano i danni della pubblicità ingannevole? il greenwashing non è misurabile ma minaccia l’intero comparto delle aziende impegnate nel rispetto dell’ambiente. lo scetticismo di fronte a messaggi poco credibili, infatti, erode la fiducia verso l’intero settore. recenti indagini mostrano che nel regno Unito l’80% delle persone ritiene che il messaggio ambientalista, sia delle imprese che dei governi, non sia autentico. lo stesso vale per gli Usa: il 70 % dei consumatori pensa che dietro a un prodotto verde non ci sia altro che una strategia di marketing. A chi è rivolta la vostra guida? alle imprese che hanno un autentico desiderio di fare buona comunicazione ambientale e magari non hanno mezzi e conoscenze. per educare il consumatore invece giocano un ruolo chiave le buone politiche di governo. (Susan Dabbous)
‘per L’80% dei consumatori i messaggi ambientalisti non sono autentici. i governi intervengano’
Non a caso le proiezioni della principale associazione di categoria, Assorel, che rappresenta l’industria del-la comunicazione “below the line”, cioè non pubblici-
taria, assegnano alla comunicazione ambientale e sociale il sesto posto nella classifica dei settori su cui le aziende investono. Messaggi a favore del clima come quelli lanciati di recente da multinazionali del petrolio, o da molte case automobilistiche, qualche anno fa sarebbero stati inconce-pibili. In questo nuovo scenario è cresciuta l’esposizione del-le aziende sui temi dell’ambiente e della responsabilità, si è arricchito il set di strumenti e di tecniche a disposizione dei comunicatori d’impresa, si è progressivamente esteso il campo d’applicazione di queste tecniche: dall’area corpora-te e valoriale fino ai prodotti per toccare, ultimamente, la stessa governance e la leadership del top management (un nome fra tutti, arcinoto, Pasquale Pistorio). E siamo arri-vati a quello che appare come un vero paradosso: chi più investe in comunicazione ambientale non sempre ottiene i benefici attesi in termini d’immagine, di reputazione, di capacità nel creare consenso attorno a sé. La comunicazio-ne ambientale, insomma, diventa sempre più un’esigenza imposta dal mutato scenario sociale, mediatico e politico. Ma spesso, come per una specie di sindrome di Stoccolma, le aziende costrette a fare comunicazione rimangono impri-gionate loro malgrado nel ruolo di soggetti poco credibili.
Occhio a…I dieci segnali di “inganno verde” nelle pubblicità
1. Espressioni vaghe
Slogan con parole poco chiare (come eco-friendly)
2. Prodotti verdi ma imprese
sporcheÈ il caso di fabbriche che producono lampadine a fluorescenza ma inquinano le acque
3.Immagini suggestive
Composizioni di forte impatto visivo ma prive di senso, come i fiori che escono dai tubi di scappamento…
4. Inezie in primo piano
Pubblicità che enfatizza-no dettagli “verdi” quan-do tutto il resto va male
5. Primi della classe
Dichiarare di essere i migliori del settore… quando però l’intero settore è pessimo
6. Chi la spara più grossa
«Sigarette ecologiche per tutti!». Così si“rinverdiscono” prodotti in realtà nocivi
7.Chi utilizza un linguaggio
criptico Utilizzare un gergo e dare informazioni che solo gli scienziati potrebbero capire
8. Bollini fai-da-te
Riconoscimenti che sem-brano ricevuti da altri ma sono in realtà autoattribuiti 9.Mancanza
di prove Potrebbe anche essere vero ma chi lo dice?
10.Bugie assolute
Dati e informazioni totalmente false
info: www.futerra.co.uk
Maurizio Maione, director di Hill&Knowlton Gaia (agenzia specializzata in comunicazione ambientale), da oltre 10 anni si occupa di tematiche relative alla reputazione e alla comunicazione ambientale e alla gestione del consenso intorno ad impianti industriali ed infrastrutture.

La nuova ecologia aprile 200950
Una risposta univoca a questo loop non esiste. Si pos-sono però avanzare alcune ipotesi. La reputazione, infatti, ha tempi molto lunghi che non coincidono
quasi mai con lo svolgimento delle singole attività di co-municazione. L’aggregazione di consenso positivo su un marchio o un’organizzazione è una strada lunga nella quale è più facile tornare indietro che non procedere spe-ditamente. C’è poi da dire che molti degli strumenti e dei set di comunicazione a disposizione delle aziende presen-tano loro stessi dei limiti e delle complessità. È il caso, per fare un esempio, degli strumenti di compensazione della CO2, almeno le volte in cui le garanzie sul controllo dello svolgimento delle operazioni di mitigazione appare lasco o quando questo strumento si utilizza a sproposito, a sosti-tuire un impegno diretto di riduzione “in casa propria”.
Di fronte a questa complessità oggettiva, all’azienda non rimane che adottare un approccio di lungo perio-do. Occorre cioè un piano di riferimento che sappia
resistere alle sirene delle trimestrali. E poi in questo per-corso occorre massimizzare la capacità di analisi e di valu-tazione. Per evitare errori occorre scegliere attentamente cosa dire e come dirlo, cioè i messaggi e gli strumenti/ca-nali per veicolarli. Diventa fondamentale, tanto più in un momento di corsa generalizzata verso il tema ambientale, non solo scegliere lo strumento più idoneo ma anche im-maginare modi differenziali di usarlo. Spesso (e di nuovo gli strumenti di rendicontazione sono un buon esempio) il semplice strumento non serve per il suo contenuto d’infor-mazione ma come mezzo di coinvolgimento dei propri in-terlocutori, in una logica di comunicazione personale che, ancora oggi, sui temi dell’ambiente appare vincente. l
Le imprese cercano una nuova sintesi fra credibilità delle informazioni ed efficacia del messaggio. Anche in Italia
di Fabio Iraldo
Il marketing ambientale punta a sviluppare, promuove-re e valorizzare prodotti e servizi in grado di generare un ridotto impatto ambientale comparativamente alle
alternative sul mercato. Le sue strategie si sono sviluppate sulla spinta dei consumatori a preferire prodotti e servizi più “sostenibili” sotto il profilo ambientale, etico e socia-le. Questa tendenza è testimoniata dai dati della recente indagine Eurobarometro della Commissione Europea, se-condo cui più del 75% degli europei propende all’acquisto di prodotti environmental friendly, ritenendo giustificato anche il pagamento di un sovrapprezzo. Oggi le aziende stanno quindi confrontandosi sempre più con l’esigenza dei consumatori di considerare le prestazioni ambientali come parte integrante della “qualità totale” del prodotto. Ciò ha avuto conseguenze, ad esempio, sulla progettazione dei pro-dotti, la cui attenzione si è spostata dalle caratteristiche “esteriori” (design o il packaging) alla ricerca di materiali innovativi in grado di accoppiare elevate performance con un impatto ambientale ridotto.
Per un prodotto o servizio ecologico, tuttavia, essere competitivo in termini di qualità e prezzo non è suf-ficiente: la vera sfida per il marketing ambientale è
quella di convincere il cliente della reale utilità del suo ruo-lo nella tutela dell’ambiente. Sul fronte della comunicazione ambientale (ad esempio in ambito pubblicitario) si sono re-gistrati significativi mutamenti. Ad una fase iniziale in cui essa si basava soprattutto su immagini naturali evocative e slogan generici sul rispetto dell’ambiente, in voga fin dagli anni Settanta, ne è subentrata una in cui le aziende hanno preso atto della maturazione da parte del consumatore e hanno deciso di puntare su una comunicazione approfon-dita, scientificamente fondata e ricca di dati sugli impatti del prodotto. Ciò ha portato negli anni Novanta allo svilup-po di strumenti molto complessi di rendicontazione e poco comprensibili per i non addetti ai lavori (come i cosiddetti “bilanci ambientali”). Oggi le aziende stanno cercando un efficace mix tra completezza e credibilità dell’informazione ambientale, da un lato, e semplicità e attrattività dei mes-saggi dall’altro, che è molto difficile da ottenere.
Interrogandosi sulla reale efficacia degli sforzi compiuti dalle aziende italiane, l’Istituto di Economia e politica dell’energia e dell’ambiente dell’Università Bocconi ha
condotto un’indagine sulla pubblicità ecologica su carta stampata. Una prima indicazione significativa emerge dal numero di messaggi pubblicitari identificati come “ecolo-gici” (181), ovvero contenenti riferimenti ai temi del ri-spetto dell’ambiente: essi rappresentano soltanto il 6,5% del totale dei messaggi identificati. Questo dato dimostra
AMBIGUItà IN CONFEzIONEIl greenwashing sui prodotti secondo i canadesi di Terrachoise
1 Nasconderela verità
Quando un prodotto di-chiara di compensare l’ef-fetto serra senza alcuna precisazione su tutti gli altri impatti causati.
2. l’assenzadi prova
Quando si dichiarano ca-ratteristiche che non sono sostenute da prove scien-tifiche o informazioni suf-ficienti e rintracciabili.
3. la vaghezzaQuando si utilizzano
termini imprecisi, che non permettono al consuma-tore di evitare equivoci. Casi classici sono quelli in cui si usano i termini come prodotto “ecologi-co”, “amico dell’ambien-te” o “naturale”.
4.L’irrilevanzaQuando si utilizzano
asserzioni che descrivono caratteristiche di sosteni-bilità ma che risultano ininfluenti per una scelta consapevole. Un classico esempio è la dichiarazio-ne “Cfc free” nei prodotti
per la pulizia della casa, ove tali gas sono ormai da tempo banditi per legge.
5. La falsità Quando si utilizza
un’affermazione falsa. Di-versamente da come si po-trebbe pensare è una prati-ca molto poco diffusa.
6. La scelta delminore dei mali
Quando si utilizza un’as-serzione vera per distrarre dal vero problema. Tipico il caso del “tabacco bio-logico”.

aprile 2009 La nuova ecologia 51
Fabio Iraldo è professore associato di Economia e gestione delle imprese alla Scuola superiore di Studi universitari e perfezionamento Sant’Anna di Pisa. È direttore di ricerca dell’Iefe dell’Università Bocconi. Nel 2006 ha fondato il Cesisp (Centro interuniversitario per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti) in collaborazione con l’Università di Genova e il Politecnico di Torino.
e l’utilizzo di materie prime biologiche (nel caso degli ali-menti). L’atteggiamento super-ficiale che domina la pubblicità ecologica in Italia, soprattutto per quanto riguarda l’informa-zione fornita al consumatore, risalta con chiarezza se si con-sidera che soltanto un messag-gio affianca al richiamo degli impatti sull’ambiente alcuni dati numerici che misurino tali impatti e informazioni in-tegrative di tipo quantitativo. In altri 17 casi le aziende si limitano a fornire le informa-zioni previste dalla legge. Nel panorama italiano, inoltre, sono quasi del tutto assenti pubblicità che propongano confronti sul piano ambientale. Solo due pubblicità del campione effettuano una comparazione a beneficio del consumatore. Infine, diverse sono le leve “esterne” utiliz-zate per potenziare il messaggio ecologico. Dall’indagine emerge, ad esempio, come sempre più aziende si servano della certificazione ambientale di parte terza per rafforza-re la propria offerta, quali ad esempio l’Ecolabel europeo. I consumatori italiani necessitano infatti di certezze circa la veridicità del messaggio ecologico, che acquista credibi-lità se convalidato da forme riconosciute di certificazione, attestanti il reale beneficio ambientale raggiungibile con l’acquisto del prodotto. l
che se, da un lato, le aziende italiane hanno imboccato la strada del green marketing, dall’altro hanno compiuto soltanto i primi, timidi passi in questa direzione. Un altro aspetto interessante è costituito dal focus del messaggio. In questo senso è essenziale comprendere se le aziende siano disposte a valorizzare solo i vantaggi ecologici del prodotto, oppure puntino anche sugli impatti ambientali (spesso più rilevanti) connessi ai processi produttivi e alle altre attività dell’azienda. Si nota una preponderanza del prodotto mentre appaiono distanziate altre dimensioni quali il processo produttivo e l’impegno dell’azienda in ambito ambientale. Vi è difatti la diffusa tendenza delle aziende a credere che il consumatore circoscriva la pro-pria sensibilità ecologica alle preoccupazioni ambientali più prossime a sé. Questo spiega, ad esempio, l’utilizzo massiccio di pubblicità ecologiche nel settore alimentare, dove il tema si sovrappone a quello della salute.
Bisogna poi evidenziare come non sempre gli impat-ti ambientali descritti nel messaggio pubblicitario siano realmente i più preoccupanti. In più di un
terzo dei messaggi, infatti, gli impatti effettivamente si-gnificativi del prodotto pubblicizzato sono in effetti com-pletamente ignorati. Fra gli aspetti ambientali più fre-quentemente enfatizzati si trovano il risparmio energetico che si può ottenere dall’utilizzo del prodotto, i benefici legati all’impiego di materiale recuperato (p. es. carta da macero) o alla possibilità di riciclare il prodotto stesso, le emissioni atmosferiche (soprattutto nel caso delle auto)
‘Le nostre aziende hanno scoperto il green marketing.
Ma si concentrano sui vantaggi
ambientali del prodotto

La nuova ecologia aprile 200952
li all’interno di un’azienda dà impulso alla creazione di una cultura organizzativa imperniata su nuovi valori. Un diverso metodo al modo stesso di fare impresa implica, però, non solo un cambiamento nelle decisioni strategico-economiche, ma anche una trasformazione di quella che è la stessa cultura organizzativa dell’azienda, che deve adottare necessariamente diverse strategie di comunica-zione sia verso l’interno (il personale) sia verso l’esterno (gli stakeholder). Cominciano a moltiplicarsi gli esempi che dimostrano come concetti di solidarietà ed eticità
possano felicemente convivere, a di-mostrazione che il perseguimento del profitto, che rappresenta il legittimo fine dell’impresa, non solo non elimina l’impulso morale, ma anzi lo rafforza. È vero anche, però, che la cultura di Rsi dominante nelle imprese è ancora una “cultura dell’apparenza”; conseguenza purtroppo della mancanza di una radi-cata e reale cultura della sostenibilità, a tutti i livelli. Ciò rende, tra l’altro, non solo poco credibili la promozione delle campagne sociali ma mette a rischio la credibilità stessa della comunicazione d’impresa in generale: da una recente ricerca è emerso che solo il 52% degli stakeholder e il 55% dei comunicatori d’impresa giudica credibile la comuni-cazione di politiche di Rsi.
Ma a questo punto viene da chiedersi: quando la co-municazione può essere definita responsabile? Pos-siamo cominciare a individuare qualche criterio di
valutazione: la trasparenza, ossia dichiarare l’obiettivo e le modalità che si intendono perseguire per raggiun-gerlo; la veridicità: le cose dichiarate devono essere vere; la chiarezza, ossia la comprensibilità; la completezza; la correttezza, si rifà cioè ai principi di legalità; la rilevanza e infine la tempestività. Deve essere chiaro, dunque, che l’etica nella e della comunicazione riguarda noi tutti, non solo le imprese. I comportamenti basati su questo valore supremo sprigionerebbero anzitutto una nuova fiducia, fondamentale e prioritaria nelle relazioni; e rappresente-rebbero il giusto collante tra le persone nella costruzione di un mondo diverso, più sostenibile e solidale. l
Gli economisti Freeman ed Evan teorizzavano che «i poteri del managment debbano essere usati a be-neficio dell’intera comunità, oltre che per il profitto
degli azionisti o dei proprietari». Nel tempo è andata mu-tando e uniformandosi l’interpretazione del concetto di re-sponsabilità sociale d’impresa (Rsi), ossia la specificazione di ciò per cui l’impresa deve ritenersi responsabile. Con la Rsi l’impresa si mette in piazza, mettendosi in gioco di fronte alla polis e non più solo di fronte al mercato. Si ren-de quindi necessaria una nuova trasparenza e un nuovo modo di comunicare che vada oltre il semplice rendiconto dei profitti.
Oggi il mondo industriale, ma non solo, si trova da-vanti all’esigenza di dare un senso alla realtà che sta cambiando repentinamente; dovrebbe, dunque,
iniziare a produrre nuove mappe cognitive grazie alle quali definire la sua vision e la sua mission. Ne consegue che l’introduzione di approcci socialmente responsabi-
Le aziende si mettono in gioco con le proprie responsabilità sociali. Ma quando la loro comunicazione si può definire responsabile?
di massimiliano pontillo
‘il profitto, che è il legittimo fine
dell’impresa, non elimina
l’impulso morale. anzi, lo rafforza’
Massimiliano Pontillo, è ad di Editoriale La Nuova Ecologia. Nel 2006 è co-fonda-tore di Pentapolis, associazione che promuove la Rsi, di cui oggi è segretario gene-rale. Nel febbraio 2009 costituisce L’Aurora, agenzia di comunica-zione e marketing,di cui è presidente.