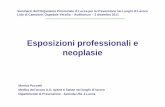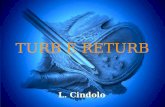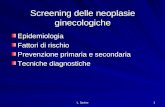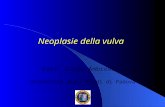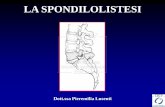Diagnosi differenziale delle neoplasie surrenali: ruolo della scintigrafia
Transcript of Diagnosi differenziale delle neoplasie surrenali: ruolo della scintigrafia

L’EndocrinologoDOI 10.1007/s40619-014-0022-0
R A S S E G NA
Diagnosi differenziale delle neoplasie surrenali: ruolo dellascintigrafia
Teresa Pellegrino · Alberto Cuocolo
© Springer International Publishing AG 2014
Sommario L’imaging scintigrafico delle ghiandole surre-naliche è in grado di distinguere la corticale e la midolla-re del surrene con l’utilizzo di traccianti specifici. I tumoridelle ghiandole surrenaliche possono originare sia dalla zo-na corticale, sia dalla midollare. Ciò che contraddistinguei tumori surrenalici dalle altre forme neoplastiche è che auna componente oncologica spesso si associa una endocri-na. Le neoplasie della corticale possono secernere cortisolo,aldosterone o steroidi sessuali. Lo studio scintigrafico del-la corticale del surrene è effettuato con 6-beta-iodo-metil-norcolesterolo marcato con iodio-131 (131I). Le neoplasiedella midollare del surrene secernono catecolamine. Lo stu-dio scintigrafico della midollare del surrene è eseguito conmeta-iodo-benzil-guanidina (MIBG) marcata con 131I o con123I. La scintigrafia con MIBG ha un’elevata sensibilità especificità nella localizzazione delle neoformazioni che ori-ginano dalla midollare e delle eventuali lesioni metastatiche.Inoltre, rappresenta l’unica metodica in grado di differen-ziare la malattia benigna dalla maligna e di monitorare larisposta alla chemioterapia. La scintigrafia permette di de-terminare se a un’alterazione strutturale del surrene ne cor-risponda una funzionale e, inoltre, permette di evidenziare
Proposta da Marco Salvatore.
Materiale elettronico supplementare La versione elettronicadi questo articolo (DOI:10.1007/s40619-014-0022-0) contienemateriale supplementare, disponibile per gli utenti autorizzati.
T. Pellegrino (B)Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, Consiglio Nazionale delleRicerche, Via De Amicis, 95, 80131 Napoli, Italiae-mail: [email protected]
A. CuocoloDipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università degliStudi di Napoli Federico II, Napoli, Italia
se la patologia sia monolaterale o bilaterale; essa, infine, haun importante ruolo nell’identificazione degli incidentalomi,di quelle lesioni cioè riscontrate casualmente a un imagingmorfologico e silenti da un punto di vista clinico.
Parole chiave Tumori delle ghiandole surrenaliche ·Meta-iodo-benzil-guanidina · Norcolesterolo
I tumori delle ghiandole surrenaliche possono originare dal-la corteccia o dalla midollare; la prima rappresenta la porzio-ne periferica, mentre la seconda la parte centrale della ghian-dola. La corticale e la midollare esercitano un diverso ruolofisiologico e hanno una differente origine embriologica. Lacorticale che origina dal mesoderma embrionale è compostada tre zone: una glomerulare, più esterna, che produce ormo-ni mineralcorticoidi (principalmente aldosterone); una fasci-colata, intermedia, che produce glicocorticoidi (essenzial-mente cortisolo); e una reticolare, più interna, che produce iprincipali androgeni surrenalici (deidroepiandrosterone, dei-droepiandrosterone solfato e �-androstenedione). La midol-lare del surrene ha un’origine endodermica ed è deputata allaproduzione delle catecolamine (adrenalina, noradrenalina edopamina).
I tumori surrenalici si differenziano dalle altre forme neo-plastiche, in quanto alla parte strettamente oncologica (ade-nomi e carcinomi) può associarsi una componente endocrina(neoplasie secernenti o non secernenti). Le neoplasie origi-nanti dalla corticale surrenalica possono secernere cortiso-lo, dando il quadro della sindrome di Cushing, aldosterone,dando il quadro del morbo di Conn, o steroidi sessuali, qua-li testosterone o estrogeni. I tumori derivanti dalla midolla-re del surrene, i feocromocitomi, secernono catecolamine.In questo scenario, l’imaging scintigrafico ha il compito di

L’Endocrinologo
determinare se a un’alterazione strutturale del surrene, evi-denziata con metodiche di diagnostica per immagini di ti-po morfologico, quali la tomografia assiale computerizzata(TAC) o la risonanza magnetica (RM), ne corrisponda unafunzionale e se la sindrome clinica evidenziata è data dauna patologia monolaterale (adenoma) o bilaterale (iperpla-sia nodulare) [1]. La scintigrafia ha un ruolo importante an-che nella valutazione diagnostica degli incidentalomi, lesio-ni surrenaliche che si riscontrano casualmente a un imagingmorfologico e silenti dal punto di vista clinico [2].
Studio scintigrafico della corticale del surrene
I radiofarmaci utilizzati per lo studio della corticale surrena-lica sono analoghi del colesterolo, il precursore di tutti gliormoni prodotti da questa parte della ghiandola. Il radiofar-maco utilizzato è il 6-beta-iodo-metil-norcolesterolo marca-to con iodio-131 (131I). Somministrato per via endovenosa,il 131I-norcolesterolo entra nelle cellule della corticale, vie-ne esterificato e immagazzinato nelle gocce lipidiche intra-cellulari come il colesterolo endogeno ma, a differenza diesso, non subisce ulteriore metabolizzazione. Nei soggettinormali, una quantità di 131I-norcolesterolo <1% dell’atti-vità somministrata è captata dalle ghiandole surrenaliche; ilsuo accumulo a livello surrenalico è influenzato dai mec-canismi di regolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene edell’asse renina-angiotensina-aldosterone.
Prima della somministrazione del radiofarmaco è esegui-ta una premedicazione con soluzione iodo-iodurata (soluzio-ne di Lugol al 2%) o con perclorato di potassio, allo scopodi inibire la captazione tiroidea dello 131I libero presente nelradiofarmaco e della quota che successivamente si libera invivo per deiodazione. La premedicazione è iniziata una setti-mana prima della somministrazione del radiofarmaco e pro-segue per tutta la durata dell’esame scintigrafico [3]. La dosedi 131I-norcolesterolo raccomandata è di 37 MBq (1 mCi);la somministrazione endovenosa deve avvenire lentamente(durata di almeno 1 minuto), allo scopo di ridurre la com-parsa di possibili effetti indesiderati (vampate al volto, rushcutanei, nausea, sudorazione, ipotensione); le reazioni di ti-po anafilattico (broncocostrizione, collasso circolatorio) so-no estremamente rare. Dopo 2, 4 e 7 giorni dalla sommini-strazione del radiofarmaco, sono acquisite le immagini scin-tigrafiche utilizzando una gamma camera a grande campo,equipaggiata con collimatori per le alte energie. Sono acqui-site immagini statiche (con matrice 128 × 128) nella pro-iezione posteriore delle regioni surrenaliche, della durata dicirca 20 minuti. Di solito si eseguono delle scansioni supple-mentari nella proiezione anteriore e laterale, per valutare l’e-ventuale asimmetria ghiandolare, la profondità e per distin-guere la presenza di captazione in loggia surrenalica da unacaptazione fisiologica presente in altri organi (ad esempio incolecisti) [1].
Sindrome di Cushing
Questa patologia è caratterizzata da segni e sintomi di ma-lattia legati alla presenza di un ipercortisolismo, cioè a uneccesso in circolo di ormoni glicocorticoidi. L’iperfunzio-ne della corteccia surrenalica può essere ACTH-dipendente(70–80% dei casi) o indipendente (20–30% dei casi). Le for-me ACTH-dipendenti sono dovute a un’aumentata secrezio-ne di ACTH dall’ipofisi (ad esempio legata a un adenomaipofisario ACTH-secernente) o da cellule extra-ipofisi (adesempio legata a una sindrome paraneoplastica da microci-toma polmonare). Le forme ACTH-indipendenti sono dovu-te a un’aumentata secrezione di cortisolo da parte di una pa-tologia in sede surrenalica (80% adenomi, 20% carcinomi)che mostra autonomia funzionale e quindi non è sensibileal controllo da parte dell’asse ipotalamo-ipofisario (adeno-ma surrenalico, iperplasia surrenalica bilaterale, carcinomasurrenalico).
L’imaging scintigrafico riflette le alterazioni fisiopatolo-giche che sono alla base dei diversi quadri patologici, conun’elevata accuratezza diagnostica (95%) ed elevata sensi-bilità (100%) negli adenomi iperfunzionanti. La scintigra-fia surrenalica nella sindrome di Cushing ACTH-dipendenteevidenzia la presenza di una simmetrica e intensa captazio-ne del radiocomposto a livello di entrambe le logge surrena-liche. Le ghiandole mostrano, inoltre, un incremento volu-metrico, stimolate dalla sovra-produzione di ACTH da partedell’ipofisi, dell’ipotalamo o da sedi ectopiche.
La scintigrafia della corticale del surrene trova però lasua maggiore indicazione nello studio delle forme ACTH-indipendenti. L’adenoma surrenalico mostra un intenso ac-cumulo del tracciante a livello della ghiandola surrenalicasede della patologia, con assenza di captazione in corrispon-denza della ghiandola controlaterale, ipofunzionante per ini-bizione della secrezione di ACTH da parte degli elevati livel-li di cortisolo (Fig. 1). Nell’iperplasia surrenalica bilateralel’imaging scintigrafico mostra una captazione del traccian-te, spesso asimmetrica, in entrambe le logge surrenaliche,denotando il coinvolgimento di entrambe le ghiandole sur-renaliche (Fig. 2). Il carcinoma surrenalico mostra alla scin-tigrafia un’assenza di captazione del tracciante a livello dientrambe le ghiandole surrenaliche. Ciò è legato, nella mag-gior parte dei casi, alla presenza di una neoplasia non diffe-renziata, e quindi non captante in concentrazione adeguatail tracciante, mentre la captazione da parte del surrene con-trolaterale è comunque inibita dall’aumentata produzione dicortisolo da parte della neoplasia.
Morbo di Conn
Questa patologia è dovuta a un’ipersecrezione primitiva dialdosterone, nella maggioranza dei casi (60–70%), da parte

L’Endocrinologo
Fig. 1 Scintigrafia cortico-surrenalica con 131I-norcolesterolo. Acqui-sizione scintigrafica eseguita in quarta (A) e settima (B) giornata dal-la somministrazione del radiocomposto. Lo studio scintigrafico mostraintenso accumulo del tracciante a livello del surrene sinistro, con assen-za di captazione in corrispondenza del surrene controlaterale. Il quadrodepone per la presenza di un adenoma cortico-surrenalico sinistro
Fig. 2 Scintigrafia cortico-surrenalica con 131I-norcolesterolo. Acqui-sizione scintigrafica eseguita in quarta (A) e settima (B) giornata dal-la somministrazione del radiocomposto. Lo studio scintigrafico mostraaccumulo del tracciante a livello di entrambe le ghiandole surrenaliche.Il quadro depone per la presenza di un’iperplasia surrenalica bilaterale
di un adenoma cortico-surrenalico; talvolta può essere lega-ta alla presenza di un’iperplasia bilaterale (25–30%) o, piùraramente, alla presenza di un carcinoma. La forma primi-tiva va distinta da quella secondaria, dovuta a una stimola-zione extra-surrenalica, legata a una iperproduzione di reni-na a livello renale, che attiva il sistema renina-angiotensina-aldosterone. Quando si sia confermata la presenza di un ipe-raldosteronismo primitivo, l’imaging scintigrafico è in gradodi discriminare se il paziente è portatore di una forma uni-laterale (adenoma o carcinoma aldosterone-secernenti) o diuna forma bilaterale. Tale distinzione è importante in quan-to l’approccio terapeutico delle due forme è differente; nelprimo caso la terapia di elezione è chirurgica, mentre nelsecondo caso è indicata la terapia medica.
Nelle forme ipersecretorie, allo scopo di valutare la cap-tazione del radiocomposto eliminando l’interferenza dellostimolo da parte dell’ACTH, la scintigrafia si esegue dopotest di soppressione con desametasone. Quest’ultimo è unfarmaco steroideo che, inibendo la secrezione di ACTH, ri-duce la captazione del radiocomposto a livello della zonafascicolata della corticale surrenalica, evidenziando i pro-cessi ACTH-indipendenti della zona glomerulare o retico-
Fig. 3 Scintigrafia cortico-surrenalica con 131I-norcolesterolo. Acqui-sizione scintigrafica eseguita in quarta (A) e settima (B) giornata dallasomministrazione del radiocomposto dopo test di soppressione con de-sametasone. Lo studio scintigrafico mostra intenso accumulo del trac-ciante a livello del surrene destro. Il quadro depone per la presenzadi un adenoma cortico-surrenalico aldosterone-secernente a livello delsurrene destro
lare. Questa procedura permette di identificare gli adenomisecernenti mineralcorticoidi, differenziandoli dall’iperplasiabilaterale. Lo schema per il test con desametasone prevedel’assunzione orale di 1 mg ogni 6 ore nei 7 giorni precedentila somministrazione del radiofarmaco e continuata fino a 5giorni dopo. Dopo test con desametasone, se la scintigrafiaevidenzia una captazione precoce monolaterale, ciò indica lapresenza di un adenoma (Fig. 3), se la captazione precoce èbilaterale e incrementa nei giorni successivi, si è in presenzadi un’iperplasia bilaterale.
Incidentalomi
Nei pazienti che non presentano sintomi da sindromi iperse-cretorie e hanno anamnesi negativa per patologie neoplasti-che, la maggior parte delle masse surrenaliche, circa il 70–90%, è rappresentata da adenomi non secernenti, di naturabenigna. Al contrario, nei pazienti con anamnesi di patolo-gia neoplastica il 50% circa delle lesioni è di origine meta-statica (frequentemente da carcinoma polmonare o mamma-rio, linfomi e melanomi). Gli incidentalomi possono esse-re rappresentati da carcinomi surrenalici (3%), feocromoci-tomi (4–10%), ganglioneuromi o ganglioneuroblastomi (0–6%), cisti surrenaliche (5%), ematomi ed emorragie (0–4%),mielolipomi (7–15%) e falsi incidentalomi (0–10%, con ori-gine da strutture vicine ai surreni, come rene, milza, linfono-di, pancreas). In caso di incidentaloma, è importante diffe-renziare le masse benigne non iperfunzionanti, per cui è in-dicata una terapia conservativa, da quelle in cui è necessariaun’escissione chirurgica o una terapia combinata. L’imagingmorfologico, con TAC o RM, è in grado di fornire informa-zioni in merito all’eziologia della lesione surrenalica, ma è lascintigrafia che permette di fare diagnosi differenziale degliincidentalomi. Lo studio scintigrafico è in grado di differen-ziare un adenoma che, anche se non iperfunzionante, potrà

L’Endocrinologo
accumulare il radiocomposto in misura maggiore rispetto alsurrene controlaterale sano; in caso di metastasi o di lesio-ni che sostituiscano il normale parenchima ghiandolare, lacaptazione del tracciante sarà assente.
Studio scintigrafico della midollare del surrene
Il radiofarmaco utilizzato per lo studio della midollare delsurrene è la meta-iodo-benzil-guanidina (MIBG) marcatacon 131I o con 123I. Questa molecola è un analogo della no-radrenalina e si concentra nei granuli neurosecretori dellecellule cromaffini a livello delle terminazioni nervose adre-nergiche. La scintigrafia con MIBG è utilizzata nello stu-dio del feocromocitoma surrenalico, per la localizzazionedi paragangliomi e per la ricerca di eventuali localizzazionimetastatiche da feocromocitomi maligni.
Prima della somministrazione del radiofarmaco è esegui-ta una premedicazione con preparati iodurati (soluzione sa-tura di ioduro di potassio, soluzione di Lugol forte, soluzio-ne di Lugol debole), iniziando 2–3 giorni prima della som-ministrazione del tracciante e continuando per 2–3 giorni,a seconda che si utilizzi la marcatura con 131I o con 123I,rispettivamente [3]. La dose di radiofarmaco raccomandataè di 40–50 MBq quando si utilizzi quello marcato con 131Ie di 111–185 MBq se il radiofarmaco è marcato con 123I.Le acquisizioni scintigrafiche sono effettuate dopo 4 e 24ore, quando si utilizza 123I e dopo 24, 48 e 72 ore quandosi utilizzata 131I; esse prevedono una scansione total-body(Fig. 4) e acquisizioni statiche (Fig. 5) su collo, torace eaddome [4].
Feocromocitoma, paraganglioma e neuroblastoma
Il feocromocitoma e il paraganglioma sono tumori del tessu-to cromaffine che originano, rispettivamente, nella midollaredel surrene o in siti extra-surrenalici (quali gangli e paragan-gli simpatici), che presentano la caratteristica di secernerecatecolamine. La forma più frequente è quella sporadica conil coinvolgimento benigno unilaterale di una singola ghian-dola surrenalica; nel 10% dei casi si presenta in una formabilaterale, extra-surrenalica, o con localizzazioni multipleo in forme familiari o maligne. Le lesioni tumorali extra-surrenali sembrano avere una maggiore incidenza di mali-gnità; per la World Health Organization il feocromocitomaè maligno quando siano presenti localizzazioni metastatichee la trasformazione maligna dipenda da una mutazione ge-netica [5–7]. La distinzione basata su criteri istologici trafeocromocitoma benigno e maligno o paraganglioma non èsemplice, poiché essi non mostrano caratteristiche istologi-che tali da definire una lesione come maligna; i segni di ma-lignità sono dati dalla presenza di infiltrazione neoplastica
Fig. 4 Scintigrafia surrenalica midollare con 131I-MIBG. Acquisizio-ne total-body nelle proiezioni anteriore (A, C) e posteriore (B, D) ese-guita a 24 (A, B) e 48 (C, D) ore dalla somministrazione del radiocom-posto. Lo studio scintigrafico mostra intenso accumulo del traccian-te a livello del surrene sinistro e fisiologica distribuzione nei restantidistretti corporei esaminati
Fig. 5 Scintigrafia surrenalica midollare con 131I-MIBG. Acquisizio-ne statica eseguita in proiezione posteriore a 24 (A) e 48 (B) ore dallasomministrazione del radiocomposto. Lo studio scintigrafico mostraintenso accumulo del tracciante a livello del surrene sinistro. Il quadroscintigrafico depone per la presenza di un feocromocitoma surrenalicosinistro
della capsula e/o la presenza di localizzazioni metastatichein sedi anatomiche dove il tessuto cromaffine non è altrimen-ti presente (come i linfonodi, il fegato, i polmoni e le ossa)o quando sia dimostrata una invasione vascolare [7]. Inol-tre, un feocromocitoma benigno raramente può presentareevoluzione maligna.
Il neuroblastoma è la più frequente neoplasia solida delbambino, che origina nella midollare del surrene; esso ri-chiede una precisa diagnostica differenziale con altre neo-plasie del bambino e un’accurata stadiazione, condizioneessenziale per un’opportuna scelta terapeutica.
TAC e RM sono in grado di differenziare il feocromocito-ma da altre masse surrenaliche, ma è stata riportata una con-siderevole sovrapposizione tra la presenza di feocromocito-ma alla RM e quella di altre lesioni surrenaliche [8]. Inoltre,le tecniche di diagnostica morfologica non sono in grado didifferenziare tra malattia benigna e maligna e gli unici crite-ri che possono essere di aiuto in tal senso sono rappresentati

L’Endocrinologo
dal rilevamento di una crescita tumorale invasiva e/o dallapresenza di metastasi a distanza [9].
La scintigrafia con MIBG ha un ruolo molto importan-te nella localizzazione dei feocromocitomi, dei neuroblasto-mi, dei paragangliomi e delle loro eventuali localizzazionisecondarie, mostrando un’elevata sensibilità (85%) e speci-ficità (>95%). Inoltre, l’analisi quantitativa dell’accumulodel tracciante a livello delle lesioni è in grado di differen-ziare la malattia benigna dalla maligna. Infatti, una maggio-re captazione della MIBG, osservata in lesioni maligne, ri-flette un maggiore immagazzinamento di catecolamine daparte delle forme tumorali rispetto alle lesioni benigne [10].Inoltre, la scintigrafia con MIBG ha un ruolo importante nelfollow-up dei pazienti con feocromocitoma maligno sotto-posti a chemioterapia, in cui il successo terapeutico porta auna riduzione della produzione di catecolamine e della cap-tazione del tracciante. I dati di laboratorio rispecchiano lostato funzionale globale della malattia, ma non sono in gra-do di definire la risposta di ogni singola lesione tumorale altrattamento. Al contrario, l’imaging con MIBG consente lavalutazione della risposta alla chemioterapia di ogni singolalesione neoplastica [11].
Conflitto di interesse Gli autori Teresa Pellegrino e Alberto Cuoco-lo dichiarano di non avere conflitti di interessi.
Consenso informato Lo studio presentato in questo articolo non harichiesto sperimentazione umana.
Studi sugli animali Gli autori di questo articolo non hanno eseguitostudi sugli animali.
Bibliografia
1. Avram AM, Fig LM, Gross MD et al (2006) Adrenal gland scintig-raphy. Semin Nucl Med 36(3):212–227
2. Kloos RT, Gross MD, Korobkin IR et al (1995) Incidentally dis-covered adrenal masses. Endocr Rev 16(4):460–484
3. Raccomandazioni procedurali dell’Associazione Italiana diMedicina Nucleare. Versione 6, 2012
4. Bombardieri E, Giammarile F, Aktolun C et al (2010) 131I/123I-Metaiodobenzylguanidine (mIBG) scintigraphy: procedure guide-lines for tumour imaging. Eur J Nucl Med Mol Imaging 37:2436–2446
5. Pacak K, Eisenhofer G, Ahlman H et al (2007) Pheochromocy-toma: recommendations for clinical practice from the first interna-tional symposium. Nature Clin Pract Endocrinol Metab 3:92–102
6. Lenders JW, Eisenhofer G, Mannelli M et al (2005) Pheochromo-cytoma. Lancet 366:665–675
7. De Lellis RA, Lloyd RV, Heitz PU et al (2004) WHO classifica-tion of tumours-pathology and genetics of tumours of endocrineorgans. IARC Press, Lyon, pp 147–150
8. Maurea S, Caracò C, Castelli L et al (1998) Magnetic resonancein the study of suprarenal neoplasms. Qualitative and quantitativeanalysis of signal intensity. Radiol Med 95:199–207
9. Gao B, Kong F, Xu Z et al (2008) Development of differential di-agnosis for benign and malignant pheochromocytomas. Int J Urol15:771–777
10. Maurea S, Cuocolo A, Imbriaco M et al (2012) Imaging charac-terization of benign and malignant pheochromocytoma or para-ganglioma: comparison between MIBG uptake and MR signal in-tensity ratio. Ann Nucl Med 26(8):670–675
11. Maurea S, Fiumara G, Pellegrino T et al (2013) MIBG molecularimaging for evaluating response to chemotherapy in patients withmalignant pheochromocytoma: preliminary results. Cancer Imag-ing 13:155–161