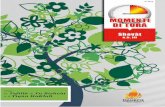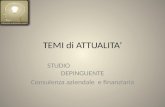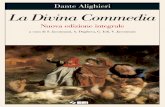Dante - L'Antisovrano. Attualita Di Una Riflessione Tardomedievale
-
Upload
paulo-pia-de-andrade -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Dante - L'Antisovrano. Attualita Di Una Riflessione Tardomedievale

343ELVIO ANCONA - DANTE L'ANTI-SOVRANO
DANTE L'ANTI-SOVRANOATTUALITAÁ DI UNA RIFLESSIONE TARDOMEDIEVALE
1. Premessa
Come la storiogra®a del pensiero politico-giuridico medievale ha da tempomostrato1, l'opposizione tra teorici della plenitudo potestatis ponti®cia e dellasovranitaÁ statale non costituisce l'unica possibilitaÁ nella disputa bassomedievalesui due poteri. Proprio nel suo culmine trecentesco, infatti, si era venuta deli-neando quella via media che porteraÁ , oltre la crisi del sistema gerarchico dioni-siano, all'umanesimo dantesco e ad una rappresentazione dell'universo politico-giuridico basata sull'idea di autonomia.
Una posizione mediana, quella di Dante, che da alcuni eÁ stata peroÁ intesacome portatrice di un`intima contradditorietaÁ . Tale la valutazione del Vossler2,tale soprattutto la valutazione del Kelsen, la cui lettura giovanile della Monarchiasi rivela sotto quest'aspetto particolarmente interessante.
2. Kelsen e Dante
EÁ a tutti noto che l'opera prima di Kelsen, rielaborazione della sua tesi dilaurea, fu dedicata alla concezione politica e giuridica di Dante e fu pubblicatacirca un secolo fa nel 1905 col titolo Die Staatslehre des Dante Alighieri3. Il
1 Cfr. J. RIVIEÁ RE, Le probleÂme de l'EÂ glise et de l'EÂ tat au temps de Philippe le Bel,Louvain-Paris 1926, pp. 272-300, e, piuÁ recentemente, B. GUILLEMAIN, Bonifacio VIII e lateocrazia ponti®cia, in Storia della Chiesa. XI. La crisi del Trecento e il Papato avignonese(1274-1378). A cura di D. QUAGLIONI, Alba 1994, pp. 173-4. Per una ricostruzione storicadell'evoluzione delle tendenze `̀ mediane'' nell'ecclesiologia medievale, si veda: M. PA-
CAUT, La permanence d'une `̀ via media'' dans les doctrines politiques de l'EÂ glise meÂdieÂvale,in Cahiers d'histoire, III, Lyon 1958, pp. 327-57. Si tenga anche presente la tesi del Wilks(The Problem of Sovereignty in the Latter Middle Ages. The Papal Monarchy with Augu-stinus Triumphus and the Publicists, Cambridge 1964, pp. 118-48) che fa coincidere lavia media con la posizione della scuola tomistica.
2 Cfr. K. VOSSLER, Die goÈttliche KomoÈdie. Entwicklungsgeschichte und Erklarung, 1.Band, 2. Teil: Ethisch-politische Entwicklungsgeschichte, Heidelberg 1907; trad. it., LaDivina Commedia studiata nella sua genesi e interpretata, vol. I, p.te II, La genesi etico-politica, Bari 19272, pp. 148 e 152.
3 Cfr. H. KELSEN, Die Staatslehre des Dante Alighieri, Wien und Leipzig 1905; trad.it. di W. SANGIORGI, La teoria dello Stato in Dante, Bologna 1974. L'opera va lettatenendo presenti le puntualizzazioni di R. RICCOBONO, Gli inizi di Kelsen: la teoria dello

344 NOTE CRITICHE - DISCUSSIONI
giurista praghese vedeva in Dante un precursore della ``concezione statalemoderna''4, ravvisando nella Monarchia la pre®gurazione, da una parte, dello``Stato di diritto''5, anzi dello ``Stato di cultura''6, impegnato nel perseguimentodella ``felicitaÁ terrena dei cittadini''7, e, dall'altra, l'anticipazione della dottrinadella `̀ sovranitaÁ popolare''8, implicante la limitazione dei poteri del monarca daesercitarsi nel nome e nell'interesse della collettivitaÁ 9 e il ``diritto di resistenzaattivo'' da parte della collettivitaÁ stessa10.
Ma allorche si era trattato di mostrare come anche la moderna concezionedella laicitaÁ dello Stato fosse giaÁ presente nella Monarchia, Kelsen non avevapotuto sottrarsi all'impressione di trovarsi davanti ad una «caratteristicainconseguenza»11: «L'accettazione di una duplice organizzazione dell'umanitaÁ pen-sata unitariamente Ð da una parte sotto il papa, dall'altra sotto l'imperatore Ð staveramente in contraddizione con il principium unitatis. Se si voleva seguire in modoconseguente questo supremo principio, in tal caso si doveva necessariamente sotto-mettere una organizzazione all'altra, cioeÁ far assorbire la Chiesa dallo Stato o loStato dalla Chiesa»12.
Mentre tuttavia Dante appariva ancora titubante tra quest'ultima soluzionee quella della separazione tra i due poteri, Kelsen riterraÁ di dover decisamenteprocedere nella direzione opposta: «La sussistenza parallela di ambedue le orga-nizzazioni, lo Stato e la Chiesa... eÁ una soluzione Ð commenta Vittorio Frosini Ðche il futuro teorico dello Stato come Rechtsordnung sostituiraÁ con quella dell'u-nicitaÁ dell'organizzazione giuridicamente valida, disconoscendo l'autonomia dell'or-dinamento canonico»13.
Con un interessante paradosso.Kelsen, che nel 1920, conducendo `̀ geometricamente'' a compimento l'uni-
®cazione di tutti i poteri e le giurisdizioni nell'unico organismo dello Statomondiale su basi democratiche, avrebbe auspicato addirittura la `̀ rimozione''del concetto di sovranitaÁ 14, dimostra in realtaÁ , con la negazione dell'autonomiadella Chiesa, di essere piuÁ che mai prigioniero della logica della sovranitaÁ , chevuole appunto che l'autoritaÁ suprema sia assolutamente illimitata e incondizio-
Stato in Dante, in «Rivista internazionale di ®loso®a del diritto», LIII (1976), pp. 261-289.
4 Cfr. KELSEN, La teoria dello Stato in Dante, trad. it. cit., p. 25.5 Cfr. ivi, p. 78.6 Cfr. ivi, p. 79.7 Cfr. ivi, p. 82.8 Cfr. ivi, p. 108.9 Cfr. ivi, p. 107.10 Cfr. ivi, p. 117.11 Cfr. ivi, p. 120.12 Ivi, p. 141.13 V. FROSINI, Kelsen e Dante, in KELSEN, La teoria dello Stato in Dante, trad. it. cit.,
p. XIX.14 Cfr., sul punto, H. KELSEN, Das Problem der SouveraÈnitaÈt und die Theorie des
VoÈlkerrechts. Beitrag zu einer reinen Rechtslehre, TuÈ bingen 1920; trad. it. di A. CARRINO,Il problema della sovranitaÁ e la teoria del diritto internazionale. Contributo per unadottrina pura del diritto, Milano 1989, e, per la concezione della scienza giuridica qualeGeometrie der totalen Rechtserscheinung, F. GENTILE, Politica aut/et statistica. Prolego-meni di una teoria generale dell'ordinamento politico, Milano 2003, pp. 172 ss.

345ELVIO ANCONA - DANTE L'ANTI-SOVRANO
nata. Dante, viceversa, indicato da Kelsen come propugnatore della dottrinadella `̀ sovranitaÁ popolare'', eÁ invece colui che nella sua opera ne prepara piuÁdecisamente il superamento.
In che senso?
3. Dante nella disputa sui due poteri
Tutti conoscono la posizione assunta da Dante nella disputa sui due poteri...Essa eÁ stata considerata come una via media15, alternativa tanto al sistema
ierocratico dei curialisti che, volendo riprodurre sulla terra il modello dionisianodelle gerarchie angeliche, predicava una rigida subordinazione del potere tem-porale al potere spirituale, quanto alla concezione simmetricamente opposta diMarsilio da Padova, che, in virtuÁ di una rappresentazione organicistica dellasocietaÁ , sottoponeva viceversa il potere spirituale al potere temporale, aprendocosõÁ la strada alla moderna teoria della sovranitaÁ 16.
Dante, infatti, eÁ netto nell'affermare che i due poteri non sono subordinatitra loro in quanto dipendenti immediatamente e unicamente da Dio stesso17.
D'altra parte, l'Alighieri non si limita a pensare ad una coesistenza senzarapporti tra le due supreme autoritaÁ , ma auspica la loro cordiale collaborazionenel conseguimento dei duo ultima assegnati all'uomo, la felicitaÁ terrena e lafelicitaÁ celeste, cosõÁ come nell'adempimento del comune impegno a `̀ rimediare''le conseguenze del peccato originale. EÁ questo il senso in cui si parla nel quartocapitolo del libro terzo della Monarchia dell'infusione di grazia operata permezzo della benedizione ponti®cia sull'imperatore, al modo in cui il sole riversala sua luce sulla luna, «af®nche operi piuÁ virtuosamente»18. Ma soprattutto eÁquesto il senso del tanto controverso epilogo dell'opera, in cui si precisa che laveritaÁ dell'immediata ed esclusiva dipendenza del Monarca da Dio «non deveessere accolta alla lettera, come se il Principe romano non fosse soggetto in alcuncheÂal romano Ponte®ce, dal momento che la felicitaÁ mortale eÁ in qualche manieraordinata alla felicitaÁ immortale»19. Il passo eÁ stato visto come ``un'aggiunta o unpentimento''20, quasi che Dante avesse voluto temperare le implicazioni teolo-gico-®loso®che del suo dualismo politico-istituzionale, ammettendo in®ne una``certa soggezione'' del Principe romano al romano Ponte®ce. In realtaÁ , di qualetipo di soggezione si tratti, Dante lo spiega subito dopo, invitando `̀ Cesare'' adusare verso `̀ Pietro'' quella reverentia che il ®glio primogenito deve al padre,
15 Cfr. J. RIVIEÁ RE, Le probleÁme de l'EÂ glise et de l'EÂ tat, op. cit., p. 339.16 Si veda in proposito il mio All'origine della sovranitaÁ. Sistema gerarchico e ordi-
namento giuridico nella disputa sui due poteri all'inizio del XIV secolo, Torino 2004, pp.171-172.
17 Cfr. Monarchia, III, XI, 1-11, ed. P.G. RICCI, Milano 1965, pp. 261-5.18 Cfr. Monarchia, III, IV, 17-20, ed. cit., pp. 238-9.19 Cfr. Monarchia, III, XV, 17, ed. cit., p. 275: «Que quidem veritas ultime questionis
non sic stricte recipienda est, ut romanus Princeps in aliquo romano Ponti®ci non subia-ceat, cum mortalis ista felicitas quodammodo ad inmortalem felicitatem ordinetur».
20 Cfr. B. NARDI, Saggi di ®loso®a dantesca, Milano- Napoli 1930, pp. 285, 342. Siveda anche, dello stesso, il piuÁ recente Dal `̀ Convivio'' alla `̀ Commedia'' (sei saggidanteschi), Roma 1960, pp. 300 ss.

346 NOTE CRITICHE - DISCUSSIONI
essendo il papa appunto, in materia di fede, padre comune di tutti i cristiani. Intal modo, sottomettendosi al ponte®ce in spiritualibus, l'imperatore verrebbe asua volta illuminato dalla luce del favore papale, cosõÁ da poter irradiare piuÁvirtuosamente, con la propria azione di governo, il mondo cui eÁ stato da Diosolo preposto21.
4. Dante e il duplex ordo
L'universo dantesco risulta dunque congiunto non solo nel suo vertice maanche nelle sue articolazioni, come dimostra la relazione stabilita dall'illustre®orentino fra le due supreme autoritaÁ e come peraltro egli stesso aveva sostenutogiaÁ ®n dal primo libro della Monarchia. «Poiche si puoÁ cogliere nelle cose unduplice ordine, Ð comincia il secondo paragrafo del sesto capitolo Ð quellocioeÁ delle parti tra loro e quello delle parti in rapporto ad una qualche unitaÁ chenon eÁ parte, cosõÁ come esiste un mutuo ordine tra i componenti di un esercito e unordine dell'esercito nel suo complesso in rapporto al comandante, [si deve dire che]l'ordine delle parti in rapporto all'unitaÁ eÁ migliore, in quanto eÁ il ®ne dell'ordineprecedente, il quale esiste in vista di quello, e non viceversa»22.
Questa dottrina del duplex ordo appare cosõÁ il fondamento legittimanteun'immagine del cosmo in cui la reductio ad unum, culminante in Dio, nonimpedisce ma, al contrario, richiede e rende possibile la coordinazione tra ivari ambiti della creazione, subordinantisi l'uno all'altro nel perseguimento deirispettivi scopi, senza percioÁ perdere la loro peculiare autonomia.
Ma nelle parole di Dante eÁ contenuta un'ulteriore indicazione. L'esempiodell'esercito, infatti, risale al dodicesimo libro della Meta®sica di Aristotele23 ed eÁpiuÁ volte richiamato anche da Tommaso d'Aquino allorche si occupa dell'assettodell'universo. «Il ®ne dell'universo Ð sostiene ad esempio l'Aquinate nellaSumma theologica Ð eÁ un bene esistente al suo interno, cioeÁ l'ordine stesso del-l'universo. PeroÁ questo bene non eÁ il suo ®ne ultimo, poiche esso si ordina ad unbene esterno come al suo ®ne ultimo; proprio nello stesso modo in cui anchel'ordinamento di un esercito eÁ ®nalizzato al comandante secondo quanto eÁ affer-mato nel libro XII della Meta®sica»24.
21 Cfr. Monarchia, III, XV, 18, ed. cit., p. 275: «Illa igitur reverentia Cesar utatur adPetrum qua primogenitus ®lius debet uti ad patrem: ut luce paterne gratie illustratusvirtuosius orbem terre irradiet, cui ab Illo solo prefectus est, qui est omnium spiritualiumet temporalium gubernator».
22 Ivi, I, VI, 2-3, ed. cit., p. 147: «Cum ergo duplex ordo reperiatur in rebus, ordoscilicet partium inter se, et ordo partium ad aliquod unum quod non est pars, sicut ordopartium exercitus inter se et ordo earum ad ducem, ordo partium ad unum est meliortanquam ®nis alterius: est enim alter propter hunc, non e converso».
23 ARISTOTELES, Metaph. XII, 10, 1075 a 11 ss. Sull'origine aristotelica della dottrinadel duplex ordo si veda J.J. SANGUINETI, La ®loso®a del cosmo in Tommaso d'Aquino,Milano 1986, pp. 73-5.
24 «Finis quidem universi est aliquod bonum in ipso existens, scilicet ordo ipsiusuniversi: hoc autem bonum non est ultimus ®nis, sed ordinatur ad bonum extrinsecumut ad ultimum ®nem; sicut etiam ordo exercitus ordinatur ad ducem, ut dicitur in XIIMetaph.» (THOMAS DE AQUINO, Summa theologiae, I, 103, 2, ad 3).

347ELVIO ANCONA - DANTE L'ANTI-SOVRANO
Il richiamo al Philosophus non eÁ esornativo. CioÁ che in fondo Aristotelerendeva possibile era una problematizzazione radicale dell'ordinamento dell'u-niverso in rapporto al principio meta®sico, una problematizzazione che eviden-ziava sia la contingenza e la funzionalitaÁ delle relazioni reciproche tra le creature,sia la necessitaÁ e l'originarietaÁ della loro relazione al Creatore. Ma proprio questaproblematizzazione, riferita al discorso dantesco, signi®cava anche che l'ordo adDeum, relativizzando ogni ordinamento mondano, ne impediva la sovranitaÁ ,fondandone l'autonomia.
5. Dante e l'autonomia degli ordinamenti
Occorre infatti ben distinguere l'autonomia dalla sovranitaÁ .La sovranitaÁ , nella sua accezione moderna, eÁ un potere legibus solutus e
superiorem non recognoscens, l'unico che in virtuÁ della sua forza eÁ legittimato agovernare. Viceversa Ð ci avverte Paolo Grossi, uno dei maggiori esperti distoria del diritto medievale Ð «se il medioevo giuridico eÁ un mondo di ordina-menti, cioeÁ di autonomie Ð di societates perfectae, direbbe san Tommaso, corifeo a®ne Dugento della antropologia medievale Ð non dobbiamo dimenticare che ca-rattere essenziale di ogni autonomia eÁ la relativitaÁ; si tratta cioeÁ di indipendenzerelative, relative ad alcuni ordinamenti ma non ad altri. L'entitaÁ autonoma nonappare mai come qualcosa che per se stat, avulsa da tutto il resto; anzi, eÁ pensatacome ben inserita al centro di un ®tto tessuto di relazioni che la limita, la condi-ziona ma anche le daÁ concretezza, perche mai pensata come solitaria bensõÁ immersanella trama di rapporti con altre autonomie»25.
Questa nozione di `̀ autonomia'', cosõÁ essenziale al `̀ medioevo giuridico'', sitrova chiaramente al centro dell'universo dantesco, gremito da una molteplicitaÁdi entitaÁ politiche di varia grandezza, nationes, regna et civitates, che all'autoritaÁimperiale erano soggette, ma non erano prive di una propria giurisdizione, diproprie funzioni e compiti, secondo una visione integralmente naturalistica dellasocietaÁ 26. L'Impero stesso, del resto, poteva ben dirsi `̀ autonomo'', essendo a suavolta limitato dai principi costitutivi del ius humanum27, ed essendo inoltre su-bordinato, sebbene esclusivamente ai ®ni dell'attingimento umano della beatitu-dine eterna, alla direzione `̀ paterna'' della Chiesa28. Ma anche la Chiesa, cosõÁcome era obbligata nei confronti degli insegnamenti vetero- e neo-testamentari29,altrettanto era vincolata dalle leggi dell'Impero, dalla cui protezione e tutela essastessa dipendeva per tutto cioÁ che attiene al temporale, che eÁ cura di benimondani30. Chiesa e Impero, quindi, distinti e reciprocamente indipendenti nel-l'ambito delle loro peculiari competenze, erano tuttavia istituzioni di un piuÁ
25 P. GROSSI, L'ordine giuridico medievale, Roma-Bari 1995, p. 48.26 Cfr. Monarchia, I, XIV, 5, ed. cit., pp. 164-5. Sulla presenza della nozione giuridica
di `̀ autonomia'' nel pensiero politico di Dante si eÁ soffermato in particolare F. BATTAGLIA,Impero Chiesa e Stati particolari nel pensiero di Dante, Bologna 1944, pp. 25 e 58 ss.
27 Cfr. Monarchia, III, X, 7-8, ed. cit., p. 258.28 Cfr. Monarchia, III, XV, 18, ed. cit., p. 275.29 Cfr. Monarchia, III, III, 12, ed. cit., p. 229.30 Cfr. Monarchia, II, X-XI, ed. cit., pp. 212-217; III, XII, ed. cit., pp. 265-7.

348 NOTE CRITICHE - DISCUSSIONI
ampio ordinamento unitario e percioÁ non potevano non collaborare nel perse-guimento delle rispettive ®nalitaÁ . Ne risultava un sistema in cui le relazioni tra idue poteri erano di coordinazione piuttosto che di subordinazione e in cui la loroauspicata reductio ad unum veniva intesa in modo tale da soddisfare l'esigenza dipreservare l'unitaÁ del mondo senza compromettere la speci®citaÁ ontologica deirispettivi domini, e soprattutto senza pregiudicarne la capacitaÁ di autoregolarsi edi autogovernarsi.
EÁ in questa prospettiva che Dante puoÁ essere considerato un esponentedella via media, ma soprattutto in questa prospettiva egli si inserisce in quellatradizione dualistica che, come notava il De Lagarde31, percorre tutta la storia delcristianesimo occidentale a partire dalla distinzione gelasiana delle due istituzioniquibus principaliter mundus hic regitur, l'auctoritas sacrata ponti®cum e la regalispotestas32, ®no alle recenti pronunce del magistero ponti®cio circa l'irriducibilitaÁe la necessaria armonia della dimensione religiosa dell'esistenza con la sua di-mensione politica33. Nella Monarchia questa secolare tradizione raggiunse indub-biamente una delle sue sintesi piuÁ felici, capace di coniugare la piuÁ ponderatari¯essione teologica con la piuÁ spregiudicata ricerca ®loso®ca, la piuÁ equilibratasapienza giuridica con la piuÁ ardente passione civile.
Certo, non mancano nell'opera di Dante aspetti discutibili e obsoleti, acominciare dallo stesso ideale dell'impero universale, che dif®cilmente potrebbetrovar realizzazione ai nostri giorni se non Ð come rischiamo di veder accadereÐ in termini volontaristici e tirannici. E tuttavia, pur con tutti i suoi limiti teoricie cronologici, la Monarchia continua a rivelare insospettati motivi di attualitaÁ .
6. L'antropocentrismo di Dante
Dante infatti non si eÁ limitato a ricordare con la sua opera come proprio ladiarchia dei poteri abbia sempre impedito la reductio della politica alla religione eviceversa, preservando la peculiaritaÁ della loro rispettiva missione. In realtaÁ ,giusti®cando la loro istituzione in vista della felicitaÁ integrale dell'uomo, egliha fatto molto piuÁ .
Egli ha indicato come mai era stato fatto prima nell'unitaÁ della personaumana il ®ne in vista del quale eÁ necessaria non solo la distinzione ma anchela concordia di Chiesa e Impero. Ha riconosciuto infatti nell'uomo il vero centrodell'ordine cosmico, come colui che «solo tra tutti gli enti occupa la posizionemediana tra le sostanze corruttibili e quelle incorruttibili e percioÁ correttamente dai®loso® viene assimilato all'orizzonte, che eÁ l'elemento mediano dei due emisferi»34.
31 Cfr. G. DE LAGARDE, La naissance de l'esprit laõÈque au deÂclin du moyen aÃge. I.Bilan du XIIIeÁme sieÁcle, Paris-Louvain 1956, p. IX: «Un des plus grands bouleverse-ments apporteÂs par le christianisme dans l'ordre social a eÂte d'imposer la distinctionentre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, entre l'utorite religieuse et l'autoriteÂpolitique, l'une incarne par le clerge , l'autre par les princes ou les magistrats laõÈques».
32 Cfr. GELASIUS I, Epistula XII, ed. A. THIEL, Epistulae Romanorum Ponti®cum,Braunsberg 1868, p. 350.
33 Cfr. in proposito T.R. ROURKE, The Social and Political Thought of Benedit XVI,Lanham 2010, pp. 49 ss.
34 Monarchia, III, XV, 3, ed. cit., p. 272: «...homo solus in entibus tenet medium

349ELVIO ANCONA - DANTE L'ANTI-SOVRANO
L'uomo, dunque, in quanto partecipa di una duplice natura, ha un duplice®ne. Ma ha anche, per cosõÁ dire, un unico destino. Non bisogna dimenticare aquesto riguardo che per l'Alighieri «la felicitaÁ mortale eÁ in qualche modo ordinataalla felicitaÁ immortale»35.
L'uomo eÁ allora, nella sua complessa struttura, l'essere in funzione del qualesia l'ordinamento temporale che l'ordinamento spirituale non solo esistono nellaloro diversitaÁ , ma devono disporsi ad una cordiale collaborazione. «L'ideÂe forcede Dante Ð cosõÁ compendiosamente la sintetizza il De Libera Ð est que lasocieÂte chreÂtienne est duelle, que cela ne compromet pas son unite , mais aucontraire la renforce. L'homme est un et double, la socieÂte ouÁ il vit, doit l'eà treaussi»36.
Si comprende meglio allora l'importanza del nuovo paradigma che Danteviene delineando, a misura d'uomo, in alternativa tanto al sistema delle angelichegerarchie, ma anche al singolare organicismo animale della comunitaÁ marsiliana.Il singolo uomo, come il genus humanum concepito a sua immagine, diventa cosõÁil protagonista unico della scena politica, chiamato a realizzare la propria perfe-zione nel suo duplice esito naturale e soprannaturale, ma anche, percioÁ stesso,destinato a fungere da principio regolativo di ogni ordinamento, tanto temporalequanto spirituale.
Lungi dall'essere solo il cantore di un ideale superato dalla storia, al croceviatra due epoche, Dante ci addõÁta cosõÁ il modello eterno di ogni ordinamentogiuridico della comunitaÁ politica.
PoicheÂ, come rileva il Gentile, «la consapevolezza della condizione umana,della condizione cioeÁ di un essere che non eÁ un bruto ne una divinitaÁ, partecipandotuttavia di questa e di quella natura, assimilabile, con immagine dantesca, all'oriz-zonte che sta tra il cielo e la terra, a questa appartenendo come a quello, consente algiurista, che sia davvero tale, di intendere la diakonõÁa dell'ordinamento giuridico...Non giaÁ al servizio del Leviatano, mostruoso `̀ dio mortale'' di hobbesiana memoria,ma al servizio di quella straordinaria creatura a cui il Creatore non ha plasmato soloil corpo materiale, ma con l'anima ha infuso il suo Spirito»37.
corruptibilium et incorruptibilium; propter quod recte a phylosophis assimilatur orizonti,qui est medium duorum emisperiorum». Si rimanda, per una compiuta disamina deisigni®cati e delle fonti del passo, a F. BERTELLONI, Dalla cosmologia alla politica. Osser-vazioni sulla `̀ Monarchia'' di Dante, III, XV, in «Revista da Faculdade de CieÃncias Sociaise Humanas», VII (1994), pp. 285-302. Sull'antropocentrismo di Dante rimane comun-que insuperata la trattazione di E. H. KANTOROWICZ, The King's Two Bodies. A Study inMediaeval Political Theology, Princeton 1957, trad. it. di G. RIZZONI, I due corpi del Re.L'idea di regalitaÁ nella teologia politica medievale, Torino 1989, pp. 387 ss.
35 Monarchia, III, xv, 17, ed. cit., p. 275: «... cum mortalis ista felicitas quodammodoad inmortalem felicitatem ordinetur».
36 A. DE LIBERA, Le troisieÁme pouvoir. Les intellectuels scolastiques et la politique, inLes philosophies morales et politiques au Moyen Aà ge. Actes du IX CongreÁs internationalde Philosophie MeÁdieÁvale (Ottawa, du 17 au 22 aouà t 1992), sous la direction de B.C.BAZA N, E. ANDU JAR, L.G. SBROCCHI, New York-Ottawa-Toronto 1995, p. 251.
37 F. GENTILE, Ordinamento giuridico tra virtualitaÁ e realtaÁ , 2. ed. integrata da trecodicilli, Padova 2001, p. 65.

350 NOTE CRITICHE - DISCUSSIONI
7. La `̀ profezia'' di Dante
Ancora oggi, di fronte al constatato fallimento della tradizionale concezionebasata sul principio di sovranitaÁ ed al suo ostinato riproporsi in forme nuove epiuÁ ef®caci, insieme con la sacralizzazione del potere e la soggezione totale deicittadini che vi eÁ implicata, il modello propugnato da Dante sembra resisterenell'epoca dei diritti dell'uomo e della secolarizzazione, in un'epoca soprattuttoin cui eÁ piuttosto il principio di autonomia ad affermarsi a tutti i livelli della vitasociale, da quello sovranazionale a quello familiare, ®no a radicarsi nella capacitaÁdi autoregolamentazione della singola persona.
Solo che Dante sviluppa ®loso®camente l'ideale umanistico che pur avrebbegoduto storicamente di grande fortuna, mostrando che l'uomo puoÁ essere dav-vero centro dell'ordinamento in quanto eÁ a sua volta ordinato da una leggeinscritta nella sua stessa natura ad una perfezione ultima a lui solo riservata.L'uomo ha un ®ne che nessun potere terreno puoÁ sostituire o modi®care, neicui confronti qualsiasi potere eÁ anzi solo strumentale. E presentandosi il ®nesotto un duplice aspetto, duplice deve essere anche lo strumento, il papatus el'imperiatus appunto.
Quanto poi alla ricomposizione di tale duplicitaÁ in unitaÁ , eÁ questo il compitoche non tanto il teologo, o il ®losofo, non il papa, ne l'imperatore, ma ciascunuomo eÁ chiamato ad adempiere. Ed eÁ questo anche il senso profondo dellareductio dantesca, il cui vero arte®ce eÁ in de®nitiva l'uomo stesso, quell'uomoche appartiene tanto all'ordinamento temporale quanto all'ordinamento spiri-tuale; eppure sa anche che tali ordinamenti, essendo tra loro irriducibili, nonsi possono considerare totalizzanti o assoluti, ma devono essere `̀ ricondotti''all'unico principio da cui provengono, non solo alla ®ne dei tempi, bensõÁ nellastessa pratica della vita. Questa eÁ la responsabilitaÁ cui, ricordandoci chi siamo, ciinvita il pensiero politico dell'Alighieri, e ai nostri giorni, in cui la confusione trapolitica e religione rivela sempre piuÁ i suoi esiti fallimentari e nefasti, il richiamo aquesta straordinaria responsabilitaÁ non eÁ forse l'ultimo dei motivi per cui DantepuoÁ ancora dirsi `̀ profeta''38.
Udine, UniversitaÁ
ELVIO ANCONA
38 Ci si riferisce, evidentemente, all'annosa polemica sul profetismo dantesco, per laquale si riamanda a R. MORGHEN, Dante profeta, in «Letture classensi», 3, 1970, pp. 13-36; ora in ID., Dante profeta tra la storia e l'eterno, Milano 1983, pp. 139-157.