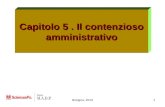CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
-
Upload
claudio-lorusso -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
1/20
CAPITOLO I
L AMMINISTRAZIONE E IL SUO DIRITTO
1. La nozione di pubblica amministrazione.
Amministrazione in senso oggettivo: si intende qualsiasi soggetto che svolge unattivit rivolta alla soddisfazione di interessi correlati ai fini che il soggetto stesso si
propone di perseguire.
Amministrazione in senso soggettivo: attivit posta in essere dalle personegiuridiche pubbliche e dagli organi che hanno competenza alla cura degli interessi dei
soggetti pubblici. Si tratta cio dell organizzazione amministrativa.
2. La nozione di diritto amministrativo.
Il diritto amministrativo la disciplina giuridica della pubblica amministrazionenella sua organizzazione, nei beni e nell attivit ad essa peculiari e nei rapporti che siinstaurano con gli altri soggetti dell ordinamento.
L attivit della pbl. amm. non si esaurisce nella sola attivit di d. pbl., ma si assisteanche ad un attivit di d. pvt. Anche gli stessi rapporti tra diritto penale e
amministrativo si sono fatti pi stretti- vedi depenalizzazione.
3. L amministrazione comunitaria e il diritto amministrativo comunitario.
La presenza del diritto comunitario, con i suoi regolamenti e direttive, nel diritto
amministrativo interno si fa sempre pi pressante, tanto da poter parlare di dirittoamministrativo comunitario, il quale a volte si inserisce direttamente nell ord.
nazionale, altre volte invece necessit dell atto di recepimento del diritto amm.interno. Ci nonostante, il diritto amm. comunitario in senso proprio sarebbe soltan to
quello avente ad oggetto l amministrazione comunitaria, la quale si intende linsieme degli organismi e delle istituzioni dell U. E., cui affidato il compito disvolgere attivit sostanzialmente amministrativa e di emanare atti amministrativi.
Malgrado ci l attivit amministrativa comunitaria influisce grandemente sull org.interna e le strutture che ne risentono maggiormente sono proprio quelle locali. In
questo senso un argine potrebbe derivare dall applicazione del principio di
sussidiariet: esso implica come normale l azione di governo del livello inferiore epi vicino ai cittadini e prevede l intervento del livello superiore di governo soltanto
se l azione del primo non consenta la cura degli interessi affidati.In ogni caso spesso l amministrazione interna finisce per essere spesso servente di
quella comunitaria, trovandosi a dover svolgere compiti esecutivi o preparatori dei
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
2/20
procedimenti adottati dall amm. comunitaria. Questo complica il procedimento
amministrativo,, crea dubbi, incertezze, soprattutto in tema di responsabilit.L esecuzione delle decisioni amministrative da parte della Comunit pu essere in
via diretta o indiretta e l organo rappresentativo dell U. E. pu essere considerato
la Commissione.
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
3/20
CAPITOLO II
ORDINAMENTO GIURIDICO E AMMINISTRAZIONE: LA DISCIPLINACOSTITUZIONALE
1. Diritto amministrativo e nozione di ordinamento giuridico.
Ordinamento giuridico generale: l assetto giuridico e l insieme delle norme
giuridiche che si riferiscono ad un particolare gruppo sociale.
2. Lamministrazione nella Costituzione: in particolare, il modello di
amministrazione emergente dagli artt. 5, 95 ,97 e 98. La separazione tra indirizzopolitico e attivit di gestione.
Nella Costituzione emergono diversi modelli di amministrazione, nessuno dei quali
pare poter costituire quello principale.Secondo lart. 98, l amministrazione legata direttamente alla collettivit nazionale,
al cui servizio i suoi impiegati sono posti.
Il disegno dellart. 5 e della revisione al Titolo V invece caratterizzato daldecentramento amministrativo e dalla promozione delle autonomie locali.Lo schema posto dallart. 97 invece mira a sottrarre lamministrazione, imparziale ed
efficiente, al controllo politico del governo.
Nonostante i modelli si diversifichino tra loro, pare costante il rapporto traamministrazione, governo e politica.
Il Governo, insieme al Parlamento, esprime un indirizzo, qualificato dall art. 95come indirizzo politico ed amministrativo.
Lindirizzo politico definito come la direzione politica dello Stato, cio come quel
complesso di manifestazioni di volont in funzione del conseguimento di un fine
unico.
L indirizzo amministrativo, stabilito nel rispetto di quello politico, consiste nellaprefissione di obiettivi dell azione amministrativa.
Il Consiglio dei Ministri determina l indirizzo generale dell azione amministrativa,mentre il Pres. Cons. Ministri impartisce ai ministri le direttive politiche edamministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio.
Il rapporto tra amministrazione e politica non del tutto assente, anzi; pernecessario che la prima sia leale verso la forza politica che detiene la maggioranza
parlamentare.
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
4/20
3. I principi costituzionali della pubblica amministrazione: la responsabilit.
Il principio di responsabilit enunciato dall art. 28 Cost.: I funzionari e idipendenti dello Stato e degli enti pbl. sono direttamente responsabili , secondo le
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilit civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
3.1. Segue: il principio di legalit.
Il principio di legalit esprime l esigenza che l amministrazione sia assoggettataalla legge. L amministrazione si presenta come esecutrice della legge.
Nel nostro ordinamento vi sono tuttavia pi accezioni del principio di legalit: in primo luogo esso considerato nei termini di non contraddittoriet dell atto
amministrativo rispetto alla legge.Inoltre esso viene visto come l esigenza che l azione amministrativa abbia uno
specifico fondamento legislativo; conformit formale il rapp. tra legge e amm. eimpostato non solo sulla non contraddittoriet ma anche sul dov ere dell amm. di
agire nelle ipotesi e nei limiti fissati dalla legge che attribuisce il relativo potere.
Esiste in terzo luogo il principio della conformit sostanziale: l amm. deve agirenon solo nei limiti legali, ma anche in conformit della disciplina sostanziale postadalla legge, che incide anche sulla modalit di esercizio dell azione e perci penetra
all interno dell esercizio del potere. Questa concezione si ricava dalle ipotesi in cuila costituzione prevede una riserva di legge.
Diversit tra principio di legalit e riserva di legge:
La ris. di legge riguarda il rapporto tra Cost., legge e amministrazione; la suaviolazione determina l illegittimit costituzionale della legge stessa.
Il p. d legalit invece attiene al rapporto tra legge e attivit complessiva della pbl.amm. e il mancato rispetto del principio in questione determina l illegittimit dell
az. amm.
L amministrazione in ogni caso non pu disattendere da parametri anche diversidalla legge, pur se ad essa collegati ( rego lamenti, statuti, regole non scritte ).
Il principio di legalit si risolve in quello di tipicit dei provvedimentiamministrativi.
Occorre infine richiamare il principio del giusto procedimento, sempre in tema dirapporti tra legge e amministrazione, il quale esprime l esigenza che vi sia unadistinzione tra il disporre in astratto con legge e il provvedere in concreto con atto
alla stregua della disciplina astratta.
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
5/20
3.2. Il principio di imparzialit.
L art. 97 pone il principio del buon andamento dell amministrazione e il principio
di imparzialit, il quale esprime il dovere dell amm. di non discriminare la
posizione dei soggetti coinvolti dalla sua azione nel perseguimento degli interessi
affidati alla sua cura.Imparzialit non significa assenza di orientamento dell amm., si impone per cheessa sia strutturata in modo da assicurare una condizione oggettiva di aparzialit.
Perci si intende imparzialit nell organizzazione amministrativa, ma anch eimparzialit nell azione amministrativa.La parzialit ricorre quando sussiste un ingiustificato pregiudizio o un indebita
interferenza di alcuni di tali interessi: l imparzialit, riferita all attivit di sceltaconcreta, si identifica invece nella congruit delle valutazioni finali e delle modalit
di azione prescelte.
3.3. Il principio di buon andamento.
Il principio di buon andamento , enunciato sempre dall art. 97, impone che lamministrazione agisca nel modo pi adeguato e conveniente possib ile. Esso variferito alla pbl. amm. nel suo complesso, non al funzionario ( buona amministrazione
), ma all ente.
3.4. I criteri di efficacia, economicit, efficienza e trasparenza.
Criterio di efficienza: indica la necessit di misurare il rapporto tra il risultato dellazione organizzativa e la quantit di risorse impiegate per ottenere quel dato risultato;
costituisce la capacit di un organizzazione di raggiungere i propri obiettiviattraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi.
Criterio di efficacia: collegato al rapporto tra ci che si effettivamente realizzato
e ci che si sarebbe dovuto realizzare sulla base di un piano o programma.Quindi efficienza ed efficacia non coincidono: un amm. che utilizzi pochissimi
mezzi potrebbe essere efficiente ma non efficace, cos come un attivit efficace nonnecessariamente efficiente.
Criterio di trasparenza: l amm. deve osservare doveri onde rendere intelligibile lapropria azione e visibile la propria scrittura.
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
6/20
3.5. I principi di azionabilit delle situazioni giuridiche dei cittadini nei confronti
della pbl. amm. e di sindacabilit degli atti amministrativi. Il problema della riservadi amministrazione.
Citati art. 24 comma 1 cost e art. 113 Cost.
Tale disciplina esprime l esigenza che ogni atto della pbl. amm. possa essere oggettodi sindacato da parte di un giudice e che tale sindacato attenga a qualsiasi tipo divizio di legittimit: si tratta del principio di azionabilit delle situazioni giuridiche
dei cittadini nei confornti dell amm. e del principio di sindacabilit degli attiamministrativi.
Riserva di amministrazione: esiste un ambito di attivit riservato alla pbl. amm.?
4. Il principio della finalizzazione dell amm. pbl agli interessi pbl .
5. I principi di sussidiariet, differenziazione ed adeguatezza.
Principio di sussidiariet: vedi supra.
Tale principio strettamente collegato con il fenomeno del decentramento, termineutilizzato per indicare la dislocazione dei poteri tra soggetti e organi diversi e assurgea regola fondamentale dell org. amm.
Il decentramento pu assumere forme diverse:
y d. burocratico: implica la responsabilit esclusiva degli organi locali nellematerie di propria competenza e l assenza di un rapporto di rigidasubordinazione con il centro.
y d. autarchico: previsto a favore di enti locali consentendo cos che la cura diinteressi locali sia affidata ad enti esponenziali di collettivit loca li o a favoredi altri enti.
Lo stesso p. di sussidiariet pu essere inteso in due sensi:
y verticale: relativamente alla distribuzione delle competenze tra centro eperiferia
y orizzontale: nei rapporti tra poteri pbl. e organizzazioni della societ.Il p. di sussidiariet fortemente richiamato all art. 118 comma 1 e 3 Cost. e dall
art. 120 Cost.
6. I principi costituzionali applicabili alla pbl. amm.: eguaglianza, solidariet,democrazia.
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
7/20
CAPITOLO III
L ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA: PROFILI GENERALI
1. Introduzione.
2. I soggetti di diritto nel diritto amministrativo: gli enti pubblici.
3. Il problema dei caratteri dell ente pubblico.
L art. 97 Cost. stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge; la l. 70/1975 afferma che nessun ente pbl. pu essere istituito o riconosciutose non per legge.
Oggi molti enti vengono riconosciuti o istituiti attraverso altri enti e quindi con delleprocedure amministrative sulla base di legge, ma non per legge: si distin gue pertanto
tra configurazione astratta e istituzione concreta dell ente.Tuttavia gli enti pbl. vengono infine riconosciuti come tali in via interpretativa,
utilizzando una serie di indici esteriori.
4. La definizione di ente pubblico e le conseguenze della pubblicit.
L ente pbl. costituito con una specifica vocazione allo svolgimento di una peculiareattivit di rilevanza collettiva: perci l ente pbl. non pu disporre della propria
esistenza, a differenza dei soggetti pvt. che possono decidere d i dimettere l attivit odi modificarsi. L indisponibilit della propria esistenza una conseguenza della
doverosit del perseguimento dell interesse pubblico.Per individuare un ente perci necessario definire l interesse che deve perseguire;gli enti che fanno uso di denaro pubblico sono detti enti pubblici economici.
Individuare un ente pubblico importante perch comporta importanti conseguenzenel campo giuridico:
Solo gli enti pbl. possono emanare provvedimenti che hanno efficacia sul piano
dell ord. gen. alla stessa stregua dei provvedimenti dello Stato, impugnabili davantial giudice amministrativo.
Perci gli enti pbl. riservano di un ampia autonomia, intesa come possibilit dieffettuare da s le proprie scelte. Essa appare diversa per ogni ente pbl. Questi
possono anche avere un autonomia di indirizzo, e cio la possibilit di darsiobiettivi anche diversi da quelli statali, capacit degli enti territoriali.La legge pu poi attribuire agli enti un autonomia finanziaria, oppure
organizzativa, o tributaria, o contabile.Perautarchia invece si intende la possibilit di agire per il conseguimento dei propri
fini mediante l esercizio di attivit amministrativa che ha la natura e gli effetti diquella della pbl. amm.
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
8/20
Solo gli enti pbl. hanno la potest di autotutela: possono cio risolvere un conflitto
attuale o potenziale di interessi e sindacare la validit dei propri atti producendoeffetti incidenti su di essi.
Le persone fisiche legate da un rapp. di servizio agli enti pbl. sono a ssoggettate ad
un particolare regime di resp. penale, civile e amministrativa.
Gli enti pbl. sono tenuti al rispetto dei principi applicabili allapbl. amm. e alcuniloro beni sono assoggettati ad un regime speciale. L attivit svolta dagli enti pbl. retta da norme specifiche.
Gli enti pbl. possono utilizzare procedure privilegiate per la riscossione delleentrate patrimoniali dello Stato.
Se gli enti pbl. hanno partecipazioni in una s.p.a., l atto costitutivo pu conferire
agli enti pbl. la facolt di nominare amministratori o sindaci.Gli enti pbl. sono soggetti a particolari rapporti o relazioni la cui intensit varia in
ragione dell autonomia dell ente.Autodichia: possibilit di sottrarsi alla giurisdizione degli organi comuni, esercitando
la funzione giustiziale relativamente alle controversie con i propri dipendenti.Autogoverno: situazione che ricorre nell ipotesi in cui gli organi dello Stato sono
designati dalla collettivit di riferimento, anzich essere nominati e cooptati da pa rte
di autorit centrali.
5. Il problema della classificazione degli enti pbl.
Gli enti possono essere divisi in gruppo anche, fra le altre possibilit, a seconda della
modalit con la quale viene organizzata la presenza degli interessati negli organi de llente:
y Enti associativi, nei quali i soggetti facenti parte del corpo sociale sottostante,determinano direttamente o a mezzo di rappresentanti eletti o delegati ledecisioni fondamentali dell ente. In essi si verifica il fenomeno dell
autoamministrazione.
y Enti a struttura rappresentativa, in cui i soggetti interessati determinano lanomina della maggioranza degli amministratori non direttamente ma attraversole proprie organizzazioni.
y Enti a struttura istituzionale, in cui la nomina degli amministratori determinata da soggetti estranei all ente.
Ma le classificazioni pi importanti sono indubbiamente quelle operate dal
legislatore.La Costituzione contempla gli enti autonomi e gli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria. Riguardo agli enti autonomi la Costituzione riconosce unaparticolare posizione autonoma a comuni, province, citt metropolitane e regioni, cui attribuita autonomia di indirizzo.
Di recente la legge ha introdotto la categoria degli enti locali funzionali, per indicarequegli enti ai quali possono essere conferite funzioni e compiti statali.
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
9/20
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
10/20
Un cenno doveroso nei confronti della delega di funzioni amministrative, figura che
ricorre nei rapporti tra Stato e enti locali. Dopo la recente riforma non si parla pi didelega, ma di conferimento di funzioni amministrative ai vari livelli di governolocale sulla base dei principi di sussidiariet, differenziazione ed adeguatezza.
Le forme associative si distinguono in federazioni e consorzi.
Le federazioni di enti svolgono attivit di coordinamento e di indirizzo dell attivitdegli enti federati, nonch attivit di rappresentanza degli stessi.I consorzi costituiscono una struttura stabile volta alla realizzazione di finalit
comuni a pi soggetti. Spesso gestiscono o realizzano opere o servizi d i interessecomune agli enti consorziati, che restano comunque titolari delle opere o servizi.Possono anche essere costituiti consorzi di d. pvt. con soggetti pvt.
Tra le forme associative rientrano anche le unioni di comuni e gli uffici comuni.
7. La disciplina comunitaria: in particolare, gli organismi di diritto pubblico.
Il termine amministrazione comunitaria impiegato per indicare l insieme degliorganismi e delle istituzioni dell U. E. cui affidato il compito di svolgere attivit
sostanzialmente amministrativa e di emanare atti amministrativi.
Imprese pubbliche: imprese nei confronti delle quali i pubblici poteri possonoesercitare direttamente o indirettamente un influenza dominante per ragioni dipropriet, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.
Gli organismi di diritto pubblico sono soggetti:
y istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere nonindustriale o commerciale
y aventi p.g.y la cui attivit finanziata perlopi dallo Stato, dagli e nti locali o da altriorganismi di d. pbl., o la cui gestione soggetta al controllo di questi ultimi, o
il cui organo di amm. direzione o vigilanza costituito per pi della met damembri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di dirittopubblico.
8. Le figure di incerta qualificazione: in particolare, le s.p.a. a partecipazione
pubblica.
Le s.p.a. a partecipazione pbl. sono soggette ad un regime particolare. Se lo Stato ha
partecipazioni azionarie, l atto costitutivo pu confe rire ad esso la facolt dinominare amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, o di
revocarli. Anche se l ente non ha partecipazioni azionarie consentita questa facolt,ove sia previsto dalla legge o dall atto costitutivo.In caso di dismissioni ( alienazioni che comportino la perdita del controllo ) delle
partecipazioni azionarie degli enti pbl. negli enti privatizzati, lo Stato mantiene poterispeciali.
Ma queste s.p.a. a partecipazione pubblica sono enti pbl. o no?
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
11/20
Si dice che ricorre ente pbl. dove lo statuto delle s.p.a. e la disciplina delle
dismissioni implichino l impossibilit di uno scioglimento.Gli enti locali possono costituire s.p.a. per l esercizio dei servizi pbl. di cui all art.113 bis T.U. enti locali e per la realizzazione di opere necessarie allo svolgimento del
servizio, non ch per la realizzazione di infrastrutture e di altre opere di interesse pbl.
9. Vicende degli enti pubblici.
La costituzione di enti pbl. pu avvenire per legge o per atto ammini strativo sullabase di una legge. Il legislatore non libero di rendere pubblica qualsiasi p.g. pvt.,sussistono infatti limiti costituzionali.
In ordine all estinzione di enti pbl ., essa pu aprire una vicenda di tipo successorio,disciplinata direttamente dalla legge, se le sue attribuzioni vengono assorbite da un
altro ente. L estinzione va prodotta da legge o da atto amm. basato su legge.Quanto alle modificazioni degli enti pbl. si ricordano il mutamento degli scopi, le
modifiche del territorio degli enti territoriali, le modifiche delle attribuzioni, latrasformazione da ente non economico a ente pbl. economico e le variazioni della
consistenza patrimoniale. Un limite alle mo dificazioni pare esservi in merito agli enti
di carattere associativo.Anche il riordino degli enti pbl. pu comportare l estinzione degli stessi o la lorotrasformazione in p.g. pvt.
10. La privatizzazione degli enti pbl.
La privatizzazione comporta che il potere pubblico rinunci ad essere imprenditore.
Il processo di privatizzazione prevede una privatizzazione formale, ovvero fasefredda della privatizzazione, e una sostanziale o fase calda. Nella prima fase illegislatore si limita a dare la gestione di interessi pbl. a strutture privatizzate, ma il
capitale rimane totalmente o quasi in mano pubblica. Nella fase calda invece siprocede alla dismissione della quota pubblica, attraverso tre possibili modalit:
1. offerta pubblica di vendita2. cessione delle azioni mediante trattative dirette con i potenziali acquirenti3. ricorso ad entrambe le procedure
La privatizzazione interessa soggetti operanti in tre settori principali:
y gestione di partecipazioni azionariey
servizi di pubblica utility settore creditizio
Si conoscono comunque altre ipotesi di privatizzazione in cui gli enti vengonotrasformati in soggetti pvt non aventi scopo di lucro.
11. I principi in tema di organizzazione degli enti pubblici.
L organizzazione delle strutture in capo all organo esecu tivo; la legge la fonteprimaria di disciplina della materia organizzativa, ma accanto alle norme giuridiche
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
12/20
di organizzazione, vi sono gli atti di organizzazione non aventi carattere normativo,
quali gli atti di istituzione di enti, organi o uffici ecc, e infine non possiamotralasciare le concrete determinazioni che trovano spazio nella discrezionalitorganizzativa.
12. L organo.
L ente, in quanto p. g., naturalisticamente incapace di agire, quindi sorge ilproblema di come esso potesse agire. Le soluzioni possibili erano due; o si agivatramite rappresentanza, o tramite l organo, la cui azione non pi svolta in nome e
per conto di altri, ma diventa direttamente attivit propria dell ente. La capacitgiuridica spetta in ogni caso all ente. L organo perci uno strumento di
imputazione, cio l elemento dell ente che consente all ente di riferire ad esso leproprie attivit.
L ente stesso si avvale di molteplici organi, e ognuno di essi, pur senza essernetitolare, esercita una quota di poteri attribuiti all ente, detta competenza , ripartita
secondo diversi criteri. La competenza va tenuta distinta dall attribuzione, che la
sfera di poteri che l ord. gen. conferisce ad ogni ente pubblico.
13. L imputazione di fattispecie in capo agli enti da parte di soggetti estranei alla
loro organizzazione.
In alcuni casi l imputazione di fattispecie all ente non viene attraverso l appenacitato fenomeno organo-ente, ma attraverso una diversa persona fisica o giuridica (
spesso un privato ), estranea all organizzazione dell ente ma che ha pur sempre ildovere di agire ( vedi notaio ).
14. Classificazione degli organi.
Vi sono varie distinzioni:
y Organi esterni o interni: a seconda che siano competenti ad emanareprovvedimenti o atti aventi rilevanza esterna o meno.
y Organi centrali o periferici: a seconda che abbiano competenza nell interospettro dell attivit dell ente o meno.
y Organi ordinari o straordinari: a seconda che siano previsti nel normaledisegno organizzativo dell ente o meno.y Organi permanenti o temporanei: a seconda che siano stabili o meno.y Organi attivi, competenti a formare ed eseguire la volont dell amm. in vista
del conseguimento dei fini ad essa affidati; organi consultivi, che rendonopareri; organi di controllo che sindacano l attivit posta in essere dagli organi
attivi.
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
13/20
y Organi rappresentativi o non rappresentativi: a seconda che i propricomponenti vengano nominati dalla collettivit o meno.
y Organi con legale rappresentanza : l organo che esprime la volont dellente nei rapporti contrattuali con i terzi e che avendo la capacit processuale,conferisce la procura alle liti per agire e resistere in giudizio.
y Organi con personalit giuridica : sappiamo che la p. g. spetta solo all ente,tuttavia alcuni organi, per legge, sono dotati anche di p. g. profilandosi cometitolari di poteri e come strumenti di imputazione di fattispecie ad altro ente.
y Organi monocratici o collegiali: a seconda che il titolare sia una sola p. f. opi.
Per capire il funzionamento degli organi collegiali occorre distinguere tra:
y quorum strutturale: n min. di membri che devono esser presenti perch ilcollegio sia legittimamente costituito.
y quorum funzionale: n min. d membri presenti che devono essere favorevolialla proposta perch essa si trasformi in deliberazione.
Nei collegi perfetti ( quorum s.= 50% + 1 ) non ammessa l astensione, in altricollegi essa non si conta, altre volte si computa tra i favorevoli o tra i contrari.
15. Relazioni interorganiche. I modelli teorici: la ge rarchia, la direzione e il
coordinamento.
La gerarchia esprime la relazione di sovraordinazione -subordinazione tra organidiversi. L organo subordinato non dispone di una propria sfera di competenza e l
organo superiore ha una competenza comprensiva anc he di quella del secondo.
I poteri caratteristici della relazione gerarchica sono:1. Potere di ordine, che vincola l organo subordinato ad un certo
comportamento nello svolgimento dell attivit. Potere di direttiva, che
consente di indicare i fini da raggiungere lasciando sussistere un margine di
scelta in ordine alle modalit con cui conseguirli. Potere di sorveglianza, sullattivit degli organi subordinati.
2. Potere di decidere i ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti dell organosubordinato.
3. Potere di annullare d ufficio o di revocare gli atti emanati dall organosubordinato.
4. Potere di risolvere i conflitti che insorgono tra organi subordinati.5. Potere di avocazione e sostituzione.6. Pi controverso il potere di delega, ritenuto sussistente solo ove previsto
espressamente dalla legge.
Nella direzione, vi sono due organi posti in posizione di disuguaglianza, ma quellosubordinato ha una certa sfera di autonomia. Il potere ordinatorio sostituito da
quello di emanare direttive, da cui per l organo inferiore non completamente
vincolato; il controllo inoltre si svolge in via successiva e riguarda l attivit. Le
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
14/20
direttive hanno efficacia vincolante, ma lasciano uno spazio di discrezionalit pi
ampio al destinatario.Il coordinamento si riferisce ad organi in situazione di equiordinazione posti adattivit che, pur dovendo rimanere distinte, sono ordinate secondo un disegno
unitario. Il contenuto di questa relazione il potere spettante ad un coordinatore, di
impartire disposizioni idonee a tale scopo e di vigilare sulla loro attuazione edosservanza.Tale istituto per, mancando di stabilit, non costituisce una relazione in senso
proprio, ma pu essere al massimo considerata come una figura di rapportointerorganico.
15.1. Segue: il controllo.
Il controllo costituisce un autonoma funzione svolta da organi peculiari. Essoconsiste in un esame di atti e attivit imputabili a un altro organo controllato ( si
svolge anche all interno della relazione gerarch ica ). Esso si conclude con laformulazione di un giudizio, positivo o negativo, sulla base del quale viene adottata
una misura.
Pu essere effettuato un controllo anche da parte di organi di altro ente, e condottoalla luce di criteri di volta in volta differenti.Le misure adottate sono di vario tipo: repressive, impeditive, sostitutive
Nell ambito di controlli sugli atti si distingue tra controlli preventivi e successivi,rispetto alla produzione degli effetti degli atti. In una via di mezzo si colloca no i
controlli mediante riesame , che procastinano l efficacia dell atto all esito di unanuova deliberazione dell autorit decidente.
Analizziamo ora i principali controlli.
15.2. In particolare: il controllo di ragioneria nell amministrazione statal e ed il
controllo della Corte dei Conti.
Il controllo di ragioneria esercitato dagli uffici centrali del bilancio e dalle
ragionerie provinciali, i quali provvedono alla registrazione degli impegni di spesarisultanti dai provvedimenti assunti dalle amm. statali e possono inviare osservazioni
sulla legalit della spesa senza che ci abbia effetti impeditivi sull efficacia degliatti.
Controllo successivo esterno e costituzionalmente garantito quello esercitato dallaCorte dei Conti.Il quadro dei controlli spettanti a tale organo contempla:
1. Un controllo preventivo sugli atti gi indicati, vedi infra.2. Un controllo preventivo sugli atti che il Pres. del Cons. Ministri richiede di
sottoporre a controllo o che la Corte decide di assoggettare a controllo p er unperiodo a causa di ripetute irregolarit riscontrate nel controllo successivo.
3. Un controllo successivo sui titoli di spesa relativi al costo del personale., suicontratti e i relativi atti di esecuzione
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
15/20
4. Un controllo successivo su atti di notevole livello finanziario.5. Un controllo sulla gestione finanziaria di enti cui lo stato contribuisce.6. Un controllo sulla gestione degli enti locali.7. Un controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amm.
pbl.
8. La Corte poi, pronuncia il giudizio di parificazione sul rendiconto generaledello Stato.15.3. L evoluzione normativa in tema di controlli. I controlli interni.
Ora le pubbliche amm., nell ambito della propria autonomia, devono istituire i
controlli interni articolati in quattro tipologie:1. Il controllo di regolarit amministrativa e contabile , volto a garantire la
legittimit, la regolarit e la correttezza dell azione amm.2. Il controllo di gestione mira a verificare l efficacia, efficienza e economicit
dell azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestiviinterventi di correzione, il rapp. tra costi e risultati.
3. La valutazione della dirigenza ha ad oggetto le prestazioni dei dirigenti e icomportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane eorganizzative ad essi assegnate.
4. La valutazione e controllo strategico valuta l adeguatezza delle sceltecompiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti dideterminazione dell indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti.Rispetto agli altri controlli, quelli interni hanno ad oggetto l intera attivit e non
soltanto i singoli atti, si svolgono sulla base di parametri spesso diversi dalla solalegittimit, non hanno efficacia automaticamente paralizzante dell attivit stessa esono di norma successivi o concomitanti rispetto al farsi del potere.
16. I rapporti tra gli organi e l utilizzo, da pa rte di un ente, degli organi di un altro
ente.
Si tratta di rapporti che di volta in volta possono correre tra organi diversi, in cui
assente il carattere di stabilit che connota le sole relazioni.In questo ambito devono essere ricordati l avocazione , la sostituzione e la
delegazione.Nell avocazione un organo esercita i compiti spettanti ad altro organo in ordine asingoli affari, per motivi di interesse pbl. e indipendentemente dall inadempimento
dell organo istituzionalmente competente.La sostituzione invece ha come presupposto l inerzia dell organo sostituito nell
emanazione di un atto cui tenuto per legge e consiste nell adozione, previa diffida,da parte di un organo sostituto degli atti di competenza di un altro organo. Lasostituzione attiene all attivit di controllo sugli atti e non sugli organi, che quindi
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
16/20
possono continuare a svolgere la loro attivit, eccetto quella relativa all adozione
dell atto che avevano l obbligo di emanare.Dalla sostituzione nell emanazione di atti di competenza di un altro organo vadistinta la sostituzione di organi dell ente, fenomeno definito gestione sostituivacoattiva, in cui si sostituisce del tutto l organo.
Nella delegazione un organo investito in via primaria della competenza di una datamateria consente unilateralmente ad altro organo di esercitare la stessa competenza.Essa richiede espressa previsione legislativa. Il delegante mantiene poteri di direttiva,
vigilanza, revisione e avocazione. L organo delegatario agisce in nome proprio, m aper conto e nell interesse del delegante.La mera delega di firma non comporta alcun spostamento di competenza; essa spetta
infatti sempre all organo delegante, mentre il delegante ha solo il compito disottoscrivere l atto, imputabile al delegante, c os come ad esso sorgerebbe resp. nei
confronti di terzi.
17. Gli uffici e il rapporto di servizio.
All interno degli enti e accanto agli organi esistono gli uffici, nuclei elementari dell
organizzazione che svolgono attivit non caratterizzata dal mec canismo diimputazione di fattispecie sopra descritto.Essi sono costituiti da un insieme di mezzi materiali e personali e sono chiamati a
svolgere uno specifico compito che concorre al raggiungimento di un certo obiettivo.Tra gli addetti all interno dell ufficio si distingue la figura del preposto, che il
titolare.Gli addetti e i titolari che restano il proprio servizio presso l ente sono legati alla p.
g. da un rapporto di servizio, che ha come contenuto il dovere di ufficio: esso ha adoggetto comportamenti che il dipendente deve tenere sia nei confronti della pbl.amm. che dei cittadini
I soggetti legati da rapp. di servizio sono di norma i dipendenti. Ricorre in tali ipotesiil rapp. di servizio di impiego, in cui tali soggetti svolgono il proprio lavoro a titolo
professionale, in modo esclusivo e permanente. Il rapp. di servizio pu anche essere
coattivo o onorario ( in cui il contenuto del rapp. di servizio ridotto, infatti non vi il diritto alla carriera ) o instaurato in via di fatto.
Il rapporto di servizio, legando all ente tutti i soggetti che fanno parte dellorganizzazione, si distingue dal rapporto organico, che corre solo tra titolare dell
organo e ente e viene in evidenza ai fini dell imputazione delle fattispecie.Oggi quasi tutti i rapporti di servizio di impiego si instaurano mediante contratto,mentre talora il rapporto organico si costituisce in assenza di investitura, cio di fatto.
Divieto di prorogatio: gli organi possono essere prorogati per 45 gg. decorrenti dallascadenza del termine di durata previsto, scaduto il quale senza che si sia adoperata
sostituzione, gli organi decadono e i loro eventuali atti successivi sono nulli.
18. La disciplina attuale del rapporto di lavoro dei dipendent i delle amministrazioni
pubbliche.
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
17/20
Principi della privatizzazione del pubblico impiego:1. I rapp. di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del c. c. e dalla
contrattazione sia sul piano individuale che collettivo, fatte salve le
disposizioni del d. lgs. 165/2001, e eccetto talune categorie specificatamente
indicate.2. La legge prevede limiti all autonomia contrattuale individuale o collettiva.3. Restano assoggettati alla disciplina pubblicistica gli organi, gli uffici, i principi
fondamentali dell organizzazione, i procedimenti di selezione per l accesso allavoro e quelli di avviamento, i ruoli, le incompatibilit, le responsabilit, adeccezione delle sanzioni e degli illeciti disciplinari, la determinazione delle
dotazioni organiche.4. I sindacati vanno consultate o informate senza che sia richiesto il loro
consenso.5. La contrattazione collettiva si svolge a vari livelli.6. Sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie riguardanti i rapp. dilavoro.7. I dipendenti sono assoggettati ad una particol are resp. amministrativa, penale e
contabile.8. Il reclutamento del personale avviene mediante procedure selettive che
garantiscono l acceso dall esterno, o mediante avviamento degli iscritti alle
liste di collocamento ( solo per lavori in cui richiesta la mera scuola dellobbligo ).
9. Viene eliminato il potere di gestione degli organi politici e affermato ilprincipio della distinzione tra indirizzo politico e gestione.
19. La dirigenza e i suoi rapporti con gli organi politici.
Ai dirigenti sono attribuiti autonomi poteri di gestione , con il compito di organizzareil lavoro, gli uffici e le risorse umane e finanziarie, nonch di attuare le politiche
delineate dagli organi di indirizzo politico -amm.
La dirigenza statale si articola in due fasce. I dirig enti della seconda fascia transitanonella prima se hanno ricoperto incarichi di prima fascia per almeno 5 anni senza
essere incorsi nelle misure previste per la resp. dirigenziale.L accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso per esami o per
concorso selettivo di formazione. Il rapporto di lavoro si fonda su di un contratto,distinto dall incarico della funzione, che definisce oggetto, obiettivi e durata dellincarico.
Propria dei dirigenti la responsabilit dirigenziale, che aggi untiva rispetto allealtre forme di responsabilit propria dei dipendenti pubblici, e sorge se non sono stati
raggiunti gli obiettivi o in caso di inosservanza delle direttive imputabile al dirigente.La sanzione l impossibilit del rinnovo dell incarico, ma possibile pure collocareil dirigente in disponibilit o recedere dal rapporto.
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
18/20
Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti sono in suscettibili di ricorso
gerarchico: questo sintomo del superamento della gerarchia. Perci la relazione traorgani politici e dirigenti sarebbe di direzione, ma tale definizione non convince,sarebbe infatti preferibile parlare di sfere di competenza separate e differenti.
20. I soggetti di diritto nel diritto amministrativo: le formazioni sociali e gliordinamenti autonomi.
Le organizzazioni sociali sono spesso costituite da aggregazioni di individui sorrettida finalit etiche, religiose, ideali e che perseguono interessi, non caratterizzati dalloscopo di lucro, in parte coincidenti con quelli affidat i alla cura di soggetti pubblici. Vi
sono poi ordinamenti autonomi, quali quelli delle confessioni religiose ( ord.canonico ) e l ord. sportivo.
21. I mezzi. In particolare i beni pubblici. Nozione e classificazione codicistica.
Tra i beni appartenenti agli enti pbl. vi sono i beni pubblici ( patrimonio
indisponibile ), assoggettati ad una normativa differente rispetto agli altri beni. Vi
sono inoltre beni appartenenti agli enti pbl. ma sottoposti alla normativa generale (patrimonio disponibile ).Il patrimonio disponibile, fra cui il denaro, pu essere oggetto di contratti di
alienazione, di acquisto e cos via.Il complesso di beni pbl. appartiene alle pbl. amm. a titolo di propriet pbl.
La titolarit della propriet dei beni pbl. appartenenti agli e nti pbl. trova la sua fonteinnanzitutto sulla legge. Vi sono infatti beni appartenenti allo Stato ex lege: il
cosiddetto demanio naturale.Ma la titolarit dei beni pbl. pu derivare anche da fatti acquisitivi, atti di d. comune,fatti basati sul d. pbl. internazionale o sul d. pbl. interno, atti pubblicistici che
comportano l ablazione di diritti reali su beni di altri soggetti, ecc.
22. Il regime giuridico dei beni demaniali.
I beni demaniali sono tassativamente indicati dalla legge e si distinguono i n necessari
o accidentali.I beni demaniali necessari sono costituiti dal demanio idrico, dal demanio marittimo
e da quello militare. Il demanio necessario costituito esclusivamente di immobili enon possono non appartenere allo Stato, eccetto i casi dei beni demaniali regionali.Il demanio accidentale composto da strade, acquedotti, immobili di interesse
storico, archeologico e artistico, musei, pinacoteche, biblioteche, ecc. Tali benipossono appartenere a chiunque ma sono tali solo se appartengono ad un ente pbl.
territoriale, ma non soltanto allo Stato o ad una regione, come previsto per quelliaccidentali. Inoltre essi possono essere costituiti da immobili, ma anche dauniversalit di mobili.
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
19/20
Comunque tutti i beni demaniali sono inalienabili e non p ossono formare oggetto di
diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Va poi esclusain assoluto la trasferibilit dei beni del demanio necessario; per quelli accidentaliinvece possibile il trasferimento da un ente terri toriale ad un altro.
E l amministrazione che deve tutelare i beni che fanno parte del demanio: essa
dispone di poteri di autotutela.I beni del demanio naturale acquistano la demanialit per il sol fatto di possedere irequisiti previsti dalla legge, mentre quelli artificiali divengono beni demaniali nel
momento in cui l opera realizzata, purch essa sia di propriet di un enteterritoriale.La sdemanializzazione comporta la cessazione del diritto di uso del bene spettante a
terzi e la estinzione delle eventuali limitazioni derivanti dalla natura demaniale delbene stesso.
Il bene demaniale infatti pu anche cessare di esserlo, attraverso la propriadistruzione o dalla perdita dei requisiti, o anche dalla cessazione della destinazione.
23. Il regime giuridico dei beni del patrimonio disponibile.
Patrimonio indisponibile: elenco all art. 826 c. c. comma 2 e 3 e art. 830 c. c. comma2.I beni del patrimonio indisponibile possono appartenere a qualsiasi ente pbl. e
comprendono beni immobili e mobili. Alc uni di essi per sono riservati ad enti pbl.,altri invece sono tali per il sol fatto di appartenere ad un ente pbl. particolare o ad un
qualsiasi ente pbl., altri ancora assumono il carattere della indisponibilit soltanto inconseguenza di una destinazione pbl.
Le cave, le torbiere, le acque termali e minerali e le foreste sono state trasferite alpatrimonio indisponibile della regione. Le miniere invece sono riservate allo Stato.Le cose mobili di interesse storico, paletnologico, paleontologico, artisti co,
appartenenti a qualsiasi ente pbl. sono assoggettate al patrimonio indisponibile salvoche non costituiscano demanio accidentale.
I beni del patr. indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.I beni del patrimonio indisponibile non sono in commerciabili, anche se gli atti di
disposizione devono rispettare il vincolo di destinazione, altrimenti l atto annullabile. Solo alcuni beni sono totalmente in commerciabili, altri sono sogg etti ad
un regime di inalienabilit, salvo permesso amministrativo.
24. Diritti demaniali su cose altrui, diritto d uso pubblico e usi civici.
Si tratta di diritti spettanti ad enti territoriali su beni altrui, quando i diritti stessi sono
costituiti per l utilit di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per ilconseguimento di fini di pbl. interesse corrispondenti a quelli cui servono i benimedesimi.
-
8/4/2019 CAPITOLO I - 3 Casetta Diritto Amministrativo
20/20
Quanto ai diritti demaniali su cose altrui si pensi alla servit di un fondo privato per
la realizzazione di un acquedotto pbl. o alla servit di via alzaia, che grava su fondiadiacenti a corsi d acqua e obbliga di lasciare uno spazio sul fondo per lospostamento dei barconi. Oltre alle servit vi sono poi le limitazioni pubbliche di
propriet private, che si limitano ad obbligare ad un non facere il proprietario.
Tra i diritti d uso pbl. gravanti su beni pvt. ricordiamo quelli di visita dei beni pvt.di interesse storico e quelli che attengono alle strade pvt., ai vicoli e agli spiazzi ap ertial pubblico traffico.
Gli usi civici possono gravare anche su beni pbl.: si tratta di diritti spettanti allacollettivit su terreni di propriet di comuni o di terzi e che hanno ad oggetto di voltain volta il pascolo, la pesca, la caccia, ecc.
25. L uso dei bei pubblici.
Per alcuni beni pubblici la distanza rispetto alla propriet pvt. meno marcata, infattine consentito l uso diretto e riservato al proprietario pubblico che lo impiega per
lo svolgimento dei propri compiti. Tra gli usi diret ti del bene ricordiamo il
conferimento di beni nelle aziende speciali o nelle s. p. a. misteIn molti casi poi il bene in grado di soddisfare anche altre esigenze: si realizza cosl uso promiscuo ( vedi strade militari ).
All opposto dell uso diretto vi l uso generale, che riguarda i beni pbl. cheassolvono la loro funzione a servizio della collettivit.
Infine vi l uso particolare, in cui i privati non si limitano ad entrare in rapportodiretto con il bene, poich esso proprio posto al serviz io di singoli soggetti ( vedi
concessioni o riserve di pesca ).