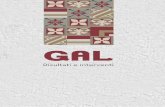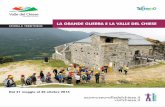Antichi Mestieri e Prodotti Tipici
-
Upload
gloria-gentili -
Category
Documents
-
view
14 -
download
0
description
Transcript of Antichi Mestieri e Prodotti Tipici


89
La Svizzera Pesciatina
2.3 vita nelle Castella e antichi mestieri
La Svizzera Pesciatina, con la sua storia, la sua cultura, il paesaggio, la tipicità e le attività economiche tradizionali, è custode di un sapere antico che affonda le proprie radici nella civiltà rurale e artigiana. Un paesaggio valorizzato dal lavoro di generazioni di agricoltori e artigiani, piccoli paesi e borghi rurali a testimoniare il lavoro dell’uomo e i suoi effetti sul territorio, sul paesaggio e sull’architettura.
L’artigianato, orgoglio e simbolo di una cultura locale assai antica, ha fornito esem-pi di prodotti generatori dal forte valore aggiunto: laboratori artigianali e attività quali ra-mai, campanari canestrai, cestai ecc., sono sopravvissuti nel passato nei centri delle dieci “Castella”. Piccoli laboratori a gestione familiare che si tramandano un ricco patrimonio artistico da generazioni. Le informazioni storiche su questi mestieri si sono tramandate nei secoli oralmente mentre documentazione cartacea si trova solo a partire dai primi del ‘900, e in maniera più considerevole a cavallo fra le due guerre mondiali.
Nel testo che segue si analizzano gli antichi mestieri con le loro peculiarità e tradiz-ioni, e, a partire dalla testimonianze e dalle interviste agli abitanti, si cerca di dedurre usi e costumi che hanno accompagnato per secoli la vita nei paesi della Svizzera Pesciatina. All’interno della maggior parte dei borghi della Valleriana si riscontrano storicamente mestieri legati alla ruralità e al piccolo artigianato; alcune “Castella”, denotano però delle tipicità che le hanno rese uniche e note, non solo in Toscana, ma anche in tutto il mondo.
A San Quirico, paese dei fonditori di bronzo, questi artigiani sono presenti a partire dal XV secolo, specializzati nella fusione per la creazione di campane, conosciuti non solo in Valleriana e a Lucca ma anche all’estero. Ogni maestro fonditore era depositario di un “saper fare” costituito da elementi di metallurgia, ma anche sensibilità musicale e perizia nelle operazioni accessorie, come la ricerca dell’argilla più adatta. Dal X secolo, le campane assunsero anche un ruolo civile per chiamare a raccolta la comunità per eventi ordinari ed eccezionali. Sappiamo che fino al XIX secolo, le botteghe artigiane erano dislocate in tutto il perimetro del paese.
La perfezione delle opere dei mastri fonditori era veramente unica e il suono prodotto dalle campane si riconosceva ovunque. Era usata una tecnica di fusione e una lega particolare basata su conoscenze che venivano tramandate oralmente e che ancora oggi è sconosciuta. Dai libri di lavoro (tutti posteriori al 1700), conservati presso l’Archivio di Stato di Lucca, o gelosamente conservati da alcuni eredi, si ricavano notizie economiche o di maestranza. Dopo il XVIII secolo alcune botteghe si trasferirono a Pescia e a Lucca, insieme alle maestranze della famiglia Moreni di Castelvecchio. Gli artigiani presenti a San Quirico appartenevano alle famiglie Benigni, Angeli e Magni, ma il più famoso fonditore era Giò Quirico Benigni, che era anche pittore e scultore in alabastro e legno. Il suo ritratto ad olio è conservato presso la famiglia Fontana, ed è stato eseguito dal pittore locale Coli, raffigurato appoggiato ad una campana.
Una notizia di particolare interesse risale al 1799, quando il paese si trovò, suo mal-grado, nella zona di transito di due eserciti nemici: da una parte i francesi diretti a Geno-va e dall’altra gli austro-russi che li inseguivano. Numerosi erano i bonapartisti, presenti in paese, che esprimevano le loro idee di libertà, anche con scritte sulle facciate delle case e, in questa occasione, l’appoggio ai francesi non mancò. Vennero suonate a raccolta le campane per difendersi e per avvertire l’esercito d’oltralpe che il nemico era vicino e favorendo un’azione difensiva. Dopo aver razziato il castello gli austro-russi se la pre-sero con la campana più grande, che fu gettata dalla torre campanaria. Ma questa non si ruppe! I soldati tentarono di frantumarla con mazze senza riuscire a scalfirla. Le crona-che raccontano che si fece avanti un paesano, Giò Quirico, che disse : “Volete proprio romperla? Ebbene la romperò io”. Prese una spina d’acciaio, la pose dalla parte opposta da dove batteva e, con un solo colpo, questa si ruppe. Occorre ricordare che il simbolo dei fonditori di campane di S.Quirico era una piccola lucertola tanto che, in alcune case, si possono ancora vedere delle lucertole scolpite nelle pietra, simbolo di questa arte, a testimonianza della presenza di tali maestri. In particolare uno stemma è ancora visibile in un tratto di muro situato in una parte del paese denominato “Orticino”.
a cura di Davide Trane e Mauro Agostini

90
La Svizzera Pesciatina

91
La Svizzera Pesciatina
Pontito era la patria dei figurinai, “gli artigiani delle figurine di gesso”, famosi per l’arte di riprodurre le statuine, commerciate in tutta Europa, rappresentanti personaggi di ispirazione religiosa e altro. Personaggi storici che dalla seconda metà dell’ ‘800, fino alla metà ‘900, emigrarono divulgando questa tradizione secolare.
Il metodo per realizzare una statuina in gesso richiedeva una grande esperienza ed abilità da parte dell’artigiano che doveva avere doti artistiche per dipingere a mano le singole statuette, una volta modellate. Il gesso non era un prodotto tipico del luogo, nè i disegni che venivano raffigurati erano esclusivi dell’ambiente, originale era invece la lavorazione del materiale, che per manualità e poesia, e per genio creativo, sapeva misurarsi con le tradizioni. Il signor Niccolai Gennaro, di Pontito, intervistato su questo antico mestiere, svolto fino alla metà del ‘900, ha raccontato che da generazioni in inverno molti uomini del paese, invece di andare a fare carbone, emigravano in altre località d’Italia, come per esempio Arezzo, Pisa, Roma, per produrre e vendere le famose statuine, mentre altri andavano addirittura all’estero. L’arte dei figurinai era diffusa anche in altre zone limitrofe e numerose furono le famiglie dei territori di Bagni di Lucca, di Barga, di Borgo a Mozzano, di Coreglia e di Pescaglia.
Castelvecchio è nota come “il paese dei gelatai”, tradizione nata per merito di Aurindo Ferrari, nato a Castelvecchio nel 1873, mastro gelataio, che seppe insegnare la sua arte ai ragazzi del paese, aiutandoli anche economicamente a farsi una fortuna in varie parti d’Italia. Dalle interviste effettuate ad alcuni paesani, tra cui anche la signora Dora Natali, è emerso che intorno agli anni ‘30 del secolo scorso, Castelvecchio poteva vantare una grande tradizione nel campo della gelateria, tramandata di padre in figlio, che coinvolgeva anche il lavoro degli altri abitanti del paese. Proprio per merito di Aurin-do Ferrari, a molti giovani del paese, fu insegnata l’arte del gelato, che appresero anche lavorando nelle gelaterie di sua proprietà ad Empoli. Questi ragazzi poterono successi-vamente aprire gelaterie in alcune regioni d’Italia come ad esempio in Sardegna, Puglia, Toscana, dove lavoravano nel periodo estivo, per ritornare al paese durante l’inverno.
Anche l’artigianato del rame, era un’antica tradizione della valle, e, dalle testimo-nianze pervenute, possiamo affermare che già nei primi del ‘900, e forse anche prima, ci fosse già un vero e proprio artigianato del rame. Il rame, martellato e stagnato, è il met-allo più adatto alla cottura delle vivande, grazie alla sua elevata conducibilità termica: si scalda uniformemente garantendo una cottura omogenea degli alimenti. Contenitori tipici in rame erano le teglie, che venivano utilizzate in cucina; i paioli usati per cuocere la polenta; le brocche utilizzate per attingere l’acqua alla fonti e anche i contenitori per la brace. La durata di questi utensili era illimitata per cui quando si bucavano, a causa del troppo uso, si portavano dallo stagnino che li riparava. Con la nascita delle prime industrie, queste lavorazioni si spostarono verso la pianura, dove molte delle persone della montagna andarono a lavorare nelle grandi aziende Pesciatine. L’ultimo ramaio della Svizzera Pesciatina si può trovare a San Quirico, nella persona di Mauro Agostini, che continua la lavorazione del rame nella propria terra nativa. Come racconta, fin da bambino, nel tempo libero, frequentava la bottega dello “zio Giovanni” valente magnano del paese, ma anche fabbro, e da questi Mauro impara le prime nozioni del mestiere. Dopo gli studi inizia a lavorare nelle botteghe artigiane del comune di Pescia, che una volta erano numerose e rinomate, e qui perfeziona le sue conoscenze in dette lavora-zioni. Negli anni ‘70 decide di iniziare un’attività in proprio aprendo la sua “bottega” nel piccolo paese dove ancora è situata e questo nonostante sembrerebbe non avrebbe senso svolgere una attività lavorativa in un paese come S.Quirico, se non al fine di volere contribuire sinceramente alla valorizzazione del proprio territorio e delle radici culturali che questo tramanda.
Vellano, Pietrabuona e Stiappa erano i centri più rinomati, sia in Italia che all’estero, nella lavorazione della pietra serena: solo a Vellano si contavano circa 300 scalpellini e 50 cave. Il mestiere dello scalpellino, fabbricante di manufatti in pietra, ha un’antica tradizione nella Svizzera Pesciatina; la scalpellatura, infatti, rappresenta una delle fasi di lavorazione della pietra dopo la cavatura e la sgrossatura. I manufatti di maggior pregio erano costituiti da colonne, architravi, stipiti, scale, acquai, caminetti, ecc. Lo scalpellino, sia che fosse maestro o garzone, lavorava principalmente nella cava e costruiva prevalen-
La Svizzera Pesciatina rappresenta degnamente la tradizione storica proiettata nel futuro, tradizione che ogni giorno si evolve paradossalmente ritornando indietro nel tempo.

92
La Svizzera Pesciatina
temente da solo gli arnesi del mestiere: subbie, scalpelli, punciotti, gradine, e quant’altro serviva al suo lavoro, tanto che nella cava era presente anche la forgia. Questo mestiere era insediato prevalentemente a Vellano, tanto da costituire da sempre la massima eco-nomia paesana e, tra egli anni 1920-1940, anche con una scuola dove “maestri scalpel-lini” tramandavano questa arte antica. Fra i tanti scalpeliini va ricordato Ivo Cosci, le cui opere sono presenti in molte ville signorili della zona. Ai primi del secolo scorso alcuni si trasferirono, come si è visto (PARTE PRIMA 2.3 antichi mestieri e prodotti tipici) anche all’estero, a Bucarest, in Romania, a lavorare il porfido. Fra il 1955 e il 1965 tutte le cave hanno cessato la loro attività, ad eccezione della “Cava della Fontanella”, nella frazione di Vellano, di proprietà di Germano Nardini che, tutt’ora, con il figlio Marco, continua l’antica tradizione della lavorazione della pietra e rappresenta l’ultima generazione di scalpellini presenti sul territorio.
Altro mestiere riconducibile alla lavorazione della pietra, era il cavatore. A questa parola venivano attribuiti più significati; erano definiti cavatori anche i renaioli, piastrai, e gli spaccaghiaia.
I renaioli con diversi strumenti di lavoro si recavano lungo il fiume scavando e se-tacciando la rena che le piene precedenti aveva depositato. La rena veniva prelevata lun-go il fiume a Nord di Pescia, fino al ponte di Castelvecchio, nella Pescia di Pontito e fino Pontaccosce nella Pescia di Vellano. Successivamente veniva trasportata con i barrocci sui cantieri per essere impastata insieme alla calce per le costruzioni. Questo mestiere fu svolto fino alla metà degli anni ‘50 anche da molti abitanti di Pietrabuona, come Gerando Panteri, Angeli Alberto, ecc. I Cavatori-piastrai lavoravano la pietra da piastre. Questo materiale veniva utilizzato come fornelli da carbone, alari, pianelle refrattarie, e piastre da “necci”, dette anche testi. Gli spaccaghiaia, lungo la provinciale Mammianese frantumavano manualmente blocchi di pietra albarese (calcarea) per farne ghiaia, usata poi per la manutenzione delle strade. La pietra albarese veniva estratta nelle cave della Maona, a Montecati Alto (PT) (in P. Biagini, 2008). Già anticamente a valle, lungo i fiumi, nei paesi di Pietrabuona, Calamari e Ponte di Sorana, erano presenti numerose
cartiere, si può dire che queste siano state l’unica e vera industria della zona, dove si produceva carta di ogni tipo. Nelle cartiere lavoravano intere famiglie di cartai di provata maestria, capaci di usare tecniche che, di generazione in generazione si sono tramandate fin dal lontano 1400 (cfr. PARTE PRIMA 2.2.4 cartiere e archeologia industriale). Qui ci soffermer-emo soltanto per descrivere, secondo alcune testimonianze la dura fatica degli operai che si recavano a lavorare nelle cartiere dai loro paesi. Secondo la testimonianza diretta della

93
La Svizzera Pesciatina
signora Vera Mariani, che negli anni ‘50 lavorava presso la cartiera Magnani, gli spostamenti degli operai per raggiungere la fabbrica avvenivano a piedi ed alcuni operai, per recarsi dalla fabbrica alla propria abitazione, impiegavano anche più di un’ora, spesso al freddo e a volte anche sotto la neve. Diverse erano le professioni all’interno della fabbrica e ognuno aveva la propria specializzazione: facchini, straccine, levatrici, spanditrici, cilindrine, botteghine, teline, contatrici, questi erano i nomi assegnati agli operai, uomini e donne, che si occupavano delle varie fasi della lavorazione della carta. Negli anni successivi al ‘46 in poi, quando la fabbrica cominciò a produrre la carta moneta, il lavoro delle contatrici era di grande responsabilità, per il valore intrinseco della carta adoperata. La signora Vera, era impiegata sia nella scelta della carta (botteghina) che come contatrice.
Oltre a queste attività, per cui la Svizzera Pesciatina era riconosciuta ed apprezzata fuori dalla Toscana, vi erano altri mestieri propri delle zone rurali della montagna. I mestieri che si potevano incontrare nelle singole “Castella”, erano indissolubilmente anche legati alla cultura contadina locale, soprattutto alla necessità di sopravvivenza delle singole famiglie: i cestai, i corbellai e altri, attività artigiane, da sempre complementari al lavoro principale dei contadini. Ad esempio a Medi-cina, erano presenti artigiani che si tramandavano di padre in figlio il sapere di potare gli olivi e che erano molto richiesti in altre località, al di fuori della valle, come in Maremma. Per questo motivo fonti locali avevano soprannominato questa “Castella” “il paese dei potini”.
Altra attività importante sui monti del territorio, dove venivano fatti nelle carbonaie loca-li quintali e quintali di carbone, era quella del carbonaio, lavoro esistito qui da sempre, ma dalla massima espansione a partire dalla metà del ‘700 fino alla metà del ‘900. L’abilità di un carbonaio si misurava dalla grandezza dai pezzi di carbone estratti dalla carbonaia. Le carbonaie venivano fatte direttamente nella parte più pianeggiante dei boschi. Il procedimento per ottenere il carbone era simile a quello seguito in altri luoghi della Toscana.
Noti erano anche i vecchi corbellai che producevano con i bacchi (sottili strisce di legno di castagno) corbelli, panieri e cesti che servivano per il trasporto dei prodotti raccolti. Dalle testi-monianze raccolte, i bacchi venivano anche prodotti per essere venduti nella provincia di Pisa, in particolare a Buti.

94
La Svizzera Pesciatina
Gli abitanti delle “Castella” davano, inoltre, in maniera particolare, rilievo alla cura riservata ai boschi: il taglio della legna era un’attività molto diffusa, e, intervistando alcu-ni anziani abitanti di Vellano, è emerso che venivano tagliati specialmente pini e ontani. La legna di pino veniva anche portata con il barroccio, fino al 1950, a Calamari a Sant’ Ilario. Gli Ontani servivano, oltre che a fare la legna, anche per fare il ceppo degli zocco-li che, fino agli anni ‘50, era un tipo di calzatura molto usata. Ma una cura particolare era riservata ai castagneti che erano, già dal Medioevo, la loro più grande fonte di sostenta-mento. Il castagno da frutto era una delle piante più diffuse della zona, e rivestiva quasi la metà dell’estensione del bosco; la sua cultura era di importanza vitale per queste mon-tagne, dal castagno si ricavava la legna da ardere e da vendere e, principalmente, il suo frutto, la castagna, che è stata per secoli la base dell’alimentazione di queste popolazioni. Ogni giovane o vecchio si impegnava nella raccolta, così per un mese, nella stagione autunnale, i paesi si svuotavano e le “selvi”, invece, erano piene di persone indaffarate. La raccolta si svolgeva con la massima velocità per evitare che le castagne si potessero gelare. Tutto si concludeva in 30/40 giorni. L’utilizzo di questo frutto era molteplice, la maggior parte veniva essiccato nei caratteristici “metati” (strutture in pietra a due piani dove si essiccavano a fuoco lento le castagne), poi venivano ridotte in farina nei mulini della zona, per ottenere così la “farina dolce”, oppure venivano utilizzate freschi per fare “ballotti” (castagne lessate in acqua), o arrostite per avere le “frugiate”. I metati erano presenti in tutti i paesi ma dalle testimonianze pervenute risulta che ad Aramo vi era una maggiore concentrazione. La farina dolce era utilizzata principalmente per la preparazi-one dei “necci”: tipiche di focacce ottenute disponendo un impasto di farina ed acqua tra due piastre (i testi), riscaldate nella brace. Fra l’impasto e la piastra venivano inserite delle foglie di castagno, prima seccate e poi bagnate in modo che il neccio non si bru-ciasse. Con la farina si preparano anche la polenta neccia, la farinata neccia, le frittelle, il castagnaccio, ecc. Gli abitanti si dedicavano anche alla raccolta di funghi, la zona era ricca di molte specie di funghi, tra cui i preziosi porcini. Allora i funghi si raccoglievano per bisogno e venivano venduti ai barrocciai o si portavano a spalla al mercato a Pescia o a Montecatini.
Altra produzione di vitale importanza per gli abitanti era l’olio d’oliva. La coltura dell’olivo ha radici antichissime, l’olio era anche moneta pregiata e si usava “barattarlo” con la farina di grano, di granturco o con la farina neccia. E’ storia, non molto antica, che i commercianti lucchesi attingevano dagli olivicoltori della zona una parte dell’olio che gli stessi destinavano all’esportazione nell’America del Nord.

95
La Svizzera Pesciatina
Ma la coltura più conosciuta in tutto il mondo era ed è quella del fagiolo bianco di Sorana, un cannellino particolare, piccolo e dalla buccia sottilissima, dalla forma schiacciata e quasi piatta. E’ importante iniziare a parlare del fagiolo di Sorana citando il canonico don Gildo Nucci, il quale a proposito ci dice:“Sorana è famosa per i fagioli che si coltivano nel fiume sottostante” e prosegue “i fagioli di Sorana sono di rinomanza mondiale”, poi, ancora ci fa sapere che Edmondo De Amicis ricorda di averli veduti in mostra in un negozio di Costantinopoli con il cartellino “fagiuoli di Sorana”. Don Gildo insiste sui fagioli di Sorana citando lo scrittore D.E. Frati di Pistoia del quale riporta il seguente aneddoto: “Gioacchino Rossini a Montecatini aveva anche come amico il ma-estro Andrea Nardi di Pescia e allo sua richiesta di correggergli delle partiture rispose che, avrebbe provveduto alla loro correzione, a patto però, che ogni anno al tempo della raccolta, gli fossero spediti alcuni chilogrammi di fagioli bianchi di Sorana”. La coltivazione di questo fagiolo è limitata a piccole superfici di terreno al margine del torrente Pescia, dal Ponte di Sorana al Ponte di Castelvecchio, ma anche lungo l’altro ramo del torrente fino al mulino di Stiappa. Circa la varietà del fagiolo di Sorana, in loco viene fatta una precisazione, distinguendo quello coltivato in “ghiaretto” (cioè su terreno di natura alluvionale, che si trova lungo il margine del fiume) da quello colti-vato, invece, in “poggio” o “vigna”. Il fagiolo di Sorana – quello vero – deve provenire da coltivazioni fatte in “ghiaretto”. La bontà di questo fagiolo deriva soprattutto dalle condizioni ambientali di coltivazione, infatti, come già detto, oltre la natura del terreno sono molto importanti anche l’irrigazione, con acqua locale, e le abbondanti “guazze” estive. Il baccello è piuttosto piccolo e alla maturazione assume il colore bianco crema, i semi, di solito quattro o cinque a baccello, a maturazione sono di un bianco latte; il suo ciclo di maturazione può essere contenuto in 130-140 giorni. Dal punto di vista organolettico il pregio di questo fagiolo deriva dall’avere una buccia sottilissima, la quale dopo la cottura, rimane impercettibile e si confonde con la pasta del fagiolo stesso. Questa particolarità e molto piacevole per il palato, e lo rende inoltre molto più digeribile rispetto a quelli di ogni altra provenienza. Comunque cucinati sono sempre ottimi, ma il sapore viene maggiormente evidenziato se lessati e conditi con olio extravergine di oliva della zona. E’ consigliato usare per la cottura una pentola di coccio o meglio, un’apposito
recipiente di vetro a forma di fiasco a bocca larga, conosciuto a Pescia con il nome di “gozzo”. Tutte queste peculiarità e unicità hanno permesso al fagiolo di Sorana di avere il riconoscimento al marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta). Questo marchio è un marchio di qualità che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali le caratteristiche e la reputazione dipendono dall’origine geografica specifica, e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avviene anch’essa nella stessa area geogra-fica. Oltre a tutelare il produttore garantisce anche il consumatore, che, con l’acquisto del fagiolo di Sorana, avrà la certezza della sua provenienza, del controllo di tutte le fasi di produzione, di confezionamento e distribuzione.
BIBLIOGRAFIA
E. LEMMI e G. SPINELLI, “Pescia fra tradizione e sviluppo”, 1993, Verasas editore
P. BIAGINI, “Il duro Pane”, 2008, Tipografia GF Press, Pistoia
P. BIAGINI, “Vellanesi di Vellano o giù di lì: arti e mestieri”, 2004, La Tipografia Pesciatina
P. BIAGINI, “Valleriana e Alta val di Forfora 18 itinerari storico-naturalistici a misura d’uomo”, La Tipografia Pesciatina
D. BARTOLONI , L. BURALLI , E. CIUTI, “I prodotti tipici della terra di Valdinievole”, 2007, Stampa nova Zincografica Fiorentina
L. GUADAGNUCCI, “Culture e paesaggi. Storia sociale della Svizzera Pesciatina”, 1994, Liguori editore
Si ringrazia per la collaborazione la popolazione locale che tramite le interviste ha saputo dare un con-tributo notevole allo sviluppo della scheda.
In particolare:Mariani Vera, Niccolai Germano, Dora Natali, Nellina Mariani, Nardini Germano, Mauro Agostini
Musei degli antichi mestieri presenti sul territorio della svizzera Pesciatina:Museo della civiltà contadina, San Quirico. Tel. 0572/400222Museo di minerali “La miniera di Publio”, Vellano. Tel. 0572/405448Museo della Carta, Pietrabuona. Tel 0572/408020