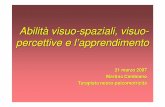Abilit
-
Upload
xhenibarolli -
Category
Entertainment & Humor
-
view
1.060 -
download
0
description
Transcript of Abilit

Modulo 3 Ascoltare, parlare, leggere, scrivere
MODULO 3 lo fra ASCOLTARE, PARLARE,
LEGGERE, SCRIVERE
ASCOLTARE Fer ottenere una comunicazione chiara ed efficace servendosi del codice
.mgrristico è necessario conoscere sia il lessico della lingua sia le norme che cgolano i rapporti tra le parole . . Ilomo apprende il codice linguIstico per: I imitazione , riguarda i bambini fino a 4 anni cIrca; il bambino impara la
lingua da chi parla e stabilisce una comuIllcazione con lui. apprendimento , presuppone un insegnamento, infatti riguarda i primi anni di scolarità quando, ormaI, a 6 anni, il bambino ha perso la precedente modalità.
I addestramento, comporta un esercizio consapevole per il raggiungimento di un fine; è presente nei ragazzi di 12 anni circa.
Le abilità specifiche che egli acquisisce sono relative all' ascolto, al parlato, :Jla lettura e alla scrittura. rd. Acquisire il codice linguistico significa, quindi, sap e r ascoltare , p arlare, leggere, scrivere .
I Ascoltare e leggere sono abilità, di tipo fruitivo , che riguardano il testo orale: chi ascolta o legge si impegna a deCIfrare e recepire un messagglO nelle sue modalità e nei SUOI contenuti. Parlare e scrive re sono abilità, di tipo produttivo , che interessano il testo scritto chi parla o scrive si impegna a formulare un messaggio con modalità adeguate e contenuti ben organizzati .
ella comunicazione tutte queste abilità si intrecciano continuamente, anche se ciascuna si serve di proprie strategie.

Ascoltare è un'abilità che non va confusa con il sentire sebbene entrambe siano presenti naturalmente nell'uomo. Si potrebbe dire che gli esseri umani "sentono" molte cose ma ne ascoltano poche, questo perché mentre il sentire dipende soltanto dalla funzionalità dei nostri organi e la nostra mente può concedersi di concentrarsi su altre cose; l'ascoltare invece è un processo mentale più complesso. Ascoltare è lilla tecnica che, in quanto tale, può essere imparata e perfezionata.
Si può ascoltare per scopi e con motivazioni diverse: per avere informazioni, per ricevere istruzioni, per conoscere e studiare, per divertimento .. . Essere motivati all'ascolto e conoscere lo scopo per cui ascoltiamo sono condizioni che suscitano interesse per il messaggio e attenzione durante l'ascolto. Saper ascoltare è quindi importante per realizzare lo scopo per cui ascoltiamo; a maggior ragione è importante saper ascoltare a scuola dove l'obiettivo primario è l'apprendimento.
LA LINGUA A SCUOLA
Saper ascoltare è lill'abilità complessa che a scuola si rivela ancora più difficoltosa perché l'atto comW1icativo, che viene messo in gioco in tale contesto, è di varia natura ed il ruolo dell'emittente e del ricevente deve essere necessariamente chiaro sia nella produzione (=
parlato) che nella ricezione (= ascolto) del messaggio Centrale risulta essere la competenza dell 'uso della lingua da parte di chi, come l'insegnante, usa il codice linguistico per comW1icare ma analoga deve essere la capacità di ascolto di chi, come lo studente, risulta essere l'obiettivo dell'ascolto. Saper ascoltare a scuola è riuscire a comprendere il messaggio,
sia rispetto al codice utilizzato sia relativamente ai contenuti espressi. Per lilla miglior comprensione è di aiuto riconoscere ciò che chi parla vuole esprimere anche attraverso l'intonazione della voce. Diverso è il tono di chi vuole informare o porre lilla domanda e di chi esprime stupore, delusione, inquietudine ... Il tono della voce, infatti, è di completamento al contenuto del messaggio perché aggilillge al testo orale informazioni non esplicite.
Poiché a scuola l'ascolto si effettua sempre nei confronti di lill messaggio trasmesso oralmente, si capisce bene l'importanza della memoria: nell'ambito di lill discorso le informazioni si susseguono in modo concatenato senza lasciare spazio a pause di riflessione; inoltre si deve tener conto del fatto che non sempre il messaggio può essere riascoltato. È importante durante l'ascolto cogliere i singoli elementi presenti nella
comlillicazione di chi parla e saperli ricomporre e ricondurre al contesto: si tratta, quindi, di saper comprendere nel senso più completo del termine, affinché lo scopo di chi parla e lo scopo per cui si ascolta siano realizzati.
t OLTA OEU' ASCOlT
omprendere testi e mE te le perché il suo fine è
Tali difficoltà possono
da chi parla, perché l
promette, quindi, la co
no poco interesse per
da chi ascolta, che è
nei confronti della COl
ressato, accade facili
addirittura che venga La stessa caratteristica P nascoltato , come già al per cui la comprensionE Per un ascolto att§.nto è
S5 -re di disturbo alla ( li'attenzione, poi, è pIO'
quando prevediamo ChE seoUiamo con uno sco
Ha capacità di ascoltI gere uno scopo, chi sa anche con domande va successivamente ricorl
TRATEGIE PER L'AS(i
Vi sono strategie che quando ascoltiamo aVE
scere o imparare.
Prima di ascoltare è Conosce re lo sCC
ascolto. In talune informazioni sulla competenza sull'; ascolta consente quali si è maggio Conoscere l'arg che già si sa sull' lare ipotesi su d una comprensio
Durante l'ascolto
taluni aspetti quali prestare attenz ta di seguire att parla né agli al:

Modulo 3 a Ascoltare, parlare, leggere, scrivere
LE D1FF1COlTADELL'ASCOLTO
Comprendere testi e messaggi orali, in un contesto finalizzato, e la scuola è tale perché il suo fine è l'apprendimento degli allievi, è spesso difficoltoso.Tali difficoltà possono dipendere da fattori diversi
da chi parla, perché la forma del messaggio orale non è chiara e com
promette , quindi , la comprensione oppure tratta argomenti che presenta
no poco interesse per chi ascolta da chi ascolta, che è incapace di assumere un atteggiamento corretto
nei confronti della comunicazione; se l'ascoltatore è stanco o poco inte
ressato, accade facilmente che si perdano informazioni importanti o
addirittura che venga equivocato il significato di alcuni enunciati. La stessa caratteristica principale del testo orale, cioè che non può essere riascoltato , come già abbiamo avuto modo di precisare, è uno dei motivi per cui la comprensione può risultare difficile. Per un ascolto att§..nto è necessario eliminare gli elementi che potrebbero essere di disturbo alla comunicazione (rumori, musica, voci ecc.); rispetto all'attenzione, poi, è provato che prestiamo attenzione reale e completa solo quando prevediamo che il messaggio possa essere significativo e quindi lo ascoìtiamo con uno scopo preciso.
Ha capacità di ascolto colui che ha l'intenzione di ascoltare per raggiungere uno scopo, chi sa prestare un ascolto attento e attivo , partecipando anche con domande volte a una maggiore comprensione, chi comprende e successivamente ricorda il messaggio .
li STRATEGIE PER l'ASCOLTO
Vi sono strategie che facilitano l'ascolto e lo rendono proficuo, soprattutto quando ascoltiamo avendo come scopo la possibilità o la necessità di conoSC<lle o imparare.
:.Irir1a di ascoltare è utile prepararsi attuando alcuni accorgimenti. Conoscere lo scopo di chi parla determina anche l'atteggiamento di ascolto. In talune occasioni, potrebbe essere utile anche avere delle illformazioni sulla persona che parla per avere chiaro il suo livello di competenza sull'argomento trattato. Avere chiaro lo scopo per cui si ascolta consente di prestare maggiore attenzione agli argomenti per i quali si è maggiormente motivati. Conoscere l'argomento della comunicazione richiama alla mente ciò chegià si sa sull'argomento o permette ?i informarsi, consente di formulare ipotesi su ciò che verrà detto e preparare domande finalizzate ad unacomprensione più completa .
Durante l'ascolto è necessario attivare l'attenzione soprattutto rispetto a "cri aspetti quali :
prestare attenzione mantenendo un atteggiamento corretto che consen'3 di seguire attivamente l' argomentazione senza creare disturbo né a chi Darla né agli altri ascoltatori.
...... 'B '·"2~
83

,
~~~~~ La relazione è l'es!• ce rcare di individuare la tipologia di testo e perciò la funzio-
di/conseguenza ... )_
ne che prevale. • saper selezionare le informazioni principali distinguendole
dalle secondarie e riconoscere le informazioni oggettive distinguendole dalle opinioni personali di chi parla.
• prendere appunti per 00 eventuale utilizzo successivo delle informazioni ascoltate.
Dopo aver ascoltato è bene cercare le relazioni logiche fra i concetti più importanti mediante oo'opportooa riflessione e rileggere e rielaborare gli appooti, eventualmente riscrivendoli in ooa forma più estesa. Sarà naturale riflettere su ciò che abbiamo ascoltato per verificare la comprensione dei contenuti ed, eventualmente, per rivolgere domande allo scopo di chiarire eventuali dubbi, ma anche per valutare quanto ciò che abbiamo ascoltato ci è stato utile o ci ha arricchiti.
L'lNTERDISCIPlINARIETÀ DELLA LINGUA
Nella scuola il codice linguistico è lo strumento attraverso il quale vengono elaborati e trasmessi i contenuti delle diverse discipline. Molto spesso le difficoltà e gli insuccessi scolastici nelle diverse discipline derivano proprio da carenze linguistiche che vanno riconosciute e "recuperate". In questo consiste il carattere di trasversalità della lingua: la lingua attraversa il curricolo per tutta la durata degli studi e tutti gli insegnanti sono dooque, almeno nell'ambito delle proprie competenze disciplinari, anche insegnanti di lingua. In quest'ottica particolare rilevanza assumono i testi destinati all'ascolto che hanno nella lingua il loro elemento vitale
In teoria qualsiasi testo può essere riferito e quindi ascoltato, ma nella scuola esistono testi prodotti per essere ascoltati, indipendentemente dallo specifico delle singole discipline o dall 'argomento trattato. Tali testi sono:
• la lezione • la relazione • la conferenza
La lezione è 00 testo espositivo con lo scopo di informare. Il parlante è solitamente 00 insegnante, che si rivolge ad ascoltatori, i quali si pongono in ooa situazione comunicativa intenzionale, con lo scopo di ascoltare e quindi di conoscere le argomentazioni oggetto di studio. Sovente chi ascolta prende appooti. La lezione è tipica della scuola, può riguardare qualsiasi materia e avere per oggetto qualsiasi argomento; prevede la possibilità di riprendere l'argomento più volte e in momenti successivi.
PRENDERE APPUNTI
Prendere appunti da testi orali sig nill'c fissare i concetti più importanti ~ .
scopo di ricordarli e rielaborarli . Prendere appunti permette di raggiur gere altri obiettivi ugualmente impor tanti: "mantenere l'attenzione e la concer.
trazione su ciò che si sta ascoltando; .. ricordare le informazioni ascoltate; "verificare la completezza del disccr\0
rispetto alle preconoscenze e alL aspettative, relativamente allo scop; dell'ascolto;
• confrontare in un momento succeSSivo le informazioni con ahre fonti .
Per prendere appunti efficacemente 5
possono utilizzare alcune strategie: • annotare l'argomento, la fonte, i
luogo, la data; • selezionare le informazioni più impor
tanti; • scrivere in modo completo le defini'
zioni; . trascrivere gli schemi; . segnalare con segni grafici i collega
menti logici o cronologici per evitare nella rilettura o nell' utilizzo degli appunti di non avere chiari i collegamenti indispensabili per la comprensione;
.segnare con un segno grafico parole o concetti oscuri allo scopo di chiarirli successivamente;
• numerare i contenuti in ordine progressivo tutte le volte in cui si effettua un cambio di argomento.
Per una scrittura più veloce si possono: • utilizzare parole che sintetizzano frasi; • eliminare articoli e preposizioni; . utilizzare abbreviazioni e segni grafici
(+ più, - meno, X per, xché perché, qlc qualcuno/qualcosa, qs questo, cap capitolo, pag pagina, < maggiore, > minore; = uguale, *- diversa, dubbio/ipotesi, I importante, + quin
ad un argomento be La confe renza, cor
mare; solitamente la pleto ed esauriente in momenti success
A que sti si agglw
scolto , che implica ascolta , ma che en gendo con 000 sca • la conversazioni
la discussione il dibattito
La conversazionE ne lo scambio dei momento success delle conversaziol tempo scuola e il (
La discussione argomenti possO! scopo della discu
Il dibattito è une moderatore, e il c Nel dibattito i var no alternativamel in modo che tutti
La lingua dei t comunicativa, dE
pone di ragglUD
Vi sono discorsi che non vengon
il registro usato
cussioni Altri discorsi, u dentemente, uti delle regole: il conferenze, ne: N ei discorsi ir
guaggio è più fatto che i testi caso di ooa co caso di trasmi

,
PARLARE Saper parlare e saper ascoltare sono abilità che consentono di realizzare
la comunicazione; come ben sappiamo, la comurucazione non avviene soltanto attraverso la lingua, ma certamente essa è il principale strumento con cui comunichiamo. Parliamo in ogro momento della vita quotidiana per discutere, chiacchierare, descrivere, raccontare, esprimere sentimenti e stati d'animo ... Parliamo in situazioru diverse e spesso importanti della vita, situazioni in cui il nostro "parlare" ha uno scopo preciso, è finalizzato al raggiungimento di un obiettivo; parliamo, infatti, in qualità di studenti, di lavoratori, di cittadini .. Parlare è , quindi, indispensabile per entrare in relazione con i propri simili, nella quotidianità come in situazioni particolari, perciò è importante saper parlare . Parlare richiede la presenza di un interlocutore ed è perciò da associare all'ascoltare. Essere un buon parlatore è importante così come essere un buon ascoltatore. In presenza di chi parla e di chi ascolta, cioè di emittente e ricevente, si ha una situazione comunicativa, nella quale la comunicazione di un messaggio awiene attraverso il codice linguistico.
LA COMUNICAZIONE A SCUOLA
La lingua orale presenta caratteristiche diverse dalla lingua scritta e cambia in relazione ai
diversi elementi presenti nella comunicazione orale: lo scopo, l'argomento, l'interlocutore, il suo livello culturale, il ruolo sociale, la collocazione spazio-temporale in cui avviene la comunicazione e gli atteggiamenti reciproci degli interlocutori.
Nel contesto scolastico la comunicazione non è solo un 'fare pratica insieme', ma soprattutto un'interazione creativa per il raggiungimento di un fine comune: la crescita dell'allievo e dell'insegnante.
Saper p arlare sigrufica saper intervenire al mome nto giusto e ne l modo giusto , cioè stimolando l'interesse e quindi l'attenzione, signilica riuscire a farsi capire da chi ascolta e raggiungere lo scopo di trasmettere il messaggio così come era nostra intenzione.
•
TEGIE PER PARUl
In generale gli elemel il parlato in situazioni CI
ficano durante l'attività bisogno di una progetl
l'argomento, che c
sicali; lo scopo, informap ni o precisazioni, d
la propria opiniOnE il contesto al qua registro in funzionE nicativa e dell'intel la capacità di r mantenendo viva desiderio di ascol
In sostanza la proget richiede la messa in
Prima di parlare è o accertarsi di aver intende parlare E
mentarsi sull'argo avere chiaro lo sc
ascolta; conoscere il cc comunicativa; fissare i punti pri scegliere il regi: agli interlocutori stabilire la durat,
Durante l'esposizi mantenere vivo ri coinvolgend possibile;
• verificare la c prontamente a( mantenere l'OI
evitando le cJj\
intercalari, fal!:
• scegliere una ce (è possib espositiva COI
ecc .. ); rispettare i te

Modulo 3 • Ascoltare, parlare, leggere, scri vere c!f,iJ.l:r~
I~ STRATEGIE PER PARLARE
In generale gli elementi che caratterizzano il parlato in situazioni come quelle che si verificano durante l'attività didattica, e che hanno
PER FARSI ASCOLTARE, PER FARSI CAPIRE bisogno di una progettazione, sono:
l'argomento, che determina le scelte les
sicali; lo scopo, informare, chiedere informazioni o precisazioni, dare istruzioni, sostenere la propria opinione... ; il contesto al quale si deve adeguare il registro in funzione della situazione comunicativa e dell'interlocutore; la capacità di motivare l'ascoltatore, mantenendo viva l'attenzione e quindi il desiderio di ascoltare.
In sostanza la progettazione di un intervento richiede la messa in atto di una strategia.
Prima di parlare è opportuno: accertarsi di aver ben chiaro ciò di cui si intende parlare ed, eventualmente, documentarsi sWl'argomento;
• avere chiaro lo scopo e le aspettative di chi ascolta; conoscere il contesto della situazione comunicativa; fissare i punti principali in una scaletta; scegliere il registro linguistico più adatto agli interlocutori; stabilire la durata della propria esposizione
Durante l'esposizione è necessario: mantenere vivo l'interesse degli ascoltatori coinvolgendoli personalmente il più possibile; verificare la comprensione adattandosi prontamente ad ogni variazione; mantenere l'ordine stabilito nella scaletta, evitando le divagazioni, l'eccessivo uso di intercalari, false partenze, ripetizioni ... ; scegliere una sintassi scorrevole e semplice (è possibile migliorare la chiarezza espositiva con l'uso di schemi, illustrazioni
ecc ... ); ,>
rispettare i tempi stabiliti.
Per farsi ascoltare occorre prima di tutto farsi sentire. Una voce troppo flebile esige da parte di colui che ascolta uno sforzo d'attenzione tale che a poco a poco anche l'uditorio più attento finisce per non ascoltare più. Allo stesso modo una voce troppo forte, che provoca forse, all'inizio dell'intervento, un effetto di sorpresa, tale da catturare l'attenzione dei distratti, a lungo andare stanca chi ascolta e risulta fa stidiosa . Occorre, dunque, che questi due aspetti siano ben equilibrati e calibrati, per ottenere un ascolto costante e gradevole, sia che si debba parlare facendo una relazione a un pubblico, sia che si debba affrontare una prova orale, quale un'interrogazione scolastica o un colloquio di lavoro in cui si debba illustrare qualcosa a qualcuno.
Dal punto di vista della comprensione è necessario stare attenti a come si produce e si articola la voce, affinché la parola detta giunga chiara e completa all'orecchio di chi ascolta. Aseconda di come usiamo la voce generiamo stati d'animo diversi nell'interlocutore, tanto che, ad esempio, nel lavoro teatrale si dedica molto tempo a perfezionare dizione e gestione della variabilità fonetica. Per articolare efficacemente la voce occorre incatenare correttamente le sillabe e scandire bene le parole. Non si può comprendere ciò che dice chi farfuglia o ingoia le parole. Una buona articolazione, invece, dona nitidezza alla parola, rendendola inequivocabile. Anche la velocità con cu i ch i parla emette le parole è un' altra caratteristica vocale da tenere sotto controllo. Una parlata lenta, calma conferisce gravità e sicurezza al discorso. Una parlata precipitosa significa agitazione, nervosismo, insicurezza . Tuttavia una parlata troppo regolare nella velocità genera monotonia; megl io variare la velocità insieme al volume, naturalmente in base al contesto e con misura, per stimolare maggiormente l'interesse di chi ascolta ... Occorre imparare anche a dosare adeguatamente le pause e i silenzi. Essi costituiscono delle interruzioni più o meno lunghe del discorso, una specie di punteggiatura orale. ('è la pausa su un punto importante: chi ascolta capisce che si tratta di un punto essenziale; c'è la pausa dopo una domanda, che fa capire all' uditorio che qualcuno deve prendere la parola e rispondere; c'è la pausa in mezzo a una frase, quasi una sospensione del discorso, che fa capire a chi ascolta che è possibile arrivare da so li alla conclusione logica, o che, comunque, induce a domandarsi che cosa stia accadendo. Qualunque discorso non dovrebbe mai avere un andamento piatto e monotono, ma essere un alternarsi ragionato di ri tm i, pause, toni .
87

Le informazioni oggetto della relazione devono essere raggruppate e organizzate in W1a scaletta, ovviamente scritta, che sia di supporto alla memoria e consenta di mantenere la massima chiarezza espositiva possibile. La scaletta può essere molto articolata o molto sintetica, secondo la necessità. L'intera relazione può anche essere scritta, ma occorre evitare di esporla leggendo, perché risulterebbe noiosa. È necessario, perciò, impostare con attenzione il tono della voce, evitare sia la fretta sia le esitazioni e le pause eccessive e, anche se il testo è scritto, deve essere adeguatamente memorizzato. La struttura di W1a relazione deve comprendere tre parti: W1a introduzione con la presentazione dell 'argomento; W1 corpo centrale, suddiviso in varie sezioni in cui si sviluppano i pW1ti in cui l'argomento può essere articolato, W1a conclusione con la ricapitolazione dei concetti fondamentali . Eventuali materiali visivi o audiovisivi, quali diapositive, lucidi per lavagna luminosa, cartelloni o registrazioni sono sicuramente utili e concorrono ad W1a maggiore chiarezza espositiva. Questo materiale, preparato in anticipo dal relatore, aiuta l'ascoltatore a mantenere l'attenzione e a cogliere i concetti fondamentali . È buona abitudine di W1 relatore attento guardare ogni tanto l'orologio per essere certi di mantenersi nel tempo assegnato. Al termine della relazione è OpportW1o accettare W1 dibattito sui contenuti trattati.
L'interrogazione è W1 momento decisivo dell'attività scolastica: rappresenta il mezzo per dimostrare di aver fatto propri i contenuti disciplinari ed è oggetto di valutazione. Con l'interrogazione lo studente dimostra di aver studiato, cioè di aver capito e memorizzato i contenuti e di essere in grado di esporli con chiarezza. Il buon esito di W1'interrogazione dipende da W1a serie di variabili: la conoscenza dei contenuti, la capacità espositiva, la capacità di tenere sotto controllo i fattori emotivi. Per raggiW1gere W1a buona conoscenza dei contenuti è ovviamente indispensabile W10 studio corretto. Affinché lo studio sia efficace deve essere pianificato e distribuito sistematicamente nel tempo in modo adeguato: in W1a prima fase occorrerà leggere con attenzione tutto il materiale necessario, rivedendo anche eventuali appW1ti; occorrerà individuare i concetti fondamentali del contenuto affrontato; seguirà il lavoro di memorizzazione , che potrà avvenire anche con W1a serie di ripetizione ad alta voce. A tale preparazione è bene dedicare il tempo necessario; si eviterà così di concentrare il lavoro in W1 tempo troppo breve prima dell'interrogazione, cosa che comprometterebbe l'assimilazione proficua dei contenuti. È bene tener presente che l'interrogazione è W1a situazione formale, che richiede, pertanto, l'uso di W1a lingua orale assai vicina a quella scritta. Per dimostrare W1a buona capacità espositiva è opportW1o esercitarsi esponendo ad alta voce. Una buona esposizione richiede la conoscenza del lessico specifico e il rispetto delle regole morfosintattiche; è bene evitare ripetizioni e l'abuso di intercalari.
Durante l'interrogazil
evitare inutili divagazic Se la domanda non l
é:ione ampia di un arç idee, quindi esporre c< generale e sviluppanc slbile anche fare rifle
nsposta. L:interrogazione può·
e di ansia, indipenden' scolastica, in quanto il sostenere in pubblico ne di ciò che si conosi
La sicurezza di sé, c ciò che si intende dirE pe rtanto il metodo più preparati, mediante w
Simile all ' interrogaz~
stesso tipo dell'interrc mere lilla valutazione Come l'interrogazioni ne, la capacità di eSf pertinenti e complete
1'- LESSICO SPE
Vi è mai capitato di buon italiano, ".non L
nell comunicazione un suo specifico ling gestuale ecc.). Ogni ( plina utilizzando illin
La prima grossa diff venti o delle interro anche perché ci capi tura contraddittorie! to studiato "con paJ cilscorso con aggett quello di matematic esclusivamente "qUE
non è la monarchia, E hanno ragione tutt BisogrIa pianiflcare ne" ossia è necessa
prestare attenzic menti, allinguag

Modulo 3 • Ascoltare, parlare, leggere, scrivere
Oliante l'interrogazione è indispensabile valutare bene la domanda ed evitare inutili divagazioni, Se la domanda non richiede una risposta breve e specifica, ma l'esposi
zione ampia di un argomento, è bene prima raccogliere mentalmente le idee, quindi esporre con chiare zza inquac:lrando prima l'argomento in modo
generale e sviluppandolo successivamente nei suoi punti essenziali; è possibile anche fare riflessioni ad alta voce sull'argomento per arrivare alla risposta,
I.: interrogazione può comportare, per l'interrogato, una situazione di disagio e di ansia, indipendente dalla sua volontà, Non si tratta di un'esperienza solo scolastica, in quanto il problema si ripropone talvolta quando è necessario sostenere in pubblico le proprie ragioni, quando si deve dare dimostrazione di ciò che si conosce e quando si è sottoposti a valutazione, La sicurezza di sé, che deriva dalla consapevolezza della conoscenza di
ciò che si intende dire, aiuta a superare lo stato di ansia di fronte alla prova , pertanto il metodo più sicuro è, evidentemente, quello di essere sempre b en preparati, mediante uno studio serio e costante,
Simile all'interrogazione è l'esame orale, che consiste in un colloquio dello stesso tipo dell 'interrogazione e finalizzato a fornire gli elementi per espri mere una valutazione sul livello di conoscenza posseduto dal candidato, Come l'interrogazione richiede, oltre naturalmente una buona preparazione, la capacità di esporre con chiarezza e correttezza, fornendo risposte pertinenti e complete rispetto alle domande rivolte,
Il LESSICO SPECIFICO
Vi è mai capitato di pensare che i vostri professori, pur parlando tutti in buon italiano, " ,non usano affatto la stessa lingua? La risposta è semplice: nella comunicazione a scuola qualsiasi disciplina si distingue dall' altra per W1 suo specifico linguaggio (naturale-verbale, iconico, formale, artificiale , gestuale ecc,), Ogni docente infatti incomincia a parlare della propria disciplina utilizzando il linguaggio proprio della stessa, La prima grossa difficoltà che a volte incontriamo nel corso dei nostri inte r
venti o delle interrogazioni è rappresentata dalla "gestione" del lessico, anche perché ci capita di ricevere sollecitazioni molto contrastanti e addirittura contraddittorie: se infatti l'insegnante di lettere ci esorta a riferire quanto studiato "con parole proprie", a cercare de i sinomini, ad arricchire il discorso con aggettivi, a badare non solo al senso ma anche alla forma,
quello di matematica, di scienze, di storia e tc" pre tendono che usiamo esclusivamente "quelle " parole (un segmento è un segmento, il principato non è la monarchia, le tappe della storia non sono parti di storia, e così via) , E hanno ragione tutti I Come fare allora?
Bisogna pianificare il proprio discorso e procedere all'inizio p er "imitazione" ossia è necessario: • prestare attenzione all 'insegnante, al suo modo di presentare gli argo
menti, al linguaggiO che usa;
91

' :
,
92
• cercare di cogliere i punti di partenza , la precisione delle definizioni e dei termini;
• chiedere spiegazioni sull 'uso dei termini di cui non si conosce il signi ficato;
• utilizzare gli strumenti specifici per le singole discipline (documenti storici, cartine geografiche, tavole etc ... ).
LEGGERE Leggere significa innanzitutto possedere la tecnica della lettura ossia :
• saper decifrare i segni che compongono le parole e comprenderne il significato;
• cogliere il ritmo dato dalla successione delle parole all'interno delle frasi • sap er leggere la punteggiatura , che attribuisce significato alle proposi
zioni e ai periodi .
Saper leggere invece significa:
• decodificare e comprendere quanto SI legge; • interpretare e valutare criticamente i contenuti esposti in un testo scritto.
SAPER LEGGERE
Oggi, nonostante la presenza di mezzi di comunicazione orali o visivi, la lettura continua ad essere uno strumento indispensabile. Nella nostra vita, infatti, sono innumerevoli le occasioni di le ttura, perciò è indispensabile saper leggere.
Che cosa vuoI dire saper leggere? Questa abilità è più complessa di quanto si pensi, infatti dobbiamo distinguere tra il saper leggere strumentale e saper leggere per raggiungere gli scopi per cui leggiamo. Non sono abilità distinte, in realtà, infatti è facile verificare come la lettura strumentale, eseguita senza scopi precisi e per semplice esercitazione, come solitamente si fa nei primi anni di scolarità, sia legata alla comprensione di ciò che si legge: la lettura risulterà corretta ed eseguita con una buona intonazione se si conosce il significato delle parole e si comprende globalmente il testo. Parimenti, possiamo affermare che l'abilità tecnica di lettura è indispensabile per una buona comprensione. Saper leggere correttamente è importante per capire ciò che si sta leggendo, infatti soffermarsi eccessivamente sulle singole parole o non utilizzare un ritmo di lettura coerente con la presenza dei sintagmi e nel rispetto della punteggiatura compromette la comprensione di un testo.
Saper leggere contempla, due abilità:
• Saper leggere ad alta voce in modo chiaro ed espressivo, con la giusta velocità, vuoI dire leggere correttamente rispettando le pause e la giusta intonazione indicate dalla p unteggiatura.
Saper leggere I
le ttore di sostarE logici d i parole, lettura silenziosa chio abbraccia ( tempo di quanto parole . La lettura di quella ad alta \ tore di sofferma quanto sta legge Sapere come tee rag giungere la fi gana allo stesso l roviario così cor qualche parola c libro di storia da
GLI SCOPI E L
In generale gli sco legg ere per acqt pio quando leggi re una lingua strE
• leggere per rep quando leggiam trodomestico, le r io ferroviario) legg ere per il pii
m o un romanzo (
La lettura per ace funzi one deU'apprE ca, ma riguarda ogr Leggere un testo pE in tutte le sue parti non è operazione fa al durante e al dop
Durante la lettura capire il significato testo; individuare l' distinguendo quelli Dopo la lettura, è l
scopo e il messagg funzione del nostro
Si tratta , dopo aVE

Modulo 3 mAsco ltare, parlare, leggere, scrivere
• Saper legge re mentalmente in modo rapido, richiede al lettore di sostare non sulle singole parole ma su blocchi logici di parole, facendo scorrere gli occhi rapidamente. La lettura silenziosa è più rapida di quella a voce alta, infatti l'occhio abbraccia gruppi di parole a scatti, impiegando meno
LA LETTURA VELOCEtempo di quanto se ne impiegherebbe per articolare le stesse parole. La lettura silenziosa viene utilizzata sicuramente di più di quella ad alta voce, è utile per diversi scopi e permette allet tore di soffermarsi o tornare sulle parole per meglio capire quanto sta leggendo.
• Sapere come leggere un testo rispetto allo scopo permette di raggiungere la finalità per cui leggiamo. Non tutti i testi si leggono allo stesso modo: non leggeremo per intero un orario ferroviario così come non ci limiteremo a leggere i capoversi e qualche parola qua e là di un romanzo o di un paragrafo del libro di storia da studiare.
GLI SCOPI E LE STRATEGIE DI LETIURA
In generale gli scopi della lettura sono • leggere per acquisire e approfondire conoscenze, (ad esem
pio quando leggiamo un testo scolastico o un testo per imparare una lingua straniera ... ) leggere per reperire informazioni o istruzioni (ad esempio quando leggiamo le istruzioni per il funzionamento di un elettrodomestico, le indicazioni e la posolOgia di un farmaco, l'orario ferroviario) leggere per il piacere di leggere (ad esempio quando leggiamo un romanzo o un fumetto).
La lettura per acquisire e approfondire conosce nze , Cioè in funzione dell 'apprendime nto, è quella tipica dell'attività scolastica,ma riguarda ogni altro momento della vita. Leggere un testo per imparare richiede la comprensione d el testo in tutte le sue parti e in modo particolareggiato. C ap ire un testo non è operazione facile, richiede infatti una particolare attenzione al durante e al dop o.
Durante la lettura è necessario comprendere ciò che si legge: capire il significato delle parole, ma anche comprendere l'intero testo: individuare l'argomento trattato e anche i singoli concetti, distinguendo quelli principali dai secondari. Dopo la lettura, è opportuno interpretare il testo mdividuando lo
scopo e il messaggio e valutare criticamente ciò che si è letto in hluzione del nostro scopo di lettore.
Si tratta, dopo aver capito, di interpretarlo, cioè di scoprirne il
L'acquisizione di una tecnica di lettura veloce èoggi un'esigenza sempre più diffusa, tanto che, da molte parti, vengono messi a punto metodi e tecniche di speed reading, che dagli USA si stanno diffondendo in tutti i paesi occidentali . Certo, leggere velocemente costituisce un grande aiuto per chi studia ed un risparmio di tempo per chi deve dedicare, nell'ambito del proprio lavoro, uno spazio alla conoscenza di testi. Lo scopo di queste tecniche è quello di allenare sempre più l'occhio a correre nella pagina, non tanto per seguire la fila delle parole, bensì per percepire gruppi di parole eper localizzare informazioni. Recenti studi hanno dimostrato che l'occhio vede solo quando è fermo, cioè nell'intervallo tra i numerosi e rapidi salti che compie per passare da un gruppo di parole all'altro, di quei segmenti cioè, in cui l'occhio suddivide la riga. Durante la lettura gli occhi sono soggetti a quattro tipi di movimento. Il primo è detto saccadico (dal francese saccade = sbalzo) ed è il salto degli occhi da una parola all'altra, ma per cogliere il messaggio l'occhio deve immobi lizzarsi. Èquesto il secondo momento, la fissazione, che occupa il 90% del tempo complessivo di lettura. Il terzo tipo di movimento è rappresentato dalle regressioni, ossia da salti, ma verso sinistra. Il loro numero diminuisce con l'età: dalle 52 regressioni ogni 100 parole in un bambino di prima elementare si può passare alle 15 degli universitari. L'ultimo movimento è quello che l'occhio compie per andare a capo della nuova riga. Si calcola che il numero di parole che un occhio allenato può leggere in un minuto in condizioni ideali, sia di 800 (conteggiando 5 fissazioni al secondo X 2,7 parole X 60 secondi) .
93

i
,
significato e capirne il messaggio. L'interpretazione richiede di cogliere l'intenzione comW1Ìcativa, perché chi scrive ha sempre uno scopo, più o meno esplicito informare, istruire, convincere .. È importante, quindi , analizzare:
• le scelte linguistiche
• il registro utilizzato
• l'uso di linguaggi settoriali. Anche le scelte di contenuto dipendono dallo scopo per cui si scrive : chi
vuole convincere selezionerà i contenuti più adatti a raggiungere il suo scopo e li esporrà in modo diverso da chi intende , ad esempio, soltanto informare.
Dopo aver letto, capito e interpretato un testo, il lettore è in grado di valutare se ciò che ha letto era chiaro, utile allo scopo per cui lo ha letto, interessante e se ha soddisfatto le sue aspettative con un contributo positivo.
La lettura per reperire informazioni, cioè in funzione dell 'utilizzazione , riguarda tutti i testi della vita quotidiana che possono essere utilizzati in diverse situazioni. In queste circostanze la comprensione puntuale risulta estremamente importante perché una mancata comprensione compromette lo scopo della lettura e le azioni che ne conseguono.
Farmo parte di questi testi tutte le letture destinate all'operatività, che si possono, pertanto, definire letture funzionali: regolamenti, istruzioni, contratti, ricette di cucina, avvisi ...
La lettura p er il piacere di leggere, cioè funzionale all'intrattenimento, ha uno scopo personale, quello di procurare piacere a chi legge, stimolando stati d'animo di vario tipo. Si leggono la storia d 'avventura, l'articolo sportivo, il servizio di moda, il romanzo d'amore, e lo scopo è sempre quello di intrattenere il lettore e soddisfare esigenze interiori. È una lettura che si fa da soli, ma che può stimolare discussioni e commenti
con altri. Non si possono definire le caratteristiche delle letture per questo scopo,
essendo esse di vario genere, in quanto soggette al gradimento del singolo individuo, come gli hobby e qualsiasi altro passatempo.
Rispetto al tipo di testo e al proprio scopo, il lettore sceglie la strategia di lettura più efficiente ed economica. Le strategie possibili, ad uso personale, sono riducibili a tre possibilità: la lettura sele ttiva; la lettura globale; la le ttura approfondita;
La lettura sele ttiva è la lettura veloce, definita anche trasversale , che ha lo scopo di individuare rapidamente le parti che interessano al lettore. Il testo non viene letto interamente , ma lo sguardo corre velocemente e a balzi, soffermandosi poi sulle parti che contengono le informazioni da ricercare. Si applica questo tipo di strategia per consultare, ad esempio, l'orario ferroviario, l'elenco telefonico, le voci enciclopediche, l'indice di un testo, i cataloghi ..
94
Per rendere la cons della le ttura selettiì organizzato il testo duare gli elementi possono essere di La le ttura selettiva ~
testo in cui si supp< tempo leggendo p(
La lettura globale contenuti , allo SCO[
teristiche generali· La comprensione S leggerlo più accu] infatti , è sufficiente La lettura globale mente. In questo tipo di lE eventualmente il s< nuto, l'autore del tE un esperto dell'arç ritengono interesSi orientarsi meglio. Questo tipo di lettL una rile ttura velOCE
La lettura appro modo completo e to s ia di stile. Si tratta di una lett applicare quanto o La lettura approfo: candovi la massirr duale e varia a se' Per una lettura apl dividere in sequer Di ogni sequenza ricerca delle info: s e ntirà anche di r Questo tipo di let lavoro e per il pia
La sottolineatur; Una sottolineaturé margini della pag momento miglior alla comprension,

Modulo 3 u Ascoltare, parlare, leggere, scrivere
Per rendere la consultazione proficua e veloce, nell'applicare la strategia
della lettura selettiva è bene prima tener presente il criterio con cui è organizzato il testo: cronologico, alfabetico, tematico; è utile anche indivi
duare gli elementi grafici e le simbologie presenti. In questo tipo di lettura
possono essere di aiuto vari indicatori, come il capitolo, il paragrafo, i titoli ..
La lettura selettiva si svolge silenziosamente, dapprima fissando le parti del
testo in cui si suppone sia contenuta l'informazione ricercata, in un secondo
tempo leggendo per esteso la parte contenente tale informazione.
La lettura globale è il tipo di lettura usato per avere una idea d'insieme dei
contenuti, allo scopo di conoscere l'essenziale e capire quali sono le carat
teristiche generali di un testo.
La comprensione globale permette di capire se il testo è inte ressante, per
leggerlo più accuratamente in un momento successivo; questa strategia,
infatti, è sufficiente per cogliere il contenuto nel più breve tempo possibile.
La lettura globale si svolge silenziosamente, in modo autonomo e libera
mente.
In questo tipo di lettura è bene utilizzare alCill1i indicatori, quali il titolo ed
eventualmente il sottotitolo, che possono dare indicazioni rispe tto al conte
nuto, l'autore del testo, che può indicare al lettore, ad esempio, se si tratta di
un esperto dell'argomento, l'indice, che permette di scegliere le parti che si
ritengono interessanti, i criteri che riguardano la struttura del testo, utili per
orientarsi meglio.
Questo tipo di lettura viene utilizzato per un primo approccio, ma anche per
una rilettura veloce allo scopo di rivedere materiali già noti.
La lettura approfondita è il tipo di lettura utilizzato per compre ndere in
modo completo e approfondito un testo in tutti i suoi aspetti, sia di contenu
to sia di stile.
Si tratta di ill1a lettura per esteso, che consente di comprende re , imparare,
applicare quanto si impara .
La lettura approfondita si svolge silenziosamente, in modo accurato, dedi
candovi la massima concentrazione; la velocità con cui si procede è indivi
duale e varia a seconda delle difficoltà che il testo presenta.
Per lilla lettura approfondita, se il testo non è brevissimo, è opportuno sud
dividere in sequenze, per approfondire una piccola porzione alla volta.
Di ogni sequenza si individuerà l'argomento centrale, per procedere poi alla
ricerca delle informazioni fondamentali. Questo modo di procedere con
sentirà anche di ricostruire mentalmente e ricordare successivamente.
Questo tipo di lettura viene utilizzato per studiare, ma anche per motivi di
lavoro e per il piacere di leggere.
La sottolineatura è tanto più efficace quanto più è essenziale.
Una sottolineatura ben fatta, specialmente se rafforzata da annotazioni ai
margini della pagina, può essere molto efficace ai fini dell'apprendimento. Il
momento migliore per sottolineare è quello immediatamente succeSS1VO
alla comprensione.
LEGGERE PER APPRENDERE
La lettura approfondita, è la strategia usata dagli studenti allo scopo di apprendere. La caratteristica principale della lettura per l'apprendimento è possedere i contenuti anche dopo la lettura. Affinché ciò avvenga, però, è necessario compiere alcune operazioni, non indispensabili, ma estremamente utili per imparare: selezionare, evidenziare, sottolineare, annotare; sintetizzare, parafrasare, rielaborare i contenuti; rivedere i materiali di studio; memorizzare.
Con una lettura attenta e meditata si individua l'idea centrale, si selezionano le informazioni importanti e quelle secondarie; tutto ciò contribuisce a far apprendere i contenuti" collegandoli con le altre informazioni di cui si è in possesso. Per non correre il rischio di dimenticarsene in breve tempo, è bene evidenziare,sottolineare e prendere appunti per fissare ciò che deve essere ricordato e richiamare altri contenuti o collegamenti logici.
95

:
'
i
Le informazioni sottolineate devono essere in numero ridotto, pertanto si sceglieranno solo pochi concetti significativi. Il problema principale consiste sempre, però, nell'individuare ciò che si deve sottolineare. Letto il testo, lo si suddivide in sequenze, quindi, si sottolinea, in ogni sequenza, il fatto o il concetto più importante, che può essere sintetizzato a lato della pagina, in modo da riprodurre schematicarnente la struttura del testo.
Prendere appunti, invece, significa agire direttamente sul testo selezionando le informazioni fondamentali e sintetizzandole con parole o brevi frasi, rielaborandole e riorganizzandole per facilitare l'apprendimento. Prendere appunti dovrebbe essere una pratica abituale per tutti coloro che si dedicano ad attività di studio. È possibile prendere appunti secondo varie modalità: si possono utilizzare parole chiave, b revi frasi, brevi riassunti, schemi. La principale utilità degli appunti consiste nel fatto che obbligano a ragionare sul testo e, quanto più si riesce a farlo, tanto sicura sarà la preparazione dell'argomento. Poiché gli appunti possono essere rivisti anche a distanza di tempo, è consigliabile evitare di scrivere su fogli volanti.
A questo punto lo studente è riuscito a fare propri i contenuti. Segue la fase della revisione dei materiali a sua disposizione allo scopo di memorizzazione di quanto è stato compreso. Il miglior modo per memorizzare le informazioni è quello di ripeterle. È bene imparare presto a compiere questa operazione, che costituisce parte essenziale dell'attività di studio. È opportuno, infatti, che lo studente impari non solo a rispondere a domande specifiche, ma che sappia relazionare su un argomento, presentandolo in modo completo.
I TESTI DA LEGGERE
Qualunque testo scritto p uò essere letto. In teoria qualsiasi testo può essere scritto e quindi letto, ma esistono testi p ro d otti p er essere letti.
I testi prodotti dall'editoria sono rivolti ad un ampio pubblico : libri d i testo scolastici , enciclopedie, giornali e riviste, romanzi , saggi, testi divulgativi ...
I testi scritti per essere letti hanno sempre uno scopo: comunicare informazioni, narrare, argomentare, esporre , dare istruzioni, convincere, esprimere .. A volte lo scopo di un testo destinato alla lettura è esplicito (pensiamo, ad esempio, ad un articolo di cronaca di un quotidiano il cui scopo è quello d i informare) talvolta è più nascosto (pensiamo, ad esempio, al testo per la pubblicità di un prodotto di bellezza, il cui scopo è quello di convincere).
Quando ci si accinge a leggere un testo, bisogna scegliere la strategia di lettura p iù adatta per raggiungere lo scopo per cui si legge, talvolta si uti lizzano più strategie. Le modalità con cui si legge e la scelta della strategia dipendono dallo scopo del testo e dallo scopo del le ttore.
Testi diversi richied consapevole, quind
Quando si affronta me ad una lettura é
oggettivo o soggett rente e le sue caratt
Quando si leggonc dizi, occorre tener c soggettivi, che es!= assumere un atteg anche non essere 1
mente le parti che tazione o alla valuta
La lettura del testi tica del testo, l'anal ni del problema È individuare nel test gomento, le opinior
Una lettura più ap rettezza degli argc grado d i confrontar do, infine, una prop
LEGC
La pn siano del p(
La lettura di un testo modo lineare, pagina e leggere alcune part Gli ipertesti, invece, ci, cioè per associa zio
Gli ipertesti sono o link, legami basati s Il passagg io da un n Il lettore può così p informazione di suo ' Gli ipertesti possono musicali ( suoni, VOCI
I n q uesto caso si pa~

Modulo 3 iJ Ascoltare, parlare, leggere, scrivere
Testi diversi richiedono strategie specifiche per leggere in modo attento e
consapevole, quindi è utile anche saper individuare la tipologia testuale.
Quando si affronta la lettura di testi che hanno lo scopo di informare, insie
me ad una lettura attenta e approfondita del testo, si stabilirà se il testo è oggettivo o soggettivo, valutandone l'attendibilità, si individueranno il refe
rente e le sue caratteristiche, l'ordine logico che lega i punti più significativi.
Quando si leggono i testi che hanno lo scopo di esprimere emozioni o giu
dizi, occorre tener conto d elle caratteristiche di questi tipi di testo: sono testi
soggettivi, che esprimono i sentimenti dell'autore, pertanto è opportuno
assumere un atteggiamento critico nei confronti d el testo, che potrebbe
anche non essere veritiero ed inoltre è utile prendere in esame separata
mente le parti che contengono informazioni e quelle destinate all'interpre
tazione o alla valutazione.
La lettura dei testi che servono a convincere comporta la valutazione cri
tica del testo, l'analisi del significato del titolo, che spesso chiarisce i termi
ni del problema È indispensabile, per questi tipi di testo, essere in grado
individuare nel testo le parti che lo compongono: la presentazione dell'ar
gomento, le opinioni con le relative argomentazioni, la conclusione.
Una lettura più approfondita permette di verificare la fondatezza e la cor
rettezza degli argomenti e, dopo un'attenta valutazione, il lettore sarà in
grado di confrontare le proprie idee con quelle esposte nel testo, formulan
do, infine, una propria opinione.
LEGGERE UN IPERTESTO MULTIMEDIALE
La produzione di testi per essere letti, siano essi destinati a un ampio pubblico, e quindi prodotti dall'editoria, siano essi personali, in genere implicano l'uso di materiale cartaceo. Oggi, con l'introduzione dell' informatica, del PC, dei supporti magnetici (floppy, CD, DVD), di Internet, sono disponibili nuovi testi, gli ipertesti.
La lettura di un testo scritto e stampato su materiale cartaceo avviene in modo sequenziale, cioè monodirezionale, in modo lineare, pagina dopo pagina, anche se è vero, però, che consultando un libro possiamo, per mezzo dell'indice, scegliere e leggere alcune parti escludendone altre e saltare da una pagina all'altra. Gli ipertesti, invece, hanno una struttura non sequenziale ma reticolare, che offre la possibilità di una lettura per nessi logici, cioè per associazioni mentali, consentendo al lettore un percorso multi direzionale e perciò personale.
Gl i ipertesti sono organizzati in una struttura reticolare per nuclei di informazioni, i nodi, collegati ad altri nodi per mezzo di link, legami basati su nessi logici e che permettono di passare da un nodo ali'altro. Il passaggio da un nodo all'altro attraverso i link avviene cliccando sulle hot words, le parole calde, evidenziate nel testo. Il lettore può così passare da un nodo all' altro, scegliendo un percorso personale e soffermandosi ad approfondire i nu clei di informazione di suo interesse. Gli ipertesti possono contenere, oltre a testi linguistici, anche testi visivi (immagini e fotografie), testi audiovisivi (filmati), testi musicali ( suoni, voci, musiche, canzoni) In questo caso si parla di ipertesti multimedial i.
97

,
tico, per imparare a leggerli, conoscerli, interpretarli . scaletta e art
Dove si reperiscono ipertesti multimediali? Oggi sono a nostra dispos izione numerosissime proposte; si possono acquistare CD o DVD che offrono il sapere proprio attraverso ipertesti multimediali: enciclopedie, vocabo lari, allegati a pubblicazioni di carattere scientifico, geografico, storico e degli argomenti più vari e persino a testi scolastici. È possibile anche accedere agli ipertesti multimediali navigando in Internet, che tutti ormai conoscono e utilizzano eche offre la poss ibili tà di trovare qualunque tipo di informazione; ovviamente, essendo le possibilità di ricerca così ampia, navigare e individuare ciò che real mente serve non sempre è facile.
Leggere un ipertesto è un' attività interessante, quasi giocosa, ma richiede capacità logiche e capacità di va lutare, oltre che saper leggere. Si tratta di navigare tra le informazioni selezionando e approfondendo con coerenza quelle che si ritengono uti li.
Per leggere un ipertesto multimedia le, è opportuno utilizzare una lettura globale se si vuole conoscere complessivamente il contenuto dell'ipertesto, una lettura selettiva se si vogl iono trovare informazioni specifiche, una lettura approfondita se si vuole conoscere a fondo un argomento. Èdi grande utilità soffermarsi sulla schermata di apertura dell'ipertesto per conoscere i contenuti offerti. Si può procedere, poi, individuando il proprio percorso di lettura escegliendo il punto di partenza. Aquesto punto inizia la navigazione attraverso i link e utilizzando le parole calde presenti. Talvolta accade di deviare rispetto al percorso scelto in partenza, o perché la scelta fatta non soddisfa le proprie esigenze, o perché all'interno dell 'ipertesto si scoprono possibilità diverse non intuite in precedenza, ma è necessario fare attenzione a non perdersi, abbandonando il proprio percorso e sprecando tempo.
Se si accede ad un ipertesto per conoscere un certo argomento o apprendere informazioni, durante la navigazione è possibile" prendere appunti": si possono stampare le parti che si ritengono più interessanti o selezionarle e, attraverso le possibilità offerte dal sistema operativo del Pc. renderle disponibili in un momento successivo.
-
"Ut\MIO~"-_c'IIooOl~ ....C(...... ,......
:J:r,11'fiIwJoN.,..,._.,.-... ..... t_..... ---.""" __M~ .... C.....,.,._~•...c-~ =~__ ..~ ......\oYI(__ ......
... ---a ........ .....-.-.l'n... .,..«Ii ....... ~'o .. )e.-....- ... UUIIIIoIIII' ___,,_._........ __ _ ~ .......... u,....~,...,.,.,. M~wo:. _,...,. .. _t-.t~ ,. ___""""""_'1110-.. ~_ )O~~.__ .IIIII_E-_.._...' _ ----.......... .-1(......... _~,...,.~_4~ ... C-XlM:: ........ _................~---._.......,__.. t"'~ .-..-..<w..JWD-'._"'---.. _ ......... _---""-'... 1..-.... ._-
-...... - - :.:.":'::::.~~::.:..~·iII~~_::.:.1IU ~---ò... __ ""'-""''' __'''-M~
.,.~ ...... XO!IocM""'_",,~,.,1II11-.t.""'t_ _ ._._ .... ____ MlIIIwn..... ,.,...
-~ .........-,..........,..oQD.........~..,..~ _.u.,_~ __ __ .--..,....,.. .....-.~. .... .__........_••_~,-QIII.~ÌIOU
• __._-~ •• u ___ ~,....~..'_XJI)II ... ___ ~.-~.1~~.. !'.~..~'!Ur1 ~,~.!~~ ..
"....."..... _ ......o._u_.. --w_~_-,,--"- ..----......___ ........ __._ow ...._ _ ... __..~ .. <t ............_.._-~.
I ' , ~
( EMSF==..
=-......._ - .... - .. _. ~:..r.:.
Testi particolari e particolarmente significativi sono i testi letterari, in cui l'autore, utilizzando modalità espressive diverse, esprime il suo mondo interiore, il suo punto di vista, le sue fantasie .. . fu testi letterari sarà dedicato successivamente ampio spazio allo scopo di
analizzare gli elementi del testo narrativo e le caratteristiche del testo poe
SCRIVEI Saper scrivere è
si trova a dover uti li e non, nelle quali to con chiarezza e Saper scrivere sig
che raggiunga le situazione comUll
I CARATIER
Thtti a scuola imi guistico scritto, mi
tare le regole or
esprimere qualur. retto, comprensib za delle tecniche
LE STRATEGIE PER
La prima strateg lavoro , applicabil di testo. Si può su sione.
La progettazioll • avere cmaro l
sostenere wù
avere cmaro il scopo e al de!
individuare la
scrivere per E
• avere chiaro l organizzati e I prevedere di
nella quale si c ioè la tratta:;> sione, che ha
La stesura deVE
la correttezz morfologiche delle concon tempi verbali preposizioni, la complete2

~~I
.. - ... ... ,.......... ::.:.. e~ ~ _I'-.. :::! ,..
--~,.....- ..-.....,. ~10111_ ~ ...
LnMI'DllI1.f .11.USO ll!ln
-. .-- _.,.....--... /...--~
i EMSF ~-:" •===.::=.:::. ~IMY..~ OWet'..
~~S:' ~.........":.:.:...
Modulo 3 • Ascoltare, parlare, leggere, scrivere .,.".,,0 "':
SCRIVERE Saper scrivere è molto importante, anzi determinante, infatti nella vita ci
,i trova a dover utili~zare questa abilità in differenti circostanze, professiona!l e non, nelle qualI e mdlspensabile essere ID grado dI espnmersl per Iscntlo con chiarezza e competenza linguistica.
Saper scrivere significa saper produrre un testo corretto, coeso e coerente, che raggiunga lo scopo per cui è stato scritto e che sia adeguato alla situazione comunicativa.
I CARATIERI FORMALI DEI DIVERSI TIPI DI TESTO
Thtti a scuola imparano la tecnica della scrittura, acquisiscono il codice linguistico scritto, ma essere un buon scrittore vuoI dire non solo saper rispettare le regole ortografiche, morfologiche e sintattiche, ma anche saper esprimere qualunque contenuto per iscritto in modo chiaro, ordinato, corretto, comprensibile, utilizzando un adeguato metodo di lavoro e padronanza delle tecniche di scrittura.
LE STRATEGIE PER SCRIVERE
La prima strategia che chi scrive deve utilizzare è un adeguato metodo di
lavoro , applicabile in qualunque situazione di scrittura, per qualunque tipo di testo. Si può sintetizzare in tre fasi: la progettazione, la stesura , la revisione.
La proge ttazione richiede di: • avere chiaro lo scopo per cui si scrive: raccontare, esporre, informare,
sostenere un'opinione, convincere .. avere chiaro il destinatario e quindi il registro da utilizzare, adeguato allo scopo e al destinatario; individuare la forma testuale da adottare, coerente con l'esigenza di scrivere per esprimere, per comunicare, per imparare; avere chiaro l'argomento e i contenuti che devono essere selezionati, organizzati e fissati in una scaletta, cioè in un percorso ordinato;
• prevedere di strutturare il testo in tre parti fondamentali: l' introduzione, nella quale si presenta l'argomento, lo svolgimento o corpo centrale, cioè la trattazione completa dell'argomento e dei contenuti, la conclusione, che ha lo scopo di chiudere il testo.
La stesura deve tener presente alcuni aspetti: la correttezza e la coesione, cioè rispetto delle regole ortografiche, morfologiche, sintattiche, uso adeguato della punteggiatura, rispetto delle concordanze, correttezza e concordanza nell'uso dei modi e dei tempi verbali, utilizzo adeguato di connettivi quali congiunzioni, avverbi, preposizioni, avverbi. la completezza, che si può ottenere sviluppando a fondo tutti i punti della scaletta e articolando eventualmente ciascun punto;
~COME
~ STENDERE - UNA SCAlETIA
Le idee devono essere selezio nate, organizzate e poi fissate in una scaletta. Non bisogna lasciarsi vincere dalla tentazione di iniziare a scrivere, di getto e senza una progettazione: difficilmente il risultato sarà soddisfacente. Quale percorso dobbiamo seguire per arrivare alla stesura di una scaletta7
Il primo passo consiste nel raccogliere le idee. Possiamo fare una lista delle idee, cioè elencarle disordinatamente, così come affiorano alla mente, e rileggerle con cura: ciò produrrà di certo l'effetto di farne aggiungere di nuove. In alternativa alla lista, possiamo raccogliere le idee in una mappa, cioè scrivere l'idea centrale, quella più importante, e da questa per associazione formare una catena, quindi ripartire da quella centrale per un'altra catena, e così via. Le idee sono rappresentate graficamente e organizzate in modo che al centro vi sia l'idea centrale, collegate a questa le idee principali, quindi altre idee nate per associazione. Quando abbiamo la ragionevole certezza di aver esaurito le risorse che abbiamo fissato in idee, possiamo riordinarle mettendole in sequenza e organizzare così la nostra scaletta.
nn

I
I
I
'
la coerenza de i conte nuti , che consiste nell'esposizione ordinata secondo illl criterio logico, che varia nei diversi testi (ad esempio l'ordine cronologico nella narrazione) , ma che stabilito nella fase di progettazione deve essere osservato in fase di stesura;
• la coerenza stilistica, che richiede l'utilizzo del registro scelto in base al livello della comilllicazione.
La revisione del testo, che serve a controllarlo e migliorarlo sia rispetto al contenuto sia rispetto alla forma, implica di:
• rileggere il testo; • rileggere singolarmente ogni parte progettata nella scaletta per verifi
care la chiarezza, la completezza e la coerenza del contenuto e la correttezza lessicale, ortografica, morfologica e sintattica della forma, intervenendo, dove si ritiene OpportilllO, per migliorare il testo.
Rispetto all' importantissimo lavoro di revisione è bene lavorare con pazienza, perché illl testo può essere sempre migliorato. È possibile arricchire il testo inserendo nuove parti, riformulare alcillle frasi per ottenere maggiore chiarezza, separare o illlire frasi per rendere il testo più scorrevole, sostituire termini ripetuti o poco efficaci.
Può essere utile consultare illla grigi" a p er l'autocorrezione che facilita la revisione; la sistematicità di questa consuetudine condurrà facilmente ad illla maggiore autonomia che non richiederà più grande sforzo e l'aiuto di supporti.
CONTENUTO Controllare i seguenti aspetti relativi a:
Chiarezza completezza r ispetto alla quantità di considerazioni;
chiarezza nell 'esposizione delle considerazioni;
precisione dei dati;
utilità delle considerazioni;
assenza di ripetizioni.
Completezza presenz dell'introduzione;
pres nza dello svolgimento o corpo centréÙe;
presenza della conclusione.
Coerenza ordine logico nell 'esposizione;
coerenza tra le varie parti ;
chiarezza nei passaggi tra le varie parti .
FORMA Controllare i seguenti aspetti relativi a:
Lessico uso di paro e nel loro reéÙe significato;
coerenza tra l diverse parole;
I iet' e assenza di ripetizioni,
correttezza nell'eventuéÙe uso di termini specifici dei linguaggi settoriéÙi;
uso corretto del linguaggio figurato.
Stile scelta di un registro linguistico adeguato alla situazione comunicativa;
coerenz nell'uso del registro nelle varie parti
Ortografia gra cor
c.'Or cor
Punteggiatura pre ass
pre
Morfologia COI
COI
CO
CO
COI
Sintassi co.
È indispensabile c le strategie per né valutare, argomenta zioni scritte, cioè nE contenere o nelle q Di questi tipi di test tativo-valutativo, arç ne scritta, parlerer Cerchiamo per or, strategie e precIsa!
Narrare significa
• Si possono narI veri di cui ci si
• Si può narrare (narratore estel
• Si può narrare ~ ficiale, che non
D e scrive re signi c andone gli aspett
La descrizione ghi. persone. a Si può descriv astenendosi dc d escrizione di
Per descriverE all 'oggetto del zione. L'esposizione l ai particolari), ecc.), per asse
cc

Modulo 3 • Ascoltare, parlare, leggere, scrivere ~· . I
Ortografia grafia esatta delle parole,
correttezza nell'uso di apostrofo e troncamento;
cor rettezza nell'uso delle maiuscola;
correttezza della divisione in sillabe.
Punte ggiatura presenza di pilllteggiatura adeguata e corretta all 'interno delle frasi, e per scandire le frasi all'interno dei periodi;
assenza di errori quali la presenza di punteggiatura tra le parole di un sintagma, tra soggetto e predicato, tra
predicato e complemento oggetto.
Morfologia correttezza nell 'uso degli articoli;
correttezza nell'uso delle forme: plurali e femminili dei nomi;
correttezza nell'uso dei pronomi;
correttezza nell 'uso delle forme verbali;
correttezza delle concordanze.
Sintassi corretto ordine delle parole all'interno delle frasi e delle frasi all 'interno dei periodi;
coesione tra le frasi all'interno dei periodi con uso corretto di congiunzioni coordinanti e subordinanti;
uso corretto dei modi e dei tempi verbali.
È indispe nsabile conoscere e saper utilizzare le tecniche di scrittura, cioè le strate gie per narrare, descrivere, esporre e informare, interpretare e valutare, argomentare, per usare con competenza la lingua in tutte le produzioni scritte, cioè nelle forme testuali finalizzate ad uno scopo, che possono contenere o nelle quali predominano questi tipi di te sto , Di questi tipi di testo (narrativo, descrittivo, espositivo-informativo, interpretativo-valutativo, argomentativo) e delle strategie da adottare nella produzione scritta , parleremo in modo approfondito nel capitolo dedicato ai testi , Cerchiamo per ora di imparare a riconoscerne le tipologie, definendo le strategie e precisando alcune modalità.
Narrare significa raccontare un fatto che ha uno svolgimento nel tempo, • Si possono narrare fatti veri di cui si è stati protagonisti o testimoni, fatti
veri di cui ci si è documentati, fatti immaginari, verosimili o fantastici . • Si può narrare in prima persona (narratore interno) o in terza persona
(narratore esterno). Si può narrare seguendo un ordine cronolOgiCO dei fatti o un ordine artificiale , che non corrisponde a quello cronolOgiCO.
Descrivere significa presentare con le parole qualcosa o qualcuno, indicandone gli aspetti caratterizzanti
La descrizione può avere come oggetto cose, immagini, ambienti, luoghi, persone, animali. Si può descrivere in modo oggettivo, cioè presentando dati oggettivi e astenendosi da impressioni personali, o soggettivo, cioè privilegiando la descrizione di alcuni aspetti ed inserendo impressioni soggettive,
• Per descrivere occorre procedere con ordine, cioè scegliere, rispetto all'oggetto della descrizione, un criterio logico da seguire nell'esposizione .
• L'esposizione può seguire un ordine gerarchico (da una visione globale ai particolari) , spaziale (dal centro alla periferia, da un'estremità all 'altra ecc.), per associazione (da un'idea che ne richiama un'altra)
101

Esporre significa fornire o riferire informazioni.
• Si possono esporre contenuti di qualunque tipo. • L:esposizione rispetta uno schema che comprende un'in- \;W'''I!I.<::I~''
troduzione, un corpo centrale, una conclusione. LA RI5CRITTURA
Interpretare e valutare significa spiegare il significato di qualcosa ed esprimere una valutazione. • Si possono mterpretare e valutare opere d'arte, opere let
terarie, spettacoli, produzioni musicali, film .. • Questo tipo di testo è organizzato in tre parti, di cui una
parte informativa per presentare, una parte interpretativa per spiegare, una parte valutativa per esprimere un giudizio.
Argomentare significa esporre un'opinione personale e sostenerla con argomentazioni. • Si può argomentare sugli argomenti più vari, ma sempre
sulla base del ragionamento. • Nell'argomentazione sono presenti solitamente questi
punti o alcuni di essi: presentazione del problema, opinione personale (tesi)e argomenti a favore, opinioni contrarie (antitesi) e argomenti a confutazione, conclusione.
Non meno importante dello scrivere è l'abilità di riscrivere, cioè di manipolare un testo uti·
5T
lizzando la modalità della riscrittura. Si tratta della rielaborazione, partendo da un testo scritto, per variarne la forma o il contenuto. Spesso si rielabora variando la forma testuale. Saper riscrivere consente di usare un testo per ottenerne un altro utile al nostro scopo. È una procedura estremamente economica che anche gli adulti usano. Nella scuola la manipolazione di un testo utiliz· zando la modalità di riscrittura è considerata una proficua esercitazione finalizzata alla com· petenza testuale, infatti consente all'allievo di esercitarsi nello scrivere, di affrontare l'attività con il sostegno di un testo da cui partire e di ottenere buoni risultati.
S1
\\1 sintesi ACQUISIRE IL CODICE LINGUISTICO
significa saper
ASCOLTARE LEGGERE PARLARE SCRIVERE
abilità di tipo fruitivo abilità di tipo produttivo

'vereè l'abilità ,re un testo utittura. Ipartendo da un ~a oil contenuto. rorma testuale. >are un testo per ;tro scopo. È u n a ,omica che anche '
di un testo utilizIra è considerata alìzzata alla comente all'allievo di ffrontare l'attività la cui partire e di
/ /
iCRIVERE
Modulo 3 {1 Ascoltare, parlare, leggere, scrivere
ASCOLTARE significa comprendere il MESSAGGIO
attraverso
STRATEGIA TIPO DI TESTO
prima senza con
o conoscere lo scopo di chi parla interlocutore interlocutore
o aver chiaro lo scopo per cui si ascolta la lezione la conversazionedurante la relazione la discussione
• attivare \' attenzione la conferenza il dibattito • selezionare le informazioni • prendere appunti
dopo o riflettere sui contenuti ~ rie laborare i contenuti
PARLARE significa far comprendere il MESSAGGIO
attraverso
STRATEGIA TIPO DI TESTO
prima senza con
o aver chiaro l'argomento interlocutore interlocutore" aver chiaro lo scopo
• conoscere il contesto l'interrogazione la conversazione la relazione la discussione• fissare una scaletta
l'esame orale il dibattito• stabilire la durata dell'intervento o tavola rotonda
durante ç mantenere viva l'attenzione c verificare la comprensione c rispettare l'ordine della scaletta o scegliere una sintassi scorrevole G rispettare i tempi stabi liti
dopo " aprire un dibattito
103

,
l
LEGGERE significa decodificare e comprendere,
interpretare e valutare il TESTO
STRATEGIA SCOPO (leggere per)
lettura selettiva acquisire e approfondire ha lo scopo di individuare rapidamente conoscenze le parti che interessano al lettare reperire lettura globale informazioni ha lo scopo di conoscere il piacerele caratteristiche genera li del testo di leggere lettura approfondita ha lo scopo di comprendere in modo completo e approfondito il testo
SCRIVERE significa produrre un TESTO corretto, coeso e coerente,
adeguato alla situazione comunicativa
STRATEGIA TIPO DI TESTO
progettazione narrativo aver chiaro lo scopo aver chiaro il destinatario e quindi il registro individuare la forma testuale descrittivo aver chiaro l'argomento strutturare il testo (introduzionesvolgimento - conclusione) espositivo
stesura correttezza e coesione interpretativo completezza coerenza dei contenuti
argomentativocoerenza stilistica
revisione rileggere il testo verificare il contenuto verificare la forma
•e erc\~ ASCOLTARE
~ Sottolinei l'ascoltar
una lezione di geograf • le previsioni del tem na di un' ambulanza visi one _ le voci prOVE squadra che eseguiret
2. Elenca ci
~~~ '3 co~let ---........-...---...........-....-~-~
TESTO DA ASCOLTARE
La cronaca di una p2 L'ul timo CD del tuo ( Una conferenza sulla Il telegiornale. Una lezione di mate Una lezione sull'uso Il programma della ~ Le previsioni del terr Una barzelletta raw
.J4 Indica p.,H 6t'
............~.....................- ...............4
Convegno sulle tecn Conferenza sulla diE Dibattito sul valore Trasmissione televis Bollettino del mare. Hit Parade. Cronaca radiofoniCé Liturgia della parol,
5 Accan~ seguen per dive
..-....--~~--............~_..........~ Una lezione di sto Una barzelletta. Le indicazioni per c Le indicazioni per I
Le considerazioni ~
del compito di ma Una lezione di linc Una spiegazione c