26 IL GIORNALE DELL’ARTE Numero 372, febbraio 2017 … · legno di Carlo Lucangeli di fine Set-...
Transcript of 26 IL GIORNALE DELL’ARTE Numero 372, febbraio 2017 … · legno di Carlo Lucangeli di fine Set-...
26 IL GIORNALE DELL’ARTE Numero 372, febbraio 2017
Archeologia
Il «Colosseo» dipinto da Ippolito Caffi nel 1857, Roma, Palazzo Braschi. A destra una fotografia di Paolo Canevari, «Colosso»
Un particolare dell’esterno della necropoli di Murrone nel nord della Sardegna
Roma
Colosseo superstarDa anfiteatro a icona, il monumento si racconta in una mostra
Roma. Il Colosseo, una superstar visitata nel 2016 da 6,4 milioni di persone, si mette in mostra per quasi un anno, dal 23 febbraio al 7 gennaio 2018 (catalogo Electa), in entrambe le gallerie del II ordine, ripensando e ampliando l’allesti-mento permanente attuale, coi grandi frammenti architettonici scampati allo spoglio dei secoli, e rimanendo in buona parte oltre i termini della mostra, a chia-rimento del visitatore oggi disorientato tra l’esterno ben conservato e il rudere interno. «Colosseo, storia di un’ico-na» traghetterà il più celebre monu-mento d’Italia nella fase di riordino della riforma Franceschini, che dovrebbe fi-nalmente completarsi con la nascita del Parco archeologico (cfr. articolo in Noti-zie). La mostra racconta per la prima vol-ta la storia bimillenaria dell’anfitea-tro, dalla costruzione intrapresa nel 72 d.C. dall’imperatore Vespasiano all’ul-timo utilizzo per gli spettacoli attestato al 523, dal suo abbandono fino alla fine dell’VIII secolo al suo riuso medievale per abitazioni, orti, stalle e magazzini, fino agli scavi e restauri ottocenteschi, al Fascismo, al suo assurgere a mito e icona dagli anni Cinquanta a oggi. Tre i curatori per una simile impresa, la di-rettrice del monumento Rossella Rea e due esperti come Riccardo Santangeli Valenzani e Serena Romano. Una mo-stra pensata per il Giubileo, poi slittata per la lunga preparazione richiesta, «che vuol essere anche un omaggio ai pontefici, spiega Rea, il cui interesse per il monumento e le attività di restauro, basti pensare ai due grandi speroni realizzati da Stern e Valadier, ha fatto sì che il Colosseo ancora esista». Non
solo spoliazioni da parte dei papi quin-di, come vuole la vulgata, e del resto il riuso dei materiali, specie dopo i terre-moti (terribile quello del 1349, dai cui crolli si attinse almeno fino al ’700), era una tradizione antica: lo stesso Colosseo, semidistrutto da un incendio nel 217, fu restaurato in gran parte col travertino di altri monumenti. Ricoverato da anni nel laboratorio di restauro di Palazzo Al-temps, riemerge il famoso modello in legno di Carlo Lucangeli di fine Set-tecento, esposto aperto per apprezzarne i particolari, che resterà poi definitiva-mente (ne esiste un secondo in sughero a Parigi, del Colosseo «allo stato attua-le»). Per la prima volta sono illustrate le vicende medievali e tardomedievali, con ricostruzioni e reperti rinvenu-ti negli ultimi 30 anni (i primi trovati proprio da Rea nel 1986 in un sottoscala) e di recente, negli scavi con l’Università di Roma Tre: attorno all’antica arena, divenuta piazza, l’anfiteatro si trasfor-mò in un quartiere, come a Lucca e a Venafro, anche se oggi di mura medie-vali ne sopravvive solo una (in un’area chiusa al pubblico) e solo in quanto ri-tenuta antica. La mostra poi si svilup-pa per temi, come la cristianizzazione del Colosseo, con le confraternite, di cui restano gli stemmi incisi sui pilastri di travertino puliti per l’occasione, i pro-getti e la costruzione di chiese interne (Santa Maria della Pietà) o a ridosso (San
Giacomo). Sul piano dell’arena, dov’era un tempo, è stata ricomposta e rimar-rà una delle edicole originali della via crucis, smantellata da Pietro Rosa a fine Ottocento tra furiose polemiche, per via dello sterro dei sotterranei. Un’ampia sezione è dedicata alle ricostruzioni e alla vedutistica tra XVI e XIX secolo (Bellotto, Caffi, van Bloemen, Piranesi ecc.), con tele e carte protette in apposite teche climatizzate, un’altra agli scavi a partire da quelli di Fea del 1805-06 sotto papa Pio VII, poi ancora la botanica, con le specie esotiche portate dagli animali delle venationes, la magia e l’occulto dal Medioevo al Settecento (pare ancora in voga nel web). Il percorso sarà costellato di reperti delle varie epoche rinvenuti in loco, tra cui materiale devozionale inedito, croci da appendere al collo e medagliette votive. Bellissimi i «souve-nir» prestati dai Vaticani, come alcuni portapillole e tabacchiere con vedute miniaturizzate dell’anfiteatro. Si finisce con il Fascismo, che ne fece emblema e fondale per la sua propaganda, opere d’arte del Novecento (Guttuso, Mambor, Canevari ecc.), una scelta di grandi foto-grafi (Parr, Capa) e scene di film proietta-te sulla volta dell’ambulacro. Intanto a febbraio, grazie ai finanziamenti di Del-la Valle, dovrebbero partire i restauri dei sotterranei e a seguire la costruzione del nuovo Centro Servizi. q Federico Castelli Gattinara
Venezia
Dal disegno al segnoL’evoluzione della scrittura a Palazzo Loredan
Venezia. «Maktub» («è scritto») in arabo, «scripta manent» in latino. Nel poema epico sumerico Enmerkar e il Signore di Aratta (3200 a.C.), troviamo il mito che fonda l’invenzione della scrittu-ra: Enmerkar, mitico sovrano di Uruk, inviava al suo avversario, il Signore di Aratta, messaggi tramite un araldo, che li memorizzava e li ripeteva a voce. Com-plicandosi la situazione e dimostratosi l’araldo incapace di tenere a mente un complesso discorso, «il messaggero aveva la lingua pesante», il re, per far passare la comunicazione, impasta l’argilla in for-ma di tavoletta e con un chiodo vi incide parole. Il Signore di Aratta, scrutando la parola scritta, commenta: «la parola detta ha forma di chiodo. La sua struttura trafigge».Non ci potrebbe essere luogo più conge-niale dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti di Venezia per ospitare «Prima dell’alfabeto» (fino al 25 apri-le), mostra promossa dalla Fondazione intitolata a Giancarlo Ligabue (1931-2015), curata da Frederick Mario Fales (Università degli Studi di Udine), coadiu-vato da Roswitha Del Fabbro (catalogo Giunti a cura di Adriano Favaro). Im-prenditore, archeologo e paleontologo, con più di 130 spedizioni scientifiche nel mondo, Ligabue, che dell’Istituto Vene-to è stato socio, mette insieme una colle-zione fondata sulla ricerca e sul desiderio di preservare la memoria di civiltà scom-parse e di luoghi che oggi sono teatro di guerra e distruzione. Il suo «archivio mesopotamico» di tavolette d’argilla e di sigilli cilindrici incisi, documen-ti di terra e di pietre semipreziose, è presentato nel Palazzo Loredan, nella
biblioteca dell’Istituto Veneto, fulcro di studi e diffusione del sapere dal 1810, e narra, attraverso reperti che coprono un arco temporale di circa sei millenni, l’avventura rivoluzionaria della scrit-tura che traghetta l’umanità dalla Preistoria alla Storia. Unendo passato e presente mediante l’utilizzo di apparati interattivi, la mostra tira fuori l’antichità dalle polverose teche e fa rivivere (ingran-diti) tavolette delle dimensioni di uno smartphone e sigilli non più grandi di un pollice. Attraverso oggetti rari e affasci-nanti, quale la tavoletta incisa con la sua busta di terracotta, si segue l’evoluzione della scrittura mesopotamica dal dise-gno al segno, dal pittogramma, che rap-presenta un soggetto in forma stilizzata, agli ideogrammi a forma di chiodo uni-formati nei segni-simbolo della scrittura, detta cuneiforme, utilizzata per 3.500 an-ni. Realizzati da abili sfragisti, i sigilli, la cui originaria funzione era quella di vidi-mare un documento, riportando nome e professione del proprietario, divengono ornamenti, amuleti, status symbol. La lo-ro superficie curva si anima di intagli con figure vegetali e animali, scene di lotta o di vita quotidiana, e racconti mitologici. Le tavolette d’argilla incise dallo scriba e poi cotte o fatte essiccare, nate come strumenti di contabilità, riproducono li-ste, resoconti, contratti. Arricchiscono la mostra reperti come il bassorilievo as-siro raffigurante Sargon II, prestato dal Museo di Antichità di Torino, e alcuni oggetti della raccolta di Austen Henry Layard, scopritore di Ninive, e da questi donati al Museo Archeologico di Venezia. q Myriam Zerbi
Sassari
La foresta pietrificataNel nord dell’isola decine di tombe scavate nella roccia
Perfugas (Ss). Nuove tombe ipogeiche del IV millennio a.C. scavate nella roc-cia, sono state scoperte tra 2014 e 2016 nella zona dell’Anglona a nord dell’iso-la. L’ultima, intatta, è riemersa lo scor-so ottobre nel corso degli scavi diretti da Nadia Canu della Soprintendenza Archeologia di Sassari, Olbia, Tempio e Nuoro. L’interno, scolpito nella pietra con travature al soffitto che imitano quelle di un’abitazione, conteneva le os-sa di almeno sei defunti. Sono in corso le analisi al radiocarbonio per stabilire l’epoca della sepoltura. La necropoli di Murrone si trova fra i tronchi fossili di una spettacolare «Foresta pietrificata» di circa 20 milioni di anni fa, la più vasta d’Europa: occupa infatti, ben 300 kmq tra i comuni di Perfugas, Laerru, Martis e Chiaramonti. Le guide la segnalano co-me Parco paleobotanico ma in realtà il Parco non esiste. C’era un sistema di pannelli didattici multilingue, sentieri, tettoie di protezione; un progetto di suc-cesso, premiato dal Consiglio d’Europa e
dalla Regione Sardegna. Ora le strutture sono in degrado e la foresta fossile resta abbandonata al saccheggio. Alcuni di quei tronchi dalle forme suggestive so-no esposti nel prezioso Museo di Per-fugas (Sassari) che conserva la memoria del Parco paleobotanico in abbandono. Pochi conoscono il museo, aperto nel 1988, che con oltre mille reperti, tutti scavati nei dodici comuni della zona, racconta la storia dell’uomo da quando è arrivato in Sardegna 400mila anni fa. Tra i materiali, esposta una collezione di rari oggetti trovati nelle Domus de Ja-nas (strutture sepolcrali preistoriche: in tutta la Sardegna ne esistono 3.500), con strumenti in selce del paleolitico, i più antichi rinvenuti nell’isola. q Tina Lepri
A scuola di falsiPadova. Si rivolge ai giovani professionisti dei beni culturali (dottorandi, specializzandi e studenti delle Università italiane e straniere) l’iniziativa organizzata dal Dipartimento dei beni culturali dell’Università degli Studi di Padova dedicata a un tema di grande attualità, la falsificazione in ambito archeologico, che sempre più interessa il mercato dell’arte e il mondo dei musei. Dal 13 al 17 febbraio e in tre sedi differenti (Padova, Vicenza e Venezia), l’International Winter School «Anthropology of forgery. A multidisciplinary approach to the study of archaeological fakes» pone l’attenzione sugli aspetti della falsificazione nell’ambito archeologico attraverso un approccio antropologico, storico, archeometrico e sociale, oltre a sottolinearne gli aspetti legali, conservativi e museali. Il corso, in lingua inglese, prevede due giorni (14 e 16 febbraio) rispettivamente a Vicenza nel Palazzo Leoni Montanari, sede della collezione di ceramica greca di Intesa San Paolo, e a Venezia nel Museo Archeologico. Direzione scientifica dell’iniziativa a cura di Monica Salvadori e Monica Baggio con la collaborazione di Elisa Bernard e Luca Zamparo dell’Università degli Studi di Padova.
Terzo salone a FirenzeFirenze. È sempre più ricco il calendario degli appuntamenti che scandiscono il Salone Internazionale dell’Archeologia «TourismA» giunto quest’anno alla terza edizione presso il Palazzo dei Congressi a Firenze dal 17 al 19 febbraio. Quasi una trentina di incontri, tra convegni e workshop, dedicati all’archeologia in Italia e all’estero, alla tutela e alla valorizzazione e all’utilizzo delle tecnologie per la ricerca e promozione della cultura. Organizzazione a cura di «Archeologia Viva» e Giunti.
La collezione AstaritaNel 1967 e nel 1968, il collezionista Mario Astarita offrì a Paolo VI, attraverso due donazioni, la propria cospicua raccolta di vasi greci, etruschi e italioti. La collezione, confluita nelle raccolte dei Musei Vaticani, venne esposta, a partire dal 1971, nella Sala cosiddetta del Pomarancio nel Museo Gregoriano Etrusco. Le Edizioni Musei Vaticani, dopo aver editato, nel 2002 e nel 2012, due cataloghi della Collezione Astarita, rispettivamente rivolti alla ceramica attica a figure nere, e alla ceramica di produzione non attica (entrambi curati da Mario Iozzo), pubblicano ora il volume La Collezione
Astarita nel Museo Gregoriano Etrusco. Ceramica attica bilingue a figure rosse e vernice nera, a cura di Giulia Rocco, con i contributi di Jasper Gaunt, Mario Iozzo e Aaron J. Paul. Il catalogo scientifico, al termine di un complesso lavoro di ricerca storico-archivistica durato oltre un decennio, è rivolto alla classificazione di 424 vasi e frammenti, di cui ben 239 hanno ora un’attribuzione, per un totale di 160 tra ceramisti, pittori e gruppi. Ciascun reperto è descritto analiticamente e catalogato nel primo dei due volumi che compongono l’opera, mentre nel secondo volume, contenente le tavole, i vasi sono illustrati e, nel caso dei frammenti, rielaborati graficamente. Emerge un repertorio esaustivo, dal ricco apparato critico, con bibliografia aggiornata e notevoli scoperte relative alla ricomposizione di frammenti Astarita con esemplari conservati in altri musei, come nel caso dei frammenti di una kylix del Pittore di Londra D 12 che possono essere associati a esemplari della Collezione Campana del Louvre. q Arianna Antoniutti
La collezione Astarita nel Museo Gregoriano Etrusco. Ceramica attica bilingue a figure rosse e vernice nera, a cura di Giulia Rocco, 556 pp., ill. b/n, Edizioni Musei Vaticani, Città del Vaticano 2016, € 180,00
© C
ourt
esy
Paol
o C
anev
ari G
alle
ria C
hris
tian
Ste
in M
ilano
© R
oma
Cap
itale
, Sov
rinte
nden
za C
apito
lina
ai B
eni C
ultu
rali,
Arc
hivi
o fo
togr
afico
del
Mus
eo d
i Rom
a
Tavoletta in argilla con busta, Provenienza Kanesh paleo-assira (XIX sec. a.C.)
© R
ipro
duzi
one
riser
vata
© R
ipro
duzi
one
riser
vata
© R
ipro
duzi
one
riser
vata

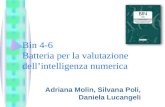


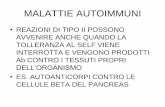

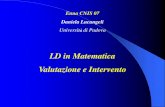


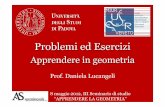





![3,$12 75,(11$/( '(//¶2))(57$ )250$7,9$ 372)...ñ 3,$12 75,(11$/( '(//¶2))(57$ )250$7,9$ ,q rwwhpshudq]d dood /hjjh gho oxjolr lo 372) 3ldqr 7ulhqqdoh ghoo¶2iihuwd](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/60b57bb1021dee34374a504b/312-7511-257-25079-372-312-7511-257.jpg)




