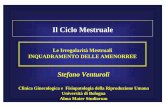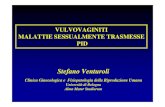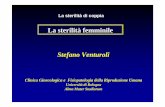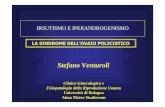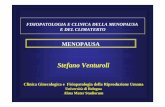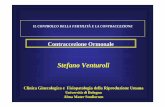115127
-
Upload
stefania-villacidro -
Category
Documents
-
view
222 -
download
0
Transcript of 115127

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 1/194
UNIVERSITÀ
DEGLI
STUDI DI TRIESTE
FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA
Corso di Laurea in Giurisprudenza
Tesi di Laurea in
Diritto amministrativo
LA SICUREZZA DEI LOCALI PUBBLICI
Laureanda
Marilisa Bombi
Relatrice
chiar.ma prof.ssa Giulia Milo
Anno Accademico 2007-2008

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 2/194
Immagine di copertina:
C.
Dell'Acqua Festa da ballo nella Sala
della Borsa,l844, Litografia, Album del Lloyd
Austriaco. Collezione privata. Trieste

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 3/194
~ Q J _ C i J U R I S P R U D E N Z A
Laurea Specialistica
in
Giurisprudenza
J2}
A Lucio
L'unica vera ricchezza è la conoscenza

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 4/194
n

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 5/194
INDICE- SOMMARIO
INTRODUZIONE
l
CAPITOLO PRIMO: IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
SEZIONE
l
IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE:
LA
SALUBRITÀ
.....................
l. Premessa .............................................................................................................. 3
2.
Il r.d.
27luglio
1934,
n.
1265 (testo unico leggi sanitarie) .................................
.4
3.
Le modifiche all'articolo 221 del Tuls ................................................................ 8
4. La semplificazione procedimentale e i contenuti dell'articolo 221 Tuls ............. 9
5. Il regolamento per l'abitabilità .......................................................................... l O
6. La vigenza del primo comma dell'art. 221 Tuls ................................................ 13
SEZIONE 2: IL TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA: L'AGIBILITÀ .............................
l.
Agibilità e abitabilità ......................................................................................... 17
2. La
riforma della pa e la semplificazione amministrativa ..................................
19
3. Il Testo unico per l 'edilizia ............................................................................... 20
4. Il Procedimento per l'agibilità ........................................................................... 24
5. Il comportamento omissivo ............................................................................... 26
6. L'inagibilità ....................................................................................................... 27
SEZIONE 3: IL TESTO UNICO
DI
PuBBLICA SICUREZZA: LA SICUREZZA
.....................
l.
L'agibili tà e la sicurezza ....................................................................................
31
2. L'articolo 80 del tulps e il relativo regolamento ............................................... 32
3. L'articolo 19 del d.p.r. 616
dell977
................................................................. 36
4. L'unitarietà del procedimento ............................................................................ 38
CAPITOLO SECONDO: DECENTRAMENTO, REGOLAMENTAZIONE
E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
l. Premessa ............................................................................................................
41
2. La
Semplificazione amministrativa nella legge 59 del 1997 ............................ .43
3.
Il decreto legislativo
31
marzo 1998,
n.
112
........................................
45
4. Il Nuovo assetto dei rapporti dopo la novella del Titolo V .............................. .47
5. Potere legislativo e potere regolamentare ......................................................... .49
6. Polizia Amministrativa e pubblica sicurezza .................................................... 54
7. Il d.P.R. 616 del1977 ........................................................................................ 56
8. La Potestà normativa prevista dall'art. 19 d.P.R. 616
dell977
........................ 58
9. Norme procedurali e norme sostanziali ............................................................. 60
l O. Regolamentazione e semplificazione .............................................................. 61
11. I Regolamenti di semplificazione e di delegificazione .................................... 65
12. La Potestà regolamentare comunale ................................................................ 69
13.
Il d.P.R. 311
del2001
...................................................................................... 76
14. La Categoria "polizia amministrativa" ............................................................ 79
III

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 6/194
15. Autorizzazioni o licenze? ................................................................................ 80
16. Semplificazione a carattere generale ............................................................... 83
17. Autocertificazione e controlli .......................................................................... 85
18. Commissione Comunale e commissione provinciale ...................................... 88
19.
La
Costituzione economica si consolida ......................................................... 90
CAPITOLO TERZO:
LA
SICUREZZA
DEI
LOCALI
E
LUOGHI
PuBBLICI
l.
Il comportamento penalmente sanzionabile ...................................................... 95
2.
La normativa antincendio .....................................................................
:
............ 99
3. L'articolo 80 Del Tulps ...................................................................................
101
4. La disciplina della materia ...............................................................................
l03
5. Il silenzio assenso per atti discrezionali.. .........................................................
l07
6. La sicurezza ..................................................................................................... 110
7. Il certificato di prevenzione incendi (Cpi) ....................................................... l l4
8. Il CPI e l'agibilità (in senso lato) ..................................................................... ll9
9.
La
regola tecnica: le origini ............................................................................. 120
10. Specifica, norma e regola tecnica .................................................................. 122
11. Il teatro come struttura ...................................................................................
l24
12.
La regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo 126
13. La commissione di vigilanza pubblico spettacolo .........................................
131
14.
La commissione comunale ............................................................................ 133
15. La composizione della commissione ............................................................. 136
16.
La
competenza del sindaco ............................................................................ 139
17.
La
soppressione delle commissioni inutili ..................................................... 147
18. Le competenze tecniche della commissione .................................................. l50
19. La conferenza dei servizi in luogo della commissione ..................................
l52
20. L'attività della conferenza ............................................................................. 155
CAPITOLO QUARTO:
UNA
PROPOSTADI SEMPLIFICAZIONE
E
DI RAZIONALIZZAZIONE
l. La direttiva Bolkestein e la riduzione degli oneri per le imprese .................... 157
2. La triplice funzione .......................................................................................... 163
3. L'incertezza della norma ................................................................................. 166
4. Una proposta di regolamento .•......................................................................... 172
CONCLUSIONI 179
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
INDICE BffiLIOGRAFICO 183
IV

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 7/194
INTRODUZIONE
L'ordinamento giuridico, per quanto riguarda l'organizzazione e l'attività
della pubblica Amministrazione, è stato, dal 1990 in poi, profondamente
trasformato con l'introduzione
di
disposizioni che hanno, da un lato radicalmente
mutato il rapporto con il cittadino-utente, dall'altro adeguato la disciplina
introducendo quelle innovazioni che l'evoluzione tecnologica rendeva possibile.
Contemporaneamente, a cavallo di fine secolo si
è
completato quel percorso di
valorizzazione delle autonomie che la Carta costituzionale aveva sancito ma che
stentava ad essere attuato per la cultura centralista che aveva caratterizzato nel
secolo scorso il sistema complessivo della Repubblica. Oggi, con il superamento
della strutturazione di tipo verticale dei soggetti titolari di poteri pubblici e con
l'affermazione di un assetto geoistituzionale orizzontale vanno riconsiderate prassi
e procedure alla luce anche del generale processo di semplificazione e di
liberalizzazione avviato dal Parlamento con la legge 59 del 1997. Il compito non è
facile per quelle materie, quali ad esempio la sicurezza, dove le attribuzioni
permangono ancora in capo allo Stato mentre la polizia amministrativa locale
rientra nelle attribuzioni assegnate alle regioni. Sistematizzare le diverse
discipline al fine di delineare un preciso quadro di riferimento seguendo il doppio
binario della tutela dell'interesse pubblico e quello della semplificazione
amministrativa, della pubblica sicurezza e della polizia amministrativa,
è
compito
arduo. Il motivo
è
legato al fatto che la stratificazione delle disposizioni che
riguarda la materia ha quale fondamento il testo unico di pubblica sicurezza che è
stato emanato ben prima della Carta costituzionale e
i l
testo unico in materia
edilizia che nell'ultimo decennio ha subito, anche, sostanziali modifiche. Ma più
gli obiettivi sono difficili da raggiungere più cresce il desiderio di realizzarli, se il
fine
è
cercare di dare un contributo alla chiarezza o, per usare un linguaggio
tecnico, alla trasparenza. Semplificazione, trasparenza e certezze. Alla fin fine
sono questi gli obiettivi che, da tempo ormai, l'OCSE e la stessa Unione europea
l

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 8/194
con la direttiva servizi del 12 dicembre 2006 (cosiddetta direttiva Bolkestein
1
)
hanno individuato come necessari o, per meglio dire, indispensabili per i l sistema
imprenditoriale.
La semplicità e l'efficienza della macchina burocratica
è
fattore determinate di
competitività e crescita economica di un paese. Ancora oggi, in Italia, i l numero di
adempimenti e di interlocutori con cui le aziende sono tenute ad interagire, i tempi
di risposta, l'incertezza e la diversificazione territoriale dei singoli procedimenti
costituiscono un costo elevato per chi fa impresa, come sempre più spesso
lamentano i rappresentanti delle categorie economiche. Cercare di delineare,
quindi, in maniera semplice ma articolata, la disciplina in materia di sicurezza dei
locali e luoghi pubblici, diventa un percorso obbligato. Punto cruciale
è
quel
concetto di agibilità che la giurisprudenza ha elaborato nel corso del tempo e che
il legislatore nazionale per più di un secolo ha fatto proprio per qualificare
l'idoneità di un locale ad uso non residenziale. Una "agibilità" prevista da diverse
fonti normative ma che, alla fin fine, persegue un medesimo obiettivo: quello di
rendere sicuri gli spazi per i fruitori.
1
È conosciuta come direttiva Bolkestein la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea relativa ai servizi nel mercato interno, presentata dalla commissione
Europea nel febbraio 2004, La direttiva Bolkestein, i l cui obiettivo è, tra l'altro, quello di
semplificare le procedure amministrative ed eliminare l'eccesso di burocrazia è stata
definitivamente approvata da Parlamento e Consiglio, profondamente emendata rispetto alla
proposta originaria, i112 dicembre 2006, divenendo formalmente la direttiva 2006/123/CE
del12
dicembre 2006. La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L
376) i l 27 dicembre 2006. La direttiva è basata sugli articoli 47.2 e 55 del Trattato della Comunità
Europea. La procedura legislativa di riferimento
è
la codecisione. Frits Bolkestein, Commissario
europeo per i l mercato interno della commissione Prodi ha curato e sostenuto questa direttiva che
per semplicità viene indicata con i l suo nome.
2

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 9/194
CAPITOLO PRIMO
IL
QUADRO DI
RIFERIMENTO NORMA TIVO
SEZIONE l
IL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE: LA SALUBRITÀ
SOMMARIO:
l.
Premessa. - 2. Il R.d.
27
luglio 1934, n.
1265
(testo unico leggi
sanitarie). - 3. Le modifiche all'articolo 221 del Tuls. - 4. La semplificazione
procedimentale e i contenuti dell'articolo
221
Tuls. -
5.
n regolamento per
l'abitabilità.- 6. La vigenza del primo comma dell'art.
221
Tuls.
l. Premessa
"Venticinque anni non bastano per dimenticare. Neppure sono sufficienti
per fare pace con se stessi, con i rimorsi e i sensi di colpa, con quei rumori terribili
che arrivavano dalla platea quando si stava per scrivere la storia del giorno più
tragico di Torino nel dopoguerra. Era i l 13 febbraio 1983
1
• Al Cinema Statuto di
via Cibrario proiettavano la Capra con Gerard Depardieu. Ricordo tutto come se
fosse ieri - dice Raimondo Capella - ero in piedi vicino alla cassa. n film era
incominciato da una ventina di minuti. Erano le 18,15 quando ho sentito quei
rumori. Erano gli spettatori che picchiavano contro le uscite di sicurezza. Spaliate,
pugni, calci. Chiusi in trappola. Sessantaquattro morti soffocati nell'incendio
partito da una vecchia tenda, morti abbracciati, stesi in bagno. Intere famiglie
cancellate. Madri, padri e bambini senza vie di scampo.
2
La storia più recente, in materia
di
sicurezza dei locali, parte da qui, dall'incendio
del cinema Statuto di Torino in una domenica d'inverno. Questo episodio ha
1
Nel 2008 è ricorso i l venticinquesimo anniversario dell'incendio del cinema Statuto. Tutta la
stampa nazionale ha ricordato quell'evento, la cui origine non è stata ancora accertata. Il cinema
Statuto era un cinema di Torino sito in via Cibrario, in cui i l 13 febbraio 1983, a causa di un
incendio, morirono 64 persone, per intossicazione da fumi e per ustioni. Stando alle dichiarazioni
del proprietario del cinema, emerse in sede di dibattimento, le fiamme si sarebbero propagate
partendo da una vecchia tenda. Le vittime, sebbene avessero tentato la fuga, trovarono le uscite di
sicurezza chiuse e bloccate, e così non sfuggirono alle esalazioni di acido cianidrico, prodotto della
combustione del tessuto ignifugo delle sedie.
2
.Zancan N. Io e il rogo allo Statuto dannazione senza fine in
La
repubblica 16 gennaio 2008
3

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 10/194
segnato la storia della legislazione italiana in materia di sicurezza nei luoghi
pubblici perché, da allora, istituzionalmente,
fu
rivista la normativa riguardante i
materiali
di
arredo dei locali di pubblico spettacolo, adeguandone per tipologie e
per quantità l'uso negli allestimenti, rivedendone le caratteristiche tecniche di
reazione al fuoco, le modalità della loro posa in opera e le procedure di
certificazione della qualità degli stessP
Ma se le tragiche vicende di Torino hanno portato alla ribalta il problema
sicurezza dei locali pubblici,
si
può comunque affermare che la disciplina in
materia è presente all'interno del nostro ordinamento, da molto, molto tempo
prima, ancora prima dell'avvento della Repubblica.
2. Il R.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie)
Esiste una netta demarcazione tra igiene e sanità pubblica e privata? A
questo interrogativo, i primi commenti
al
testo unico delle leggi sanitarie, il regio
decreto 27 luglio 1934 n. 1265 avevano risposto nel senso che il problema è di
natura politica e non giuridica, o meglio ancora,
è
di natura politica prima che
giuridica. Non è possibile, infatti, si affermava, fissare in astratto quali siano e
debbano essere i limiti tra i compiti dello Stato e quelli degli individui nel campo
igienico e sanitario. E' evidente che un ordinamento statale, il quale abbia per
presupposto il canone della minore ingerenza possibile dell'Autorità pubblica, nei
rapporti individuali, sarà necessariamente orientato verso una maggiore
autonomia dell'individuo per quel che si riferisce alla tutela della sua salute. Nello
stesso momento, un ordinamento statale, che abbia per base l ' onnipotenza dello
Stato in tutti i rapporti, tenderà verso una più intensa tutela pubblica della salute
individuale.
4
3
E' questo un passaggio della testimonianza pubblicata sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it di
Enzo Ariu, vigile del fuoco di Torino che partecipò ai soccorsi nel tragico incendio in cui persero
la vita 64 persone.
4
Pappalardo N.,
Commento al testo unico delle leggi sanitarie,
Editrice torinese, Torino, 1935, p.
26
4

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 11/194
E'
su quest'ultimo substrato culturale che si va a redigere, nel 1934, il testo unico
delle leggi sanitarie. Il criterio direttivo era quello
di
rendere sempre più efficienti
i poteri dell'autorità sanitaria, sia centrale che periferica, estendendo l'azione
di
vigilanza e di controllo dell'autorità su ogni attività, anche privata, che abbia
finalità inerenti alla salute pubblica.
5
Con l'entrata in vigore del nuovo testo unico, anche nei più modesti comuni
rurali, ogni nuova costruzione, sopraelevazione o modificazione che possa
comunque influire sulle condizioni
di
salubrità delle case esistenti venne
sottoposta al visto del Podestà, il quale vi provvedeva previo parere dell'ufficiale
sanitario e sentita la commissione edilizia. Il testo unico delle leggi sanitarie del
'34, innovò sostanzialmente la previgente disciplina. Non
fu
quindi un testo unico
meramente compilativo. Prevedeva, infatti, l'obbligo non soltanto
di
autorizzare
l'abitazione nelle case già costruite, ma anche di approvare prioritariamente i
progetti per le costruzioni
di
nuove case urbane e rurali,
6
con ciò creando i
presupposti per il connubio: progetto approvato e opera realizzata.
5
In tal senso è la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione generale di sanità del 20 agosto
1934, sul nuovo teso unico delle leggi sanitarie
6
Della rilevante giurisprudenza emanata in riferimento all'art.
221
si segnala la seguente massima
perché, evidenzia in maniera puntuale il significato che, all'epoca era stato attribuito
all'autorizzazione per l'uso dell'immobile. La preventiva "licenza di abitabilità" -la cui necessità
è
imposta dall'art.
221
t.u. leggi sanitarie anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 5 d.P.R. 22
aprile 1994, n. 425 - si pone quale limite legittimo all'esercizio del diritto di proprietà,
costituzionalmente riconosciuto, poiché tende al soddisfacimento della tutela della salute, che pure
ha rango costituzionale. Pertanto, abitare un immobile anteriormente al rilascio di tale
provvedimento autorizzatorio significa non "esercitare" il diritto di proprietà, ma "abusare" di esso,
ed a nulla rilevano l'inerzia o
i l
ritardo della P.A., tenuto conto della tutela apprestata dalla legge
per tali evenienze. Per la configurazione dell'esimente dell'esercizio di un diritto, di cui all'art. 51
c.p., il diritto - il cui esercizio può escludere la punibilità di un fatto sanzionato penalmente - deve
essere un vero e proprio diritto soggettivo protetto in modo diretto ed individuale, tale da
comportare
il
sacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso.
E'
necessario, altresì, che
l'attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in
questione, poiché - in caso contrario - si superano i confini dell'esercizio lecito e si configurano
ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono
al
di fuori della sfera di operatività dell'art.
51
c.p.
Cass. Sez. III, 18 giugno 1996 n. 5889. Pres. Corsaro, rel. Fiale, p.m. Ranieri (conf.), imp. P.M. in
proc. Saccocci in
wwwjurisdata.it
5

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 12/194
Par strano, leggendo i primi commenti dell'epoca, rilevare che poche
considerazioni venivano sviluppate a commento dell'articolo 221
7
del Tuls; ciò in
quanto, si asseriva, detto articolo non richiedeva particolare illustrazione.
8
L'articolo 221 del Tuls, invece, attraverso una complessa interpretazione
dottrinale e giurisprudenziale è stato la base di partenza attraverso la quale sono
stati costruiti il concetto di abitabilità e quello di agibilità. Solo con il più recente
testo unico dell'edilizia, il d.P.R. 380/2001, di cui si tratterà in seguito, sono state
unificate le distinte denominazioni di abitabilità riferita alla residenza e di
agibilità riferita alle altre funzioni. Prima di allora, dottrina e giurisprudenza
avevano elaborato questa distinzione, che oggi, per motivi di semplificazione
linguistica è venuta meno per volontà e opera del legislatore che ha deciso di
utilizzare il solo lemma
di
agibilità.
La relativa certificazione, (di abitabilità o di agibilità) nota negli anm passati
anche come licenza d'uso,
9
trae origine, quindi, dal diritto dell'igiene pubblica, ed
è stata a lungo disciplinata dal Tuls.
L'agibilità o l'abitabilità, venivano accordate, come dispone l'articolo 221,
allorquando "risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto
approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano
altre cause
di
insalubrità."
Una lettura giurisprudenziale riduttiva dell'art.
221
aveva tuttavia circoscritto
l' operatività della certificazione alla sola valutazione igienico-sanitaria, sul rilievo
7
L'articolo
221
del Tuls, oggetto di diversi interventi di modifica sull'articolato, disponeva, nella
sua formulazione originaria, che:
"Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza
autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di
un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto
approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di
insalubrità.
Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da
lire duecento a duemila. "
8
N.Pappalardo, Commento al testo unico delle leggi sanitarie cit., p. 303
9
L'utilizzo del termine "usabilità" in luogo di "abitabilità" è stato conseguente
ai
risultati
interpretativi della Suprema Corte di Cass., come la stessa ha evidenziato nella sentenza Cass. Pen.
Sez. un.,
19
giugno 1996
n.
6819, in
Juris Data.
Secondo la Corte, il termine "utilizzare" meglio
esprime la possibilità di estendere il divieto (di utilizzo) anche agli immobili destinati ad usi
diversi da quelli abitativi.
6

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 13/194
che la repressione degli illeciti edilizi dovesse essere perseguita con gli strumenti
propri del diritto edilizio, non già negando una certificazione ritenuta funzionale
ad interessi pubblici di altra natura e finalità. Il fondamento culturale di una tale
opinione era il formalismo giuridico, mentre il fondamento teorico era
i l
principio
della nominatività e tipicità degli atti amministrativi, per i l quale ogni interesse
pubblico deve essere perseguito con i distinti mezzi che l'ordinamento mette a
disposizione dell'autorità per il raggiungimento dei diversi obiettivi. Nel nostro
ordinamento esiste i l principio della tipicità degli atti amministrativi, nel duplice
senso che i mezzi dell'agire pubblico sono espressamente previsti dalla legge e
che la pubblica Amministrazione deve avvalersi solo di quelli e non di altri. Non
esistono, in pratica atti amministrativi innominati e, peraltro, l'Amministrazione
deve anche utilizzarli per gli scopi previsti per ciascuno di essi dalla legge. In
pratica, la repressione di un illecito edilizio, richiede i poteri di polizia edilizia e
quindi non possono essere usati quelli predisposti a tutela dell'igiene pubblica.
10
Applicando questo principio, quando l'immobile era salubre ma illegittimo, il
sindaco non poteva negare l'agibilità, perché il provvedimento aveva finalità
igienico-sanitarie: doveva rilasciare il certificato e poi ordinare il ripristino
avvalendosi degli strumenti di polizia edilizia.
11
Insomma, nel passato
si
è assistito ad una interpretazione un po' anacronistica, in
relazione al fatto che se l'ispezione prevista dal primo comma dell'articolo 221
Tuls veniva fatta da un ingegnere, che igienista non è di certo, questa aveva lo
scopo di accertare la conformità al progetto originariamente approvato. Di
10
Rota G. L e Rusconi G., Edilizia. Urbanistica. Governo del territorio, (a cura di) Utet, Torino
2006,p.56
11
Si segnala, una tra tante, la seguente massima: Nel regime previgente il d.l. n. 398 del1993 art.
4 (che ha testualmente esteso i controlli da effettuare ai fini del rilascio della licenza di abitabilità
all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia), il rilascio del certificato di abitabilità
previsto dall'art. 221 t.u. 27 luglio 1934
n.
1265 postula la verifica dell'insistenza di causa di
insalubrità dell'edificio, senza alcun collegamento col conseguimento di fini di carattere edilizio-
urbanistico, conservando l'Amministrazione comunale il potere di reprimere gli abusi edilizi
ancorché il certificato venga rilasciato; nè rileva, nella Regione Puglia, il riferimento all'art. 34 l.
reg.
n.
56 del1980 (titolata "Tutela ed uso del territorio"), dovendosi lo stesso interpretare in senso
conforme alla disciplina di cornice dettata dalla legge statale (il citato Tuls) ed inerendo la licenza
di abitabilità a profili diversi da quelli urbanistico-edilizi. T.a.r. Puglia Bari, Sez. II, 4 febbraio
2003,
n.
489, Foro amm. TAR 2003,723
7

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 14/194
conseguenza l'abitabilità o l'agibilità non poteva essere assentita se l'opera
realizzata era diversa rispetto i disegni approvati ma non c'era modo di intervenire
se i muri erano pieni d'amianto. E' evidente che la norma tiene conto di quello
che, all'epoca della sua redazione era il contesto sociale e lo spettro della
tubercolosi.
12
Si era, quindi, reso necessario riordinare la disciplina al fine di prevedere un
quadro normativo di riferimento che tenesse conto anche di quanto, nel frattempo,
dottrina e giurisprudenza avevano elaborato su questo particolare procedimento
autorizzatorio.
3. Le modifiche all'articolo 221 del Tuls
L'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie ha subito, nell'ultimo
decennio del secolo scorso, diverse sostanziali modifiche la cui portata è
decisamente rilevante. La meno problematica è certamente quella apportata al
secondo comma, con l'introduzione della sanzione amministrativa in luogo
dell'ammenda. Ciò è avvenuto con l'articolo 70, comma
l,
lettera b), del decreto
legislativo n. 507 del 1999
13
(legge di depenalizzazione). Questo secondo comma
dell'articolo
221
del Tuls, peraltro, è stato abrogato dal d.P.R. 380/2001 ma,
relativamente a quest'aspetto ci sarà modo
di
esaminare la questione in occasione
dell'esame del testo unico per l'edilizia che con tale decreto è stato approvato.
Merita, invece, soffermarsi sul contenuto del primo comma dell'art.
221
Tuls, che
ha subito una prima modifica a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento
recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo
statico e
di
iscrizione al catasto", approvato con d.P.R. 22 aprile 1994
n.
425. Con
l'articolo 5
14
di detto regolamento veniva disposta l'abrogazione di alcune
12
G.L
Rota E
G.
Rusconi Edilizia. Urbanistica. Governo del territorio,
cit. p. 57
13
Si tratta del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e
riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo l della legge 25 giugno 1999, n. 205"
14
Specificatamente, l'art. 5 Abrogazione di norme, del d.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, disponeva
che:
l.
Ai sensi dell'art.
2,
comma
8,
della legge 24 dicembre 1993,
n.
537, dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono abrogati il primo comma dell'art. 221 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265 e il comma lO dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
8

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 15/194
disposizioni e, tra queste, interveniva sull'articolo 221, primo comma, del Tuls
"limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato
di
abitabilità".
4.
La semplificazione procedimentale e i contenuti dell'articolo 221 Tuls
Nell'ambito della semplificazione avviata all'inizio degli anni
90,
il
sostegno dell'occupazione e l'accelerazione degli investimenti è stato, fin
dall'inizio, uno degli obiettivi principali che Governo e Parlamento hanno inteso
perseguire. Non poteva mancare, in quest'ottica, la revisione dei procedimenti in
materia edilizia. Risale al 1993, infatti, il primo concreto passo in questa specifica
materia che venne attuato dal decreto legge
5
ottobre
1993
n.
398
e dalla relativa
legge
di
conversione
4
dicembre
1993
n.
493,
recante "Disposizioni per
l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la
semplificazione dei procedimenti in materia edilizia". Una concreta azione,
quindi, avviata prima ancora dell'emanazione della legge
537
del
24
dicembre
1993
che, in materia
di
semplificazione, impose tra l'altro un'accelerazione
al
processo avviato pochi anni prima con la legge
241/90.
La nuova norma contenuta nell'articolo
4
comma 11 del d.l.
39811993
e relativa
legge di conversione, prevedeva,
15
che: "I controlli da effettuare ai fini del rilascio
dei certificati di abitabilità e
di
agibilità, estesi all'accertamento della conformità
urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali (e non quindi più dalle Asl
n.d.r.). In caso
di
inadempienza protratta per oltre
60
giorni, il certificato può
essere sostituito, in via provvisoria, da una dichiarazione redatta
ai
sensi della
legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, sotto la propria
responsabilità da un professionista abilitato".
Fu questo, in pratica, il primo significativo provvedimento sulla strada della
semplificazione delle procedure in materia di agibilità e abitabilità, anche
se
la
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, limitatamente alla disciplina per il rilascio
del certificato di abitabilità.
15
Il passato è d'obbligo perché la disciplina è stata successivamente abrogata dal d.P.R. 42511994
ovvero dalla legge di delegazione 24 dicembre 1993,
n.
537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e
9·
'
9

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 16/194
sopraindicata dichiarazione (autocertificazione) aveva carattere provvisorio e,
quindi, era sempre necessario il rilascio del certificato da parte del comune. Ed è
per questo motivo che, soli pochi mesi dopo, il Parlamento stabilì che il
procedimento andava necessariamente rivisto. Infatti, il procedimento di
autorizzazione all'abitabilità, è incluso nell'allegato 4 della legge 24 dicembre
1993 n. 537. L'allegato 4 della citata legge 537/1993 individuava i procedimenti
che dovevano essere oggetto di regolamentazione e, in pratica, il primo massiccio
intervento di delegificazione, ovvero della predisposizione di regolamenti
governativi che, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
2,
della legge 23 agosto
1988, n. 400, avrebbero disciplinato ex novo una materia precedentemente
regolata da norma primaria abrogandola per espressa previsione contenuta nella
legge di delega.
In sostanza, la legge può, ed in alcuni casi deve, aprire spazi normativi a fonti
secondarie espressive di forme di governo autonome. E rendendo vuoti spazi
normativi in precedenza disciplinati con legge si aprono, evidentemente,
possibilità di normazione autonoma. Il dato appare incontrovertibile nelle
sentenze 231 e 329 del 2008 che, parlando espressamente di "regolamenti di
delegificazione", ha definitivamente specializzato il significato del termine nel
suo uso tecnico.
Sembra possa essere letta in questo modo anche l'abrogazione dell'art. 128 della
Costituzione e la sua radicale sostituzione con gli artt. 114, comma 2 e 117,
comma 6, laddove la potestà regolamentare degli enti locali diventa lo strumento
normativa per eccellenza per regolare materie in precedenza disciplinate dello
Stato.
16
5. Il regolamento per l'abitabilità
Il regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione
all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto, approvato con d.P.R.
16
Depuro G.,
La
delegificazione, Qualità della regolazione, coord. da A. Natalini e G. Tiberi in
www .astrid-online.it
10

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 17/194
22 aprile 1994 n. 425 è rimasto in vigore per meno di un decennio; nondimeno, ha
creato le condizioni per una diatriba giurisprudenziale che forse nemmeno il
nuovo testo unico sull'edilizia d.P.R. 380/2001 in cui il regolamento per il
procedimento relativo all'abitabilità è stato incorporato, è riuscito a dirimere.
Pomo della discordia proprio l'articolo 221 del Tuls o meglio il primo comma
dell'articolo 221, che alcuni giudici ritengono abrogato ed altri, invece no.
17
.
A dire il vero, dubbi interpretativi non dovrebbero più sussistere dopo il
pronunciamento delle sez10m unite della Cassazione penale che ha
definitivamente statuito per la ineludibile ed insostituibile necessità di tutelare le
condizioni igienico sanitarie degli edifici che l'uomo deve, a qualsiasi titolo,
frequentare per soddisfare le sue molteplici esigenze e, quindi, non può essere in
alcun modo rimessa in discussione (la vigenza dell'articolo 221, primo comma
art.
221
Tuls n.d.r.)".
18
L'art. 221 Tuls prevede, al I comma, che: "gli edifici o parti di essi indicati
nell'articolo precedente non possono essere abitati senza l'autorizzazione del
podestà (ora sindaco), i l quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale
sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata
eseguita in conformità al progetto approvato, che i muri siano convenientemente
prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità", mentre al comma 2
statuisce che "il proprietario che contravvenga alle disposizioni del presente
articolo è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000".
Il testo del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, coordinato con la legge di conversione 4
dicembre 1993,
n.
493, che recava disposizioni per l'accelerazione degli
investimenti ed i l sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei
procedimenti in materia edilizia stabiliva, al comma
10
dell'art. 4 che: I controlli
da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità estesi
all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia sono eseguiti dagli uffici
17
Si vedano a tale proposito le sentenze Cass. Pen. Sez. III, 16 gennaio 1996, n. 120; Sez. III, 27
aprile 1995, Palmegiani, C.E.D. Cass.,
n.
201795; Sez. III, 20 febbraio 1995, Salvatori, ivi,
n.
201999; Sez. III, l
o
giugno 1994, Talarico, ivi, n. 199829
18
Cass. Pen. (Sez. Un.,) 19 giugno 1996 n. 6816 in Juris Data online
11

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 18/194
comunali, in caso di inadempienza protratta per oltre sessanta giorni, il certificato
può essere sostituito in via provvisoria, da una dichiarazione redatta ai sensi della
L
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
da un professionista abilitato".
L'art. 2 (semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi) della
legge 24 dicembre 1993,
n.
537, la legge finanziaria per il 2004, prevede al
comma 7 che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L
23
agosto 1988,
n.
400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti
amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e
dei procedimenti ad essi connessi", e al comma
8:
"Le norme anche di legge
regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla
entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7".
Il d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, regolamento recante disciplina dei procedimenti
di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto,
dispone all'art. 5 che "ai sensi dell'art. 2 comma 8 della L 24 dicembre 1993,
n.
537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il
comma l dell'art. 221 del r.d. 27 luglio 1934,
n.
1265, e il comma
lO
dell'art. 4 del
d.l. 5 ottobre 1993,
n.
398, convertito con modificazioni, dalla L 4 dicembre 1993,
n.
493, limitatamente alla disciplina per i l rilascio del certificato
di
abitabilità".
In pratica, secondo le sezioni unite della Corte di cassazione, con i l regolamento
di semplificazione del procedimento in materia di abitabilità era "inevitabile
eliminare dalla norma penale quelle parti che, non riguardando
i l
contenuto del
precetto, né le conseguenze scaturenti dalla sua violazione, in essa erano state
comunque comprese per l'ovvia opportunità di indicare in quella stessa sede le
modalità con le quali l'autorizzazione poteva essere concessa ed i presupposti ai
quali la stessa era subordinata".
12

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 19/194
6.
La vigenza del primo comma dell'art. 221 Tuls
La Cassazione penale, Sez. unite ha lasciato con la sentenza n. 6816/1996,
quindi, in minoranza la tesi dell'implicita abrogazione dell'articolo 221 Tuls
19
per
sostenere, invece, la seconda interpretazione che affermava l'abrogazione solo
parziale dell'art.
221
comma l del Tuls.
I sostenitori
di
tale assunto sono partiti esplicitamente, od implicitamente,
dall'analisi del contenuto precettivo dell'art.
221
comma l Tuls, il quale individua:
l)
l'oggetto dell'autorizzazione (gli edifici o parte
di
essi indicati dall'art. 220
Tuls);
2)
l'obbligo di (preventivo) rilascio dell'autorizzazione sindacale;
3) le condizioni per concederla: ispezione dell'ufficiale sanitario; esecuzione
dell'opera.
Si ritiene, allora, che l'abrogazione statuita dall'art. 5 d.P.R. n. 425
dell994,
per la
espressa limitazione sopra specificata, contenuta nella sua formulazione: "sono
abrogati il primo comma dell'art.
221
del regio decreto
27
luglio 1934, n 1265, e il
comma
10
dell'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993,
n.
398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n.
493, limitatamente alla disciplina
per il rilascio del certificato
di
abitabilità" attenga esclusivamente
al
modulo
procedimentale afferente
al
rilascio di detto certificato e dunque
al
n. 3 della
sopraindicata elencazione. Il certificato di abitabilità, nel momento in cui viene
diversamente regolamentato, lungi dall'essere abolito, resta, in pratica,
inequivocabilmente confermato nella sua preventiva necessità. Pertanto il precetto
posto dal I comma dell'art.
221
Tuls, costituito dal divieto di "abitazione senza
autorizzazione del sindaco... degli edifici o parte di essi", non sarebbe stato
abrogato dall'art. 5 del d.P.R. 42511994, e rimarrebbe invariato ed in vigore il Il
comma dell'art. 221 del medesimo Tuls
20
•
19
Nella citata sentenza si precisa che questa tesi era stata inizialmente sostenuta dalla Cass. Pen.
III Sez. con le sentenze
dell9
gennaio 1995 e
23
gennaio 1996.
20
Il II comma dell'art. 221 è stato successivamente abrogato in quanto assorbito dall'art. 24 del
d.P.R. 380 del2001, testo unico per l'edilizia.
13

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 20/194
Corollario di tale tesi è che le fasi procedimentali che l'interessato ed il sindaco
devono seguire per ottenere e rilasciare il certificato di abitabilità non entrano
nella vecchia ipotesi contravvenzionale
né
entrano nella nuova.
21
La tesi che ritiene la perdurante vigenza della fattispecie penale prevista dall'art.
221 Tuls è da preferire per una ragione fondamentale che attiene
al
meccanismo
delegificativo previsto dalla
l. 23
agosto 1988, n. 400. La legge 24 dicembre 1993
n. 537, precisano le Sezioni unite Cass. Pen. nella sentenza 6816/1996, nel
determinare i contenuti ed i limiti del potere normativo delegato al Governo,
nonché i criteri ed i principi ai quali lo stesso doveva conformarsi, non aveva
autorizzato alcuna
abolitio criminis,
nè alcuna revisione della normativa penale
correlata alle disposizioni che disciplinavano gli effetti conseguenti alla omessa
acquisizione
di
determinate autorizzazioni, tale da giustificare interventi riduttivi
nell'area della illiceità penale. Di conseguenza, sottolinea il Giudice, il
regolamento approvato dal Governo in attuazione
di
quella legge sarebbe incorso
in un manifesto eccesso di delega, e quindi avrebbe violato l'art. 76 della
Costituzione qualora
il
suo esplicito contenuto ovvero una possibile
interpretazione di alcune delle sue disposizioni potessero effettivamente
giustificare le conclusioni dalle quali la Suprema Corte dissente, e cioè
l'abolizione del reato previsto e punito dall'art.
221
del Testo Unico delle Leggi
Sanitarie.
È
altresì opportuno, afferma ancora la Corte di cassazione, precisare che nessuna
delle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993
n.
537 stabilisce la
superfluità dell'autorizzazione preventiva all'abitabilità di un edificio per motivi
igienico sanitari, nè in alcuna di esse è possibile cogliere un'oggettiva
incompatibilità con l'imposizione dell'obbligo
di
quella autorizzazione; anzi, tale
obbligo, nella sua specificità, è dalla stessa legge presupposto tant'è che in
relazione al suo adempimento si dà mandato al Governo di semplificarne e
accelerarne l'attuazione.
21
Gargiulo R., nota a margine della sentenza Cass. Pen., Sez. III, 16 gennaio 1996,
n.
120 in
Cass.
pen. 1996,9,2770
14

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 21/194
Pertanto, conclude la sentenza, una volta stabilito che in base a quanto disposto
dall'art. 17 comma 2 della legge
23
agosto 1988 n. 400 sono soltanto le
disposizioni contenute nella legge
di
autorizzazione a poter determinare l'ambito
della materia nella quale può intervenire la fonte normativa secondaria, e cioè le
disposizioni regolamentari, ed una volta accertato che l'art. 2 della Legge
n.
537
del 1993 aveva ad oggetto delle mere semplificazioni procedimentali (cfr. in tal
senso Corte Cost. sent.
n.
69 del 1995), deve convenirsi che l'art. 5 del d.P.R.. 22
aprile 1994
n.
425 non può che essere interpretato nell'unico mordo che ne
consente il riconoscimento della sua intrinseca legittimità: e cioè che la disposta
abrogazione parziale del primo comma dell'art.
221
del Testo unico delle leggi
sanitarie è conseguente al corretto esercizio della facoltà concessa
al
Governo,
espressamente, dal comma 8 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993
n.
537, e
cioè alla possibilità
di
"abrogare" soltanto le norme c ~ m c e r n e n t i la disciplina dei
procedimenti amministrativi relativi
al
rilascio di alcune autorizzazioni. Tale
conclusione è oggettivamente confermata dalla stessa formulazione della norma
che non giustifica alcun dubbio interpretativo.
E che il citato regolamento non abbia voluto in alcun modo abrogare o modificare
il contenuto precettivo e sanzionatorio dell'art.
221
è dimostrato anche dal fatto
che proprio nell'art. 4 dello stesso regolamento si ribadisce, e con evidente
chiarezza, che perché un edificio possa essere legittimamente utilizzato è
"necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità
al
sindaco".
Le modifiche introdotte dal regolamento 425 del 1994, peraltro ora abrogato,
all'art.
221
Tuls, lungi dall'aver abolito, quindi, i connotati dell'illiceità penale che
qualificano la condotta di colui che utilizza un edificio senza l'autorizzazione
all'abitabilità, ribadiscono, e con maggiore rigore tecnico, l'estensione del
divieto.
22
Del resto, il permanere in vigore dell'articolo
221
Tuls è ricavabile anche dal
parere che il Consiglio di Stato ha espresso, in adunanza generale nella seduta del
22
E'
stato, comunque, già precisato che la sanzione Pen. è stata trasformata in illecito
amministrativo e che ciò è avvenuto con l'articolo 70, comma l, lettera b), del d. lgs 50711999.
(legge di depenalizzazione).
15

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 22/194
14 aprile 1994, sullo schema di quello che, poi, è divenuto il regolamento
425/1994. Afferma il collegio: "la semplificazione del procedimento relativo alla
agibilità, non essendo prevista nell'allegato 4 della legge n. 537 del 1993, non può
essere oggetto del presente regolamento"; regolamento che, infatti, ha poi
disciplinato esclusivamente l'abitabilità (per l'edilizia residenziale). In pratica,
l'articolo 221 Tuls avrebbe, comunque, continuato a disciplinare l'agibilità per i
locali produttivi o,
meglio ancora, per tutti i locali con destinazione d'uso diversa
da quella abitativa.
In conclusione, soltanto m seguito, il Parlamento ha conferito al Governo la
delega a ridefinire e riunire in un unico corpus normativa i procedimenti sia
relativi al certificato di agibilità per i locali a destinazione diversa da quella
abitativa, sia quelli relativi all'abitabilità per la residenza.
16

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 23/194
SEZIONE2
IL TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA: L'AGIBILITÀ
SOMMARIO:
l.
Agibilità e abitabilità. - 2. La riforma della pubblica
Amministrazione e la semplificazione amministrativa, - 3. n testo unico per
l'edilizia. - 4. Il procedimento per l'agibilità. - 5. Il comportamento omissivo. - 6.
L'inagibilità.- 7. L'inagibilità
l. Agibilità e abitabilità
L'evoluzione normativa che ha portato alla distinzione formale tra il
concetto di abitabilità e agibilità ha inizio con la legge
28
febbraio 1985
n.
47
(condono edilizio) in quanto, all'art. 35 "Procedimento per la sanatoria", è
formalmente previsto, al terzultimo comma, che:
"A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato
il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme
regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti
in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera
b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni."
Uno specifico riferimento alle due distinte ipotesi dell'abitabilità e dell'agibilità è
contenuta anche all'art. 52 della stessa legge 4711985 nella parte in cui si
disciplina l'iscrizione al catasto. Va rilevato ancora che, a seguito dell'univoca
dottrina e giurisprudenza che distingueva la fattispecie dell'abitabilità da quella
dell'agibilità, già con la legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di "Istituzione
del servizio sanitario nazionale", ali' art. 24 punto 7, si prevedeva la necessità di
stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di
consentirne l'agibilità.
23
23
L. 83311978, art. 24. (Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e
di omologazioni): Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del
Ministro della sanità con
i l
decreto dei Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza
del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché
in
materia di
omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche
17

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 24/194
L'agibilità è necessaria, in pratica, perché un edificio o parte di esso destinato ad
attività produttiva, commerciale, e comunque non abitativa, possa venir usato per i
fini per cui l'edificio stesso è stato costruito. Essa consiste in un'apposita
autorizzazione, concessa previa ispezione di funzionario incaricato dell'ufficio
tecnico comunale, dell'ufficiale sanitario, di altri eventuali organi
di
controllo
(VV.FF., ISPESL, medico provinciale, commissione provinciale di vigilanza per
lavori pubblici ecc.) volta ad accertare l'esecuzione edilizia in conformità
al
progetto approvato ed agli eventuali obblighi sottoscritti ed ì1 rispetto in genere
dei disposti del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.
24
La distinzione tra abitabilità ed agibilità, tuttavia, ha trovato in seguito una
semplificazione concettuale, in quanto il concetto di agibilità è stato aggiornato
per ricomprendere tutti i controlli e le verifiche, attinenti alla sicurezza
dell'immobile e introdotte negli anni dal legislatore, e ciò con riferimento a tutta
l'attività edilizia. Infatti, con il d.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia", si è fatto ricorso al concetto di
sicurezza in senso ampio, (in quanto attinente non solo all'igiene e alla salubrità
dell'edificio e degli impianti in esso installati, ma anche alle condizioni qualitative
dell'edificio, nonché alla statica dello stesso valutata alla luce di indagini anche a
carattere geognostico).
Quindi, se nel linguaggio normativa il termine licenza di "abitabilità" è stato
inizialmente utilizzato in relazione ad immobili ad uso abitativo, mentre il termine
licenza di "agibilità" è stato riferito ad immobili non residenziali, in un secondo
tempo, il legislatore ha operato una diversa distinzione, considerando
riconducibile ali' "agibilità" la disciplina generale relativa alla stabilità e alla
sicurezza dell'immobile, e ali'" abitabilità" la disciplina speciale dei requisiti
della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i principi
generali indicati nella presente legge.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
punti l) - 6) omissis
7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro. al fine di consentirne
l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica all'autorità competente dei progetti di costruzione, di
ampliamento,
di
trasformazione e di modifica
di
destinazione di impianti e di edifici destinati ad
attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;
24
Borri D., Lessico urbanistico, Dedalo, Bari, 1985,
p.
17
18

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 25/194
dell'imm
obile rispe
tto a spec
ifiche destin
azioni d'us
o
25
•
Proprio
con il
regolamento
380/2001 ch
e, allo stato
attuale, disc
iplina l'attiv
ità edilizia,
si è
provv
eduto ad el
iminare il d
uplice riferi
mento termi
nologico pre
sente nella
legislazione
i
settore, optando per il più ampio termine agibilità .
2 L
a rifonna de
lla P e la se
mplificazion
e amministra
tiva
L
a legislazione
più recente,
nell'intento
di migliorare
la qualità d
ell'agire
pu
bblico,
s
i
è
is
pirata a dei c
riteri guida c
he si possono
individuare
nell'efficienz
a,
traspare
nza, econom
icità e pubbli
cità.
Tali princi
pi, tipici del
le aziende pr
ivate, rispon
dono alle esi
genze
i
far
fronte
al
le annose
disfunzioni
che hanno
caratterizza
to per ann
i la pubbl
ica
Ammin
istrazione, c
ollocandola
in una posi
zione vessat
oria nei con
fronti del
cittadino.
L a
trasformazio
ne epocale c
he da un lat
o ha ribaltat
o la tradizion
ale posizion
e
del la pu
bblica Amm
inistrazione
nei confron
ti del citta
dino e dali '
altro ha
provveduto a
riorganizzar
e il sistema
amministrati
vo, si è avut
a all'inizio d
egli
anni
'9 0, con la l
egge
n
241/1
990.
Alla fine
del decenn
io tuttavia u
n'altra legge
, la
n
59 d
el 1997
26
in
serendosi
nell'am bito i
quegli orie
ntamenti leg
islativi che d
alla l 24111
990 in poi ha
nno
mira
to alla ottim
izzazione de
ll'azion e amm
inistrativa, h
a rappresent
ato la chiave
di volta
per la semp
lificazione d
ell'agire pub
blico, media
nte la previs
ione di
strumenti diretti a migliorare il rapporto pubblica Amministrazione-cittadino.
Di se
mplificazione
dell'attività
amministrati
va, dopo la le
gge 59 del 1
997, si parla
con riferi
mento a situ
azioni diver
se, in quanto
gli obiettiv
i perseguiti
con la
se
mplificazione
sono moltep
lici ed atteng
ono essenzia
lmente alla:
individuazion
e
25
L'
an alisi storica
dell'evoluzione
te rminologica
è contenuta ne
lla relazione de
l Governo allo
schem
a di regolamen
to per l 'approva
zi one del testo
un ico per l'edili
zi a.
26
L
a legge
15
marz
o 1997,
n
59
Delega al Gover
no per il confer
im ento di funzio
ni e comp iti al
le
regioni ed enti locali, per la riform a della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
am m
in istrativa va c
onsiderata com
e il pilastro sul
quale sono stat
e realizzate le p
iù significative
riform
e economiche
che hanno carat
terizzato la fine
del secolo scors
o.
19

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 26/194
di
regole di comportamento nei rapporti tra amministrazione e cittadino per
rendere più comprensibile l'attività amministrativa
al
cittadino utente;
eliminazione degli adempimenti non prescritti dalla legge, non necessari per la
procedura e che gravano sul cittadino-utente; soppressione
di
adempimenti
prescritti da disposizioni vigenti, ma non necessari per la tutela
di
interessi
rilevanti. In quest'ottica si collocano i testi unici che, per effetto dell'art. 20
comma 11 della legge
59
del 1997, i l Governo è delegato ad emanare, anche
attraverso modifiche, integrazioni ed abrogazioni
di
norme.
3.
Il testo unico
per
l'edilizia
L'iniziativa normativa del Governo in tema
di
testo unico delle leggi in
materia edilizia
27
va ricondotta ad un complesso e per molti versi non facile
quadro normativo di riferimento; ciò si evince inequivocabilmente dalla lettura del
parere che il Consiglio di Stato
28
ha espresso sullo schema
di
testo unico. Il testo,
infatti, sulla base delle fonti primarie di autorizzazione, ha proceduto ad una
triplice azione razionalizzatrice: raccolta delle fonti primarie, raccolta delle fonti
regolamentari e
di
delegificazione delle norme procedimentali ed organizzative,
accorpamento dei due testi, con conseguente redazione
di
tre distinti corpi
normativi?
9
La complessità del testo unico per l'edilizia deriva dal fatto che il medesimo trova
fondamento nella delega conferita
al
Governo
ai
sensi dell'articolo 7 commi l e 2
della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo l della legge 24
27
.Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
è
stato approvato
con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ha il proprio fondamento nella delega conferita al Governo ai
sensi dell'articolo 7, commi l e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo
l della legge 24 novembre 2000, n. 340.
28
Sulla proposta di testo unico in materia edilizia il Consiglio di Stato si è espresso in adunanza
~ e n e r l e
il29
marzo 2001 con parere n. 52/2001.
9
Tale modo di procedere, ispirato anche ali' esigenza di evitare una indesiderata rilegificazione di
norme ormai di rango secondario, peraltro, era stato già ritenuto legittimo dalla Sezione per gli atti
normativi, con parere 18 settembre 2000,
n.
147/2000, relativo al t.u. delle norme sulla
documentazione amministrativa.
20

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 27/194
novembre 2000, n. 340
30
• Tale norma prevede l'emanazione di testi unici intesi a
riordinare, tra le altre, le materie di cui all'art. 20 della legge
15
marzo 1997, n.
59. Uno degli obiettivi previsti dalla l. 59 del 1997 è stato quello di procedere
all'emanazione di regolamenti di delegificazione
31
per la disciplina delle materia e
dei procedimenti espressamente individuati in un allegato. Nell'allegato l alla l.
59 del 1997, al n. l
05
è indicato il procedimento per i l rilascio delle concessioni
edilizie e al
n.
112-quinquies il procedimento per il rilascio del certificato di
agibilità.
Insomma, va dato atto al Consiglio di Stato di aver rivendicato, perlomeno, la
necessità di mantenere, in rubrica, l'indicazione delle norme di rango primario o
regolamentare trasfuse nel testo unico, e ciò al fine di agevolare l'interprete. Se
così non fosse stato fatto, questo tentativo di sistematizzare le disposizioni in
materia di agibilità sarebbe stato improbo.
Sul piano procedimentale, il testo unico redatto in attuazione dei criteri dell'art. 20
l.
n. 59 del 1997, contiene diversi aspetti innovativi tra i quali vanno annoverati,
l'istituzione dello sportello unico dell'edilizia, modellato
su
quello per le attività
produttive previsto dal d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447,
32
lo snellimento della
30
In attuazione della delega conferita ai sensi della legge 50/1999 oltre al testo unico in materia
edilizia, sono stati emanati i seguenti decreti legislativi: d.lgs. 24 febbraio 1998,
n.
58 Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
21
della L. 6
febbraio 1996, n. 52; d.lgs.
25
luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.; d.lgs. 29 ottobre 1999,
n.
490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo l della L. 8 ottobre 1997,
n.
352; d.lgs.
18
agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali; d.lgs. 26 marzo 2001,
n.
151 Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo
15
della L. 8 marzo 2000,
n.
53; d.lgs. 8 giugno 2001,
n.
325 Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità; d.lgs. 18 gennaio 2002,
n.
52 Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea; d.lgs. 30 maggio 2002, n.
113
Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di spese di giustizia.; d.lgs. 14 novembre 2002, n.
311
Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 396
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico; d.lgs. 31 luglio 2005,
n.
177 Testo unico della radiotelevisione.
31
L'obiettivo è previsto dall'articolo 20, comma 8 della l. 5911997
32
A dire i l vero, lo sportello unico per le attività produttive, SUAP, ha stentato a decollare per un
insieme di motivi tecnici e politici; non ultimo quello di aver visto vanificare dalla Corte
costituzionale l'obiettivo di affidare ai Comuni la gestione del procedimento unico per tutte le
attività economiche: sentenza
23
luglio 2002,
n.
376.
21

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 28/194
procedura per il rilascio della concessione edilizia, attraverso l'eliminazione
dell'obbligatorietà del parere della commissione edilizia, la cui sopravvivenza
viene rimessa all'autonoma scelta dei comuni, e l'introduzione, seppure con
alcuni limiti, dell'autocertificazione in sostituzione del parere dell'azienda
sanitaria locale.
33
In definitiva, al di là del tecnicismo burocrate che neppure la relazione di
accompagnamento ad un provvedimento di semplificazione
è
riuscito a debellare,
il testo unico, facendo propri i principi dello snellimento amministrativo e di un
più intenso contatto tra P .A. e cittadini, avrebbe dovuto lanciare lo "sportello
unico dell'edilizia", provvedendo, quindi, ad una duplice semplificazione; da una
parte snellendo l'organizzazione interna degli uffici comunali e, dall'altra,
favorendo e semplificando i rapporti tra "cittadino" e pubblica amministrazione,
mediante l'utilizzo delle autocertificazioni.
C'è da dire, relativamente a questo aspetto, che se anche il d.P.R. 380/2001 non
ha risposto appieno alle esigenze innovative che in molti si attendevano, si
presenta comunque come un provvedimento organico, composto da ben 138
articoli, che coordina e semplifica l'intera materia da cui, per l'appunto, la
denominazione di Testo unico dell'edilizia, abrogando, nel contempo, ben
18
provvedimenti diversi tra leggi e decreti.
Il cambiamento introdotto dalla normativa, che rileva ai fini di questa analisi, è di
carattere terminologico: la distinzione tra "abitabilità" e "agibilità" viene, infatti,
definitivamente superata e i rispettivi titoli di assenso riunificati sotto la
denominazione di "certificato di agibilità".
Inizialmente con i l primo termine (abitabilità) si indicava l'attitudine
dell'immobile alla destinazione d'uso ad esso attribuita e con il secondo (agibilità)
la sua idoneità sotto il profilo della statica e della sicurezza. Successivamente, il
vocabolo abitabilità venne usato con riferimento alle abitazioni, vale a dire agli
33
In tal senso la già citata relazione del Governo di accompagnamento allo schema di testo unico
che
è
disponibile nel sito www.casaportale.com/public/uploads/norme-4040-doc3.pdf.
22

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 29/194
edifici residenziali, mentre la parola agibilità riguardava più propriamente gli
immobili produttivi, nei quali vi fosse comunque transito di persone.
L'articolo 24 comma l del d.P.R. 380/2001, nel definire la funzione del certificato
di agibilità, stabilisce, quindi, in via generale che esso "attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente". Senza dubbio, il testo unico aggiorna la nozione di salubrità degli edifici
prevista originariamente dali' art.
221
Tuls e vi ricomprende anche fattori quali la
sicurezza, la statica e il risparmio energetico che hanno assunto sempre maggiore
rilevanza negli ultimi anni.
Poiché l'agibilità di un immobile deve essere valutata sulla base dell'uso cui esso
è
destinato,
è
necessario domandare un nuovo certificato ogni qualvolta l'edificio
subisca un mutamento di destinazione d'uso, strutturale o funzionale. Tale
indirizzo viene mitigato solo nel caso in cui la nuova destinazione d'uso sia
sostanzialmente simile e affine a quella precedente, ad esempio, abitazione e
uffici.
34
Per quanto riguarda la procedura per l'agibilità, il testo umco opera quella
distinzione sostanziale tra edilizia residenziale e non residenziale che i l d.P.R.
42511994 aveva lasciato sospesa in forza della delega ricevuta dal Parlamento e
limitata alla determinazione del procedimento per il solo certificato di abitabilità,
ovvero, ali' epoca, per la sola edilizia residenziale.
n
testo unico 380/2001, invece, individua nel certificato di agibilità l'unico atto
finale per tutte le tipologie di edifici anche se, contemporaneamente, determina
due procedimenti distinti. Peraltro, sembra utile evidenziare che il certificato di
agibilità deve oggi essere considerato, a tutti gli effetti, un'autorizzazione
amministrativa, espressione di discrezionalità tecnica. Esso, infatti, non si traduce
in una mera attestazione o certificazione. Del resto va evidenziato i l fatto che già
i l
d.P.R. 425/1994, recava, espressamente nel suo titolo la "Disciplina dei
34
Benedetti A.
Certificato di agibilità. Nuove norme e procedure,
in "Geopunto" bimestrale del
Collegio dei Geometri di Roma n.
l,
maggio 2004
23

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 30/194
procedimenti
di
autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al
catasto"; certificato, quindi, in senso lato, individuato come tale
al
fine di
richiamare la provenienza pubblica.
4.
Il procedimento
per
l'agibilità
L'iniziativa di richiedere il certificato di agibilità previsto dall'articolo 24
del d.P.R. 380/2001 spetta al titolare del titolo abitativo, sia questo il permesso di
costruire o la denuncia di inizio attività.
n certificato di agibilità, che viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale, attesta l'esistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati. Il rispetto delle condizioni deve essere valutato secondo quanto dispone
la normativa vigente, ovvero quella in vigore nel momento della decisione, anche
se nel frattempo, modificata o sostituita.
n certificato è necessario per gli interventi relativi alle nuove costruzioni; le
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ma anche per interventi su edifici
già esistenti nel momento in cui modifichino le condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 77,00 a 464,00 euro.
La rubrica dell'articolo 24 del tu in materia edilizia reca indicato, tra gli altri,
l'articolo 221, comma II del Tuls che, infatti,
è
stato espressamente abrogato
dall'articolo 136, comma 2 lettera a. Nulla afferma il nuovo testo unico edilizio,
invece, con riferimento al primo comma dell'articolo 221 del Tuls che, in base
alla già indicata sentenza della Corte Cass.
35
è
da considerarsi tuttora in vigore.
L'articolo
25
detta, invece, le specifiche disposizioni per il procedimento di
rilascio del certificato di agibilità.
35
Cass. Pen. (Sez. Un.,) 19 giugno 1996 n. 6816 cit.
24

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 31/194
In carenza di provvedimento da parte del soggetto responsabile, l'agibilità si
intende attestata quando siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta nel caso in cui sia
stato espresso parere da parte dell'Asl e dopo 60 giorni nel caso di
autocertificazione del richiedente. L'autodichiarazione
di
conformità del progetto
alle norme igienico sanitarie va intesa, tuttavia, alla luce del combinato disposto
recato dall'articolo
5,
c. 3lett.
a)
e dall'art. 20, c. l . del testo unico, ovvero:
"Ai fini del rilascio del permesso
di
costruire o del certificato
di
agibilità, l'ufficio
di
cui
al
comma l (lo sportello unico) acquisisce direttamente, ove questi non
siano stati già allegati dal richiedente:
a)
il parere dell'
A.S.L.
nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell'articolo
20,
comma
l;
(art.5,
c.
3 lett.
a):
"La domanda per il rilascio del permesso di costruire, [ .. ] va presentata allo
sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo
di
legittimazione,
dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano
i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte Il, nonché da
un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie
nel caso in cui il progetto riguardi interventi
di edilizia residenziale ovvero la
verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-
discrezionali.
36
"
In
sostanza, ritorna in primo piano con il testo unico per l'edilizia, il ruolo svolto
dall' Asl, per gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale.
I l
combinato
disposto delle sopraindicate disposizioni conferma, quindi, il contenuto dell'art.
221, l
o
c. del Tuls:
"Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere
abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa
ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la
costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri
36
Rota G.L. e. Rusconi G Edilizia. Urbanistica. Governo del territorio, cit., p. 62
25

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 32/194
siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di in
salubrità.".
Non possono essere condivise, relativamente a questo aspetto, le considerazioni di
coloro i quali ritengono che il parere dell' A.S.L. fornito in sede progettuale ai fini
dell'ottenimento del permesso di costruire, sia esaustivo anche ai fini del rilascio
del certificato di agibilità
37
•
Ostano a tale interpretazione la lettura dell'articolo 5,
comma 3, del d.P.R. 380/2001, il quale dispone che:
"Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio
di cui al comma l acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati
dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cm non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma l;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio."
L'autocertificazione indicata all'articolo 20, comma
l,
fa riferimento alla
conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto
riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale
conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. Ma, appare opportuno,
per gli interessi che vengono ad essere coinvolti, prima ancora che logico, ritenere
che il richiamo all'articolo 20, comma l che presuppone il parere dell' A.S.L. sia
riferito alle tipologie edilizie (non residenziali) piuttosto che al progetto.
5.
Il comportamento omissivo
Il regime sanzionatorio per l'utilizzo di un edificio privo di certificato di
agibilità era originariamente sanzionato penalmente (articolo 221 II comma del
R.d. 1265/1934). Successivamente, l'articolo 70 comma l lettera b), del d.lgs 30
dicembre 1999, n. 507 in materia di "Depenalizzazione dei reati minori e riforma
37
Foderino D., Il parere dell'ASL e dei W. F. ai fini dell'agibilità in Consulente immobiliare Sole
24 ore, www ilsole24ore.com
26

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 33/194
del sistema sanzionatorio", ha depenalizzato la fattispecie. Attualmente per la
mancata presentazione della richiesta del certificato
di
agibilità
è
prevista una
sanzione amministrativa (da 77,00 a 464,00 euro: articolo
24,
comma 3),
nonostante la normativa tuteli
un
bene
di
rilevanza costituzionale quale il diritto
alla salute.
La novità introdotta dal testo unico consiste nell'anticipazione della sanzione già
al
momento della mancata presentazione della domanda (articolo
24
comma 3).
Ne
consegue che, mentre nella disciplina previgente era sanzionato l'utilizzo
dell'edificio non agibile o non abitabile, con la conseguenza che, in caso di non
uso dell'immobile, doveva reputarsi lecita la mancata richiesta del relativo
certificato, attualmente
è
fatto obbligo
di
richiedere comunque il titolo di assenso,
indipendentemente dall'uso effettivo della costruzione.
I l legislatore, peraltro, non ha preso in considerazione l'ipotesi
di
richiesta tardiva
del certificato anche
se sembra irragionevole equiparare, (ai fini del relativo
trattamento sanzionatorio) il comportamento di chi domanda il titolo dopo la
scadenza del termine previsto dalla legge e quello
di
chi omette
tout court
tale
adempimento, usufruendo di un immobile non dichiarato agibile.
Giova ricordare, al riguardo, che a favore della soluzione ermeneutica appena
citata dispone la ben nota regola di cui all'art.
l,
c.2 della
l.
24 novembre 1981,
n.
689 la quale, come noto, sancisce il divieto di analogia per le leggi che prevedono
sanzioni amministrative.
6.
L 'inagibilità
Nel concreto, possono verificarsi due distinte ipotesi: che l'immobile, già
dichiarato agibile, perda nel tempo le caratteristiche
di
adeguatezza igienico -
sanitaria; oppure che l'edificio sia utilizzato nonostante la mancanza del
certificato, ovvero non ne sia stato autorizzato ancora il suo utilizzo.
E'
evidente
che questa seconda ipotesi non comporta, necessariamente, che l'edificio sia
senz'altro insalubre.
27

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 34/194
Relativamente alla prima ipotesi sarà necessario, accertato l'effettivo stato dei
luoghi, assegnare un termine per effettuare i necessari interventi di risanamento.
Nell'ipotesi in cui, nonostante il termine imposto per l'adeguamento, perduri lo
stato di insalubrità, il comune dovrà procedere alla dichiarazione di inagibilità e al
conseguente sgombero dell'immobile, ai sensi dell'articolo 222 del testo unico
delle leggi sanitarie.
Più complessa la seconda ipotesi in cui, fermo restando ovviamente, la sanzione
amministrativa pecuniaria per l'assenza del certificato di agibilità rectius, per
l'assenza della domanda del certificato di agibilità, il dirigente dei servizi tecpici
dovrà procedere ad emettere ordinanza di sospensione dell'attività eventualmente
esercitata. La particolare situazione conseguente alla modifica del sistema
autorizzatorio per l'agibilità
è
stata già considerata dal Consiglio di Stato
38
•
L'art.
221 del Tuls al I comma, secondo il Giudice di appello, dispone che gli edifici o le
parti di essi di nuova costruzione non possono essere abitati senza essere
preventivamente autorizzati dell'Autorità comunale, che
la
concede dopo che sia
stato accertato che la costruzione sia conforme al progetto approvato, che i muri
siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause d'insalubrità.
In
sostanza, il relazione al contenuto della norma
è
preclusa la possibilità di
abitare o di svolgere una qualsiasi attività in locali per i quali non sia stato
rilasciato il certificato di agibilità. Tale disposizione, puntualizza il Consiglio di
Stato, è rimasta immutata anche dopo le modifiche apportate alla citata norma dal
d.P.R. 22 aprile 1994,
n.
425.
39
Stante il divieto imposto
ex lege
di abitare o svolgere attività in locali privi del
certificato di agibilità, ne consegue che l'Autorità comunale, preposta
all'osservanza della citata norma legislativa, è tenuta ad intervenire laddove ne
riscontri la violazione, disponendo la cessazione dell'utilizzo di locali privi di
certificato di agibilità. In pratica, il potere repressivo è insito nel divieto di abitare
o di esercitare attività in locali privi del certificato di agibilità contenuto nell'art.
38
Cons. Stato, Sez.V,
7luglio
2005
n.
3732
39
Si è già precisato che il d.P.R. 425/1994 è stato incorporato nel testo unico edilizio d.P.R. 380
de12001.
28

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 35/194
221, I comma del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. E' ovvio, afferma la sentenza, che
se una norma pone un certo divieto, l'Autorità cui compete il relativo potere di
vigilanza dispone anche del potere repressivo dell'abuso, che, nella specie, non
può che essere esercitato disponendo la cessazione dell'indebito utilizzo dei locali
privi di agibilità. Quanto alla disposizione contenuta nel comma secondo del
summenzionato art. 221, che prevede l' irrogazione di una sanzione pecuniaria a
carico del contravventore della disposizione contenuta nel comma primo dello
stesso articolo 221, essa non comporta, sostiene ancora il Giudice, che l'esercizio
di un'attività in locali privi
di
agibilità possa essere perseguito unicamente
attraverso l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
Rispondendo, infatti, la disposizione del primo comma dell'art. 221 alla finalità di
tutelare la salute e
l'
incolumità della collettività, è ovvio che la prevista
applicazione di una sanzione pecuniaria ha un esclusivo intento punitivo
dell'abuso, ma la sua applicazione non ha un effetto sanante dell'infrazione
perpetrata. In sostanza, l'abitazione nonché l'esercizio di attività in locali per i
quali non sia stata accertata e dichiarata l'agibilità, potendo nuocere a chi
vi
soggiorna ed anche a chi vi dimora nei pressi, non sono, infatti, tollerabili, in
quanto contrastanti con l'interesse generale, e, conseguentemente, l'Autorità
comunale, competente in materia, è tenuta a disporne la cessazione.
Dal punto di vista degli effetti del rilascio del certificato di agibilità, trattandosi di
titolo non assoggettato a limiti temporali, appare evidente che la sua validità sia
condizionata al permanere di positive condizioni di sicurezza, igiene, salubrità. In
sostanza, il loro venir meno determina l'impossibilità di utilizzo dell'edificio che
non può più ritenersi autorizzato.
40
Anzi, l'insalubrità dei locali, positivamente
accertata ai sensi dell'art. 222 del r.d. 27luglio 1934,
n.
1265, consente l'adozione
dell'estrema misura, costituita dall'integrale abbandono coattivo dei locali stessi.
41
40
A.Benedetti
Certificato di agibilità. Nuove norme e procedure,
in "Geopunto"cit.
41
T.a.r. Sardegna 6 febbraio 2002
n.
115. Per l'obbligo e non la facoltà di disporre lo sgombero
dei locali
si
è espresso,
in
seguito,
i l
medesimo Tar Sardegna con la sentenza
16
giugno 2006
n.
1264. "La mancanza del certificato di agibilità di un locale interessato da uso pubblico, [
.....
]
unitamente alla accertata assenza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza, impone l'adozione
29

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 36/194
da parte dell'autorità comunale del provvedimento di sgombero dei locali medesimi, previsto
dall'art. 222 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato còn il R.D. 1265 dell934.
30

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 37/194
SEZIONE 3
IL TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA: LA SICUREZZA
SOMMARIO:
l . L'agibilità e la sicurezza. -
2.
L'articolo 80 del Tulps e il relativo
regolamento. -
3.
L'articolo
19
del d.P.R. 616 del 1977. - 4. L'unitarietà del
procedimento.
l. L'agibilità e la sicurezza
Se l'articolo 24 del d.P.R. 380/2001 definisce i contenuti del certificato di
agibilità edilizia, nel senso che "attesta la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati", l'articolo 80 del testo unico di pubblica sicurezza Regio
Decreto
18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di pubblica Sicurezza",
(Tulps), attesta le condizioni di sicurezza per una determinata tipologia di locale
pubblico. L'art. 80 Tulps, dispone infatti al primo comma, che "L'autorità di
pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o
di
un
luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione
tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente
adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio."
Fin dall'origine, questa verifica è stata definita come "dichiarazione di agibilità"
anche se sono in molti, impropriamente, a chiamarla "licenza di agibilità".
Va precisato, ad ogni buon conto, che autorevole dottrina
42
concepisce la licenza
ex art. 80 Tulps quale un'agibilità degli edifici, ma a fini particolari, "in quanto
assoggettata a ulteriori verifiche", da qui, per l'appunto, la dizione di "licenza di
agibilità" comunemente utilizzata.
Insomma, si dovrebbe ritenere che per l'apertura di un teatro o di un luogo
di
pubblico spettacolo, siano necessarie due distinte verifiche, ovvero due agibilità e
ambedue connesse ai medesimi aspetti di sicurezza: la prima riconducibile al
42
Sandulli A.M. Manuale di diritto amministrativo, XV ed.,
VolI,
JOVENE EDITORE, Napoli
19,p.625
31

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 38/194
d.P.R. 380/2001, testo unico per l'edilizia, e la seconda all'articolo 80 del testo
unico di pubblica sicurezza. Si può ben dire che una situazione di questo tipo è
certamente non coerente con i l disegno di semplificazione procedimentale che
i l
legislatore ha avviato per la disciplina delle attività economiche, ma
i l
tentativo di
sistematizzare le disposizioni in materia di agibilità è proprio i l fine al quale
si
intende pervenire, con l'individuazione di proposte solutive.
2. L'articolo 80 del Tulps e il relativo regolamento
La complessa disciplina dettata dall'art. 80 Tulps è diretta a garantire la
sicurezza per incolumità pubblica dei luoghi in cui
si
svolgono rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, ed altre forme di spettacolo o trattenimento pubblico,
attività soggette alla visite di prevenzione incendi
43
•
C'è
da dire peraltro, a tale
proposito, che la disciplina di cui
si
tratta non è sorta con i l tulps del '31 essendo
già prevista nel codice Zanardelli
44
e nella relativa legge di pubblica sicurezza
45
•
In conclusione, a più di cent'anni dalla loro originaria formulazione le due
disposizioni di riferimento, anche se hanno cambiato contesto essendo state
riprodotte la prima nel vigente codice penale la seconda nel vigente testo unico
riformato dopo l'entrata in vigore del codice Rocco, continuano a far parte
dell'ordinamento anche se nel frattempo altri istituti ed altre regole più al passo
con i tempi vi sono stati introdotti, quali ad esempio il certificato di agibilità
previsto dal d.P.R. 380 del 2001, testo unico edilizia e le regole tecniche di
prevenzione incendi previste dal decreto del Ministero dell'interno 19 agosto 1996
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di in rattenimento e di pubblico spettacolo".
43
Cass. Sez. I, 25 maggio 1999,
n.
5056 in www.jurisdata.it
44
L'art. 447 del codice Zanardelli disponeva che "Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico
spettacolo o ritrovo, senza averne osservato le prescrizioni stabilite dall'Autorità a tutela
dell'incolumità pubblica, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda; e in caso di
recidiva nello stesso reato, l'ammenda non può essere inferiore a lire 300".
45
L'art. 78 del testo unico di pubblica sicurezza, regio decreto 6 novembre 1926
n.
1848,
disponeva che: "L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un
teatro o di altro locale di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione
tecnica la solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo
prontamente in caso di incendio".
32

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 39/194
l testo unico, comunque, non esaunsce la disciplina di settore. Infatti, la
disciplina primaria è integrata dal "Regolamento per l'esecuzione del testo unico
18
giugno 1931,
n.
773 delle Leggi di pubblica Sicurezza" approvato con regio
decreto 6 maggio 1940,
n.
635.
Dall'art.
141
all'art.
145
del regolamento di esecuzione del Tulps
è
disciplinata la
costituzione e i l funzionamento della commissione tecnica chiamata ad esprimersi
sul possesso dei requisiti di sicurezza dei locali. Tali articoli sono stati,
sostanzialmente, modificati dal d.P.R. 28 maggio 200 l
n.
311, con la previsione di
una commissione comunale laddove precedentemente era competente
esclusivamente una commissione provinciale di nomina prefettizia.
La commissione comunale, secondo le modifiche al regolamento Tulps, introdotte
dal d.P.R.
311
del 200
l,
opera per le finalità di cui all'art. 80 Tulps per le seguenti
tipologie di locali: cinema, teatri e spettacoli viaggianti con capienza pari o
inferiore
ai
1.300 posti; tutti gli altri locali o impianti con capienza pari o inferiore
a 5.000 posti e, infine, i parchi di divertimento dove non sono presenti attrezzature
meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli
spettatori o del pubblico partecipante
ai
giochi superiori ai livelli indicati con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il
Ministro della sanità; in tal
caso, infatti,
è
competente la commissione provinciale.
Specificatamente, i compiti della commissione sono elencati nell'art.
141
del
regolamento Tulps e riguardano le seguenti attribuzioni:
a)
esprimere
i l
parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di
pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli
esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o
degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia
nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e
degli avvisi per
i l
pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
33

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 40/194
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.
3,
anche avvalendosi di personale tecnico di altre arruninistrazioni pubbliche, gli
aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui
all'articolo 4 della legge
18
marzo 1968,
n.
337
46;
46
La competenza indicata alla lettera d) riguarda le attrazioni per lo spettacolo viaggiante.
Relativamente a questo settore e alla competenza della commissione comunale di vigilanza
pubblico spettacolo, va registrato il fatto che in GU n. 136 del 14 giugno del 2007
è
stato
pubblicato il d.m.
18
maggio 2007 che assegna, ai comuni, la competenza di certificare la
sicurezza della attrazioni per lo spettacolo viaggiante. A tale proposito va evidenziato che con
l'articolo 4 della legge
18
marzo 1968, n. 337, "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo
viaggiante",
è
stato istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle
attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico
- costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Circa trent'anni dopo, e precisamente con d. lgs 3/1998 all'articolo 4, la cui rubrica recita
"commissione apertura sale cinematografiche"
è
stato aggiunto al comma 2 un periodo (cosiddetto
intruso) il quale dispone che:
"Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di
altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di
sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge
18
marzo
1968, n. 337."
Le commissioni provinciali, previste dal regolamento al testo unico di pubblica sicurezza erano e
tuttora sono, di nomina prefettizia ed operano all'interno delle strutture dello Stato.
Con il d.P.R. 311/2001, regolamento di delegificazione emanato ai sensi l'articolo 17, comma 2,
della l. 400/1988, alle commissioni provinciali sono state sostituite le commissioni comunali che,
di conseguenza, sono competenti
a:
"accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di
personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al
fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge
18
marzo 1968, n. 337;"
Va rilevato, tuttavia, che fermo restando il riparto delle competenze in materia di polizia
amministrativa e pubblica sicurezza che ha ormai copertura costituzionale con la chiara
ed
inequivocabile distinzione operata dal decreto leg.vo 11211998, l'art. 118 Cost. prevede che "Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."
Ne consegue un dubbio di legittimità, quindi,
in
capo al d.m.
18
maggio 2007 in quanto le
competenze alle autonomie locali possono essere conferite con legge e non certamente, quindi, con
un d.m. Ma a prescindere da tale considerazione, l'interrogativo che ci si deve porre, alla luce della
norma, è se la certificazione delle attrazioni per lo spettacolo viaggiante è funzione statale ma,
implicitamente, delegata ai comuni con il decreto sopraindicato o, invece, è funzione propria dei
comuni in base al trasferimento delle competenze disposta dal d.P.R. 616/1977. Si potrebbe
ritenere, infatti, che la verifica della sicurezza delle attrazioni per lo spettacolo viaggiante altro non
sia che una fase connessa al procedimento autorizzatorio per l'esercizio dell'attività ex articolo 69
tulps, la cui competenza è stata trasferita ai comuni con il già indicato d.P.R. 616/1977; ai comuni,
infatti, compete la verifica dell'agibilità prevista dall'articolo 80 tulps.
Va evidenziato, peraltro, che la previgente disciplina di certificazione e contestuale assegnazione
del contrassegno metallico alle attività dello spettacolo viaggiante era di competenza del Ministero
del turismo e spettacolo, così come risulta evidente dall'articolo 5 della circolare 27 settembre
1989 n. 4803rrB30 del suddetto ministero. E, a tale proposito, è ben noto che il trasferimento di
competenze deve essere preceduto dal trasferimento delle risorse.
34

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 41/194
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte
e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità
competente gli eventuali provvedimenti.
Lo stesso articolo
141
del regolamento disciplina le eccezioni e le deroghe che
riguardano i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200
persone. In tal caso, le verifiche e gli accertamenti sul rispetto delle indicazioni
fomite dalla commissione in sede di parere sul progetto, possono essere sostituite,
ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica redatta da
un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti, dei
periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del locale o
dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
La funzione relativa
al
rilascio delle autorizzazioni per l'attività di trattenimento,
prevista dall'articolo 68 Tulps e la prioritaria verifica dell'agibilità dei locali
prevista dali' articolo 80 del medesimo Tulps
è esercitata dai comuni. Ciò è
avvenuto a seguito della legge 22luglio 1975
n.
382 con la quale
è
stata conferita
delega al Governo per il secondo trasferimento delle competenze dallo Stato alle
Dirimere la questione (pubblica sicurezza o polizia amministrativa) e sciogliere i dubbi
interpretativi diventa sostanziale anche perchè l'interrogativo non è di poco conto. Nel primo caso,
infatti, la competenza sarebbe del sindaco nella sua qualità di ufficiale del governo o autorità di
pubblica sicurezza e non in quanto vertice dell'amministrazione comunale, che la potrebbe
comunque delegare ad un funzionario, mentre nel caso in cui la materia rientrasse nella polizia
amministrativa la funzione sarebbe di competenza del dirigente competente in base alla distinzione
operata dal t.u.e.l. 267/2000. La questione è rilevante perché l'emanazione di atti da parte di un
soggetto incompetente ne potrebbe determinare la loro nullità.
Il successivo interrogativo è ancor più complesso. Ci si chiede, infatti, se la materia rientra
nell'ambito della polizia amministrativa, la cui potestà legislativa è attribuita alle regioni (dopo la
modifica del titolo V Tulps) e le cui funzioni sono state assegnate ai comuni con il più volte
richiamato d.P.R. 616/1977 (e successivo decreto legislativo 11211998), a quale titolo il Ministero
dell'Interno interviene nel fornire direttive in materia, come è stato con la circolare 570 del 2
maggio 2008 che, seppur inviata ai direttori e comandanti dei vigili del fuoco e, per conoscenza ai
prefetti, invitava gli stessi a fornire indicazioni ai comuni sulle procedure da adottare per le
attrazioni già in attività all'entrata in vigore delle nuove disposizioni?
In pratica, ancora una volta
si
evidenzia che il confine tra polizia amministrativa e pubblica
sicurezza (o pubblica incolumità) viene facilmente superato creando le condizioni per un conflitto
di attribuzioni. Sta di fatto che nessuna regione ha impugnato detto provvedimento anche perché,
come si è argomentato in altro paragrafo, nessuna regione ha ancora emanato disposizioni nelle
materie trasferite sia con il d.lgs 112/1998 sia a seguito della legge Cost. 3 del2001.
35

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 42/194
regioni.
47
Le nuove attribuzioni ai comuni in materia di polizia amministrativa
hanno trovato, poi, individuazione nell'art. 19 del d.P.R. 616 del1977
48
•
3. L'articolo 19 del d.P.R. 616 del1977
La corretta interpretazione dell'articolo 19 del d.P.R. 616 del 1977 e,
specificatamente per l'analisi in argomento, di alcuni punti nello stesso compresi,
ha aperto fin da subito, un contenzioso di cui hanno avuto modo di occuparsene,
per quanto di loro competenza, i l Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale.
49
47
Giova ricordare, a tale proposito, che i l terzo e conclusivo trasferimento disposto dal decreto
legislativo 112/1998 non è ancora operante nel Friuli Venezia Giulia in attesa della conclusione
del lavoro da parte della apposita commissione paritetica. Il trasferimento delle competenze
relative sia al d.P.R. 616/1977 sia al d.lgs
11211998
non è stato ancora disposto, invece, dalla
regione Sicilia.
48
Le funzioni previste dall'art. 19 del d.P.R. 616/1977 nella regione Friuli Venezia Giulia sono
state esercitate dopo l'emanazione del d.P.R.15 gennaio 1987 n. 649.
49
La Corte Cost.
si
è pronunciata con diverse sentenze, citate peraltro in altre sezioni, sulla
questione della "Polizia amministrativa" che rubrica l'art.
19
del d.P.R. 616/1977. Nonsiante le
diverse pronunce, tuttavia, se la "Polizia amministrativa" è una funzione o una materia, allo stato
attuale non è stato ancora definito. Al riguardo la Corte Cost. nella sentenza n.
115
depositata
i l
7
aprile 1995 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
3,
comma
l,
e
12,
comma
2,
del
decreto legislativo 13 luglio 1994,
n.
480, recante "Riforma della disciplina sanzionatoria
contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n.
773", promosso con ricorso della Regione Toscana, ha affermato che la polizia amministrativa è
connessa alla funzione collegata e così, ad esempio, "Per quanto riguarda l'art.
111
del testo unico
di pubblica sicurezza, relativo all'obbligo della licenza per l'esercizio dell'arte tipografica,
litografica, fotografica e di qualunque altra arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica
in molteplici esemplari, [ ...] deve ritenersi che le norme in esame rientrino nelle competenze
regionali nella misura in cui siano riconducibili alla materia dell'artigianato, di cui all'art. 117 della
Costituzione; limitatamente cioè alle ipotesi in cui ricorrano le condizioni, soprattutto di ordine
dimensionale, dettate dalla legge-quadro 8 agosto 1985,
n.
443, che qualificano le imprese
artigiane.
Di diverso avviso, relativamente a questo aspetto in una nota a margine di questa sentenza,
Mangiameli S.
La polizia locale urbana e rurale: materia autonoma o potere accessorio e
strumentale?
in Giur.
Cast.
1996, 01, p. 457. In tale nota, si afferma
che
... non è da escludere
che-
come «funzione» (e cioè: come potere finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico)
- la «polizia amministrativa>> possa rivestire un carattere strumentale, idoneo a garantire
i l
rispetto
della disciplina di altre materie enumerate, ma nella disposizione costituzionale che prevede
nell'enumerazione la voce «polizia locale urbana e rurale» è espressamente detto che «la Regione
emana per le seguenti materie norme legislative ... » (art. 117 Cost.). Si evince (quindi)
agevolmente che questa non rappresenta solo una qualificazione formale, costituendo - come si
ammette anche in altri casi di poteri presi in considerazione come «materie» .
. Infatti, l'assegnazione di una materia alle Regioni, per la legislazione e l'amministrazione,
comporta una puntuale garanzia di contenuto, che trova i l suo riscontro:
a)
nell'individuazione
degli oggetti afferenti agli ambiti sistematici caratterizzanti una parte dell'ordinamento, da cui si
deduce la «nozione presupposta>>, cristallizzata dalla Costituzione; b) nella disponibilità degli
oggetti medesimi per interventi giuridici di tipo sostanziale. Si può, allora, concludere asserendo
36

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 43/194
Specificatamente, in relazione alla commissione di vigilanza pubblico
spettacolo va evidenziata, relativamente ali' aspetto in trattazione, l'iniziati va del
comune di Milano che, alla bocciatura della deliberazione di approvazione del
regolamento
di
nomina della commissione da parte dell'allora comitato
di
controllo
50
, ricorse ai diversi gradi fino ad ottenere il pronunciamento del
Consiglio di Stato il quale, con sentenza n. 556 del 30 settembre
1987
(Regione
Lombardia e Ministero Interno/ comune di Milano) si espresse in termini
favorevoli al comune affermando che "Le funzioni di polizia amministrativa di
cui all'art. 19 d.P.R. 24luglio
1977
n. 616 sono riferibili unitariamente alle diverse
materie decentrate agli enti locali, in relazione alle quali i comuni hanno il potere
non soltanto di emanare l'atto finale del procedimento, ma anche di condurre i
relativi accertamenti istruttori, nonché di porre norme regolamentari anche per
quanto attiene all'organizzazione delle competenze e disciplina delle procedure."
51
Il comune di Milano, in sostanza, aveva ritenuto di nominare una propria
commissione comunale la cui composizione era diversa da quella individuata dal
regolamento Tulps, non ritenendosi condizionato dalla disposizione statale in
forza della norma contenuta nell'art.
19
d.P.R. 616 del
1977
che, relativamente
alle funzioni trasferite ai comuni, prevede che "Fino all'entrata
in
vigore della
legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano
procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle
funzioni".
che nell'ordinamento regionale
si
situa una «potestà di polizia amministrativa» che
è
un potere
accessorio e strumentale, cui fa riferimento anche l'art. 9 d.P.R.
n.
616 del 1977, e che ha trovato
nella legislazione regionale una ricca utilizzazione attraverso la definizione del «modo di
disciplina» (tipico dell'attività di amministrazione attiva) degli oggetti delle varie materie
enumerate, come la previsione di una autorizzazione sull'attività
di
cava, il divieto del taglio degli
alberi in agricoltura, l'ordine di esporre i dati sulla qualità degli alimenti per fini sanitari, le
acquisizioni amministrative di manufatti edili abusivi. Questo potere di polizia, infatti, diventa
parte necessaria della disciplina della materia per il perseguimento dei fini riconducibili alla
medesima
e,
come può evincersi anche dai molteplici esempi offerti dalla legislazione regionale,
ha la seguente articolazione:
a)
l'individuazione sul piano normativo delle fattispecie; b) l'esercizio
dell'attività di polizia (vigilanza, prevenzione, ecc.); c) l'emanazione dei provvedimenti
di
polizia
(ordini, autorizzazioni, ecc.).
50
I comitati regionali e di controllo sono stati soppressi, da tutte le regioni, a seguito della novella
del titolo V Cost. che non ammette, più,
in
relazione ali' art. 114 la gerarchia tra enti prevista
dall'originaria formulazione.
51
Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 1987
n.
556 in "Il Consiglio Stato", n. 9/1987, p. 1233.
37

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 44/194
La questione è, oggi, di ancor maggiore attualità ed interesse, in relazione alla
modifica del titolo V
Coste
alla costituzionalizzazione dell'esercizio della potestà
regolamentare da parte dei comuni. Se, infatti, prima della novella la potestà
regolamentare era esercitata dal soggetto titolare della potestà legislativa, oggi la
potestà regolamentare è esercitata dal titolare della funzione, come di seguito sarà
adeguatamente approfondito.
4.
L'unitarietà del procedimento
Le questioni connesse all'oggetto della verifica prevista dall'art. 80 Tulps,
e alla composizione della commissione e provinciale prevista dagli articoli
141
-
142
del regolamento al Tulps novellato, per la parte in questione, dal d.P.R. 311
del 200 l saranno, comunque, ampiamente esaminate in altra sezione. Ciò che
premeva evidenziare, fin d'ora, in questo primo capitolo nel quale viene preso in
esame i l quadro di riferimento normativo, è che in materia di agibilità e di
sicurezza, nonostante l'attivazione dello sportello unico per le attività produttive e
quello per l'edilizia, non
c'è
ancora alcun raccordo e si continua ad operare come
nel passato.
C'è stato un originario orientamento in cui prevaleva una visione dell'ordinamento
amministrativo nella quale ogni singolo potere sarebbe attribuito alla pubblica
Amministrazione in funzione della tutela di uno specifico interesse pubblico, in
modo tale che l'esercizio di ciascuno di quei poteri, anche se appartenenti allo
stesso ente, restava circoscritto al relativo settore di intervento e dava luogo a
procedimenti amministrativi destinati ad operare singolarmente ed
al
di fuori di
forme di coordinamento, ma oggi così non è più.5
2
In effetti, già la legge n. 241 del 1990 rappresenta una più compiuta esplicitazione
dei contenuti del canone costituzionale del buon andamento dell'Amministrazione
pubblica, nel senso che l'esercizio dissociato dei poteri che fanno capo allo stesso
ente per la realizzazione di più interessi pubblici, specie ove tra di essi sussista un
52
Il suddetto orientamento
è
stato meditatamente rivisto dal Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2000,
n.3639
38

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 45/194
obiettivo collegamento, si pone contro il basilare criterio di ragionevolezza e,
pertanto, in evidente contrasto con il principio di buona amministrazione.5
3
In quest'ottica, la fondamentale legge n. 24111990, che espressamente prevede,
all'articolo 14, l'ipotesi di una pluralità di interessi pubblici
54
coinvolti in uno
stesso procedimento amministrativo e di un loro "esame contestuale", disegna un
modello procedimentale in cui una delle funzioni principali è proprio quella di
coordinamento ed organizzazione dei fini pubblici, come dimostrano istituti quali
la comunicazione dell'avvio del procedimento, la partecipazione degli interessati,
il responsabile del procedimento ed, infine, la stessa conferenza di servizi.
55
53
In particolare, nei sensi ora detti la decisione del Co ns. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5656.
54
Secondo la dottrina, Caringella F. Delpino L. Giudice (del) F. Manuale di diritto
amministrativo XXII ed., Simone, Napoli, 2005, una particolare forma di coordinamento e
collaborazione tra organi o uffici appartenenti a pubbliche amministrazioni diverse è costituita
dalla conferenza di servizi, figura introdotta o, meglio, positivizzata, in quanto la realtà aveva già
portato alla creazione di figure di cooperazione tra soggetti diversi all'interno della P.A. dalla legge
7 agosto 1990, n. 241 e notevolmente modificata dalla L. 15/2005. Essa rappresenta in linea
generale lo strumento per realizzare
i l
giusto contemperamento tra le esigenze di concentrazione
delle funzioni in un'unica istanza ed
i l
rispetto delle competenze delle amministrazioni preposte
allo cura di un determinato settore, consentendo la contestuale valutazione di tutti gli interessi
pubblici coinvolti in una determinata operazione amministrativa" (così C.d.S. Sez. IV, sent. 24-2-
2000, n. 1002).
55
In tal senso anche la sentenza Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2005 n. 1543
39

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 46/194
O

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 47/194
CAPITOLO SECONDO
DECENTRAMENTO, REGOLAMENTAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA
SOMMARIO
l. Premessa. -
2.
La semplificazione amministrativa nella legge 59
del 1997.- 3. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. - 4. Il nuovo assetto
dei rapporti dopo la novella del titolo V. - 5. Potere legislativo e potere
regolamentare. - 6. Polizia amministrativa e pubblica sicurezza - 7. Il d.P.R. 616
del 1977. -
8.
La potestà normativa prevista dall'art.
19
d.P.R. 616 del 1977. - 9.
Norme procedurali e norme sostanziali.
10.
Regolamentazione e
semplificazione. - 11. I regolamenti di semplificazione e di delegificazione. - 12.
La potestà regolamentare comunale. - 13. Il d.P.R.
311
del 2001. -
14.
La
categoria "polizia amministrativa". - 15. Autorizzazioni o licenze?. - 16.
Semplificazione a carattere generale. -
16.
Autocertificazione e controlli. -
17.
Commissione comunale e commissione provinciale - 18. La Costituzione
economica
si
consolida.
l. Premessa
Nell'ordinamento costituzionale che ha attribuito al popolo la titolarità
della sovranità, lo Stato persona è divenuto lo strumento mediante il quale il
popolo stesso esercita il potere sovrano. In tale contesto, l'Amministrazione cessa
di essere un corpo chiuso e separato dal complesso dei cittadini, i quali diventano
invece titolari di pretese nei confronti di essa. In sostanza, oggi il concetto di
pubblico non può più essere fatto risalire allo Stato inteso come ente, perché al
contrario, la fonte di ogni potere
si
ritrova nell'ordinamento sociale. Il primato dei
diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali, il medesimo
riconoscimento delle autonomie locali, indicano la necessità di operare un
capovolgimento di prospettiva configurando un potere che va dal basso verso
l'alto.
In
quest'ottica, il rovesciamento dell'elencazione degli enti territoriali
nell'art. 114 sancisce valori che sviluppano l'impianto costituzionale originario,
come l'ispirazione di avvicinare governati e governanti comporta il radicamento
dell'Amministrazione nello Stato comunità, ovvero nell'ordinamento sociale.
1
1
Cariola A., voce Pubblica amministrazione (principi Cost.) in Il diritto Enc.giurid. Vol 12, Il
sole 24 ore Spa- Pirola, Bergamo, 2008, p. 517
41

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 48/194
Ed
è
proprio la presa di coscienza di questo senso di appartenenza all'ordinamento
sociale che rende il cittadino utente sempre più attento al funzionamento della
pubblica Amministrazione e alla sua capacità di soddisfare i propri bisogni,
attraverso un'azione di rivendicazione dei diritti che non sempre trova adeguata
risposta. Nonostante il processo di trasformazione e modemizzazione delle
amministrazioni pubbliche avviato nei primi anni novanta e finalizzato a
migliorare la soddisfazione dei cittadini e delle imprese per i servizi offerti dalle
amministrazioni pubbliche, poco è cambiato e non si può dire che le riforme
abbiano dato ancora buoni frutti.
Tale processo di modernizzazione e trasformazione, infatti, se da
un
lato ha
riconosciuto l'importanza, in tema di qualità dei servizi pubblici e
il
ruolo centnile
del cittadino, non solo nella veste di destinatario dei servizi ma anche quale
risorsa strategica per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali,
dall'altro, tale processo è stato soltanto parzialmente in grado di soddisfare le
aspettative annunciate, così mantenendo (e forse giustificando) quel livello di
malanimo che permane nell'immaginario collettivo e che, a volte, viene
politicamente abilmente sfruttato. A poco sono serviti, ad esempio, sotto questo
punto di vista, i buoni propositi contenuti nell'articolo 12
2
decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.
29
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego" così come
la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
27
gennaio 1994, che
individuavano la partecipazione e l'ascolto dei cittadini quali strumenti utili e
costruttivi per verificare la qualità e l'efficacia dei servizi prestati.
2
L'articolo 12 del d.lgs 29/1993 ha previsto l'istituzione nelle amministrazioni pubbliche
dell'ufficio relazioni con il pubblico. In particolare, dispone il comma 5 bis di tale articolo che "Il
responsabile dell'ufficio per le relazioni con
il
pubblico e
il
personale da lui indicato possono
promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per i l pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento
delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e
ai
documenti amministrativi." Peraltro, con l'articolo 5 quater tale disposizione è stata estesa, a
decorrere dal 1luglio 1997, a tutto i l personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.
42

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 49/194
2.
La
semplificazione amministrativa nella legge 59 del1997
La legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha concesso "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", ha avviato un
processo riformatore che trova un filo conduttore nel tentativo di recuperare
efficienza e trasparenza ad una pubblica amministrazione assai carente. Non è
possibile, oggi, affermare che l'obiettivo sia stato raggiunto. Ciò che, invece, è
certamente possibile fare, è asserire che questa legge rappresenta un caposaldo
nella riforma della pubblica Amministrazione.
Tuttavia, relativamente alla riforma avviata dalla legge 59 del 1997 "La fase della
implementazione, [
...
], è decisiva: innanzitutto perché le leggi da sole non
cambiano
la
vita degli uomini e delle donne, e neppure il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche.
Ma
anche per un'altra ragione: perché nessuna
riforma nasce perfetta, e solo nella fase della sua implementazione si scopre che
cosa non ha funzionato, che cosa deve essere corretto, rivisto, integrato; si può
fare in altri termini, quel lavoro di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che
consente di correggere quei tasselli del disegno riformatore, magari anche solo dei
dettagli, che impediscono il corretto e convincente funzionamento dell'intera
riforma.
E'
per questo che le riforme amministrative devono essere progettate e
varate con metodo bipartisan: per evitare che successivi cambi di maggioranza
blocchino la riforma nella sua fase decisiva, quella della sua implementazione?"
Non si può nascondere, peraltro, che i testi unici, i regolamenti di delegificazione
e di semplificazione, l'autocertificazione, insomma tutte le grandi rivoluzioni che
hanno dominato e caratterizzato in questi ultimi dieci anni l'attività della pubblica
Amministrazione, partono dalla legge 59 del 1997, ed è per questo motivo che
qualsiasi opera di sistematizzazione della normativa non può che trovare alimento
3
Bassanini F. relazione tenuta al Convegno
su:
Le riforme amministrative a dieci anni dalla
Riforma Bassanini,
organizzato dall'Università di Roma Tre a Roma,
i l
30-31 gennaio 2008 in
astrid on line
43

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 50/194
dallo spirito che nel 1997 animava il Parlamento, al di là di ogni appartenenza
politica.
La legge 59 del 1997 si articola in tre oggetti principali costituiti dal conferimento
di funzioni alle regioni e agli enti locali, dalla riforma delle amministrazioni
centrali, degli enti e delle istituzioni scolastiche e dalla delegificazione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
n conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali è avvenuto a Costituzione
invariata e attraverso la individuazione delle attribuzioni che restano allo Stato,
invece che di quelle da trasferire. In tal modo
si
è avviato un processo forte di
trasformazione dell'ordinamento in senso federale. La legge, inoltre, ha fissato i
criteri ai quali il legislatore delegato
si
deve ispirare, individuando le funzioni da
mantenere in capo alle amministrazioni centrali, nonché i blocchi di funzioni da
trasferire ispirandosi ai principi di sussidiarietà, di responsabilità, di unicità
dell'amministrazione, di omogeneità e di adeguatezza.
Con riferimento alla semplificazione, la legge 59 del 1997 ha autorizzato il
Governo ad intervenire per disciplinare, con norme di rango regolamentare, quei
procedimenti amministrativi che risultano particolarmente farraginosi, lenti e poco
coordinati. Inoltre, è contemplata la compilazione di testi unici, soprattutto nelle
materie interessate all'attuazione della legge medesima, al fine di ridurre il
numero delle leggi e rendere più semplice e chiara la disciplina. Il testo unico per
l'edilizia, di cui si è già parlato, ad esempio, parte da questa legge riformatrice.
Da una costola della legge 59 del 1997 è derivato anche il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, recante norme sul "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59". In sostanza, l'atto normativo con il quale
si
è
dato corpo ad una redistribuzione delle funzioni pubbliche e all'avvio della
stagione del federalismo.
4
4
TI
d.lgs 112/1998
ha
disposto la distribuzione di funzioni in diversi ambiti. Nell'ambito del settore
dello sviluppo economico, sono state trasferite le competenze di agricoltura e foreste (materia
disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143), artigianato, industria, energia, miniere e
44

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 51/194
Con questo decreto sono stati disposti i trasferimenti di competenze riguardanti la
sanità pubblica, le politiche sociali, l'istruzione, i beni culturali e, soprattutto, la
polizia amministrativa.
3.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.
112
Con l'emanazione del d.lgs.
n.
112 del marzo 1998 il Governo ha
provveduto all'esercizio della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997,
conferendo nuove funzioni al sistema delle autonomie locali in alcune materie
specificatamente individuate. Tale conferimento è stato effettuato attraverso un
meccanismo che, rispettando l'impostazione del precedente d.P.R. 616 del 1977,
individua le materie oggetto di decentramento amministrativo in modo residuale
rispetto a quelle che rimangono di competenza statale, e che vengono
esplicitamente richiamate dali'
art. l,
comma l, attraverso l'indicazione della
disciplina normativa che le riguarda. La norma delegata stabilisce che l'esercizio
delle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, inizi a decorrere
contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse (art.?, comma
l). Tale decorrenza è determinata con appositi decreti emanati dal Consiglio dei
ministri per l'individuazione ed il trasferimento dei beni e delle risorse statali,
necessarie a garantire la "congrua copertura degli oneri" consequenziali
all'esercizio delle funzioni conferite. Relativamente alle funzioni ed ai compiti
conferiti alle regioni ed agli enti locali, è conservato in capo allo Stato il potere di
risorse geotermiche, ordinamento delle camere
di
commercio, fiere e mercati e commercio,
turismo ed industria alberghiera.
In materia di territorio, ambiente e infrastrutture,
si
sono rinviate competenze
su
territorio e
urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e
gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità, trasporti e
protezione civile; in particolare
si
è ordinato che il capo del Governo entro due anni, con proprio
decreto, declassificasse tutte le strade statali che non facessero parte della rete nazionale
principale; con questo articolo sono state trasferite alle regioni e alle province circa 15.000 km
di
strade. In materia di urbanistica
si
sono anche soppresse le previgenti funzioni consultive spettanti
al Consiglio superiore dei lavori pubblici su questioni di interesse urbanistico. Parimenti,
è
stato
soppresso il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori
pubblici. Uno dei tratti salienti è il trasferimento della maggioranza delle strade statali dal
patrimonio statale ANAS
al
patrimonio delle Regioni (strade regionali), ed eventualmente a quello
delle Province, con lo scopo evidentemente di migliorarne la manutenzione, concedendone la
proprietà all'ente più vicino, secondo il principio di sussidiarietà.
45

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 52/194
emanare atti di indirizzo e di coordinamento nella forma di deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, o con la
singola regione interessata.
Con le riforme del c.d. "federalismo amministrativo"
è
stata spostata nella
dimensione regionale e locale una ampia quota di compiti relativi allo "sviluppo
economico e alle attività produttive", come si esprime il Titolo II del d.lgs. 112
del 1998, sintetizzando così un ambito di nuovo impegno e responsabilità delle
regioni e degli enti locali nel quale venivano fatte confluire più materie fino allora
trattate settorialmente. Al conferimento di compiti si accompagnano, inoltre,
disposizioni volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti in ordine agli
insediamenti produttivi e il riconoscimento dell'autonomia funzionale alle camere
di commercio, salvo il controllo delle regioni sugli organi camerali e alcune
funzioni di livello nazionale, per le quali in parte
si richiede l'intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni ed in parte la deliberazione della Conferenza unificata.
L'ampio conferimento di compiti per lo "sviluppo economico e le attività
produttive" nella legge 59 del1997
e nel d.lgs. 112 del1998, che interessa diverse
attribuzioni disciplinate dal Tulps e che erano rimaste escluse dal primo pacchetto
di conferimento ai comuni disposto con
i l
d.P.R. 616 del 1977, era inserito in una
cornice normativa che definiva - in modo tassativo, secondo la regola "federalista"
della legge 59 - i compiti statali esclusi dal conferimento e postulava l'esistenza di
un sistema di relazioni collaborative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali. Tra i
compiti statali vi erano funzioni di regolazione a carattere generale e determinate
attività di promozione (da identificare secondo i criteri, tra gli altri, della loro
rilevanza economica strategica e della valutabilità solo su scala nazionale per i
caratteri del settore e per assicurare la concorrenza), in molti casi richiedendo la
partecipazione regionale alle decisioni.
5
5
Desideri C., Lo sviluppo economico locale. verso una nuova materia regionale? In Rapporti su
regioni e attività produttive, www.issirfa.cnr.it
46

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 53/194
L'art.
l,
al comma 3, lettera
1),
aveva tuttavia escluso dal conferimento le funzioni
e i compiti riconducibili alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza
pubblica.
4. Il nuovo assetto dei rapporti dopo la novella del titolo V
La legge Cost. n. 3 del 200 l intitolata "Modifiche al titolo V della
Costituzione" ha introdotto innovativi principi nell'ordinamento, atti ad incidere
sensibilmente sui rapporti tra Stato e autonomie, caratterizzandoli in senso
"federalistico" ma con copertura costituzionale, differenziandosi in ciò, rispetto
alle competenze e funzioni attuate con il d.lgs 112 del 1998. Basti pensare
al
principio di sussidiarietà, che è stato costituzionalizzato dall'art. 118 con
riferimento alla allocazione delle funzioni amministrative, ma che indubbiamente
informa anche il criterio di ripartizione delle funzioni legislative che è stato
introdotto dal nuovo art. 117, in base al principio di parità formale tra Stato,
regioni ed enti locali, introdotto dall'art. 114 Co st.. Il nuovo art. 117, che, ad una
prima lettura, sembrava aver devoluto alle autonomie regionali rilevantissime
competenze legislative, avendo espressamente riservato allo Stato le specifiche
competenze delineate dal comma secondo, oltre ad una potestà legislativa di
principio nelle materie elencate dal comma terzo è stato, peraltro, ridimensionato
dall'intervento della Corte costituzionalé in favore di un sistema di ripartizione
6
Con la sentenza depositata l ' l ottobre 2003 n. 303, la Corte Costituzionale ha affermato che: "Il
nuovo art. 117 Cost. distribuisce le competenze legislative in base ad uno schema imperniato sulla
enumerazione delle competenze statali; con un rovesciamento completo della previgente tecnica
del riparto sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative
residuali. In questo quadro, limitare l 'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente
attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà
concorrente, come postulano le ricorrenti, significherebbe bensì circondare le competenze
legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltrernisura istanze
unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale
giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti
pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco
(konkurrierende Gesetzgebung) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense
(Supremacy Clause)]. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a
rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e
funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di
unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principi giuridici,
trovano sostegno nella proclamazione di unità e indi visibilità della Repubblica
47

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 54/194

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 55/194
esigenze dell'autonomia e del decentramento", riconobbe anche che essi erano e
restavano forti e vitali, pronti a reggere la sfida del futuro.
9
5.
Potere legislativo e potere regolamentare
Nel sistema precedente, per il principio del parallelismo che lo innervava, i
depositari del potere legislativo erano anche depositari e titolari delle
corrispondenti funzioni amministrative, e comunque di tutte le funzioni che non
fossero state attribuite o delegate agli enti territoriali. Nel sistema attuale i titolari
del potere legislativo, al pari di tutti gli altri livelli di governo, non hanno altro che
le funzioni che ad essi possono legittimamente essere assegnate dalle leggi in virtù
del principio del loro esercizio unitario, e sempre nel rispetto più rigoroso del
principio di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, mentre gli enti
territoriali diversi dalla regione hanno tutti un nucleo, comunque da definire e da
rispettare, di competenze proprie che spettano ad essi in virtù della norma
costituzionale.
10
La
riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione recata dalle leggi Cost.
n.
l del 1999 e n. 3 del 200 l ha profondamente mutato, quindi, non solo l'assetto
complessivo della potestà legislativa, ma anche quello della potestà regolamentare
dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali, affidando ai comuni l'esercizio
delle funzioni amministrative e, per queste, la potestà regolamentare.
L'art. 117 novellato, prevede l'attribuzione della potestà regolamentare allo Stato
nelle (sole) materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni; alle regioni
in ogni altra materia e alle autonomie locali: comuni, province e città
metropolitane, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite dallo Stato.
9
Pizzetti F.,
Piccoli comuni e grandi compiti:
la
specificità italiana di fronte ai bisogni delle
società mature
in Formiconi D.(a cura di),
Comuni, insieme, più forti,
EDK, Rimini, 2008, p. 45
10
Pizzetti F.,
Il sistema costituzionale delle autonomie locali (tra problemi ricostruttivi e problemi
attuativi),
in "Le Regioni", n. 1-2, Il Mulino, Bologna, 2005,49-102
49

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 56/194
Va peraltro rilevato, a tale proposito, che la presenza, fra le materie di esclusiva
competenza dello Stato, di una serie di ambiti di disciplina che non possono
definirsi "materie" in senso stretto, (per ciò che riguarda questo lavoro: salute,
edilizia, sicurezza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto i l territorio
nazionale), fa sì che esse interferiscano, per loro natura, in modo "trasversale" con
vari campi di intervento legislativo e in alcuni casi possano incidere in modo
significativo su materie affidate alla competenza regionale, compresa quella
esclusiva, con le conseguenti ricadute sul piano della potestà regolamentare.
Comunque si può ben dire che, con la riforma disposta dalla l. Cost. n. 3/200l, un
ruolo di particolare rilievo è stato assunto dai regolamenti. Questi - appena
menzionati nella Costituzione del1948 (quelli statali, all'art. 87, relativo al potere
del Presidente della Repubblica di emanarli; quelli regionali, all'art. 121, che
attribuiva la potestà regolamentare al Consiglio regionale ed
i l
potere di emanarli
al Presidente della Giunta, e all'art. 123, che ne riferiva il fondamento agli statuti)
- trovano oggi, invece, una specifica disciplina nell'art. 117, sesto comma, con
l'espressa attribuzione della potestà regolamentare allo Stato, alle regioni ed alle
autonomie locali. Ciò, evidentemente, in relazione al ruolo sempre più incisivo
che nel sistema della normazione contemporanea hanno assunto i regolamenti,
tendenti oggi ad occupare ambiti prima ricoperti dalla legge in modo fin troppo
invasivo e capillare, nonché in attuazione dei consistenti processi di
semplificazione e di delegificazione che da alcuni anni si stanno verificando nel
nostro ordinamento.
11
La nuova disposizione sembrerebbe voler assegnare al soggetto titolare del potere
regolamentare regionale un ruolo fondamentale nel processo di riforma dello
Stato. In altri termini, se da un lato le regioni assumono con la riforma una
posizione di centralità all'interno dello Stato, anche per via del diverso riparto di
competenze legislative e regolamentari rispetto ad esso, dall'altro lato si è voluto
11
De Lise P.,
Potestà regolamentare dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie locali dopo
il
titolo
V:
riflessi sulla giurisdizione amministrativa e sulla funzione consultiva del Consiglio Stato,
Studi e contributi, sul sito www.giustizia-amrninistrativa.it
50

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 57/194
porre un freno al "centralismo" del potere legislativo che ha contraddistinto le
legislature regionali. La via prescelta per ottenere un simile risultato è stata quella
di assegnare un nuovo ruolo politico istituzionale agli esecutivi, i quali dalla
riforma nel suo complesso
(l.
Cost. 1/1999 e 3/2001) escono rafforzati.
12
Complessivamente, dalla lettura dell'art. 117, si può desumere anche che
l'obiettivo principale è quello
di
ripartire la funzione normativa tra i vari enti
territoriali con una tecnica diversa dal passato. Infatti il legislatore non si è
preoccupato solo di stabilire entro quali ambiti materiali e con quale intensità i
vari enti possono intervenire, ma ha voluto espressamente ripartire tra di essi
anche l'esercizio della potestà legislativa e di quella regolamentare, non creando le
condizioni per una perfetta coincidenza tra attribuzione di competenza materiale e
attribuzione di potestà normativa, in quanto l'assegnazione all'ente del potere di
porre in essere norme non lo abilita ad esercitarla con qualsiasi atto normativa.
Inoltre, la circostanza che sia una norma costituzionale a prevedere i poteri
regolamentari degli enti territoriali di cui si compone la Repubblica ed a
delimitarne, sia pure per grandi linee, le rispettive aree di competenza, non sembra
priva di effetti sullo status dei regolamenti in questione: non si tratta più di fonti
secondarie nel senso tradizionale del termine, e cioè in tutto e per tutto
subordinate alla legge, che dovrebbe essere in grado di determinarne i caratteri e
gli spazi di intervento, al punto da poterli comprimere a piacimento, bensì di fonti
riconosciute direttamente dalla Carta costituzionale, e che sembrano porsi perciò
in rapporto diretto con il testo costituzionale, almeno fintanto che rimangano negli
ambiti di competenza che la Costituzione ha loro assegnato.
13
E' evidente infatti che, per quanto riguarda i l potere regolamentare connesso
all'esercizio delle funzioni amministrative, anche lo Stato e le regioni in tanto
hanno potere regolamentare in quanto abbiano funzioni amministrative dovendosi
chiaramente ammettere che, in virtù dell'art. 117, comma settimo, Co st., laddove
le funzioni amministrative siano a qualunque titolo attribuite a comuni, città
12
Barbuto L.,
La
potestà regolamentare delle Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione,
cit.
13
N.Lupo,
Nel nuovo titolo V il fondamento costituzionale della potestà regolamentare del
governo
cit.
51

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 58/194
metropolitane o province,
lì
il potere regolamentare relativo all'esercizio e
all'organizzazione delle funzioni spetta obbligatoriamente, e per diretto disposto
costituzionale, agli enti territoriali.
14
Riguardo alla nuova formulazione dell'art. 117, rispetto a quella previgente, va
affermato che la stessa esprime quella pari-ordinarietà tra i diversi soggetti che
l'art. 114 ha statuito. Stato e regioni hanno propri ambiti di competenza per
interpretare i bisogni della comunità attraverso l'esercizio della potestà legislativa.
Con la novella dell'art.
117
e l'esclusione della potestà legislativa allo Stato nella
materia della polizia amministrativa locale, è stata data copertura costituzionale al
riparto di competenze disposto dal decreto legislativo 112 del 1998 che ha
definitivamente sottratto alla competenza statale l'esercizio di quelle funzioni il
cui esercizio non aveva più alcun motivo di permanere in capo allo Stato, m
quanto vengono tutelati interessi locali.
Diventa rilevante, quindi, non trascurare quanto dispone l'articolo 161 del d.lgs
112 del 1998 il quale afferma che: "Sono conferiti alle regioni e agli enti locali,
secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i
compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o
attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all'articolo 160." In un gioco ad incastri
che certamente non aiuta nel tentativo di costruire un significato coerente con
l'evoluzione normativa, i l citato articolo 160, al comma l, dispone che: "Ai sensi
dell'articolo
l,
commi 3 e 4, e dell'articolo
3,
comma
l,
lettera a), della legge
15
marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia
amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo l e quelli
relativi
ai
compiti di rilievo nazionale
di
cui
al
predetto comma 4 del medesimo
articolo 1." Per completezza di esposizione, quindi, non è possibile omettere,
perlomeno in nota, quanto dispone l'articolo l della legge 59 dell997.
15
14
Pizzetti F. ,
Il
sistema costituzionale delle autonomie locali (tra problemi ricostruttivi e
problemi attuativi), cit.
15
"1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi
degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei
princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per
52

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 59/194
La funzione di polizia, in sostanza, più che una funzione assolutamente autonoma
è uno degli aspetti complementari necessari e strumentali, attinenti ad ogni
competenza amministrativa che tende a realizzare determinati interessi pubblici;
ovvero, sussistono tante "funzioni"
di
polizia amministrativa quante sono le
funzioni, i servizi o i beni che nell'interesse pubblico richiedono una tutela.
"conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti
locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche
ai
sensi dell'articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n.
142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e
alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti
amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi l e
2le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti
materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonchè cooperazione internazionale e attività promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni
referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi l e
2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità
indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la
tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello
spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di
decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera
motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare
l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
accordi internazionali .
53

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 60/194
6. Polizia amministrativa e pubblica sicurezza
Lo
Stato
ha
competenza esclusiva nelle materie elencate al comma
secondo dell'art. 117, dalla lettera a) alla lettera s). Alla lettera h) dell'elenco
risulta inserita, tra le competenze esclusive dello Stato, la pubblica sicurezza ma,
subito dopo, è precisato che è esclusa la polizia amministrativa locale. In sostanza,
se allo Stato è attribuita la potestà regolamentare per la materia della pubblica
sicurezza, in quanto rientra nella competenza legislativa esclusiva assegnata allo
Stato stesso, così non è per la polizia amministrativa che, essendo espressamente
esclusa dalle materie la cui legislazione è conferita allo Stato, rientra, in via
residuale, tra le materie assegnate alle regioni. Che cosa si intenda rispettivamente
per pubblica sicurezza e per polizia amministrativa è stato lo stesso legislatore a
chiarirlo. La distinzione, infatti, è stata sancita inequivocabilmente dal decreto
legislativo 112 del 1998 che all'art. 159 ha espressamente disposto che:
"1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa
regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che
possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di
attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche
delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in
pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della
sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza
pubblica di cui all'articolo
l,
comma 3, lettera
1),
della legge
15
marzo 1997,
n.
59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento
dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e
degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza
nella comunità nazionale, nonchè alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei
loro beni."
Al di là, comunque, della disposizione o, per essere più precisi, della definizione
fornita dall'art. 159 del d.lgs 112 del 1998, una precisa distinzione è stata fornita
54

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 61/194
dalla Corte costituzionale
16
, la quale ha affermato che: "la ripartizione delle
attribuzioni tra lo Stato e le Regioni, in relazione alle funzioni di polizia, deve
ritenersi fondata sulla distinzione tra le competenze attinenti alla sicurezza
pubblica, riservate in via esclusiva allo Stato ex art. 4 del d.P.R.
n.
616 del 1977, e
le altre funzioni rientranti nella nozione
di
polizia amministrativa, trasferite alle
Regioni come funzioni accessorie rispetto agli ambiti materiali attribuiti alla loro
competenza. La funzione di polizia di sicurezza riguarda quindi le misure
preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico e, pertanto,
si
riferisce alla attività di polizia giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza; la
funzione di polizia amministrativa riguarda, diversamente, l'attività di
prevenzione e repressione diretta ad evitare danni o pregiudizi a persone o cose
nello svolgimento di attività rientranti nelle materie affidate alla competenza
regionale".
In altre parole, fermo restando quanto stabilito dall'art. l, comma 2 della legge 59
del 1997, il quale ha disposto che "tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive
comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei
rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello
Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici", la polizia
amministrativa è quella potestà che consente di vigilare sugli "eventi" che
all'interno delle comunità locali possono creare turbativa per l'ordine e
preoccupazione per la sicurezza pubblica; seguendo così l'ordinamento un antico
principio di organizzazione della libertà comunale, per il quale la comunità che
crea un rischio per l'ordine pubblico materiale ha interesse a provvedervi e deve
. . 17
sopportame
1
costi.
16
Corte Cost., 25 luglio 2001
n.
290
17
Mangiameli S.
La
polizia locale urbana e rurale: materia autonoma o potere accessorio e
strumentale? Ci
.
55

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 62/194
7.
Il d.P.R. 616 del1977
la distinzione inequivocabile tra polizia amministrativa e pubblica
sicurezza, positivizzata nell'ordinamento soltanto dal d. lgs 112 del 1998 è i l
frutto
di
un'attività interpretativa effettuata dal Giudice delle leggi, sulla base
delle norme con le quali è stata data attuazione
al
principio costituzionale di
valorizzazione delle autonomie, e di quelle regionali in primis. Sotto questo punto
di vista, per comprendere pienamente il senso
di
ciò che si intende oggi per
"polizia amministrativa" in un'accezione del termine che consenta di
comprendere, con precisione, qual è l'ambito
di
competenza delle regioni e
comuni, non
si
può prescindere dalla conoscenza
di
quelli che sono stati i passaggi
logici nella ricostruzione della nuova materia o meglio sarebbe dire, a questo
punto, della funzione di polizia amministrativa. Ciò è dovuto anche per ribadire la
contraddittorietà del comportamento del legislatore delegato che, tre n 'anni fa con
i l
d.P.R. 616 del 1977, attribuiva
ai
comuni nuove funzioni, salvo porre poi una
serie
di
condizionamenti e limiti tali da dar vita a "rapporti di subordinazione" nei
confronti dell'amministrazione dell'Intemo
18
, che ancora oggi stentano ad essere
rimossi, perlomeno a livello
di
timore reverenziale
se
non di vincolo giuridico.
In sostanza, l'equivoco
di
fondo che
i l
comune di Roma aveva già rilevato in
relazione alla formulazione dell'articolo
19
del d.P.R. 616 del 1977 e che ha
portato la Corte costituzionale a dichiararne la parziale incostituzionalità, è stato
soltanto in parte rimosso, perché
c'è
ancora chi ritiene che i compiti e le funzioni
di cui all'art. 19 siccome derivati dal Tulps dovrebbero conservare tuttavia questo
carattere, con conseguente legittimazione dell'Autorità statale, competente in
materia
di
pubblica sicurezza, ad ingerirsi in un aspetto della gestione
di
essi.
19
Non è un caso, sosteneva allora la difesa del comune di Roma l'uso
dell'espressione "polizia amministrativa" usata nella specie, che dimostrerebbe
come i provvedimenti ex art. 19 siano stati scorporati dalla materia "pubblica
18
In tal senso la sentenza della Corte Cost.
27
marzo 1987
n.
77.
19
Nonostante la sentenza della Corte costituzionale
n.
77/1987 abbia fatto luce
su
queste
problematiche,
il
Ministero dell'interno mantiene inalterata la prassi di diramare circolari
interpretative alle sedi periferiche, invitando i prefetti ad informare sul contenuto delle stesse i
sindaci dei comuni competenti territorialmente.
56

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 63/194
sicurezza", essendo cessate le condizioni che avevano determinato l'inserimento di
essi in tale materia. Del resto, depone in tal senso anche la norma dell'art. 20 del
d.P.R.
n.
616 del 1977, atta da sola ad assicurare, con competenza
al
riguardo
dello Stato, quei controlli
di
pubblica sicurezza eventualmente necessari circa
l'esercizio delle attività
di
cui all'art. 19. Infatti, l'art. 20 del d.P.R. 616 del
1977
dispone che:
"Art. 20 (Controlli di pubblica sicurezza)
Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia
di
pubblica sicurezza di
accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio
di
attività soggette ad
autorizzazione
di
polizia a norma dell'articolo precedente,
al
fine
di
vigilare
sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle
regioni e degli enti locali."
Oggi, l'espressione "Polizia amministrativa" utilizzata per la prima volta dal
legislatore con
i l
d.P.R. 616 del1977 e definita dall'articolo
159
del d.lgs.
112
del
1998 riunisce una serie di funzioni disciplinate dal Tulps per attribuirle
complessivamente
ai
comuni. E' stato, dunque, lo stesso legislatore delegato a
rilevare
i l
nesso
di
interdipendenza funzionale che lega la "Polizia
amministrativa" alle diverse materie decentrate agli enti locali. Relativamente a
queste materie, peraltro, un dubbio
è
stato già fugato più
di
vent'anni
fa,
ed
è
quello connesso all'ambito dei poteri strettamente amministrativi attribuiti
dall'articolo
19
d.P.R. 616 del 1977 nelle funzioni indicate dalla medesima
norma, oltre ali' esercizio della potestà regolamentare.
Relativamente
ai
poteri che i comuni possono esercitare, ancora in forza
dell'articolo
19
d.P.R. 616 del 1977 rientra non soltanto l'emanazione dell'atto
finale del procedimento, ma anche l'accertamento istruttorio che ne costituisce il
presupposto. Tale conclusione, rilevava già vent'anni fa
il
Consiglio di Stato nella
sentenza del 30 settembre 1987 n. 556, consegue
ad
una concatenazione tra
attività istruttoria e provvedimento autorizzatorio che emerge con chiarezza
dall'articolo 80, (ovvero proprio l'argomento in trattazione) e dalle relative norme
del Tulps.
57

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 64/194
Secondo il giudice, la norma regolatrice del potere configura dunque quest'ultimo
come unitario, ancorchè articolato in una fase di accertamento ed una dispositiva.
L'attribuzione della funzione
al
comune è avvenuta nella sua interezza
assecondando un'esigenza
di
razionalizzazione delle competenze amministrative,
delineata dalla stessa legge delega a base dell'intervento normativa. E aggiunge
ancora il giudice, fugando ogni dubbio che, invece, permane ancora in capo a
molti comuni: "Sarebbe contraddittorio affidare
al
comune [ .... ] la competenza ad
emanare l'atto terminale del procedimento riservando contestualmente allo Stato i
compiti di accertamento tecnico, che nei casi di specie assumono un valore
decisivo ai fini del rilascio dell' autorizzazione.
20
"
8.
La
potestà normativa prevista dall'art. 19 d.P.R. 616 del1977
Il Consiglio
di
Stato, nella più volte citata sentenza, che ha visti opposti il
comune di Milano e il Ministero dell'Interno, prende in esame un'altra importante
questione assolutamente rilevante per l'argomento in trattazione. La problematica
trattata è quella connessa alla potestà normativa per l'esercizio delle funzioni
assegnate con l'articolo 19 del d.P.R. 616 del 1977.
Dopo aver precisato che l'art. 19,
al
secondo comma, così recita: " .. i consigli
comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione
all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente", il Consiglio di Stato
rileva che, contrariamente a quanto sostiene il Ministero dell'Interno
(e
la Regione
Lombardia) non può essere negato che tale potere giunga fino all'abrogazione
di
norme secondarie (statali) previgenti. Insomma, il potere regolamentare previsto
dal secondo comma dell'art.
19
d. P
R.
616 del 1977 non riferisce unicamente
all'organizzazione interna
al
comune.
20
La questione all'esame del Consiglio Stato e che aveva visto contrapposti
il
Ministero
dell'Interno e la Regione Lombardia contro i l comune di Milano, partiva da una deliberazione con
la quale i l Capoluogo lombardo si era dotato di una propria commissione tecnica per l'espressione
del parere previsto dall'art. 80 Tulps. Sosteneva
il
Ministero dell'interno che, invece, le
disposizioni regolamentari del Tulps che definivano la composizione della commissione non erano
state oggetto di trasferimento come invece era avvenuto per l'articolo 80.
58

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 65/194
lnnanzitutto, afferma ancora la sentenza, la Corte costituzionale ha espressamente
riconosciuto, nella sentenza 7711987, il carattere regolamentare del potere
attribuito al comune quanto a riparto delle competenze e disciplina delle
procedure (par. 6.1?' sul presupposto, ove necessario, di una delegificazione della
materia riconducibile allo stesso art. 19. La Corte ha altresì riconosciuto la
legittimità di tale conferimento di potere regolamentare ai comuni e l'esclusione,
da esso, della sola disciplina sostanziale della materia (par. 6.2). Orbene, una volta
riconosciuto che
il
primo comma ha trasferito
al
comune anche l'esercizio della
funzione di accertamento istruttorio dei presupposti, deve ammettersi anche che il
comune
è
titolare del potere regolamentare, anche per quanto attiene alla
organizzazione
di queste competenze.
Ridurre tale intervento al procedimento interno agli uffici comunali, in sostanza,
secondo il Consiglio
di
Stato, significherebbe rendere superflua la norma, non
21
Afferma la Corte Cost. nel citato paragrafo 6.1. Ugua1mente a conclusioni di infondatezza
conduce l'esame della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 19,
sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., agli artt.
117
e 118 Cost., nonché agli artt. 5 e
128
Cost.
Si assume dal giudice a quo che la disposizione predetta restringerebbe i compiti dei consigli
comunali alla sola determinazione delle "procedure e delle competenze" degli organi dei comuni,
in relazione alle funzioni
di
cui al primo comma, senza alcuna possibilità di incidenza sul piano
sostanziale. La disposizione
in
parola comporterebbe perciò che la disciplina sostanziale
di
cui al
T.U. delle leggi di P.S. del 1931 resti ferma, talché non sarebbe dato
di
intendere se la disciplina
della materia sia rimasta allo Stato, sia divenuta di competenza dei comuni ovvero rientri nella
competenza legislativa delle regioni.
Osserva in proposito la Corte che
i l
secondo comma dell'art. 19
si
limita a prevedere che fino alla
entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali, i consigli comunali determinino
procedure e competenze dei propri organi
in
relazione all'esercizio delle funzioni di cui al primo
comma del medesimo art.
19.
Si é in presenza- come si vede - non già di una norma limitativa
bensì
di
una disposizione volta a consentire ai comuni non solo
di
disciplinare le procedure ma
anche di distribuire le competenze relative alle nuove attribuzioni in materia di polizia
amministrativa, ancor prima dell'avvento della nuova legge sulle autonomie, secondo le scelte che
ciascun consiglio comunale vorrà operare.
I poteri comunali vengono cioè accresciuti dalla norma censurata, perché attualmente il riparto
delle competenze in generale fra gli organi del comune é determinato dalle leggi dello Stato,
laddove per le materie di polizia amministrativa testé trasferite, sono i comuni stessi che potranno
provvedervi.
Così del pari la gran parte dei procedimenti amministrativi é attualmente disciplinata con legge,
laddove
i l
secondo comma dell'art. 19
ne
prevede la delegificazione consentendo ai comuni di
determinare secondo le loro valutazioni le procedure con atto regolamentare. Lungi perciò da una
diminuzione
di
compiti, si é in presenza di un allargamento dei poteri comunali, cui però non
corrisponde una diminuzione di quelle altre potestà che i comuni stessi hanno in genere
relativamente alle proprie funzioni. Difatti nessuna delle disposizioni censurate prevede una tale
limitazione, con la conseguenza che, rispetto alle nuove funzioni, i comuni conservano gli stessi
poteri regolamentari ed organizzativi che essi hanno relativamente a tutti gli altri compiti di loro
spettanza.
59

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 66/194
potendosi negare che esso sarebbe spettato anche a prescindere dal secondo
comma dell'art. 19.
Il Consiglio di Stato, non elude la circostanza che il problema è complesso.
"La scelta del legislatore delegato apre delicati problemi costituzionali, soprattutto
quanto alla legittimità di un intervento di delegificazione anche in materie
devolute alla competenza regionale (art.
117
Cost.) e quanto alla previsione del
superamento di tale assetto al momento dell'entrata in vigore della legge di
riforma degli enti locali territoriali. Nelle materie di cui all'art. 117 Cost. spetta,
infatti, alle Regioni non solo la disciplina legislativa sostanziale della materia, ma
anche quella procedurale. Deve tuttavia rilevarsi, sottolinea ancora il giudice
amministrativo di appello, proprio con riferimento alle materie regionali, che
l'attribuzione di quel potere regolamentare, limitato alle competenze ed alle
procedure degli organi comunali, si giustifica, da un lato, con la sua contestualità
all'attribuzione delle funzioni sostanziali, dall'altro con la già rilevata attribuzione
al comune ed ai suoi organi di tutte le competenze inerenti a quelle funzioni".
E'
evidente, tuttavia, che dopo la novella dell'articolo 117 Cost. che ha
espressamente affidato
ai
comuni l'esercizio della potestà regolamentare per lo
svolgimento delle proprie funzioni, ed è venuto meno il parallelismo tra potestà
legislativa e potestà regolamentare precedentemente previsto, il problema più non
si
pone.
9. Norme procedurali e norme sostanziali
Il Consiglio di Stato, infine, in questa sua articolata e fondamentale
sentenza, prende in esame ancora una questione rilevante, ed è quella connessa
alla verifica se il contenuto degli articoli 9 e l O del regolamento comunale di
Milano, con i quali era stata prevista una composizione della commissione
comunale difforme da quella prevista dalla norma statale, attenesse alla procedura,
come ritenuto dal T.a.r. in prima istanza, o piuttosto alla sostanza, come ritenuto
dalle amministrazioni appellanti, Regione Lombardia e Ministero dell'interno.
60

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 67/194
La distinzione tra procedura e sostanza, afferma la sentenza, è, come sempre,
problematica. Tuttavia, con riferimento
al
caso
di
specie va sottolineato che
i l
legislatore delegato ha inteso riservare ai comuni l'organizzazione dell'esercizio
delle funzioni enumerate nell'art.
19,
anche con interventi normativi. In tale
finalità rientra certamente non solo la disciplina dell'attività interna degli uffici
comunali, potere rientrante nella generale capacità di autoorganizzazione degli
enti pubblici, bensì anche
(e
soprattutto) l'articolazione del procedimento
amministrativo in frasi distinte e la struttura degli organi che
vi
intervengono. Ed
è proprio quello che ha fatto il comune di Milano, precisa la sentenza, che non ha
introdotto un organismo prima inesistente, ma ha riorganizzato un organo
rientrante ormai nella propria struttura amministrativa, per la sua stretta
connessione all'esercizio del potere sostanziale attribuito all'ente.
Del resto, la questione connessa a questo aspetto era stata già presa in
considerazione pochi mesi prima dalla Corte costituzionale, che nella sentenza
n.
77 del
27
marzo 1987 aveva, tra l'altro, sostenuto che "in ordine alle funzioni di
polizia amministrativa loro conferite dall'art.
19
del d.P.R.
n.
616 del 1977 i
comuni hanno, in base
ai
principi, potestà regolamentare che, secondo quanto
stabilito dal secondo comma dell'art.
19
cit., si estende anche alla determinazione
delle procedure e della distribuzione delle competenze fra i suoi organi."
10.
Regolamentazione e semplificazione
Semplificare l'azione amministrativa vuoi dire tagliare passaggi
procedurali, controlli, adempimenti inutili: cioè vuoi dire eliminare tutto quello
che è superfluo o addirittura dannoso per un buon funzionamento
dell'amministrazione. Il problema è che spesso non
si
può tagliare, perché certi
passaggi o adempimenti non
si
possono eliminare senza provocare danni maggiori
dei vantaggi dell'eventuale semplificazione. In questi casi semplificare significa
allora saper trovare modi diversi, più semplici, rapidi ed economici per ottenere lo
stesso risultato garantito da quel particolare passaggio procedurale, controllo,
adempimento. In questo ultimo senso, semplificare l'azione amministrativa vuoi
61

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 68/194

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 69/194
dell'amministrazione finalizzato a rendere la sua azione più efficiente, rapida ed
economica.
24
Allo stato attuale, non esiste una definizione comunemente accettata di
regolamentazione applicabile ai diversi sistemi normativi dei paesi OCSE.
Comunque, nel rapporto che l'OCSE ha elaborato verso la fine degli anni '90, è
scritto che per regolamentazione si intende l'insieme diverso di strumenti
mediante i quali i governi stabiliscono gli obblighi ai quali sono assoggettati i
cittadini e le imprese. Le regolamentazioni, in pratica, includono le leggi, i
provvedimenti formali e informali, e le norme delegate emesse da tutti i livelli
governativi e da organismi non governativi o di auto-regolazione ai quali i governi
hanno delegato poteri di regolazione.
Le regolamentazioni, secondo l'OCSE, si suddividono in tre categorie:
l - Regolamentazioni economiche: intervengono direttamente nelle decisioni
relative al mercato, quali determinazione dei prezzi, concorrenza, ingresso nel
mercato o uscita dal mercato. Questa tipologia di riforma, secondo l'OCSE, ha
l'obiettivo di aumentare l'efficienza economica, sia riducendo le barriere alla
concorrenza e all'innovazione (spesso mediante
la deregulation e l'utilizzo di
norme per la promozione dell'efficienza), sia migliorando i quadri normativi per
favorire il funzionamento del mercato e dei controlli prudenziali.
2 - Regolamentazioni sociali: tutelano gli interessi dei cittadini quali la salute, la
sicurezza, l'ambiente e la coesione sociale. Gli effetti economici delle norme
sociali possono essere secondari o imprevisti, ma essere anche rilevanti. La
riforma ha l'obiettivo di verificare
la
necessità della regolazione e creare un
quadro regolamentare e di altri strumenti, quali incentivi per i l mercato e approcci
basati sugli obiettivi, caratterizzati da maggiore flessibilità, maggiore semplicità
ed efficacia, e costi minori.
3 - Regolamentazioni amministrative: formalità amministrative - la cosiddetta
"burocrazia"- mediante le quali i governi raccolgono informazioni e intervengono
nelle decisioni individuali di carattere economico. Possono avere un impatto
24
Voce
Semplificazione amministrativa,
in
Pubblic@ndo
cit.
63

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 70/194
notevole sulla performance del settore privato. La riforma ha i l fine di eliminare le
procedure burocratiche non necessarie, velocizzare e semplificare quelle
necessarie e migliorare la trasparenza nell'applicazione delle procedure stesse.
La
deregulation
è un sottoinsieme della riforma del sistema di regolazione e si
riferisce all'eliminazione completa o parziale di una regolamentazione di settore
al fine di migliorarne la performance economica.
25
Quindi, nella loro azione, Regioni ed enti locali - a cui oggi è attribuito il compito
di esercitare e modulare la potestà normativa - dispongono di un solco già
tracciato. Non solo, ma la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico
delle imprese è anche l'obiettivo espressamente individuato rectius ribadito
26
dalla
legge 28 novembre 2005,
n.
246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno
2005). L'art. 5 della legge 246/2005, per garantire il rispetto delle attribuzioni
regionali, specifica che il riassetto normativo che lo Stato emanerà, avrà ad
oggetto le disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale,
di
cui all'art.
117, secondo comma della Costituzione, ma gli altri commi del medesimo articolo
della legge 246/2005 forniscono le linee strategiche alle quali dovrebbe risultare
difficile derogare.
I l
secondo comma dell'art.5 prevede, infatti, anche che Stato e
regioni stipulino degli accordi o intese per favorire il coordinamento delle
reciproche competenze normative, l'armonizzazione della regolamentazione in
materia e il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti
connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa su tutto il territorio nazionale,
oltre a individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il
25
OCSE (1997), OECD
Report on Regulatory Reform,
Parigi. nel sito
www.agcom.it
26
In
Italia, i primi interventi
di
semplificazione risalgono agli inizi degli anni '90. La legge
generale sul procedimento amministrativo (L.24111990) ha introdotto i primi istituti
di
semplificazione dei procedimenti, che sono stati successivamente modificati ed integrati, ed ha
individuato un primo elenco di procedimenti da semplificare con successivo regolamento di
delegificazione (L. 537/1993). Tuttavia, la politica di semplificazione e qualità della regolazione,
in
Italia, ha raggiunto una configurazione organica a partire dalla 13a Legislatura (1996/2000).
Innanzitutto, gli obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi sono stati collocati
all'interno di una più ampia politica
di
qualità della regolazione.
In
secondo luogo,
è
stata
aumentata la gamma degli strumenti da utilizzare per conseguire tali obiettivi (strumenti
di
semplificazione dei procedimenti, razionalizzazione della normativa, valutazione di impatto della
regolazione, ecc). In terzo luogo, sono stati definiti gli assetti organizzativi volti a dare impulso
alla politica di semplificazione e qualità della regolazione e a favorirne l'attuazione (1..59/1997 e
successive leggi annuali di semplificazione, 1..80/2005 e 1..80/2006).
64

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 71/194
territorio nazionale. Il comma 4, per rafforzare i l coordinamento e la leale
collaborazione tra i livelli di governo, per il raggiungimento dei comuni fini della
semplificazione dell'attività d'impresa e della riduzione degli adempimenti
amministrativi, infine, dispone che le regioni adeguino la propria disciplina alle
finalità e obiettivi stabiliti con la legge.
Ma a ben vedere, la stessa semplificazione amministrativa non costituisce
di per
sé l'obiettivo finale. Secondo un processo iniziato con la l. n.
241
del 1990, ciò
che la riforma amministrativa intende rilanciare
è
essenzialmente
i l
criterio di
efficacia dell'azione pubblica, con la conseguente rivalutazione del concetto di
"buon andamento", che l'art.
97
Co st. indica fra
le
finalità dell'azione
amministrativa. La
semplificazione amministrativa
è dunque,
a sua volta,
strumentale
al
raggiungimento
di beni
e servizi
concreti,
all'effettivo
conseguimento del
buon risultato amministrativo.
In tal
modo l criteri
di
valutazione dell'operato della pubblica Amministrazione non
si
collocano più
soltanto sul piano giuridico-formale, ma su quello materiale, dove gli interessi si
sostanziano in beni.
27
11.
I regolamenti di semplificazione e di delegificazione
La questione della semplificazione normativa per le attività economiche
non è questione da poco, anche considerando che una recente indagine
dell'OCSE, condotta su un campione di imprenditori di 14 paesi aderenti alla
organizzazione, ha rivelato che, nella percezione degli operatori economici, le
burdensome regulations
vengono avvertite come uno dei maggiori impedimenti
all'attività imprenditoriale. Dal canto suo, in uno studio del 2003,
i l
Fondo
Monetario Internazionale ha sostenuto che incisive politiche
di
riduzione dei
carichi regolativi e burocratici e di miglioramento della qualità della
regolamentazione europea potrebbero portare, nel lungo periodo,
ad
un aumento
fino
al 7%
del PIL dei Paesi dell'Unione e ad un incremento del
3%
della
27
Razzano G., Le fonti del diritto e il principio di sussidiarietà nel quadro dei più recenti
interventi legislativi
per
la «semplificazione», Dir. Amm.
2001, 2-3, 273
65

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 72/194
produttività. Infine, una recentissima indagine del Ministero delle Finanze
olandese ha stimato per i Paesi Bassi costi da regolazione per le imprese pari a
16,4 miliardi di euro all'anno (il 53% per effetto di regolazioni europee),
equivalenti
al
3,6% del PIL.
28
Il primo intervento in materia è costituito dall'art. 2 della legge 53711993, in cui
fu lanciato il primo processo sistematico di delegificazione e semplificazione di
un numero consistente di procedimenti amministrativi prima regolati dalla legge.
Si è proseguiti con l'art. 20 della legge 15 marzo 1997
n.
59, per sfociare nelle
leggi annuali di semplificazione (che però hanno assunto una cadenza più lenta)
interamente dedicate alla materia della semplificazione normativa e
amministrativa. Con esse si è progressivamente passati da un modello di
semplificazione/delegificazione che consisteva nell'emanazione di regolamenti ex
art. 17, secondo comma legge 40011988, su singoli procedimenti amministrativi
ad un modello di riordino/riassetto di intere materie organiche, prima con testi
unici e poi con codici,
29
anche se è bene precisare che questo sistema non è
applicabile per le funzioni dei comuni.
L'art. 17, II co., della legge 40011988 prevede che la legge possa autorizzare
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando le norme
generali regolatrici della materia e disponendo l'abrogazione delle norme vigenti,
con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari: si tratta
di
una legge
di delegazione a regolamentare diversa dalla legge di delegazione a legiferare, il
cui unico limite è rappresentato dalla vigenza di campi protetti da riserva assoluta
di legge, ed il cui contenuto funzionale è la regolazione della materia con norme
generali.
30
In seguito, la riforma del titolo V ha radicalmente cambiato le condizioni rispetto
alle precedenti politiche di semplificazione, nelle quali lo strumento dei
regolamenti statali di delegificazione era ancora preponderante. Oggi il contesto è
28
Bassanini F., Torchia L.,
Sviluppo e declino. Il ruolo delle istituzioni per la competitività del
Paese.
Passigli, Firenze 2005
29
Consiglio Stato, (Ad. gen.), parere
del25
ottobre 2004
n.
2/2004 in
Foro
it
2005,
p.
210.
30
Verrienti L., voce
Regolamenti e potere normativa degli enti locali,
in
Dig. /t.,
vol. XIII, UTET,
1997.
66

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 73/194
nuovo, a più livelli; molte scelte rilevanti sono adottate anche in sede regionale,
per non parlare di quelle che si prendono in sede di Unione europea, che pure
sfuggono al "semplificatore" nazionale.
31
Peraltro, relativamente all'applicazione dei regolamenti governativi alle regioni ed
alle province autonome, se già nel sistema antecedente la riforma del 200 l i
regolamenti governativi (compresi quelli di delegificazione) non potevano
incidere sulle materie attribuite alle regioni e tassativamente elencate dali' art. 117,
la questione oggi presenta situazioni ancora diverse. Infatti, data la non specifica
definizione, nel vecchio art. 117 Cost, delle competenze in materia di potestà
regolamentare, veniva consentito (anche mediante pronunce della Corte
costituzionale) che lo Stato, nel momento in cui veniva a modificare i principi
fondamentali di una materia di competenza regionale, potesse dettare anche una
normativa di dettaglio applicabile immediatamente alle regioni ed idonea a
disciplinare la materia emendata in attesa della specifica normativa regionale.
In
tale ottica, e qualora ancora mancasse la normativa regionale, eventuali
regolamenti di delegificazione potevano incidere anche sulla materia regionale
temporaneamente disciplinata con legge dello Stato.
La legge Costituzionale
n.
3/200l, modificando l'art. 117 Co st. ha rigidamente
definito le competenze legislative e regolamentari di Stato e regioni. Con la
riforma del 2001, pertanto, lo Stato viene privato di quella generale potestà
regolamentare che gli era stata implicitamente riconosciuta dal precedente
sistema, stabilendo che lo stesso può emanare regolamenti solo nelle materie ad
esso riservate dali' art. 117, comma II.
Per inciso, con la sent.
n.
303/2003, la Corte costituzionale ha riampliato il potere
legislativo e regolamentare dello Stato, concedendo allo stesso (nei limiti indicati)
di disciplinare materie che pur non essendo comprese in quelle previste dall'art.
117 comma Il, necessitino di una disciplina unitaria a livello nazionale. Ma,
nonostante tale "concessione", la Corte Costituzionale ha escluso che eventuali
regolamenti di delegificazione possano essere adottati dallo Stato in materie ad
31
Consiglio Stato, parere del 25 ottobre 2004
cit.
67

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 74/194
esso non riservate e che, di conseguenza, gli stessi possano avere efficacia in capo
alle regioni e relativamente a materie di loro competenza.
32
La delegificazione, aveva già precisato la Corte costituzionale con la sentenza
376/2002, è solo lo strumento adottato dal legislatore statale per realizzare
l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti nell'ambito di ciò che era già
disciplinato dalle leggi statali precedentemente in vigore.
La
sostituzione, in parte
qua, con norme regolamentari riguarda esclusivamente le preesistenti disposizioni
di leggi statali, come confermano i riferimenti negli allegati delle leggi di
semplificazione: e dunque le disposizioni di leggi statali che già operavano nelle
materie di competenza regionale. Tali leggi, (a parte i casi di interventi particolari
che lo Stato avesse effettuato sulla base di specifici titoli costituzionalmente
giustificati, e che però in quanto tali si collocavano, propriamente, al di fuori
dell'ambito delle attribuzioni regionali), potevano spiegare efficacia ad un doppio
titolo: in quanto recanti le disposizioni da cui
si desumevano i principi
fondamentali vincolanti per i legislatori regionali, o in quanto recanti disposizioni
immediatamente operative (di dettaglio) applicabili a titolo suppletivo in
mancanza di legislazione regionale.
Ma
molto è cambiato dopo la modifica del
titolo V, anche in relazione alla legge 131/2003 e, nel Friuli Venezia Giulia, alla
l.r.
112006
che nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha espressamente
previsto la cedevolezza delle disposizioni di dettaglio contenute nella disciplina
regionale e statale relativa a funzioni attribuite agli enti locali.
Il legislatore regionale dovrà, quindi, dettare le linee guida delle politiche
pubbliche, materia per materia, così vincolando gli interventi che, nel quadro della
legislazione regionale, comuni e province sono chiamati a porre in essere, così
come è espresso nella legge 400 del 1988, che impone al legislatore che voglia
delegificare la determinazione delle norme generali regolatrici della materia, cioè
gli richiede di non rinunciare a dettare comunque i principi direttivi e la disciplina
generale degli interventi. Tutto ciò ovviamente presuppone che il legislatore
32
Scasserra M.,
I regolamenti governativi di delegificazione:
limiti di
applicabilità alle regioni e
alle province autonome prima e dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001 (Sentenze n. 30212003 e
n. 303 2003 della Corte Costituzionale),
in www.diritto.it
68

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 75/194
regionale, indicando le disposizioni legislative destinate potenzialmente a vedere
limitata la loro efficacia, individui puntualmente gli oggetti che possono essere
interessati dall'intervento degli enti locali?
3
12. La potestà regolamentare comunale
Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e
finanziaria, da esercitare in conformità al quadro normativo vigente. In particolare
i l
Consiglio comunale deve adeguare lo Statuto alla condizione di autonomia ed ai
nuovi valori sanciti dalla riforma del titolo
V,
parte
Il,
della Costituzione,
introdotta dalla legge costituzionale
18
ottobre 2001,
n.
3, tenendo conto delle
leggi emanate per l'attuazione della medesima, con particolare riferimento alla
legge n. 5 giugno 2003 n.
131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3).
Se prima della riforma costituzionale, ogni riferimento ai poteri e alle funzioni,
doveva, per svariati motivi, ispirarsi al Testo Unico 267 del 2000 - dal quale si
ricava una certa apertura proprio sui principi dell'autonomia - successivamente,
con la modifica della Costituzione e l'approvazione della legge di attuazione, è
sostanzialmente mutato i l quadro di riferimento delle autonomie locali.
Il potere regolamentare degli enti locali è, adesso, istituzionalmente implicito in
quanto costituzionalmente previsto espressamente dalla Costituzione negli artt.
114, c. 2), e 117, c.6): quest'ultimo, in particolare, prevede espressamente la
riserva regolamentare a beneficio dei comuni e delle province in materia di
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Per avere un quadro completo della potestà regolamentare, bisogna tuttavia rifarsi
all'art. 4 della legge
n. 131
del2003, nonchè al Tuel.
L'art. 7 del Tuel prevede che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo
statuto, il comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
33
In tal senso Bartole
S.
L'attribuzione di potestà regolamentare agli enti locali con effetti di
delegificazione
Atti del convegno "Norme di attuazione dello Statuto speciale regionale e nuovo
ruolo degli enti locali" Villa
Manin-
Codropio maggio 2006 in www.regione.fvg.it.
69

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 76/194
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi
di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni.
Al
riguardo, l'art. 4 della legge
n.
13112003
si esprime tra l'altro
come segue:
"3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto
delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle
funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla
potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e
della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le
rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli artt. 114, 117, sesto
comma, e 118 della Costituzione.
5.
Il potere normativo è esercitato anche dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità
montane ed isolane".
Il raffronto fra le due normative evidenzia:
a)
un miglioramento dell'assetto soggettivo, nel senso che l'art. 4 estende la
disciplina alle Città metropolitane, nonché alle Unioni di Comuni ed alle
Comunità montane e isolane;
b) una diversa articolazione dei limiti opposti alla funzione regolamentare ed una
distinzione tra "organizzazione degli enti locali" e "gestione delle funzioni",
nonché un ulteriore limite all'esercizio della potestà regolamentare "nell'ambito
della legislazione dello Stato e della Regione", quest'ultimo tuttavia sottoposto a
riserva "che ne assicura i requisiti minimi di uniformità";
c) la necessità di un'integrazione fra le due normative sino a quando il legislatore
non apporterà le previste modificazioni
al
Tuel.
A questa organizzazione sovrintende, anche come contenuto e limite, la normativa
statutaria che esce rafforzata dalla recente legge costituzionale di modifica del
70

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 77/194
Titolo V della Costituzione e dalle relative norme di attuazione di cui alla legge n.
131/2003.
n
regolamento, infatti, si pone come subordinato allo statuto nella disciplina delle
fonti locali: ciò, come si è detto, è chiaramente indicato dall'art. 4 comma 3 della
L.
n. 13112003.
In attuazione dell'art. 117, comma
6)
Cost., è inoltre stabilito che
la potestà regolamentare operi nell'ambito della legislazione dello Stato o della
Regione, affinchè siano assicurati i requisiti minimi di uniformità, secondo le
rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli artt. 114, 117,
6
comma, e 118 della Costituzione.
34
Senza entrare nella complessa discussione
se
i l
dettato dell'art. 4, comma quarto
della
l. 131
del2003, trovi o meno un solido fondamento costituzionale, va invece
messo in risalto che la formulazione della norma, indicando i limiti e i vincoli al
potere regolamentare locale, fa riferimento "ali' ambito della legge" e non alla
legge
tout court.
Inoltre, va evidenziato che laddove si specifica che la legge
debba fissare i "requisiti minimi di uniformità"
(e
dunque quelli soltanto), appare
chiaramente che la disposizione è orientata ad accogliere la tesi che rispetto alla
disciplina delle funzioni attribuite agli enti territoriali la legge, sia statale che
regionale, incontri i l limite del rispetto dell'autonomia dell'ente e, in particolare,
del potere regolamentare ad esso attribuito.
35
La rubrica dell'art. 4 della
l.
131/2003 recita: "attuazione dell'articolo 114,
secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di
potestà normativa degli enti locali". L'ultima parte della disposizione contenuta
nel comma sesto dell'art.
117
prevede la competenza regolamentare delle
autonomie locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite. Sul sistema delle autonomie locali aveva comunque
già inciso un'altra legge fortemente innovativa. La legge
15
marzo 1997, n. 59,
34
Cerulli Irelli V. e Narducci R., L'autonomia normativa degli enti locali, cap.II Statuti e
regolamenti per gli enti locali: un contributo per l'attuazione della nuova potestà normativa
dell'ente locale, Anci in coll. Upi e Uncem, sul sito www.statuti.anci.it
35
Pizzetti F., Il sistema costituzionale delle autonomie locali (tra problemi ricostruttivi e problemi
attuativi), ci
.
71

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 78/194
infatti, aveva introdotto nell'ordinamento diverse significative novità, fra le quali
l'inversione del criterio di riparto delle competenze, con l'introduzione della
cosiddetta clausola dei poteri residui a favore delle autonomie locali e con la
riserva allo Stato di funzioni tassativamente enumerate. Inoltre, nell'ambito del
sistema delle autonomie, le competenze dovevano essere distribuite dalla legge
regionale in applicazione di vari principi, come la sussidierietà, l'adeguatezza e la
differenziazione, divenuti poi principi costituzionali. Ma la legge 59 del 1997
introdusse anche il principio del parallelismo fra le competenze amministrative e
la potestà regolamentare. In virtù di tale principio ad ogni competenza
amministrativa dell'ente locale doveva corrispondere una potestà regolamentare.
36
Si potrebbe anzi sostenere che, dopo la modifica al titolo V Cost., la potestà
normativa degli enti locali costituisce la fonte primaria dell'ordinamento
repubblicano per la parte che attiene alle comunità locali; sottolineando subito,
però, che per fonte primaria non va inteso altro che la parte che viene prima, e non
certo l'elemento che sta sopra e che è quindi gerarchicamente superiore agli altri.
La primarietà degli statuti e dei regolamenti dei Comuni, delle province e delle
città metropolitane cioè, è nel processo ermeneutico una priorità di ordine (logico)
temporale e non significa altro che la necessità di partire da essi e non dalla legge
(statale o regionale) per ricostruire l'ordinamento comunitario di base e
disciplinarne le funzioni. Dunque, una differenza radicale rispetto alle opinioni
assai diffuse, che ritengono che la natura degli statuti e dei regolamenti degli enti
locali sia pur sempre quella di costituire una fonte secondaria, subordinata a
qualsiasi disposizione statale o regionale. Tutto trae origine, quindi, dalla logica
del novellato art. 114 Cost. che, parificando la posizione di comuni, province,
città, regioni e Stato ha sancito la fine della sovranità statale e la sua
trasformazione in autonomia comunitaria di ogni singolo ambito istituzionale.
37
Dopo la novella costituzionale introdotta dalla legge costituzionale 3/2001, in
sostanza, il problema della titolarità della potestà regolamentare viene risolto non
36
Fenucci F. I regolamenti di autonomia locale, cit. p. 144
37
Piratino
A.,
La funzione normativa di comuni, province e città nel nuovo sistema costituzionale,
cit. p. 14
72

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 79/194
solo attraverso la sua ripartizione tra i vari enti ma anche attraverso la fissazione
di una sorta di principio "di titolarità esclusiva delle potestà regolamentari". In
base ad esso, per ciascun settore materiale la funzione normativa secondaria viene
assegnata integralmente ad un solo ente, cosicché deve escludersi, a differenza di
quanto accade per le competenze legislative, l'ammissibilità di un concorso di
regolamenti imputabili ad enti diversi, con riferimento allo stesso oggetto
38
•
Significativa è stata, a tale riguardo,
la
fase di riforma del potere locale costituita
dalla l. 3 agosto 1999,
n.
265 che ha modificato l'art. 5 della l. 142 del 1990
sostituendo alle parole "nel rispetto della legge e dello statuto" l'espressione "nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto", con ciò portando
ali' interpretazione che i principi contenuti nella legge e nello statuto degli enti
locali sono un limite inderogabile alla potestà regolamentare degli enti locali
stessi. Tale interpretazione è confermata dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il cui
art. l, comma 3, precisa che la legislazione in materia di ordinamento degli enti
locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia
espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro
autonomia normativa".
Se ne deduce che le norme di dettaglio contenute nelle leggi statali e regionali
sono derogabili. In tal senso si è anche già espresso il Tar Lazio
39
, i l quale ha
affermato che le regioni hanno potestà di emanare norme generali sulle modalità
di esercizio del commercio e dettare i criteri generali ai quali i comuni devono
attenersi, dove la determinazione della disciplina di dettaglio viene lasciata alla
competenza esclusiva dei comuni. Inoltre, l'organo di giustizia amministrativa ha
sottolineato che la disciplina di dettaglio emanata dalla regione sicuramente
invade illegittimamente la sfera di competenza dell'amministrazione comunale,
considerato anche il nuovo assetto di competenze del novellato art. 117 della
Costituzione, attribuisce espressamente ai comuni potestà regolamentare in
38
Barbuto L., La potestà regolamentare delle regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione, cit.
9
T.a.r. Lazio, 22 settembre 2003, n. 7700
73

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 80/194

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 81/194
autonomia da disposizioni costituzionali.
43
Ma
le fonti locali, pur espressamente
legittimate in Costituzione, non godono delle medesime garanzie riconosciute ad
altri soggetti del sistema, in ordine alla salvaguardia del proprio ambito di
competenza a fronte di indebite invasioni di campo. Infatti,
è
attualmente inibito
(o comunque non previsto) un accesso diretto degli enti locali alla Corte
costituzionale
44
(a differenza delle regioni, per le quali si è invece ora rafforzata
una tutela per certi versi paritaria rispetto allo Stato, con il regime di ricorsi fissato
nel nuovo art. 127 Cost.) Nonostante ciò è fuori discussione il carattere fortemente·
innovativo delle nuove previsioni del Titolo V in ordine al fondamento e alla
latitudine del potere normativa locale, conseguente al riconoscimento del
pluralismo istituzionale nell'assetto della Repubblica: al punto che si può
probabilmente parlare di una "via italiana al federalismo", per la compresenza di
istituzioni territoriali multilivello ciascuna con una propria ragion d'essere,
proprio ruolo e propria sfera di poteri, nell'ambito dell'unità del sistema. In altre
parole si può dire che anche il sistema delle fonti si
è
ora adeguato alla fisionomia
pluralistica e autonomista del sistema ist ituzionalé
5
.
43
Barbuto L.,
La
potestà regolamentare delle Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione, cit.,
p.42.
44
Non a caso Falcon G., in L'autonomia amministrativa e regolamentare, in Le Regioni", 2-3, Il
Mulino, Bologna, 2004, p.418, si chiede, proprio tenuto conto che la Corte costituzionale non ha
avuto modo di soffermarsi su questi profili, quanto l'esercizio del potere regolamentare della
Regione possa penetrare nella disciplina di funzioni degli enti locali, titolari anch'essi di poteri
regolamentari, e più in generale titolari di autonomia garantita dalla Costituzione.
45
De Martin G. L'autonomia normativa degli enti locali nel pensiero di Aldo M. Sandulli in
www.amministrazioneincammino.luiss.i
75

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 82/194
13. Il d.P.R. 31l del 2001
Già con la prima
46
legge Bassanini, la legge 59 del 1997, il Parlamento ha
ritenuto talmente inderogabile semplificare la normativa che disciplina le attività
economiche che sono ancora incluse all'interno del
corpus
del Tulps che,
nell'elenco allegato alla legge stessa, ha inserito le voci (evidentemente per errore,
ma sintomatico della volontà) per ben due volte. Infatti, al
n.
77 si trovano i
"procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo
svolgimento di industrie, mestieri ed attività imprenditoriali e tenuta registri in
materia di attività commerciali" e al n. 108 (con gli stessi riferimenti normativi)
"procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo
svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali".
Il d.P.R.
28
maggio 2001, n.
311
"Regolamento per la semplificazione dei
procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della
qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato l della
legge n. 59 del 1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato l della legge n. 5011999)"
è stato pubblicato nella G.U.
n.
178 del 2 agosto 2001 e, di conseguenza, è entrato
46
Appellate con il nome del Ministro proponente, le leggi Bassanini l, 2, 3 e 4 sono state la pietra
miliare nel tentativo
di
riformare la pubblica amministrazione. Oltre alla più nota Bassanini l, la
legge 59/1997, va ricordata la Bassanini 2, ovvero la Legge 15 maggio 1997, n.
127
"Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di
decisione e di
controllo", la Bassanini 3: Legge 16 giugno 1998,
n.
191 "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15
marzo 1997, n. 59, e
15
maggio 1997,
n.
127, nonche' norme in materia di formazione del
personale dipendente e
di
lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica". Infme, va ricordata anche la Bassanini 4: Legge 8 marzo 1999, n. 50
"Delegificazione e testi unici
di
norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998". Questa legge rappresentò il primo tentativo
di
riforma organica della
Presidenza del Consiglio, della struttura del Consiglio dei Ministri e dell'ordinamento dei
ministeri. Tale provvedimento ha delineato
un
nuovo assetto dell'organizzazione ministeriale,
prevedendo anche l'istituzione delle agenzie, ma non entrò mai in vigore integralmente, poiché il
II Governo Berlusconi la modificò alla sua entrata in carica. I ministeri aumentarono e solo alcune
della agenzie furono costituite:
in
particolare l'Agenzia per la Protezione Civile (poi abolita e
riconfluita nel vecchio Dipartimento della Protezione Civile), le Agenzie del Ministero
dell'Economia (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, Agenzia del
Demanio) già istituite nel 1999,
in
deroga alla generale entrata in vigore della Riforma Bassanini
nel 2001, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) istituita solo
nel 2001. Franco Bassanini, nella legislatura 1996-2001, guidata dai governi dell'Ulivo,
è
stato
nominato Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali (primo governo Prodi),
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (primo governo D'Alema) e nuovamente
Ministro per la Funzione Pubblica (secondo governo D'Alema e secondo governo Amato).
76

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 83/194
in vigore
il
giorno 17 agosto 200 l. Meno di due mesi dopo, e precisamente il 7
ottobre
47
, si
svolgeva il primo referendum confermativo della storia repubblicana
per la conferma della modifica del titolo V Cast., approvata dal Parlamento senza
aver ottenuto, tuttavia,
il
numero dei voti necessari previsti dalla medesima
Costituzione.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 117 novellato, la potestà legislativa in materia
di polizia amministrativa (seppur locale) è stata trasferita alle regioni per effetto
della competenza residuale. In pratica, spetta alle regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato dal secondo o terzo comma dell'articolo 117.
E'
per questo motivo che si
parla di competenza residuale delle regioni come dispone l'art. 117 comma 4 della
Costituzione.
Peraltro, già il comma 3 dell'articolo l del d.lgs 112 del 1998 disponeva che:
"Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano
funzioni legislative o normative
ai
sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della
legge 15 marzo 1997,
n.
59." Le funzioni trasferite hanno riguardato alcune
attività economiche, quali ad esempio le agenzie di affari, che sono state trasferite
ai comuni ed altre, ad esempio le gare automobilistiche su strada, che sono state,
invece, trasferite alla competenza delle province.
48
In sostanza, il d.lgs 112 del
47
Il risultato del referendum fu il seguente: Votanti: 34% degli elettori. Votarono per il Sì, ovvero
per le modifiche alla Costituzione, 10.348.419 elettori pari
al
64,2% dei votanti. Si espressero,
invece, negativamente 5.819.187 elettori pari al35.8% dei votanti. Fonte www.riforme.net
48
Art.
163. Trasferimenti agli enti locali
l.
Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati
nell'articolo
161
del presente decreto legislativo.
2.
Ai
sensi dell'articolo
128
della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e
compiti amministrativi:
a)
i l rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo
37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18
giugno 1931,
n.
773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940,
n.
635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e
fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
c)
i l
ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria
di
affittacamere o
appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui
all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
77

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 84/194
1998 ha completato i l percorso avviato vent'anni prima con il d.P.R. 616 del1977
attribuendo le funzioni in base
al
principio di sussidiarietà, ma ha anche assegnato
alle regioni l'esercizio della potestà legislativa per la disciplina delle stesse.
Il d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei
procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della
qualifica di agente di pubblica sicurezza" è, contrariamente a quanto afferma i l
titolo, un regolamento complesso. Il motivo di questa affermazione lo si ritrova
chiaramente espresso nel parere che il Consiglio di Stato ha formulato sullo
schema di decreto. Nel parere
n.
163
del 9 ottobre 2000, la Sezione consultiva per
gli atti normativi cita alcuni passaggi della relazione di accompagnamento del
Ministero dell'Interno e, tra questi, è di particolare interesse quello in cui si
afferma che ". . . . . . tali procedimenti concernono la materia della sicurezza
pubblica, si è ritenuto (pertanto) di accorpare l'intervento di semplificazione in
un'unica fonte regolamentare per soddisfare l'esigenza di "conoscibilità
normativa", in applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 5, lett. d,
della legge
n.
59 del 1997 e che per lo stesso motivo e per evitare la dispersione in
più testi delle norme procedimentali si è ritenuto di inserire le nuove disposizioni,
con tecnica novellistica, nel corpo del regolamento di esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940". La novella
al
regolamento Tulps introdotta da quello che successivamente è divenuto i l
d. P
R. 311
del 200
l
riguarda disposizioni in materia di semplificazione dei
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attivita' di recupero
crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
e)
il
rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della
capacita' tecnica dell'interessato da parte della commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di
cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
f)
il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o
ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo
68
del
predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui
all'articolo
31
della legge
18
aprile 1975,
n.
110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del
citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
78

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 85/194
procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo. In particolare, viene
istituita la commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo ed individuate
le rispettive competenze.
Ciò che appare contraddittorio
è
affermare che i procedimenti disciplinati dal
d.P.R. 311 del 2001 concernono la materia della sicurezza pubblica
49
•
Infatti, è
stato già chiarito o, meglio ancora, la Corte costituzionale ed il Consiglio di Stato
rispettivamente con le sentenze n. 77 del27 marzo 1987 e n. 556 del30 settembre
1987, hanno già precisato che i procedimenti la cui competenza è stata trasferita ai
Comuni dal d.P.R. 616 del 1977 e ai quali alcuni dei procedimenti ridisciplinati
dal d.P.R. 311 del 2001 fanno riferimento, non attengono alla pubblica sicurezza,
anche se tuttora inseriti all'interno del testo unico di pubblica sicurezza.
14. La categoria "polizia amministrativa"
A dire il vero la questione è complessa e, quindi, non è possibile
prescindere dall'analisi che la Corte Cost. ha svolto nella sentenza 77/1987,
allorquando ha preso in esame il contenuto dell'articolo 19 del d.P.R. 616 del
1977. Secondo la Corte, la nozione di "polizia amministrativa" adoperata nel
decreto delegato, è diversa da quella che l'articolo 117
5
°Cost. elenca fra le
materie di competenza regionale come "polizia locale urbana e rurale", affermava
allora il Giudice delle leggi, perché appare chiaramente formulata per raggruppare
49
II d.P.R. 311 del 2001 novella, tra l'altro, la disciplina in materia di intrattenimento e
commercio cose usate, ambedue inserite all'art.
19
d.P.R. 616 del1977.
50
Ovviamente la Corte Co st. fa riferimento all'art. 117 nella sua formulazione antecedente alla
novella introdotta dalla l. Cost. 3 del 2001 che ha modificato i l titolo V Cost. prima della riforma,
l'art.117 Cost. prevedeva che "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e
degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica;
turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilità,
acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e
termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre
materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione i l potere di emanare norme per la loro
attuazione.
79

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 86/194
una categoria di ulteriori funzioni da attribuire alle regioni, alle province ed ai
comuni. La categoria "polizia amministrativa, secondo la Corte, è stata enucleata
da un complesso di disposizioni precedenti che appunto contemplavano funzioni
definite di "polizia amministrativa" solo in quanto molte di esse erano esercitate
in passato dagli organi dello Stato titolari delle funzioni di polizia in senso
proprio, giudiziaria e di sicurezza.
Funzioni definite di polizia amministrativa, quindi, perché non assolvendo
esclusivamente al compito della prevenzione, . come la polizia di sicurezza,
tendono - in presenza delle condizioni previste in astratto dalle leggi, a rendere
possibili e lecite certe attività dei privati attraverso singole attribuzioni, quali le
autorizzazioni, i permessi, le licenze ed anche i regolamenti. Questa caratteristica,
affermava ancora la Corte, ha fatto addirittura spesso dubitare dell'inquadramento
di molte di quelle funzioni nella categoria delle attività di polizia e, più
di
recente,
ha fatto ritenere anche inesistente una nozione giuridicamente rilevante di "polizia
amministrativa", così giustificandosi la sottrazione di molte di quelle funzioni agli
organi di polizia e la loro conseguente attribuzione alle regioni ed agli altri enti
territoriali, restando ovviamente impregiudicata la tutela statale per le esigenze
attinenti alla sicurezza pubblica.5
1
15.
Autorizzazioni o licenze?
Autorizzazioni o licenze? Questo
è
oggi il grande dilemma che
accompagna il sistema autorizzatorio disciplinato dal testo unico di pubblica
sicurezza. Autorevole dottrina
52
ha da tempo individuato gli elementi distintivi
delle due tipologie di atti abilitativi facendo rientrare le autorizzazioni nella sfera
51
Non aiuta nella ricostruzione del significato del termine "Polizia amministrativa"
il
d.P.R.
15
gennaio 1987
n.
469 "Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli
Venezia Giulia" Infatti, a ll'art.
17
dalla rubrica: polizia locale, urbana e rurale, dispone che:
l. La Regione Fr.V.G. è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie elencate
negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.
2 . La delega alla regione Fr.-V.G. di funzioni amministrative statali si considera conferita anche
per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.
3 .Nella regione Fr.-V.G. si applicano gli articoli 19, 20 e
21
del d.p.r.
n.
616.
52
Sandulli A.M.
Manuale di diritto amministrativo.
XII ed. JOVENE EDITORE, Napoli 1980, pp.
423 ss
80

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 87/194
d'azione istituzionalmente libera e, quindi, una posizione di preesistente diritto
soggettivo; mentre la licenza consente l'attività sulla base di una valutazione
discrezionale circa la rispondenza all'interesse pubblico che, nelle condizioni
ambientali esistenti, una nuova attività di quel genere venga svolta o meno. Nelle
licenze, quindi, la discrezionalità non investe la valutazione dei requisiti, come
avviene nelle autorizzazioni, ma addirittura l'opportunità dell'esercizio
dell'attività.
Questa distinzione motiva, oggi più che mai, dopo la novella dell'art.
19
della
legge 241 del 1990 ad opera del d.l.
35
del 2005, l'esclusione del procedimento
semplificato della dichiarazione
di
inizio attività per i provvedimenti rientranti
nell'ambito del Tulps rimasti di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza.
Sul fronte opposto, si potrebbe ritenere che i procedimenti pur disciplinati dal
Tulps ma rientranti oggi nella nozione di polizia amministrativa, trasferiti alla
competenza dei comuni, con i decreti legislativi rispettivamente 616 del 1977 e
112 del 1998 sono oggi assoggettati ad autorizzazione e non a licenza e, in alcuni
casi, anche a dichiarazione di inizio attività. Infatti, la discrezionalità in capo al
comune competente non può rilevare ai fini di pubblica sicurezza ma soltanto con
riferimento alla ponderazione degli eventuali interessi contrapposti, alla luce del
conclamato articolo
41
Cost.
Tuttavia, secondo una dottrina più recente
53
,
la licenza che era definita come il
provvedimento che permette lo svolgimento di un'attività previa valutazione della
sua corrispondenza ad interessi pubblici, ovvero della sua convenienza in settori
non rientranti nella signoria dell'amministrazione (perché in tal caso
si
dovrebbe
parlare di concessioni) è
figura che oggi la legge tende a sostituire con
l'autorizzazione. Insomma, autorizzazione o licenza sono la stessa cosa e, quindi,
la richiesta di una autorizzazione o di una licenza fanno scattare un interesse
legittimo pretesivo, ovvero il soggetto richiedente mira ad ottenere una situazione
di vantaggio grazie ad un'attività della pubblica Amministrazione che incide in
modo favorevole sulla sua situazione soggettiva.
53
Casetta E.,
Manuale di diritto amministrativo.
GIUFFRE' Taranto 2007, pag. 322
81

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 88/194
Ma quale è l'attività che la PA deve porre in essere per soddisfare la pretesa? Qual
è
l'interesse pubblico che deve fungere da parametro? La sola verifica del
possesso dei requisiti soggettivi è elemento sufficiente o va invece compiuta
qualche ponderazione aggiuntiva? Posto che per l'attività commerciale, ad
esempio, il legislatore è intervenuto, nel tempo, a chiarire la fattispecie,
delineando un quadro certo, per quanto riguarda i procedimenti riconducibili alla
polizia amministrativa i contorni non sono stati ancora ben definiti.
Oggi che con la riforma dell'art. 117 Cost la potestà legislativa per la disciplina
delle attività economiche è stata trasferita dallo Stato alle regioni l'interrogativo
sui contenuti della discrezionalità
è
d'obbligo, soprattutto per quelle attività che,
più di ogni altra, possono rendere difficile l'individuazione dell'interesse pubblico
o utilità sociale.
54
Allo stato attuale, tuttavia, nessuna regione ha ancora messo mano alla disciplina
delle materie elencate nell'art. 19 d.P.R. 616 del 1977 e nelle varie disposizioni
contenute nel d.lgs 112 del 1998 il cui esercizio della funzione è stato trasferito ai
comuni. Dopo la legge Cost. 3 del 2001 diverse regioni si sono cimentate nel
ridisciplinare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ma
l'hanno fatto usando come canovaccio la legge 28711991 che, a livello nazionale,
era stata a suo tempo emanata a fini di programmazione commerciale. Ma nessuna
di queste regioni ha previsto la disapplicazione delle disposizioni contenute nel
Tulps per la regolamentazione dell'attività contenuta nell'art.86. Anzi, la Regione
Veneto con la recente l.r. 29/2007 ne ha fatto proprio il sistema sanzionatorio
contenuto negli artt.
17
bis e seguenti.
E dire che la fine del monopolio statale del diritto consentirebbe l'emergere,
accanto allo Stato apparato, di una molteplicità di istituzioni distinte, espressive di
variegate realtà sottostanti, tra le quali vengono a collocarsi anche le comunità
locali: il pluralismo istituzionale, in altri termini, si configura quale una delle
54
Interessanti a tale proposito le considerazioni espresse da Andrea Bitetto
su
Problemi
interpretativi e applicativi in tema di liberalizzazione del commercio. astrid Rassegna
www.astrid-online.it 29 maggio 2008 pag. 8
82

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 89/194
manifestazioni, articolata sulla base dell'elemento territoriale, di quel pluralismo
sociale che connota lo Stato democratico contemporaneo.
55
16. Semplificazione a carattere generale
E'
stato affermato che
il
d.P.R.
311
del 2001
è
un decreto complesso e
sono stati individuati
alcuii.i
motivi che giustificano l'affermazione. Tuttavia, ci
sono ulteriori contenuti nel d.P.R. 311 del 2001 che presentano elementi di
criticità.
La prima osservazione riguarda l'art. 2 la cui rubrica recita "Semplificazioni a
carattere generale"; dispone
i l
comma l che:
l
Al regolamento di esecuzione del testo unico
18
giugno 1931,
n.
773, delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:
In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al
titolo III della stessa legge
56,
la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali
o regionali, hanno carattere permanente, salvo che
si
riferiscano ad attività da
svolgersi per un tempo determinato."
Si tratta di una disposizione assolutamente innovativa in relazione al fatto che,
precedentemente, tutte le autorizzazioni o licenze, avevano durata annuale e, per
essere rinnovate, era necessario provvedere al pagamento della tassa di
concessione che ne prorogava la validità. Quanto appare decisamente strano, in
relazione alla disposizione in esame
è
che, nonostante i l d.P.R.
311
del 2001 sia
stato emanato al sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 40011988
57
, non è
55
Sulla nozione di autonomia costituzionale delle comunità locali, in un'ottica volta a evidenziare
la connessione con il principio pluralistico, v. in particolare Rolla G., L'autonomia costituzionale
delle comunità territoriali.
Tendenze
e problemi, in Groppi T. (a cura di), Principio di autonomia e
forma dello
Stato
Giappichelli, Torino, 1998 15 ss.
56
Il titolo m del Tulps contiene le disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie,
tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.
57
Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 400/1988, disciplina l'emanazione dei regolamenti di
delegificazione. Specificatamente, dispone che:
83

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 90/194
stato abrogato,
rectius
modificato contestualmente, l'articolo 13 del Tulps che
dispone la validità annuale delle autorizzazioni di polizia.
Ulteriore comma dispone che:
"Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in
locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o
di
sostanziali
modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di
regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità,
comunque definita, dei locali medesimi."
La finalità di questa disposizione è assolutamente oscura. Infatti, l'articolo 71 del
Tulps dispone che "le licenze di cui agli articoli precedenti
58
,
sono valide
solamente per i l locale e per il tempo in esse indicati". In pratica, ogni
trasferimento deve essere preventivamente autorizzato. Alla stessa stregua, gli
articoli 152 e 153 del regolamento Tulps prevedono rispettivamente l'obbligo di
indicare nella domanda l'ubicazione del locale e la sua insegna; la licenza può
essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si
prestino ad essere convenientemente sorvegliate". In sostanza, dal combinato
disposto degli articoli 152 e 153 regolamento Tulps si evince inequivocabilmente
che ogni variazione di sede presuppone il rilascio di nuova autorizzazione che
potrà essere concessa se sono rispettate le relative condizioni. Non pare, in
pratica, che nel sopraindicato comma o nelle novità complessivamente introdotte
dal d.P.R.
311
del 2001 siano stati apportati elementi tali da rendere necessario
riconfermare l'obbligo
di
verifica (e quindi di rispetto) delle disposizioni di legge
e di regolamento eventualmente previste per l'esercizio dell'attività.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.
58
La disposizione riguarda le autorizzazione per l'attività
di
intrattenimento e di pubblico
spettacolo disciplinate dagli articoli
68
e 69, ovvero quelle oggetto del presente approfondimento.
84

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 91/194
17. Autocertificazione e controlli
La lettera b) del comma l dell'articolo 2 del d.P.R. 311 del 2001 novella
l'articolo 12 del regolamento Tulps. Detto articolo dispone, in particolare,
al
primo e secondo comma che:
''Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei
requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le
disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative."
Relativamente
al
primo comma, va sottolineata la coerenza del legislatore che
accentua, riproponendolo in questo articolo, il diritto ali' autocertificazione. Del
resto, il d.P.R. 28 dicembre 2000,
n.
445, Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa era entrato in vigore
da soli pochi mesi e, di conseguenza, appare giustificata una enfatizzazione delle
procedure. Ciò che, invece, non può essere ritenuto condivisibile
è
quanto dispone
il successivo comma:
È
fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti,
con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione
dei suoi effetti."
La perplessità connessa
al
contenuto di questa disposizione
è
motivata dal fatto
che l'articolo 71 "Modalità dei controlli" del d.P.R. 445 del 2000 prevede, al
primo comma, che:
l.
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47."
Il comma l dell'articolo
71
dispone con assoluta chiarezza che le amministrazioni
procedenti sono tenute ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47. La norma, allora, dispone un comportamento obbligatorio e
cogente. Le amministrazioni sono obbligate ad effettuare i controlli sulle
85

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 92/194
dichiarazioni: non si tratta di una facoltà, ma di un dovere d'ufficio, che completa
l'iter procedimentale anche se
il
controllo interviene dopo che
il
provvedimento
sia già stato emanato. Le amministrazioni, pertanto, non possono scegliere se
effettuare o meno i controlli, in quanto
si
tratta di un adempimento assolutamente
doveroso.
Il medesimo comma l precisa, peraltro, ed a maggior ragione, che i controlli
debbono essere effettuati "in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi" sulla
veridicità delle dichiarazioni. Quindi, se il responsabile del procedimento ritiene
possibile o probabile che la dichiarazione ricevuta sia falsa, deve necessariamente
procedere al riscontro successivo. La norma sembra suggerire, tuttavia, il dovere
di esplicitare con una congrua motivazione il fondamento del dubbio sulla
veridicità della dichiarazione.
Il comma l dell'articolo 71 (Modalità dei controlli) del d.P.R. 445 del 2000 si
completa con un'altra importante affermazione, che ha indotto alcuni a ritenere
che i controlli siano un adempimento sostanzialmente eventuale, tenuto conto che
la norma consente l'effettuazione dei controlli a campione.
Dalla lettura, dall'interpretazione e dalla finalità della norma, invece, si desume
tutt'altro. In sostanza, si deduce che quanto è facoltativo è proprio il controllo con
la metodologia del campione. Non si spiegherebbe, se così non fosse, il testo della
disposizione, che prescrive "le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione ...
.
L'utilizzo dell'inciso anche fa
comprendere che per le amministrazioni è possibile, se lo ritengono opportuno,
non effettuare i controlli su tutte le dichiarazioni, ma questo non significa che
- l'adempimento del controllo sia divenuto esso stesso una facoltà. In pratica, il
controllo a campione è solo un metodo di svolgimento del riscontro, di tipo
statistico
59
; è questo il motivo per il quale il d.P.R.
311
del 2001, che prevede
esplicitamente la mera facoltà della verifica dei requisiti, non pare coerente con
l'intero sistema di semplificazione che, se da un lato ha sottratto al cittadino
59
Oliveri
L., I controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del Testo unico sulla
documentazione amministrativa,
in www .lexitalia.it
86

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 93/194
l'adempimento di obblighi formali, quale quello di andare nei diversi uffici e
richiedere l'estrazione di certificati, dall'altro ha trasferito alla PA l'onere di
verificare la veridicità di quanto asserito e, quindi, il possesso dei requisiti di volta
in volta richiesti dalle diverse disposizioni di riferimento.
Del resto, l'ultimo comma dell'art.
18
(Autocertificazione) della legge 241/1990
prevede che:
"3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli
stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione é tenuta a certificare."
Integra la disposizione della legge sul procedimento il d.P.R. 26 aprile 1992,
n.
300 "Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli
articoli
19
e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241." Il comma 2 dell'articolo 3 del
d.P.R. 300/1992, dispone che:
2 . La denuncia e la domanda devono identificare le generalità del richiedente e
le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere; inoltre, alla denuncia o alla
domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la
sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e
contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attività.
quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia e la domanda
devono contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o
conseguimento dei requisiti stessi."
In sostanza, la legge 24111990 che disciplina il procedimento amministrativo
prevede, all'articolo 18, che la PA acquisisce d'ufficio gli atti e documenti
necessari all'istruttoria procedimentale. Inoltre, la verifica dei requisiti dichiarati
dal proponente
è
effettuata dalla medesima P
A,
in base all'art. 3 d.P.R. 30011992
che, in particolari situazioni può effettuare tale verifica, a campione.
La disposizione contenuta nel d.P.R. 311 del 200 l che dà facoltà alla PA di
effettuare le verifiche sui requisiti, in sostanza,
è
totalmente estranea non solo al
quadro normativa in materia di semplificazione appena delineato ma anche allo
87

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 94/194
spirito che ha caratterizzato la stagione delle riforme. Infatti, obiettivo di ogni
legge di semplificazione è stato quello di eliminare gli oneri a carico delle imprese
al fine di aumentarne la produttività e la competitività anche trasferendo sulla PA
la responsabilità ad effettuare i controlli. Mai, in sostanza,
si
è operato nel senso
di sorvolare sull'accertamento dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle
attività disciplinate dalla legge. Quando, poi, l'attività rientra tra quelle
disciplinate dal Tulps, anche se nella materia della polizia amministrativa,
l'omissione di ogni approfondito controllo risulta addirittura inopportuna in
relazione al fatto che i l medesimo Tulps affida alla PA competente una
valutazione discrezionale con riferimento a i requisiti di onorabilità previsti dal
secondo comma dell'art. 11 del testo unico in questione.
18.
Commissione comunale e commissione provinciale
L'articolo 4 del d.P.R.
311
del 2001, istituisce la commissione comunale
di vigilanza pubblico spettacolo assegnando alla stessa specifiche funzioni diverse
da quelle assegnate alla commissione provinciale. Composizione e funzioni della
commissione comunale saranno esaminate, in maniera approfondita, nel prossimo
capitolo. Quanto interessa qui evidenziare è che lo scenario normativa nel
momento in cui si è messa mano alla modifica del regolamento Tulps è
estremamente complesso. Infatti, dall'articolo 158 del d.lgs 112 del 1998 è stata
data definizione alla materia della polizia amministrativa operando la distinzione,
peraltro già elaborata dalla Corte costituzionale, con la materia della pubblica
sicurezza. Pochi mesi dopo rispetto alla pubblicazione in Gazzetta del d.P.R.
311
del 200 l avvenuta il 2 agosto 200 l è entrata in vigore la legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
che è stata pubblicata nella GU n. 248 del 24 ottobre 2001 a seguito del
referendum confermativo sul testo della legge costituzionale approvato dal
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.
59 del
12
marzo 2001. Con
tale legge costituzionale è stata sottratta allo Stato la potestà legislativa in materia
88

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 95/194
di polizia amministrativa e la contestuale potestà regolamentare nelle diverse
materie che viene, adesso, assegnata al soggetto che esercita la funzione.
Nonostante questo quadro ben delineato,
i l
Ministero dell'Interno al quale il
terzultimo comma dell'articolo
19
del d.P.R. 616 del 1977 riconosce che "In
relazione alle funzioni attribuite
ai
comuni il Ministero dell'interno, per esigenze
di
pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo,
direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle" interviene con una circolare
interpretativa sui contenuti del d.P.R.
311
del2001 per la parte relativa
ai
soggetti
che ai sensi della novella del regolamento Tulps possono certificare, mediante una
relazione tecnica,
i l
rispetto delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene
dei locali o degli impianti destinati all'attività
di
trattenimento e pubblico
spettacolo.
60
E dire che, a tale proposito, la Corte costituzionale con la sentenza
60
Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia
amministrativa e sociale. Nota 11 febbraio 2003, n. 557/B.363.12982(3) D.P.R. n. 311 del 28
maggio 2001 - Chiarimenti "Come è noto, il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, recante il
Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento
di attività disciplinate dai Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento
della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ha introdotto rilevanti modifiche incidenti sui
procedimenti autorizzatoti di polizia.
Con riferimento al settore specifico dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo,
una novità, con evidente intento semplificatorio dell'attività delle commissioni ai vigilanza,
è
data
dalla possibilità, prevista dal testo novellato dell'an. 141 del Regolamento di esecuzione al Tulps,
che, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche
e gli accertamenti siano sostituiti da una relazione tecnica dì un professionista iscritto nell'albo
degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza dei locale o dell'impianto alle
regole tecniche stabilite con decreto dei Ministro dell'Interno.
A tale riguardo numerosi Uffici Territoriali del Governo hanno sollevato dubbi interpretativi: in
particolare è stata posta all'attenzione dello scrivente Ufficio la questione circa l'esatta
individuazione della normativa di riferimento per il professionista chiamato ad effettuare le
verifiche.
Questo Dipartimento, attesa la valenza generale della problematica, nonché l'esigenza
di
garantire
una uniforme applicazione delle norme da parte degli uffici periferici di questa Amministrazione,
ha ritenuto opportuno acquisire le valutazioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile.
Il cennato Dipartimento, nel rendere noto il proprio avviso, ha rappresentato che il quadro
normativa di riferimento, anche per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a
200 persone, è dato dalla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, approvata con decreto del Ministro
dell'Interno D.M. 19 agosto 1996.
Tale fonte normativa infatti contiene disposizioni di prevenzione incendi riguardanti sia la
tipologia di locali con capienza superiore a 100 persone (art.
l,
comma
l,
punto e)) sia quella con
capienza non superiore a 100 persone (art, l, comma 3), cui si applicano le disposizioni del titolo
XI dell'allegato allo stesso decreto.
89

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 96/194
7711987 si
era già espressa nel senso che l'art.
19,
III comma del d.P.R.
616
del
1977
non
è
lesivo degli artt. 5 e
128
Cost. posti a salvaguardia delle autonomie
locali, perché l'ingerenza dello Stato sulle attività previste nel suddetto art. 19
avviene mediante direttive generali, in via preventiva e per il perseguimento
di
esigenze di sicurezza e ad opera
di
organi istituzionalmente preposti alla cura di
questo tipo di interessi pubblici; il che, in una visione armonica e coordinata delle
funzioni pubbliche appare perfettamente conforme
ai
principi costituzionali.
Problema certamente diverso, affermava peraltro la Corte, é quello secondo cui
l'emanazione delle direttive potrebbe essere utilizzata dallo Stato con riferimento
ad esigenze diverse da quelle che riguardano la sicurezza pubblica ma in
evenienze del genere si sarebbe in presenza
di
un cattivo uso del potere conferito
dalla norma.
19.
La
Costituzione economica si consolida
A metà del guado, tra l'emanazione del d.P.R.
311
del
2001
che novella il
regolamento Tulps e la modifica titolo V Cost, con la sentenza
n.
290
del
26
luglio 2001, la Corte costituzionale, entra nuovamente nel merito della distinzione
tra polizia amministrativa e pubblica sicurezza.
La funzione di polizia
di
sicurezza, ha osservato la Corte, richiamando una propria
precedente sentenza, la n. 218 del 1988 e a Costituzione invariata, riguarda le
misure preventive e repressi ve dirette
al
mantenimento dell'ordine pubblico e,
pertanto, si riferisce alla attività di polizia giudiziaria e a quella di pubblica
Lo stesso Dipartimento, nella medesima occasione, ha altresì chiarito che, nelle more dell'adozione
del decreto interministeriale con i l quale devono essere individuati i livelli di sollecitazioni fisiche
prodotte da attrezzature meccaniche o elettromeccaniche, il cui superamento radica la competenza
della commissione provinciale di vigilanza, possano ritenersi in vigore e dunque applicabili, per
tutto ciò che non attiene alla prevenzione incendi, le disposizioni diramate con la circolare n. 16
del1951.
Si coglie, infine, l'occasione per richiamare l'attenzione di codesti uffici sulla recentissima
pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2002,
n. 293 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. l del 2 gennaio 2003 Serie generale) con il quale,
modificandosi ancora l'art.
141
del Regolamento di esecuzione
al
Tulps, anche le figure
professionali degli architetti e dei periti industriali (art. l comma
l)
sono state ammesse ad
espletare le attività di verifica e di accertamento prima rimesse solo agli ingegneri ed ai geometri.
Tanto si rappresenta quale contributo per i conseguenti adempimenti di codesti Uffici."
90

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 97/194
sicurezza; la funzione di polizia amministrativa riguarda, diversamente, l'attività
di
prevenzione e repressione diretta ad evitare danni o pregiudizi a persone o cose
nello svolgimento di attività rientranti nelle materie affidate alla competenza
regionale. L'art. l della legge
15
marzo 1997,
n.
59, ha delegato
il
Governo ad
emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali
funzioni e compiti amministrativi (comma
1),
estendendo l'ambito del
conferimento alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle
comunità locali, nonché allo svolgimento di tutti i compiti e
di
tutte
le
funzioni
localizzabili nei rispettivi territori, in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato, centrali o periferiche, ovvero tramite enti o altri
soggetti pubblici (comma 2).
n
medesimo
art. l, al
comma
3,
lettera
1),
ha tuttavia
escluso dal conferimento le funzioni e i compiti riconducibili alla materia
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
L'art. 159, comma
2, del d.lgs. n. 112 del 1998 precisa, poi, che le funzioni e i
compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica
concernono le misure preventive e repressive dirette
al
mantenimento dell'ordine
pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli
interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella
comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro
beni.
E'
opportuno chiarire che tale definizione nulla aggiunge alla tradizionale
nozione
di
ordine pubblico e sicurezza pubblica tramandata dalla giurisprudenza
della stessa Corte, nella quale la riserva allo Stato riguarda le funzioni
primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o
psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume
primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento. E' dunque in questo
senso che deve essere interpretata la locuzione "interessi pubblici primari"
utilizzata nell'art. 159, comma
2:
non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura
siano preposte le pubbliche amministrazioni, ma soltanto quegli interessi
essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile. La precisazione,
conclude la Corte, é necessaria ad impedire che una smisurata dilatazione della
nozione di sicurezza e ordine pubblico si converta in una preminente competenza
91

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 98/194
statale in relazione a tutte le attività che vanificherebbe ogni ripartizione di
compiti tra autorità statali di polizia e autonomie locali.
Del resto, precisa ancora la Corte, lo stesso art. 159 del decreto legislativo 112 del
1998,
al
comma
l,
definisce le funzioni e i compiti di polizia amministrativa
regionale e locale, alle quali riconduce le misure dirette
ad
evitare danni o
pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e alle cose nello
svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le
competenze, anche delegate, delle Regioni e degli enti locali, purchè non siano
coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell'ordine pubblico e
della sicurezza pubblica, poichè in questo caso si esulerebbe dai compiti di polizia
amministrativa e si ricadrebbe in un ambito di attività riservate allo Stato.
Ma ancor di più è definitoria la Corte costituzionale nel momento in cui, a
conclusione delle sue argomentazioni, asserisce che "quando venga in
considerazione l'attività dei privati a contenuto economico, nelle svariate forme
giuridiche nelle quali essa può manifestarsi, la scelta di larga massima compiuta
dal legislatore, [ ...] stata quella di rimettere ogni valutazione agli organi che sono
espressione diretta o indiretta della comunità locale, sulla non irragionevole
premessa che siano in primo luogo questi, per la loro maggiore vicinanza alle
popolazioni amministrate, ad averne a cuore lo sviluppo economico, in
applicazione del principio di sussidiarietà, la cui realizzazione costituisce uno dei
principali obiettivi della legge di delegazione. Ciò non significa che l'ambito delle
competenze statali nel rapporto tra attività economica e sicurezza pubblica sia
stato interamente soppresso: esso, nel confine mobile segnato dalle opzioni del
legislatore in materia di controlli sullo svolgimento delle attività economiche, si é
tuttavia considerevolmente ridotto. E' infatti rimasto integro il potere generale di
prevenzione e repressione dei reati, ma si é venuta ridimensionando quella sua
proiezione provvedimentale, che si esprimeva in misure direttamente incidenti
sull'attività economica, per dar luogo a un nuovo equilibrio di poteri tra Stato ed
autonomie che vede riservato al primo l'adozione di misure ablatorie, preventive e
repressive, sulla base peraltro di procedimenti interamente giurisdizionalizzati in
92

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 99/194

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 100/194
t6

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 101/194
CAPITOLO TERZO
LA SICUREZZA DEI LOCALI E LUOGHI PUBBLICI
SOMMARIO: l. Il comportamento penalmente sanzionabile. - 2. La normativa
antincendio. -
3.
L'articolo 80 del Tulps. - 4 La disciplina della materia. - 5. Il
silenzio assenso per atti discrezionali. - 6. La sicurezza. - 7. Il Certificato di
prevenzione incendi (CPI). - 8.
Il
CPI e l'agibilità (in senso lato). -
9.
La regola
tecnica: le origini. - 10. Specifica, norma e regola tecnica. - 11. Il teatro come
struttura. - 12. La regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico
spettacolo. - 13. La commissione di vigilanza pubblico spettacolo. - 14. La
commissione comunale. - 15. La composizione della commissione. - 16. La
competenza del sindaco. -
17.
La soppressione delle commissioni inutili. -
18.
Le
competenze tecniche della commissione. - 19. La conferenza dei servizi in luogo
della commissione. - 20. L'attività della conferenza.
l. Il comportamento penalmente sanzionabile
L'articolo
681
1
(Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o
trattenimento) del codice penale, dispone che:
"Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o
ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità
pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a
euro 103".
Questa disposizione è una norma penale in bianco, perché non è applicabile se,
nel caso concreto, non siano state emanate prescrizioni dell'Autorità a tutela
dell'incolumità pubblica. L'articolo 681, quindi, ha carattere meramente
sanzionatorio. Commette contravvenzione, pertanto, colui il quale apre o tiene
1
Il codice penale attualmente in vigore in Italia è il frutto di un percorso legislativo durato 5 anni,
dal4 dicembre 1925, giorno in cui venne pubblicata la legge n. 2260 con la quale il governo venne
delegato ad emendare
il
codice penale allora in vigore (cd. codice Zanardelli), al 19 ottobre 1930
giorno in cui venne promulgato i l codice, realizzato tecnicamente sotto la direzione di Vincenzo
Manzini, con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato sulla GU del 26 novembre 1930,
n.
251,
SO. Il regio decreto di promulgazione riporta in calce le firme del Re d'Italia Vittorio Emanuele
III, dell'allora Capo del Governo Benito Mussolini, e del Ministro della Giustizia (Guardasigilli)
Alfredo Rocco di cui i l codice porta il nome.
95

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 102/194
aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento e ritrovo, senza aver osservato
le prescrizioni.
E'
interessante osservare che l'art. 681, così come strutturato, di fatto
si
pone in
rapporto di specialità con l'art. 9 Tulps il quale pure punisce l'inosservanza delle
prescrizioni imposte in sede
di
rilascio dell'autorizzazione. In sostanza,
i l
legislatore ha preso coscienza che l'art. 9 Tulps appena citato è posto a presidio di
prescrizioni "amministrative"; mentre l'art. 681 c.p. tutela prescrizioni collegate
alla pubblica incolumità (e da qui, la sanzione penale più severa per quest'ultima
norma).
2
Il fatto consta
di
due elementi. Il primo
è
commissivo che può concretarsi tanto
con un'azione: l'aprire, quanto con un'omissione, ovvero il tenere aperti. L'altro
elemento è omissivo e consiste in una omissione, ovvero non fare ciò che
l'Autorità ha prescritto o in una azione: fare ciò che non si deve fare?
L'art.
681 c.p. si propone di tutelare la pubblica incolumità e di prevenire
eventuali danni o lesioni alle persone che frequentano esercizi pubblici, mediante
la prescrizione dell'osservanza
di
disposizioni amministrative volte allo scopo
sopraindicato, le quali devono essere osservate ogniqualvolta, per i motivi più
gravi, vengano poste in essere le condizioni che favoriscano l'afflusso in un dato
luogo di
un
numero considerevole di persone.
4
I luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo citati nella disposizione,
sono tutti quelli, all'aperto o al chiuso, comunque destinati ad ospitare il pubblico
per ragione
di
divertimento o per qualsiasi altro motivo. Di conseguenza,
concettualmente dovrebbero essere assoggettati a tale norma anche i pubblici
esercizi, i circoli, le chiese e le scuole, Tuttavia, la disciplina amministrativa di
polizia (amministrativa), presupposto dell'art. 681 che ha carattere esclusivamente
2
In tal senso Cass. Pen, Sez. I, sentenza 7 aprile 2005
n.
13055
3
Manzini V., Trattato diritto Pen. italiano, Vol. 10, UTET, Torino 1986, p. 553
4
Trib. Massa, 6 agosto 2003 Paletti Riv. pen. 2003, 1017 in www.jurisdata
96

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 103/194
sanzionatorio
fa
riferimento esclusivamente ad una certa tipologia di locali.
5
Infatti, l'art. 80 del Tulps dispone che:
"L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un
teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una
commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio".
n codice penale del 1859 e quello toscano del 1853 non contenevano alcuna
norma dal medesimo contenuto. Una disposizione simile a quella oggi presente
nel codice penale, invece, apparve per la prima volta nel progetto di codice penale
del 1887
al
fine
di
prevenire gli incendi nei teatri che, ali' epoca, si manifestavano
con una certa frequenza a causa, soprattutto, dei mezzi di sicurezza. Ciò che
i l
legislatore, comunque, nel 1930 ha voluto fare, è stato di tenere distinto, rispetto
al codice precedente del 1889, il reato previsto dall'art. 681, il quale espone a
pericolo la pubblica incolumità, dalle altre contravvenzioni concernenti gli
spettacoli, trattenimenti o ritrovi pubblici e specialmente dal reato previsto
dall'articolo 666
6
che riguarda contravvenzioni relative all'ordine pubblico e la
tranquillità pubblica. Sottolineare questa distinzione che la dottrina
7
, fin dalla
stesura del codice ha voluto svolgere, non è di poco conto, perché qualifica
inequivocabilmente una materia che è stata, e sempre sarà, di competenza
esclusiva dello Stato.
n bene-interesse che l'art. 681 c.p. intende proteggere è, quindi, quello
dell'incolumità pubblica ed in tale nozione va ricompresa non soltanto la vita
umana ma anche l'integrità fisica e la salute delle persone. Non è un caso, quindi,
se la violazione dell'art. 681 è rimasta ancora, dopo le due leggi di
depenalizzazione, sanzionata penalmente mediante arresto o ammenda; mentre
per la violazione all'art. 666 c.p. che punisce colui il quale dà spettacoli o
5
Manzini V.,
Trattato diritto
Pen. Italiano cit. p. 554
6
L'art. 666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza, dispone che "Chiunque, senza la
licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o
trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o
di
audizione, è punito con
l'ammenda da lire ventimila a un milione."
7
Manzini V.,
Trattato diritto
Pen.
italiano,
cit, p. 553
97

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 104/194
trattenimenti
di
qualsiasi natura, in carenza di autorizzazione, oggi è soggetto
soltanto
al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
8
• Evidentemente,
secondo il legislatore, la tutela dell'ordine pubblico che l'art. 666 persegue, inteso
come condizione di pacifica convivenza, di buon assetto e regolare andamento del
vivere civile, necessita di minor tutela rispetto all'incolumità pubblica. Del resto,
il ricordo dell'incendio del cinema Statuto di Torino è ancora troppo intenso
perché si possa soltanto immaginare una disciplina o una sanzione di minor
rigore.
In
sostanza, tralasciando ogni possibile riferimento alla più recente
depenalizzazione, va posto in rilievo che, nonostante gli articoli 666 e 681 trovino
collocazione tra le contravvenzioni concernenti la polizia
di
sicurezza, diverso è
l'oggetto specifico dei due reati. L'interesse oggetto di tutela nella
contravvenzione di cui all'art. 666 è la pubblica tranquillità o ordine pubblico,
mentre quello tutelato dall'art.
681
è la pubblica incolumità. Certamente la rubrica
di quest'ultimo: "Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o
trattenimento" non aiuta nel tentativo di ricostruire una interpretazione coerente
al
mutato quadro normativo rispetto all'epoca in cui il codice è stato elaborato,
anche perché sussiste il dubbio su quale sia l'Autorità le cui prescrizioni devono
essere osservate.
E' indubbio,
al
di là di quest'ultima osservazione, come il bene giuridico tutelato
(la pubblica incolumità) abbia indotto da sempre la giurisprudenza, facendo leva
anche sulla rubrica dell'articolo ove si parla testualmente di "apertura abusiva di
luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento" ad operare un'interpretazione
estensiva del precetto e a considerare applicabile l'art. 681 c.p. anche in caso di
apertura abusiva tout court di un locale, cioè in assenza della licenza di agibilità.
9
8
La sanzione per la violazione all'art. 666 c.p.
è
stata depenalizzata dall'art. 49, d.lgs. 30 dicembre
1999,
n.
507.
9
Tra le altre, Cass. Pen., Sez. I, sentenza 26 settembre 2006
n.
31571.
98

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 105/194
2. La
normativa antincendio
Prima ancora di prendere dettagliatamente in esame quali sono i locali di
pubblico spettacolo o di trattenimento o di ritrovo soggetti alla disciplina dell'art.
681
c.p. e dell'art. 80 Tulps, non è superfluo evidenziare che la prima norma in
materia
di
prevenzione incendi
è
stata emanata soltanto nel settembre del 1934 e,
quindi, ben quattro anni dopo l'entrata in vigore del codice penale. Si trattava del
d.m.
31
luglio 1934 "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione,
l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto
degli stessi". Mentre
è
dell'anno successivo i l regio d.l. 10 ottobre 1935, n. 2472
"Organizzazione provinciale e coordinazione nazionale dei servizi pompieristici".
La prima legge organica in materia, comunque,
è
la legge
27
dicembre 1941
n.
1570 che detta "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi"
10
•
Questa legge, che
è
rimasta in vigore fino a tempi recentissimi
11
,
prevedeva un
ruolo importante per il Ministero dell'Interno che, in base all'art. 28, era tenuto a:
a) dare le direttive generali per la prevenzione e l'estinzione degli incendi e per i
soccorsi tecnici in genere;
b) impartire le istruzioni di massima per l'acquisto ed
i l
collaudo dei materiali,
tenendo presenti i criteri della unificazione;
c) compiere gli studi e decide sulle questioni tecniche ed organizzati ve di indole
generale;
d) stabilire, su proposta dei comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco, quali
industrie, stabilimenti, depositi e simili, debbono avere servizio proprio
di
10
Successivamente sono state approvate disposizioni speciali per determinati tipi di immobili. Per
gli edifici storici la disciplina in materia antincendio è intervenuta, ad esempio, solo nel 1942 con
l'emanazione del r.d. 7 novembre 1942 n. 1564 "Approvazione delle norme per l'esecuzione, i l
collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e
quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse
culturale." Questo decreto è stato quindi, successivamente integrato dalle disposizioni contenute
nel d.m. 20 maggio 1992 n. 569 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli
edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre., in parte ancora in vigore".
Insomma, per la villa storica che viene adibita a sala convegni o vi vengono organizzate feste
danzanti, dovranno essere osservate le disposizioni speciali per gli edifici di pregio che il
legislatore ha espressamente individuato.
11
La legge 157011941, infatti,
è
stata abrogata dall'art. 35, d.lgs. 8 marzo 2006,
n.
139 con
esclusione di alcune specifiche disposizioni relative al personale.
99

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 106/194
prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima (personale e materiale) di
detto servizio, nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali;
e)
provvedere all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della prevenzione
incendi, dei materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e prodotti in genere;
f)
sorveglia l'andamento
di
ciascun Corpo dei vigili del fuoco.
Ed è, quindi, anche
12
in base a questa specifica attribuzione che viene diramata dal
Ministero dell'interno, la circolare
16
gennaio 1949,
n.
6 con oggetto:
"Organizzazione e disciplina dei servizi pubblici per la prevenzione degli
incendi". Lamenta il Ministero, nella citata circolare, che nonostante le
attribuzioni previste dalla legge
157011941
siano ben definite, in periferia le
disposizioni non vengono rispettate. "Risulta a questo Ministero, si afferma, che
in molte province, la prevenzione incendi non viene effettuata, o che, da parte
delle autorità competenti alla concessione delle licenze di esercizio (autorità
comunali nei riguardi dell'esercizio commerciale e autorità di pubblica sicurezza
nei riguardi di polizia, ai sensi di legge), non sempre vengono osservate le
disposizioni di legge innanzi ricordate, mentre le medesime autorità hanno
obbligo, prima del rilascio delle licenze, di richiedere la visita ed il controllo, da
parte del comandante dei vigili del fuoco". Inoltre, si precisa ancora "Nelle
località ove le anzidette prescrizioni sono in tutto od in parte osservate, vengono
seguiti criteri diversi da una città all'altra, non sempre tali da offrire
le
necessarie
garanzie. Si rende pertanto necessano di unificare i criteri e le modalità per
l'espletamento dei compiti di cui ai citati articoli di legge, in materia di
prevenzione incendi. Verranno, quindi, con provvedimenti in corso, sancite
apposite disposizioni che contempleranno le prescrizioni di cui appresso, le quali
12
Il
Ministero dell'Interno dialoga costantemente con gli uffici periferici a mezzo
di
circolari, a
prescindere, quindi, dalle disposizioni normative che gli riconoscono tale facoltà. L'uso delle
circolari, tipico delle organizzazioni burocratiche, vengono utilizzate dai superiori per impartire
ordini e disposizioni ai loro subordinati. Dal punto di vista giuridico gli ordini e le disposizioni
contenute nella circolare hanno validità limitata all'ordinamento interno dell'organizzazione e non
trovano, quindi, applicazione nei confronti degli estranei che si rapportano con essa. Nella pratica
le circolari sono largamente utilizzate nelle amministrazioni pubbliche, i cui uffici interpretano ed
applicano le norme di legge secondo le indicazioni in esse contenute.
100

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 107/194
dovranno essere obbligatoriamente osservate, con decorrenza immediata, sia dagli
enti pubblici che dai privati, sotto il rigoroso controllo delle SS.LL."
Infine, precisa il Ministero dell'interno: "Le competenti autorità, prima del
rilascio o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi innanzi specificati, e
della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno
richiedere il prescritto nulla osta al comando dei vigili del fuoco, il quale dopo la
visita sopralluogo, rilascerà un apposito "certificato di prevenzione incendi" dal
quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve
essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda
la
prevenzione
incendi. Nasce così quel documento, "il certificato di prevenzione incendi"
comunemente chiamato CPI che, ancora oggi, attesta che l'attività, sottoposta a
controllo, è conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
n Ministero dell'interno rispetta gli impegni assunti ed, infatti, solo due anni dopo
emana un'ulteriore circolare che, a tutt'oggi, viene adottata come parametro di
riferimento per le attività di trattenimento e svago. Si tratta della circolare
15
febbraio 1951, n. 16 contenente "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio
e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere." In
pratica, da tale data, il ruolo che la commissione provinciale di vigilanza pubblico
spettacolo veniva a svolgere, e di cui si dirà tra breve, viene fortemente
ridimensionato, nel senso che un embrione di regola tecnica fornisce al
comandante provinciale dei vigili del fuoco un ruolo di primo piano all'interno
della commissione che, peraltro, è presieduta dal prefetto, da cui gerarchicamente
dipende il comandante dei vigili del fuoco. Questo ruolo da protagonista del
comandante viene mantenuto nel tempo e permane tuttora, anche a causa di un
equivoco che un legislatore distratto ha reso possibile.
3.
L'articolo 80 del Tulps
Prima dell'emanazione della disciplina in materia antincendio che ha
individuato, con precisione,
i
requisiti per la costruzione e l'esercizio dei locali in
101

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 108/194
cui hanno luogo spettacoli o trattenimenti di qualsiasi genere o entità"'
3
che, come
si è evidenziato, è successiva sia al Tulps sia al codice penale, a garantire i l bene
giuridico che l'art. 681 c.p. intendeva e tuttora intende tutelare, vi provvedeva
l'art. 80 Tulps. Dispone, infatti, questa norma rimasta a tutt'oggi invariata che:
"L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un
teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una
commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi
sono a carico di chi domanda la licenza".
In sostanza, la commissione prevista dall'art. 141 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635,
che approva il "Regolamento per l'esecuzione del testo unico
18
giugno 1931,
n.
773 delle leggi di pubblica sicurezza" fornisce i l necessario supporto tecnico di
cui questore o prefetto hanno la necessità, tenuto conto che ali' origine non
esisteva alcun parametro tecnico da prendere a riferimento per l'apertura di teatri,
cinema o comunque locali di pubblico spettacolo. Quest'ultimi, infatti, sono stati
introdotti soltanto con la circolare
n.
16
del 1951.
E'
evidente che il rilascio della
licenza per l'apertura del locale non poteva prescindere dai necessari accertamenti
tecnici, tenuto conto che gli stessi erano e sono tuttora il presupposto che
giustifica il procedimento autorizzatorio.
La composizione della commissione è strutturata dal medesimo art. 141, il quale
così originariamente disponeva:
Per
l'applicazione dell'art. 80 della legge è istituita in ogni provincia una
commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal prefetto, che la
presiede.
13
La puntuale disciplina
è
contenuta nella già indicata circolare Ministero dell'interno 15 febbraio
1951, n. 16 nella quale, all'articolo 15, si afferma che: "le presenti norme riguardano la
costruzione e l'esercizio dei locali in cui hanno luogo spettacoli o trattenimenti di qualsiasi genere
o entità. Le norme generali di prevenzione incendi negli edifici
in
genere, nonché quelle previste
nei regolamenti locali edilizi e di igiene sono applicabili se e in quanto non contrastanti con le
presenti. Le norme stesse si applicano tanto
ai
locali in cui il pubblico è ammesso a pagamento
quanto a quelli in cui è ammesso ad invito."
102

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 109/194
Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del genio civile, il
comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un
rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante
dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle
organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonché il podestà del comune in cui
trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Può essere
aggregato, ove occorra, un esperto in acustica.
Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo è sostituito da chi ne fa le
veci o da altro funzionario espressamente designato, per i primi quattro membri,
l'esperto in elettrotecnica è sostituito da un supplente all'uopo designato, e i
rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei
lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle
rispettive organizzazioni sindacali.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con
l'intervento di tutti i componenti."
Oggi la composizione della commissione è mutata ed anzi esistono due tipologie
di commissioni, una comunale ed una provinciale, ma su questo specifico organo
ci si soffermerà più avanti.
Anche se a prima vista l'articolo 80 Tulps pare non ponga particolari
problematicità, diverse sono, invece, le questioni connesse a questa disposizione
direttamente collegata con l'articolo 681 c.p.
4. La disciplina della materia
Con
il
d.P.R. 616 del 1977 e precisamente con l'articolo 19, sono state
trasferite ai comuni diverse attribuzioni. Tra queste, figura
al
n. 9) la licenza di
agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 e al punto l O) i
regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo.
14
14
La funzione è relativa all'art.84 Tulps (art. 82 T.U. 1926) il quale disponeva che: "I Prefetti
provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine
e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo". L'articolo in questione è stato
abrogato dall'art. 6, d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
103

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 110/194
L'art 80 del Tulps prevede che non può essere concessa, prima dall'autorità di
pubblica sicurezza ora dal comune, la licenza per l'apertura
di
un teatro, di una
sala cinematografica o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto
verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e
l'esistenza
di
uscite pienamente adatte a consentire prontamente lo sgombero nel
caso di incendio.
Rientrano, quindi, nell'ambito di questa previsione una molteplicità di luoghi e di
locali, dal parco di divertimenti all'ippodromo, dalla discoteca
al
night, dal teatro
al cabaret.
15
In sostanza, ciò che il legislatore intende perseguire attraverso questa norma, è che
ogni locale aperto
al
pubblico o luogo pubblico cui si accede, indifferentemente
gratuitamente o a pagamento, deve possedere quella serie di requisiti
espressamente previsti dalla normativa vigente in materia
di
sicurezza e di
incolumità pubblica.
16
Tra autorizzazione per l'attività
di
trattenimento o
di
pubblico spettacolo prevista
dali' art. 68 del Tulps e verifica
di
agibilità prevista dali' articolo 80, a dire il vero,
non
c'è
alcun rapporto
di
connessione diretta, nel senso che nonostante un locale
sia stato dichiarato agibile, i l richiedente può non essere in possesso dei requisiti
di
onorabilità previsti dali' articolo 11 del medesimo Tulps e, quindi,
l'autorizzazione gli dovrà essere negata. Sul fronte opposto, un'associazione
di
volontariato che intende organizzare un concerto in una palestra dovrà richiedere
15
Secondo V. Manzini, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, sono tutti quelli,
chiusi o aperti, destinati ad accogliere il pubblico per ragione di divertimento o per altro motivo
qualsiasi che tenga liberamente riunito il pubblico per un certo lasso di tempo.
16
comunemente, alle diverse tipologie vengono assegnati i seguenti significati: Un luogo pubblico
è
uno spazio pubblico a cui può accedere chiunque senza alcuna particolare formalità, essendo
quello il suo scopo ed utilizzo normale e prevalente (ad esempio strade, piazze, giardini pubblici,
spiagge demaniali).
Un luogo aperto al pubblico è uno spazio in cui chiunque può accedere, limitatamente e
regolatamente a regole (che possono ad esempio essere un'orario d'apertura, il pagamento di un
biglietto d'ingresso, l'obbligo d'iscrizione ad un'associazione che lo gestisca) stabilite dal
proprietario (sia esso un privato o un ente pubblico) o da altre norme.
Un luogo esposto al
pubblico è uno spazio dove lo spazio stesso, ciò che vi si trova e ciò che vi
accade può essere esposto alla visione di un generico pubblico di persone.
104

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 111/194
la verifica dell'agibilità dei locali, ma non avrà la necessità di essere autorizzata ai
sensi dell'art. 68 Tulps.
17
La prima questione che rileva, in relazione alla citata criticità connessa all'art. 80
Tulps
è
questa "licenza" prevista al punto 9) dell'articolo 19 del d.P.R. 616 del
1977 che, nei fatti, non esiste in quanto l'articolo 80 prevede esclusivamente una
verifica
18
che si inserisce all'interno di un procedimento autorizzatorio, ovvero
quello per il rilascio della licenza per l'attività di trattenimento.
19
In relazione ai decreti delegati emanati in attuazione della legge 22luglio 1975,
n.
382, sembra quasi che Governo e regioni si siano, all'epoca, mossi secondo una
logica politica più che giuridica, che è stata quella dei rapporti fra i centri di
potere, perdendo così di vista i l criterio di una coerente e globale applicazione
della ridistribuzione dei compiti e delle funzioni fra Stato, regioni ed enti locali
per settori organici di materie individuate in base ad un analisi delle funzioni
svolte.
20
Non si comprende come, altrimenti, il connubio tra verifica di solidità e sicurezza
prevista dall'articolo 80 Tulps e autorizzazione all'esercizio di un'attività
economica di trattenimento e svago prevista dali' articolo 68 del medesimo testo
unico abbiano potuto ambedue convivere nel pacchetto di funzioni conferite ai
comuni sotto l'egida di quella "categoria" la cui definizione si andava già
consolidando sotto il nome di "polizia amministrativa".
E'
evidente, infatti, che la
17
La Corte Cost. con sentenza 15 aprile 1970 n. 56 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 68 del
tulps e 666 c.p. nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al
pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, occorra la licenza del questore (ora
del comune).
18
Correttamente, infatti, nell'allegato l della legge 15 marzo 1997, n. 59, al n. 78 risulta inserita la
voce" Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della commissione provinciale di
vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento: testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"
19
In tal senso Romeo G., Locali di pubblico spettacolo, II ed. Maggioli, Repubblica di San
Marino, 2002, p. 89. Secondo Rubertis (de) N.,
La
legislazione di pubblica sicurezza, IV ed.,
Noccioli, Firenze, 1987, p. 503, sotto la denominazione "licenza di agibilità" s'intende
l'emanazione del provvedimento comunale qualificante in ordine all'idoneità per l'apertura al
pubblico di un nuovo locale, o dell'adattamento, o trasformazione di un'esistente sala o impianto
s ~ o r t i v o
2
Celli R.,
Manuale di polizia amministrativa, le funzioni attribuite ai comuni dal D.P.R. 616,
2.a
edizione, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, Febbraio 1986, p. 22
105

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 112/194
verifica e la solidità di un immobile, di un locale o di
un
luogo, ha il fine,
chiaramente espresso dall'art. 681
c.
p. di tutelare la pubblica incolumità.
Attribuire al comune l'esercizio
di
questa funzione, già esercitata dal Corpo dei
vigili del fuoco che provvede ad emettere il certificato
di
prevenzione incendi,
non fa altro che realizzare una duplicazione di funzione che, in questo caso, non
è
lesiva del principio del decentramento bensì di quello di buon andamento della
pubblica amministrazione statuito dall'art. 97 Cost.
Solo con l'art. 159 del d.lgs 112 del 1998
è
stata data, m seguito, formale
definizione ai compiti e funzioni di polizia amministrativa, per distinguerli da
quelli relativi all'ordine e sicurezza pubblica. In base all'art. 159, "Le funzioni ed
i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale
concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere
arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle
materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle
regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e
gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica."
L'interrogativo che, a tale proposito, sorge naturalmente, con riferimento all'art.
80 Tulps, è
come possa la determinazione delle prescrizioni che devono essere
rispettate nella costruzione, e nella gestione, di
un
locale di pubblico spettacolo o
di trattenimento a tutela della pubblica incolumità essere funzione comunale di
polizia amministrativa e contemporaneamente funzione statale tesa ad assicurare
l'incolumità pubblica. In sostanza, in materia di prevenzione incendi e di
sicurezza, si determina una sovrapposizione tra il ruolo svolto dall'autorità
comunale e da quella statale
Allo stato attuale, fermo restando la particolare disciplina contenuta nel
d.
P R.
311 del 200 l che ha previsto l'istituzione di una commissione comunale oltre ad
innovare la composizione della commissione provinciale e ad individuarne
distinte attribuzioni, tutta la disciplina abitualmente presa a riferimento per la
procedura di controllo, è quella relativa alla materia della prevenzione incendi e
106

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 113/194
alle diverse regole tecniche approvate dal Ministero dell'interno per le diverse
fattispecie di attività.
Peraltro, sempre con riferimento all'articolo 80 Tulps, va registrata anche un'altra
criticità contenuta nel d.P.R. 407/1994
21
,
qui
di
seguito analizzata, che denota
come il processo di semplificazione avviato in attuazione della legge 241/1990 sia
stato gestito in maniera approssimativa.
5. Il silenzio assenso
per
atti discrezionali
Il primo significativo passo compiuto sulla strada della semplificazione è
riconducibile, come già accennato, alla legge
241
del 1990 che nello specifico
capo IV ha dettato nuove regole in tema di semplificazione dell'azione
amministrativa. Anche se la legge 241/1990 è comunemente nota come la legge
sulla trasparenza o sull'accesso, le regole in materia di semplificazione
amministrativa sono state la vera rivoluzione della riforma. Agli articoli 19 e 20,
si demanda, infatti,
ad
apposito regolamento l'individuazione di tutte le attività
che possono avere inizio, senza alcuna ulteriore formalità, immediatamente dopo
la presentazione
di
una apposita denuncia agli uffici competenti, (comma l e 2 art.
19)
nonché tutti i casi in cui una determinata domanda è considerata accolta se
non interviene la risposta dell'amministrazione in un termine prefissato (art.20)
invertendo, in assenso, contrariamente al passato, l'originario silenzio-rifiuto della
pubblica amministrazione.
Con l'apposito regolamento previsto dall'art. 19, in pratica, si vanno ad
individuare tutte
le
attività la cui "autorizzazione" all'esercizio è sostituita
da
una
"denuncia di inizio attività" da parte dell'interessato all'amministrazione
21
Si tratta del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 "Regolamento recante modificazioni al decreto del
presidente della repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla
disciplina degli articoli
19
e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241". Con i l d.P.R. 300 del 1992
erano state individuate tre distinte tabelle che comprendevano le attività sottoposte rispettivamente
alla disciplina dell'art.
19
(la tabella A e B) e dell'art. 20 (la tabella C). Detta tabella C, tuttavia,
non prevedeva alcuna attività disciplinata da leggi statali ma soggetta ad autorizzazione comunale.
A questa mancanza, quindi, si
è
ovviato con il d.P.R. 407/94 che comprende diverse distinte
ipotesi sia per il comparto del commercio, per quello della somministrazione di alimenti e bevande
e, infine, di polizia amministrativa.
107

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 114/194
competente. Questa innovazione procedurale, precisa la legge, è applicabile in
tutti i casi in cui l'atto
di
assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente
dall'accertamento
di
presupposti e requisiti richiesti dalla normativa di
riferimento, senza l'esperimento di prove e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo.
In concreto, come ha avuto modo
di
evidenziare il Consiglio di Stato nel parere
espresso sul d.P.R. 300 del 1992, devono essere sottoposte alla disciplina dell'art.
19 tutte quelle fattispecie che sono sottoposte ad accertamenti a carattere
rigorosamente vincolato
o,
comunque, caratterizzate da una discrezionalità
particolarmente limitata, operando direttamente sul procedimento.
Nella sostanza, si sostituisce ad un accertamento preventivo un'accertamento
successivo, fermo restando la disciplina sostanziale relativa
ai
presupposti e
requisiti ritenuti necessari ai fini dell'esercizio dell'attività.
L'art. 20, invece, prevede che il relativo regolamento deve individuare tutte quelle
ipotesi in cui, per la complessità del procedimento e per l'esistenza di momenti di
discrezionalità, alla pubblica amministrazione deve essere assegnato un congruo
periodo di tempo per valutare la situazione e assumere, quindi, le relative
determinazioni, con la salvaguardia per il cittadino che il silenzio della pubblica
Amministrazione, protratto oltre il termine fissato, corrisponde all'assenso per
l'esercizio dell'attività. Il silenzio della pubblica amministrazione previsto da tale
articolo, in sostanza, corrisponde a un provvedimento autorizzatorio esplicito,
ovvero l'accoglimento formale dell'istanza del privato.
Dopo una fase di consultazione, tra
i
diversi ministeri, le prefetture e l' Anci, che
in termini evidenti non sarà comunque considerata esaustiva, venne, quindi,
emanato, con d.P.R. 26 aprile 1992
n.
300, il regolamento attuativo degli articoli
19
e 20 della legge 24111990.
Il d.P.R. 300 include tre distinte tabelle: la "tabella A" comprendente l'elenco
delle attività alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la denuncia, "la
tabella B" contenente l'elenco delle attività che possono essere intraprese una
108

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 115/194
volta decorso un certo termine dalla denuncia e, infine, "la tabella C" che
comprende l'elenco delle attività sottoposte alla disciplina del silenzio assenso.
Nelle diverse tabelle, tuttavia, non sono comprese le attività soggette ad
autorizzazione degli enti locali. Questo dipende dalla evidente necessità, rispetto
ai tempi, di approfondimento della materia, che si presenta complessa.
L'articolato comprende la disciplina della domanda o della denuncia del privato,
dei termini per l'esercizio dei poteri che la legge riserva ali' Amministrazione e
delle condizioni per la formazione del silenzio assenso.
Relativamente a questo aspetto va evidenziato l'orientamento espresso dal
Consiglio di Stato, nella parte in cui lo stesso ritiene che: "Pur in mancanza di una
esplicita previsione legislativa in proposito, sembra che debbano ritenersi esclusi
dall'ambito di applicazione dell'art. 20 i casi in cui per il rilascio dell'atto di
autorizzazione, abilitazione, nulla osta richiesto dal privato, siano previsti
l'esperimento di prove, ovvero un limite o un contingente complessivo."
n
Consiglio di Stato sostiene, in pratica, che se in tale ipotesi non può trovare
applicazione l'art.
19
che presuppone per l'amministrazione un mero riscontro
della sussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività privata, a
maggior ragione deve ritenersi che, nei medesimi casi, non trovi applicazione la
normativa prevista dall'art. 20 che suppone l'esercizio, da parte
dell'amministrazione, di poteri discrezionali ed in genere una ponderazione
dell'istanza del privato alla luce dell'interesse pubblico.
Come si è già evidenziato, con il d.P.R. 300/92 erano state individuate tre distinte
tabelle che comprendevano le attività sottoposte rispettivamente alla disciplina
dell'art.
19
(la tabella A e B) e dell'art. 20 (la tabella C). Detta tabella C, tuttavia,
non prevedeva alcuna attività disciplinata da leggi statali ma soggetta ad
autorizzazione comunale. A questa mancanza, quindi, si
è ovviato con i l d.P.R. 29
maggio 1994 n. 407 che ha previsto diverse distinte ipotesi di applicazione del
silenzio assenso sia per
i l
comparto del commercio sia per quello della
somministrazione di alimenti e bevande e di polizia amministrativa.
109

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 116/194
Per quanto riguarda la categoria della polizia amministrativa, la tabella "C" elenca
le attività sottoposte alla disciplina dell'art. 20 (silenzio assenso) e l'indicazione
del termine entro cui la relativa domanda si considera accolta. Ebbene, al punto
53
di detto elenco figura anche l'apertura di locali di pubblico spettacolo
22,
ed
l
termine previsto per il silenzio assenso è di 60 giorni. Tra i riferimenti normativi
che il legislatore cita vi sono elencati l'art. 80 del r.d.
18
giugno
1931 n.
773,
ovvero il Tulps; gli artt. 116 e ss del relativo regolamento r.d. 6 maggio 1940 n.
635; ed, infine, cita con assoluta genericità, il d.P.R. 24luglio 1977 n. 616.
Ogni considerazione circa l'inopportunità di assoggettare a silenzio assenso un
procedimento che comporta valutazioni tecniche discrezionali e la cui
inosservanza
è
sanzionata penalmente dall'art.
681
c.p.
è
certamente superfluo;
come anche appare evidente l'inesistenza di ogni tentativo di sistematizzazione
delle regole che disciplinano l'apertura dei locali pubblici.
6. La
sicurezza
La sicurezza
23
è
una certamente una condizione. Con precisione ancor
maggiore si può anche affermare che la sicurezza è una condizione obiettiva di
uno stato nel quale sono rispettati e fatti osservare i principi che lo reggono onde
garantire ai singoli il tranquillo svolgimento delle attività, mediante una azione di
prevenzione ed una di repressione. La sicurezza, dal latino
"sine cura":
senza
preoccupazione, può essere definita anche come la conoscenza che l'evoluzione di
un sistema non produrrà stati indesiderati o, ancora, sicurezza è sapere che quello
che sarà fatto non provocherà dei danni.
n
presupposto della conoscenza da un
punto di vista epistemologico
24
poiché un sistema può evolversi senza dar luogo a
22
Nessun riferimento viene fatto nel d.P.R. 407 all'attività di intrattenimento mentre
è
stato già
chiarito che esiste un connubio tra art. 68 e 80 del tulps e art. 681 c.p.
23
Per le definizioni,
i l
dizionario enciclopedico italiano dell'Istituto della enciclopedia italiana
Treccani, ne fornisce una articolata, in senso astratto e in senso concreto, con riferimento alla
sicurezza sociale, alla tecnica delle costruzioni e a quella di pubblica sicurezza. Quella indicata è
il
r,rimo senso;.
4
Da
Wikipedia, enciclopedia online multilingue a contenuto libero, redatta in modo collaborativo
da volontari, e sostenuta dalla Wikimedia Foundation, un'organizzazione no-profit. A maggio 2006
era pubblicata in oltre 200 lingue differenti (di cui circa l 00 attive, è quella inglese la lingua
110

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 117/194
stati indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro. Solo una
conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può
garantire una valutazione sensata della sicurezza ed è da questa convinzione che
sono state elaborate e, quindi, scritte le "regole tecniche".
25
In sostanza, la sicurezza è una nozione che fatica ad essere definita
esclusivamente con riferimento al proprio contenuto concettuale, a prescindere da
una ulteriore qualificazione che, in qualche modo, imitandola, contribuisca a
specificarla. Sotto questo profilo, la stessa sembra contrassegnarsi per un carattere
specificamente relazionale: nel senso, cioè, che essa è normalmente destinata ad
incontrarsi con un'altra, in riferimento alla quale acquista un significato concreto il
suo contenuto concettuale.Z
6
La
sicurezza disvela così il suo carattere plurale nel
duplice senso dell'esistenza di tipologie diverse di sicurezza e della normale
necessità di più interventi per la soddisfazione della domanda che di essa fanno i
destinatari o i cittadini in genere e più specificatamente utenti.
La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli. In senso assoluto, si tratta di un
concetto difficilmente traducibile nella vita reale anche se l'applicazione delle
norme di sicurezza rende più difficile
il
verificarsi di fatti criminosi, eventi
dannosi e di incidenti e si traduce sempre in una migliore qualità della vita.
Ed è in accezione ampia del termine che i l legislatore con legge n. 128 del 26
marzo 2001 "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
ha emanato disposizioni a modifica dei codici penale e di procedura penale, oltre a
prevedere, all'articolo
17,
comma l, che:
"Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la
realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati
attualmente più sviluppata) e contiene voci sia sugli argomenti propri di una tradizionale
enciclopedia che di almanacchi, dizionari geografici e di attualità. Il suo scopo è quello di creare e
distribuire un'enciclopedia internazionale libera nel maggior numero di lingue possibili. Wikipedia
è
uno dei siti di consultazione più popolari del web ricevendo circa
60
milioni di accessi al giorno.
25
Di
regole tecniche in materia di prevenzioni incendi si parlerà successivamente in relazione al
fatto che le stesse condizionano pesantemente l'ambito di applicazione dell'articolo 80 Tulps per
la
connessione che nel tempo si
è
creata con
la
regola tecnica.
26
Pajno A.,
La "sicurezza urbana" tra poteri impliciti e inflazione normativa
in
astrid
RASSEGNA 13
febbraio 2009 n. 86 www.astrid-online.it
111

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 118/194
di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di
Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività
d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione
di
contingenti
dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito
di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di
presidi mobili
di
quartiere nei maggiori centri urbani, nonchè il potenziamento e il
coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi
di
soccorso
pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini."
Tra l'altro, vale la pena ricordare che con il medesimo art.
17
della legge 128 del
2001, all'ultimo comma, sono stati estesi ai fini della prevenzione dei delitti di
ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli
concernenti armi o esplosivi, i controlli previsti dall'articolo 16 del Tulps
relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dal medesimo
Tulps.
E con riferimento a queste attività di controllo, i prefetti sono tenuti a predisporre
per conto del Ministero dell'interno apposita relazione contenente tutti i dati
relativi alle iniziative svolte; ciò in quanto il Ministro dell'interno presenta
annualmente
al
Parlamento una relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo
stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.
Esistono, quindi, tante definizioni della sicurezza, a seconda del ramo che si
prende in considerazione. Nell'ambito della sicurezza dei locali pubblici,
frequentati prevalentemente da giovani e anche da minorenni, ad esempio, a tutela
della sicurezza della salute è posto
i l
divieto alla vendita
di
bevande alcoliche ai
minori di anni 16
27
previsto dall'art. 689 c.p.; mentre a tutela della sicurezza
a
27
Riduzione della lucidità, diminuzione della memoria, perdita di coscienza. Gli effetti
dell'eccessivo consumo di bevande alcoliche possono essere devastanti e causare danni futuri,
troppo spesso, irreparabili. Lo afferma dal sito www.ospedalebambinogesu.it, la dott.ssa Valeria
Zanna spiegando che per l'incapacità dell'organismo a metabolizzare l'alcol prima dei 18-20 anni,
bere sotto i 16 anni può produrre nei ragazzi effetti sul sistema nervoso centrale e più in generale
sull'intero organismo, con episodi di intossicazione da alcol, come perdita di coordinamento,
riduzione della lucidità, diminuzione della memoria, rallentamento dei riflessi o anche perdita di
coscienza o danni futuri. Ed è per questo motivo, afferma inoltre, che la legge italiana vieta la
vendita di alcolici ai minori di 16 anni in tutti i luoghi pubblici in cui è possibile acquistarli. Sul
112

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 119/194
stradale è stato posto l'obbligo agli esercenti, dal 23 settembre 2008, di esporre le
tabelle anti-alcool.
28
La sicurezza intesa come prevenzione incendi, quindi,
è
soltanto una delle
possibili relazioni e alla sua tutela è preposto il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
29
Agibilità e prevenzione incedi: questo è un connubio che, rileggendo l'articolo
80
30
del Tulps evidenzia, fin da subito, l'intersecarsi dei due procedimenti: uno
riconducibile alla materia specifica
di
prevenzione incendi ed una, vaga, tesa ad
accertare, in senso lato, la solidità e la sicurezza del teatro o del luogo pubblico.
Appare utile, a tale proposito, evidenziare che la verifica, prevista per
un
teatro o
un
luogo
di
pubblico spettacolo, "della solidità e la sicurezza dell'edificio e
l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di
incendio" così come previsto dall'art. 80 Tulps, consiste, in sostanza, ad una parte
dei riscontri richiesti
al
dirigente tecnico comunale preposto
al
rilascio del
certificato di agibilità di cui all'art. 24 del d.P.R 380 del 2001, testo unico in
divieto di vendita degli alcolici al di fuori dei locali commerciali punito dall'art. 689 c.p., si veda
anche Donolato F. e Bombi M.
La
vendita e la somministrazione degli alcolici in www.astrid-
online luglio 2008.
28
Le cosiddette tabelle anti-alcool sono state previste dal decreto legge 3 agosto 2007,
n.
117,
riconvertito poi, dalla legge 160 del 200. In particolare si prevede che tutti i titolari e i gestori di
locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di
intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche,
devono interrompere la somrninistrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e
assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei
clienti, una rilevazione del tasso alcolernico.
29
n Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima frammentato nei vari corpi comunali, nasce come
tale con il Regio Decreto Legge del
27
febbraio 1939, successivamente convertito in Legge 1570
del
27
dicembre 1941, ed è chiamato inizialmente "a tutelare la incolumità delle persone e la
salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di servizi
tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea". In seguito allo sviluppo del paese questi
compiti diventano sempre più complessi e differenziati, fino a che il D.Lg.
n.
139 dell'8 marzo
2006 stabilisce che: "Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è una struttura dello Stato ad
ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno- Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo del quale il Ministero dell'interno assicura,
anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli
incendi su tutto i l territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo
nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo."
30
L'art. 80 del Tulps dispone che "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza
per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una
commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte
a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio."
113

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 120/194
materia edilizia il quale al comma l dispone che "Il certificato di agibilità attesta
la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto
dispone la normativa vigente."
E per accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, propedeutiche
al
rilascio del certificato
di
agibilità, lo Sportello unico per l'edilizia "acquisisce
direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente: [ ...] b) il
parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa
antincendio". E' questo quanto dispone il comma 3 dell'art. 5 del d.P.R. 380 del
2001.
7.
Il Certificato di prevenzione incendi (CPI).
Emanato in esecuzione dell'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406
31
, il
d.P.R. 29 luglio 1982
n.
577 "Approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi antincendi" rappresenta il primo organico intervento
finalizzato a garantire la sicurezza utilizzando un sistema fondato su presupposti
tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni
di
rischio da prevenire?
2
Tuttavia, è con il procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione
incendi, CPI, che i l legislatore ha posto sotto tutela le attività a rischio.
Come il testo unico in materia edilizia d.P.R. 380 del 2001, sul quale ci si è già
soffermati, anche il procedimento
33
per il rilascio del CPI previsto dal d.P.R. 12
31
La legge 18 luglio 1980, n. 406 dettava Disposizioni per la prevenzione incendi per le attività
alberghiere esistenti.
32
I presupposti scientifici diventano, quindi, norme tecniche adottate dal Ministero dell'interno di
concerto con le amministrazioni
di
volta in volta interessate.
E'
quanto dispone l'articolo 3 del
d:P.R. 577 del1982
33
Il d.P.R. 12 gennaio 1998
n. 37
disciplina il procedimento per il rilascio del certificato incendi di
cui alla legge
15
marzo 1997
n.
59 nel rispetto dei criteri, principi e modalità indicati all'articolo
20 della legge stessa. Il nuovo regolamento è stato emanato nell'intento di semplificare
i
procedimenti dettati dalla legge
26
luglio 1965 n. 966 e dal d.P.R. 29 luglio 1982 n. 577 relativi
all'attività di controllo dei vigili del fuoco sul rispetto delle condizioni di sicurezza per la
prevenzione degli incendi.
Il d.P.R. n. 37 del 1998
è
costituito da dieci articoli che disciplinano le varie fasi relative all'esame
dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività, all'approvazione delle
114

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 121/194
gennaio 1998 n. 37, è stato emanato in attuazione della legge 59 del 1997 anche
se, formalmente,
i l
CPI che "attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla
normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio richiesti" è stato istituito già con
i l
d.P.R. 577 del 1982?
4
L'art. 8 del suddetto d.P.R. 577 individuava con precisione quali sono le attività
fondamentali che rientrano nella "prevenzioni incendi": la predisposizione di
norme generali e specificazioni tecniche e procedurali; lo studio, ricerca,
sperimentazione e prove
su materiali, strutture, impianti, apparecchiature; la
designazione in organi collegiali centrali e periferici, interni o esterni
all'Amministrazione dell'interno; l'esame di progetti
di
costruzioni e
di
installazioni industriali e civili ed, infine, gli accertamenti sopraluogo ovvero le
visite tecniche per l'accertamento che tutto sia a norma.
L'art.
15
35
(Adempimenti di enti e privati) del medesimo decreto, tra l'altro in
parte abrogato, al comma 5 disponeva che:
"Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del
fuoco: le visite di controllo al fine del rilascio del certificato
di
prevenzione
incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti
al
pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il certificato
di
prevenzione incendi non
può essere rilasciato prima di aver fatto verificare, nel termine per l'adozione dei
deroghe per tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi elencate
nell'allegato al d.m. 16 febbraio 1982 e nei successivi decreti di modifica (d.m.
27
marzo 1985;
d.m. 30 ottobre 1986).
34
A dire
i l
vero, di "certificato di prevenzione incendi" già parlava l'art. 4 della legge 26 luglio
1965 n. 966 i l quale, al I comma, prevedeva che l depositi e le industrie pericolose soggetti alle
visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati
con decreto del Ministro per l'interno,
di
concerto con
i l
Ministro per l'industria e commercio, in
relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti." Il terzo comma, invece, disponeva
che: "Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza
degli impianti alle prescrizioni
di
sicurezza, rilascia un «certificato di prevenzione» che ha validità
pari alla periodicità delle visite."
35
Il d.P.R. 577 del 1982 è stato abrogato dall'art. 35, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, limitatamente
agli articoli l; 2;
3,
commi l e 2, numeri l) e 2); 7;
8;
10, successivamente all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006;
11,
ad
eccezione dei commi
2,
3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 21, comma
2,
del suddetto decreto legislativo
n. 139
del 2006;
12; 17;
20, ad eccezione
dei commi
2, 3,
4 e
5,
da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto
di
cui all'articolo 22,
comma 3 del decreto legislativo
n.
139 del2006.
www.leggiditalia.it
115

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 122/194
provvedimenti conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorità, dalla
commissione di cui all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635
36
,
le condizioni
generali
di
sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle
manifestazioni. La validità del certificato di prevenzione incendi, appositamente
rilasciato per l'occasione, è limitata alla durata della manifestazione."
Il citato comma 5 dell'art. 15 del d.P.R. 577 del 1982, come precisato, è stato
abrogato dall'art. 9, d.P.R. 12 gennaio 1998,
n.
37
37
, ma la lettura di queste
disposizioni rende ben evidente come tra il CPI e i l procedimento per la verifica
dell'agibilità prevista dal Tulps ci sono state non soltanto delle interferenze ma
delle vere e proprie sovrapposizioni che non avrebbero motivo di sussistere in
relazione al fatto che il fine perseguito è il medesimo. Infatti, l'art. 80 del Tulps
prevede il controllo della "solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio" per teatri e
luoghi di pubblico spettacolo. Una norma, questa, che è stata scritta più di ottanta
anni fa, nel 1926, quando ancora non esisteva neppure
il
Corpo
38
nazionale dei
vigili del fuoco preposto, oggi, espressamente a questo tipo di controllo?
9
36
La commissione prevista dall'art.
141
reg.to Tulps, originariamente di nomina prefettizia è ora
stata sdoppiata. E' di nomina comunale per tutte le verifiche previste dall'art.
80
Tulps ma è
rimasta provinciale e presieduta dal prefetto per particolari e rilevanti strutture.
37
L'art. 9 del d.P.R. 37 del 1998 individua le disposizioni che dall'entrata in vigore del decreto
stesso vengono abrogate. Esse sono:
a)
articoli
10,
comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, numero
5); 21
del
decreto del Presidente della Repubblica 29luglio 1982,
n.
577;
b)
articoli
2,
commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984,
n.
818.
38
I compiti d'istituto del Corpo sono la salvaguardia di persone, animali e beni,
il
soccorso tecnico
urgente e la prevenzione incendi. Il personale operativo del CNVVF ha funzioni di polizia
giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e di prevenzione. Spetta
ai
vigili infatti, in
collaborazione con le altre forze di polizia, individuare le cause degli incendi e stabilire
se
si tratti
di incendi dolosi.
39
La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che
esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.
È
la funzione di
preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul
territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione,
lo
studio, la predisposizione e la
sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare
l'insorgenza di
un
incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le
conseguenze. Essa
si
esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione
al
rischio di incendio
e,
in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di
lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
116

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 123/194
Tra l'altro, con d.m.
19
agosto 1996 è stata approvata la "regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali
di
intrattenimento e
di
pubblico spettacolo" ovvero sono stati individuati criteri e
presupposti che dovrebbero essere oggetto
di
valutazione della commissione
di
vigilanza
di
pubblico spettacolo.
Comunque, allo stato attuale la disciplina
di
riferimento per
l'
ottenimento del CPI
è
tutta contenuta nel d.lgs
139
del 2006. In particolare, l'art.
16
40
ne detta le
pericolose, dell'energia, della protezione
da
radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione. Da
www.
vigilfuoco. it
40
Art. 16 del d.lgs 139/2006:
l.
Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa
di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività,
depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli
per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma
l,
della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-
scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del
certificato per le attività ivi individuate.
2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili
del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un
procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati
all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e
l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a
verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle
prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo
quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti
responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione
tecnica richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei
vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del
Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti
in materia designati dal Comitato stesso, nonchè richiedere il parere del Comitato centrale tecnico
scientifico di cui all'articolo 21.
4.
Ai
fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del
fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti
responsabili delle attività di cui al comma l le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la
conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o
professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del
Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono
subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di
prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone
comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei
provvedimenti
da
adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando
provinciale sono atti definitivi.
6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il
regolamento di cui al comma
l,
l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono
117

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 124/194
modalità per la richiesta, il rinnovo e l'eventuale revoca. Va anche sottolineato, a
tale proposito, che il comma 7 di tale articolo, prevede l'emanazione di
disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di
prevenzione incendi da emanare in base all'art. 17, comma l della legge 400 del
1988. A tutt'oggi queste disposizioni non sono state ancora varate.
Il comma 5 dell'articolo 16 del d.lgs 139 del2006, dispone che:
"Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle
norme tecniche di prevenzione incendi, i l Comando provinciale non provvede al
rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al
prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei
rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti
de fini ti vi."
Ed
ancora, il comma 3 dell'art. 20, dispone che:
"Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto
può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili
omettano di richiedere:
i l
rilascio ovvero
i l
rinnovo del certificato di prevenzione
incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e
nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi
medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento
dell'obbligo."
modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni
qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni
qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma l, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni
attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso
disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per
il
rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa
di
prevenzione incendi, in
relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche
tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei
soggetti responsabili delle attività.
8. Resta fermo quanto previsto
al
punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.
118

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 125/194
8.
Il CPI e l'agibilità (in senso lato)
Si è ritenuto necessario evidenziare i due sopraindicati commi, in quanto
gli stessi sono strettamente connessi alla problematica in esame. Infatti,
relativamente al procedimento per il certificato di agibilità previsto dall'art. 24 del
d.P.R. 380 del2001, risulta indubbio che, in base al comma 5 dell'art. 16 del d.lgs
139 del 2006, se dall'esito del procedimento previsto per il CPI il Comando dei
VV F. rileva la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di
prevenzione incendi e, quindi, non provvede al rilascio del certificato stesso, lo
Sportello per l'edilizia non può concludere neppure il proprio procedimento.
Peraltro,
è
fuor di dubbio che il dirigente comunale preposto
al
rilascio del
certificato di agibilità previsto dall'articolo 24 del d.P.R. 380 del 2001 non dovrà
limitarsi ad acquisire il CPI nei casi espressamente previsti dal d.m.
16
febbraio
1982 che, per la questione in esame, rileva soltanto per quanto previsto al punto
83 dell'elenco annesso ovvero per i locali di spettacolo e di trattenimento in
genere con capienza superiore a l 00 posti, ma dovrà acquisire il parere del
Comando dei VV F. in tutti gli altri casi in cui è stata prevista una specifica regola
tecnica di
prevenzione incendi, come previsto dal già citato art. 5, comma 3 d.P.R.
380 del 2001.
Più complessa è la questione connessa al comma 3 dell'articolo 20 del d.lgs 139
del 2006, in quanto risulta innegabile che questa disposizione è, parzialmente, in
una posizione di antinomia rispetto alla disciplina in materia edilizia. Infatti, il
prefetto, in base al sopraccitato art. 20 comma 3 può disporre la sospensione
dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il
rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Ma si è appena
visto che il certificato di agibilità previsto dal testo unico in materia edilizia
prevede che il certificato stesso possa essere rilasciato soltanto all'intervenuta
acquisizione, eventualmente d'ufficio se non presentata dal richiedente, del CPI.
La disposizione citata, quindi, non può che riguardare le modifiche di
destinazione d'uso dell'immobile con riferimento ad una attività che presuppone
diversi parametri in base alla regola tecnica rispetto all'attività precedentemente
119

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 126/194
assentita. L'antinomia rilevata consegue al fatto che da un lato, il d.lgs 139 del
2006 demanda
al
prefetto la facoltà di disporre la sospensione dell'attività, mentre
dall'altro, per il dirigente del comune sussiste l'obbligo di revocare il certificato di
agibilità per la mancanza, ovvero la perdita, di uno dei presupposti.
Non sarebbe, invece, in conflitto con altre disposizioni, l'ultimo inciso del comma
3 dell'art. 20 del d.lgs 139 del 2001 nella parte in cui assegna al prefetto la facoltà
di disporre la sospensione dell'attività nel caso in cui siano omessi i "servizi di
vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture
caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono
obbligatori". Infatti, la sospensione in tal caso attiene alla pubblica incolumità che
rientra nella pubblica sicurezza e, in quanto tale, di competenza statale. Anche a
questo proposito, tuttavia, esistono delle criticità che saranno illustrate trattando
della commissione provinciale di pubblico spettacolo.
Fin d'ora, comunque, è opportuno ricordare che il prefetto presiede la
commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo prevista dall'art. 142
Tulps ed è competente, come il sopraindicato comma 3 del d.lgs 139 del 2001
aiuta a ricordare per strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico,
ovvero, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di
capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con
. . 5 000 '
41
capienza supenore a . spettaton ;
9. La regola tecnica: le origini
Una premessa è, a questo punto, d'obbligo. Il d.m. 16 febbraio 1982 che
determina le attività soggette alle visite di prevenzione incendi, ne prevede
l'applicabilità per i "locali" la cui capienza deve essere superiore
ai
100 posti.
Invece, la verifica dell'agibilità prevista dall'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931,
n.
773, trascura ogni riferimento al numero di persone che potenzialmente possono
accedere
al
locale e prendere parte all'attività di trattenimento o spettacolo e, a
,
41
La competenza esclusiva della commissione provinciale
è
stata espressamente prevista
dall'ultimo comma, lettera
a)
dell'art.
142
regolamento tulps.
120

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 127/194
stretto rigore, si applica ai luoghi, anziché ai locali adibiti ad ospitare tali
attività.
42
E del resto, l'art. 681 c.p. che punisce il mancato rispetto delle
prescrizioni dell'Autorità fa prima ancora riferimento ai "luoghi" stessi e a
"Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o
ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità
pubblica". Luogo
43
, quindi, in un'accezione ampia che rende, quindi, esteso
l'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 80 Tulps e, di
conseguenza, l'assoggetabilità all'art. 681 c.p.
La storia e l'esigenza che una sanzione penale non trovi applicazione in maniera
difforme da un "luogo all'altro" hanno dimostrato che è il controllo della
prevenzione incendi che ha fatto da "apripista", nel senso che sono state emanate
regole tecniche capaci di uniformare gli indirizzi interpretativi in materia di
prevenzione incendi che hanno finito per guidare anche le valutazioni della
sicurezza del locale sotto ogni altro profilo. Del resto non poteva essere
diversamente tenuto conto che i teatri, primi destinatari della norma venivano
realizzati completamente, o in parte, in legno.
Chiarire, peraltro, che cosa sono le regole tecniche risulta a questo punto
indispensabile perché strettamente connesse al sistema stesso della sicurezza.
n sistema giuridico italiano della sicurezza è posto sui seguenti principi base: il
principio della tassatività delle misure di prevenzione e di protezione fissate dalla
normativa, il principio del pericolo presunto per legge o per regolamento e il
principio della massima sicurezza tecnologicamente raggiungibile con lo stato
dell 'arte e della tecnica e dei processi.
La stessa normativa comunitaria che si basa sulla normalizzazione ha elaborato tre
nozioni fondamentali: la specifica tecnica, la norma tecnica e la regola tecnica.
42
Manzione A.
La
licenza di agibilità ed il certificato di prevenzione incendi: aspetti interessanti
l'attività di polizia amministrativa ed i controlli della P.M. Relazione al convegno nazionale di
Polizia locale, Atti del convegno. Riccione, settembre 2005
43
Secondo i l dizionario enciclopedico Treccani i l termine "luogo" va inteso, in senso ampio come
una parte dello spazio, idealmente o materialmente circoscritta ed anche precisa che per la sua
genericità la parola può essere riferita di volta in volta a vaste regioni del globo o d'un continente,
a paesi contrade, città, oppure a zone più ristrette di campagne o dentro luoghi abitati e, non di
rado, a ristrettissime porzioni
di
spazio sia all'aperto sia all'interno di un edificio.
121

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 128/194
10.
Specifica, norma e regola tecnica
La specifica tecnica è un documento tecnico ad applicazione volontaria,
definita come "specificazione contenuta in un documento che definisce le
caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di
utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili a un
prodotto per quanto concerne la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di
prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura".
44
Con riferimento all'Ente di unificazione italiano (UNI) la specifica tecnica è un
documento elaborato e pubblicato sulla base di una specifica procedura UNI;
messo a punto consensualmente da parti interessate che svolgono attività a livello
nazionale; che rappresenta lo stato dell'arte non ancora consolidato di prodotti,
processi e servizi, che viene sottoposto ad un periodo di verifica della validità.
Le
specifiche tecniche sono di due tipi, denominati "norme europee EN" le quali
obbligano gli enti nazionali di normalizzazione a considerare tali norme come
norme tecniche nazionali e ad abrogare le norme nazionali divergenti e
"documenti armonizzati Hd", che obbligano gli enti nazionali di normalizzazione
solo a recepire gli standards con norme tecniche nazionali.
Rimane fermo
i l
carattere non vincolante di tali norme tecniche per i soggetti
dell'ordinamento giuridico nazionale. Ogni Stato membro deve comunicare alla
Commissione le normi nazionali ritenute conformi alle norme tecniche
comunitarie, sulle quali esprime un parere il comitato permanente istituito dalla
direttiva di armonizzazione.
La norma tecnica è, invece, una specifica tecnica che è stata approvata da un
organismo riconosciuto a livello comunitario. Il rispetto della norma tecnica non è
strettamente obbligatorio, secondo quanto riportato anche dal d.lgs 23 novembre
2000 n. 427 "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986 n. 317,
concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e
44
La definizione è fornita dall'art. 1.1, Dir. 83/189 CEE.
122

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 129/194
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società
dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, all'art. 2,
lettera f) "(per) norma: (deve intendersi) una specifica tecnica, approvata da un
organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui
osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie:
norma internazionale, europee o nazionali, le norme adottate e messe a
disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale di
normalizzazione, da un organismo europeo di normalizzazione o da un organismo
nazionale di normalizzazione."
Il valore giuridico delle norme tecniche pubblicate da un organismo riconosciuto,
è tale per cui la loro applicazione, sebbene non obbligatoria, garantisce
il
rispetto
della regola d'arte, e quindi della legge.
In definitiva, le norme tecniche sono elaborate da esperti che rappresentano le
parti economiche e sociali interessate (produttori, utilizzatori, commercianti,
centri di ricerca, consumatori, pubblica Amministrazione) organizzati in gruppi di
lavoro, secondo la procedura dell'Ente di normazione nazionale, che si limita s
volgere una funzione di coordinamento dei lavori, mentre
i l
contenuto delle norme
viene deciso dagli esperti esterni.
Le
norme tecniche, di conseguenza, non sono disposizioni normative, quindi,
bensì documenti che definiscono le caratteristiche, ad esempio con riferimento
alle dimensioni, aspetti di sicurezza, requisiti delle prestazioni di un prodotto,
processo o servizi, secondo lo stato dell 'arte tecnico e tecnologico.
Le norme tecniche si fondano su principi condivisi e riguardano
la
consensualità,
nel senso che la norma tecnica deve essere approvata con i l consenso di tutti
coloro i quali hanno partecipato ai lavori; la democraticità, in quanto tutte le parti
economiche-sociali interessate possono partecipare ai lavori e soprattutto
chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nell'iter che prevede
l'approvazione finale; la trasparenza, nel senso che l'ente di normazione segnala
le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il
progetto stesso a disposizione degli interessati. Infine, l'applicazione delle norme
123

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 130/194
tecniche si basa sulla volontarietà, nel senso che le norme sono un puro
riferimento in quanto nessuno è obbligato a seguirle, con l'eccezione di
pochissimi casi legati a questioni connesse alla sicurezza delle persone.
Con riferimento alla volontarietà, quindi,
è
possibile distinguere le norme tecniche
dalle regole tecniche, le quali, al pari delle prime, sono specifiche che definiscono
le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni di prodotti e servizi, ma hanno
natura obbligatoria, essendo contenute, o indicate come obbligo, in atti emanati
dalla pubblica Autorità con legge, decreto o altro atto amministrativo.
45
In sostanza, la regola tecnica
è
una specifica tecnica che non soltanto
è
stata
adottata da un organismo riconosciuto, ma
è
anche stata incorporata in una vera e
propria norma giuridica ovvero in una prescrizione.
46
11.
Il
teatro come struttura
Oggi, nell'accezione comune, per teatro si intende un edificio perlopiù
realizzato in muratura ma può essere costituito anche da una tenda (i cosiddetti
teatri-tenda) o all'aperto come in uno stadio, in una piazza o in un'area pubblica o
privata, destinato per la maggior parte delle volte a rappresentazioni sceniche
secondo l'arte e la tecnica capaci di creare attraverso opportune soluzioni
pittoriche, architettoniche e prospettiche la realtà ambientale provvisoria richiesta
dal soggettista e dal copione. Solo dopo i l regno di Alessandro Magno, comunque,
si dette inizio alla costruzione di teatri interamente in pietra e con fastose
decorazioni. Prima di allora, infatti, per la costruzione degli anfiteatri veniva
utilizzata l'area che naturalmente si prestava maggiormente alla sua realizzazione.
I primi segni dello spettacolo moderno si ebbero con il Rinascimento, ma si
continuò a costruire
i l
locale con l'antica forma della cavea, ovvero con una o più
gradinate per la cosiddetta platea. Successivamente la gradinate vennero sostituite
con loggiati sovrapposti in diversi ordini e di essi alcuni venivano predisposti con
45
Baldacconi
A.
e Nocchi E.
La pratica ergonomica nella valutazione dei rischi da lavoro,
IPSOA, 2007, p. 70 ss.
46
In tal senso Guastini R. Il diritto come linguaggio: lezioni, Giappichelli, Torino, 2001, p. 13
124

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 131/194
apposita chiusura in modo da formare altrettanti camerini o palchi aperti verso
l'interno della sala. In seguito all'intervento della Chiesa, che vietava la maggior
parte delle rappresentazioni sceniche non
si
edificarono nuove sale fino al regno
di Luigi XIII.
47
Sta di fatto che il primo teatro italiano
fu
quello progettato e
realizzato da Luigi Bramante nella Corte del Vaticano; poi furono edificati quello
del Palladio a Vicenza, dell' Aleotti a Parma, nel1618.
48
E non è un caso, quindi, se ancora nell'800
i l
codice Zanardelli si preoccupava di
rendere obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni fomite dall'Autorità, a tutela
dell'incolumità pubblica, per l'apertura di luoghi di pubblico spettacolo o ritrovo.
Tra l'altro, non è neppure un caso se l'articolo 78 del Tulps emanato in attuazione
del codice penale Zanardelli prevedeva, specificatamente, la necessità di far
verificare ad una apposita commissione tecnica la solidità e la sicurezza, in
funzione antincendi, dei teatri ed altri locali di pubblico spettacolo.
Su questa specifica connessione tra teatro e prevenzione incendi
si
potrebbe
continuare ad argomentare, precisando che l'articolo 80 del vigente Tulps
ripropone parola per parola l'originaria formulazione del testo del 1926 come, tra
l'altro, non
è
superfluo evidenziare che i primi luoghi ad ospitare delle proiezioni
cinematografiche furono dei teatri adattati per l'occasione con uno schermo.
Inizialmente, infatti, essendo i film muti, non servivano apparecchiature per la
riproduzione del sonoro, e una qualsiasi stanza
si
adattava alle esigenze. Spesso, i
proprietari dei locali ingaggiavano dei musicisti, in genere un pianista, per
accompagnare musicalmente lo spettacolo.
Con l'avvento del sonoro, anche i cinematografi dovettero adattarsi alle nuove
esigenze di quello che stava iniziando a diventare un ricco affare, e nacquero le
prime vere e proprie sale cinematografiche, dedicate esclusivamente alla
proiezione di film. Il più antico cinema italiano, inaugurato i l
15
dicembre 1905 e
47
Da Wikipedia: Luigi XIll di Borbone, detto il Giusto (Fontainebleau, 27 settembre 1601- Saint-
Germain-en-Laye, 14 maggio 1643),
fu
Re di Francia dal1610 alla sua morte. Nato nel Castello di
Fontainebleau, Luigi fu i l primo figlio di Enrico IV e di Maria de' Medici. Ascese al trono all'età di
nove anni dopo l'assassinio del padre.
La
madre diventò reggente per
i l
figlio minorenne finché
questi non compì i sedici anni e le subentrò nel governo del regno.
48
Rubertis (de) N., La legislazione di pubblica sicurezza IV ed., Noccioli, Firenze, 1987, p. 463.
125

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 132/194
realizzato dall'architetto Luigi Bellincioni si trova a Pisa sul retro di Palazzo
Agostini:
i l
Cinema Lumière. Il
19
ottobre
1906 vi
venne realizzato
il
primo
esperimento di sonorizzazione
di
pellicole da parte del professore Pietro Pierini
dell'Università
di
Pisa, brevettato dalla Fabbrica pisana
di
pellicole parlate sotto la
dizione 'Sistema elettrico per sincronismo
di
movimenti' e, dopo averne
migliorato
i l
funzionamento, come 'Isosincronizzatore'. Cinema e teatro sono,
quindi, per antonomasia, i luoghi in cui all'epoca della redazione del codice e del
relativo Tulps maggiormente elevata era la necessità
di
verificare le condizioni
di
sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica.
E,
a dire il vero, cinema e teatri
continuano tutt'oggi a prevalere rispetto alle altre tipologie
di
trattenimento per
quanto riguarda la tutela della incolumità pubblica
se nel d.m.
19
agosto 1996
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali
di
intrattenimento e
di
pubblico spettacolo"
gran parte delle disposizioni sono riservate proprio a questa tipologia di
spettacolo.
12. La regola tecnica di prevenzione incendi
per
i locali di pubblico spettacolo
La prime disposizioni a carattere tecnico, comunque, sono antecedenti a
quella positivizzata nel d.m. del 1996 e risale, infatti, all'anno 1951, quando fu
emanata la circolare n.
16
del
15
febbraio di tale anno che recava "Norme di
sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed
altri locali di spettacolo in genere".
A dire
il
vero la circolare del 1951, non contiene delle vere e proprie regole
tecniche nella accezione letterale del termine,
49
ma comunque delle prescrizioni
49
Si è già rilevato che solo una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni
ripetibili, può garantire una valutazione sensata della sicurezza e, quindi, rende possibile la
determinazione delle regole tecniche. Più di recente, le regole tecniche vengono predisposte
dall'UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione che è un'associazione privata senza scopo di
lucro, i cui soci, oltre 7000, sono imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e
scolastici, realtà della pubblica Amministrazione. Svolge attività normativa in tutti i settori
industriali, commerciali e del terziario
ad
esclusione
di
quello elettrico ed elettrotecnico di
competenza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano. Il ruolo dell'UNI, quale Organismo
nazionale italiano di normazione, è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del
126

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 133/194
che le commissioni provinciali di vigilanza pubblico spettacolo hanno sempre
rispettato anche se, sotto quest'aspetto la dottrina tecnica non è concorde. Per certi
autori, infatti, queste norme sono fondamentali e da tenere ben presenti
50
, per altri
sussiste qualche dubbio
di
natura giuridica sulla valenza delle prescrizioni in
relazione alla conseguenza per il loro inadempimento.
51
Comunque, a prescindere dalla distinzione tra "norma", precedentemente usata, e
"regola tecnica", usata per la prima volta dal legislatore con il d.m. 9 aprile 1994
in materia di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività
ricettive turistico-alberghiere, con il d.m.
19
agosto 1996 è stata introdotta
nell'ordinamento la "Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico
spettacolo".
Come il titolo puntualmente afferma, si tratta di una "regola tecnica" cioè di un
complesso di indicazioni, che vanno ad abrogare e sostituire, in parte, quelle del
1951 contenute nella circolare e dirette, in quanto tali e per la loro specificità ad
un organo altrettanto tecnico, i Vigili del Fuoco, ma anche al soggetto che intende
costruire e successivamente gestire un locale di pubblico spettacolo, a lui
fornendo il necessario supporto anche definitorio in materia di prevenzione.
E'
avvenuto
52
,
invece, che sia stato creato un testo organico e coordinato utilizzato
non solo in materia, appunto, di prevenzione incendi, ma quale indispensabile
marzo 1983, recepita dal Governo con la legge
n.
317 del
21
giugno 1986. L'UNI partecipa, in
rappresentanza dell'Italia, all'attività normativa degli organismi sovranazionali di normazione: ISO
(Intemational Organization for Standardization) e CEN (Comité Européen de Normalisation).
L'UNI è stato costituito nel 1921, con la sigla "UNIM", a fronte dell'esigenza dell'industria
meccanica di unificare le tipologie produttive, facilitare l'intercambiabilità dei pezzi, ecc.
Da
allora, l'attività di normazione ha assunto sempre più importanza nel contesto economico del
paese: già nel 1928 la Confindustria ne riconobbe i l ruolo fondamentale per l'economia e ne
promosse l'estensione a tutti i settori industriali: l'UNIM si trasformò così anche formalmente e la
sigla che lo contraddistingueva perse la "emme" finale, diventando l'attuale UNI
5
°Celli R., Manuale di polizia amministrativa, le funzioni attribuite ai comuni dal D.P.R. 616, cit.
~ 3 7 3
1
Romeo G., Locali di pubblico spettacolo, II ed. Maggioli, Repubblica di San Marino, 2002, p.
38
52
In tal senso Manzione
A.
La
licenza di agibilità ed
il
certificato di prevenzione incendi: aspetti
interessanti l'attività di polizia amministrativa ed i controlli della P.M. Relazione al convegno
nazionale di Polizia locale, Atti del convegno cit.
127

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 134/194
vademecum per le commissioni di vigilanza preposte alla verifica della agibilità
dei locali
di
trattenimento e/o spettacolo.
Da una lettura attenta delle due disposizioni, invece, la circolare del 1951 e la
regola tecnica del 1996 appare ben chiaro che i contenuti della circolare erano
direttamente collegati al procedimento autorizzatorio per l'apertura
di
un cinema o
di
un teatro che, antecedentemente al 1998 era del Ministero del turismo e
spettacolo in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 "Nuovo ordinamento dei
provvedimenti a favore della cinematografia". Successivamente, l'art. 31 della
legge 1213 del 1965, la cui rubrica recita "Apertura di sale cinematografiche"
53
è
stato novellato dall'art 4 del d.lgs 8 gennaio 1998, n. 3, nel senso che segue:
53
L'originaria formulazione dell'art.
31
"apertura nuove sale" della legge 1213 del 1965, era la
seguente:
La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per
spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività
sono subordinati ad autorizzazione del ministro per il turismo e lo spettacolo.
E'necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'articolo 33
sono determinati ogni due anni con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il
parere della commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della
frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatasi in ciascun comune o frazione o
località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.
Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone
periferiche e
di
quartieri coordinati (c.e. p.) o realizzati in base alla legge
18
aprile 1962, n. 167, per
migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove
sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistar:to peculiari
esigenze di interesse turistico, nonché nei capoluoghi
di
provincia che non sono provvisti di sale
cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.
Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti,
che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi
composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di
carattere culturale organizzate dalla cineteca nazionale. tali sale potranno essere destinate anche a
manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali
riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate
di
proiezione non superiore
a 50 per ciascun circolo.
La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche
per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni
che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che
abbiano una popolazione fra 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.
Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film
prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.
L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le
località sprovviste di sale cinematografiche.
I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano
presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria
domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della repubblica l'attività
128

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 135/194

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 136/194
Solo le cosiddette multisale, in base del d.lgs 28 del 2004 avrebbero dovuto essere
autorizzate dallo Stato ma questa disposizione, come molte altre contenute nel
decreto legislativo sono già state dichiarata incostituzionali.
54
n
comma 3 dell'articolo 22 del d.lgs 28 del 2004 parzialmente dichiarato
incostituzionale ma non nella parte in esame prevede che:
"3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza." In altre parole, la
commissione comunale o quella provinciale di vigilanza pubblico spettacolo sono
chiamate ad esprimersi sul progetto.
Ad
abundantiam,
il comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. 8 gennaio 1998,
n.
3 "Riordino
degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma l, lettera a), della
L.
15 marzo 1997,
n.
59", tuttora in vigore nonostante il riordino della normativa
in materia, dispone che:
"2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità,
di
sicurezza e di igiene per il
rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei
locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali,
è
esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui
all'articolo
141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . Ai fini
del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei
locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una
conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n.
241 , come modificato dall'articolo
17
della legge 15 maggio 1997,
n.
127 [
...
]"
A piccoli passi la Conferenza dei servizi entra anche nella disciplina in materia di
cinematografi e teatri e, quindi, nei locali di pubblico spettacolo.
54
Su ricorso delle regioni Emilia Romagna e Toscana che hanno eccepito l'illegittimità di diverse
disposizioni contenute nel d.lgs 28 del 2004, la Corte si è pronunciata con sentenza 19 luglio 2005,
n.285
130

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 137/194
13. La
commissione di vigilanza pubblico spettacolo
Il più volte indicato art. 80 Tulps prevede che "L'autorità di pubblica
sicurezza (oggi
il
comune) non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro
o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una
commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio". Se, quindi, ci
si sofferma sulle competenze elencate nell'art.
141
del reg. Tulps non si può non
pervenire alla conclusione che, teleogicamente, l'organo a cui si riferisce l'art. 80
Tulps
è,
o meglio ancora deve essere, organo squisitamente tecnico.
A dire il vero, dopo l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di
pubblico spettacolo, non è possibile non interrogarsi sulla necessità di questa
commissione, in relazione al fatto che le regole tecniche poste sono, di per se,
prescrizioni. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza
55
la quale ha affermato
che "Configura il reato previsto dagli artt.
681
c.p. e 80 r.d. n. 773 del 1931 la
gestione di una piscina
56
con impianto di acquascivolo, con licenza di agibilità
decaduta per il mancato adeguamento alle prescrizioni del
d.m.
18 marzo
1996
n.
61
57
previste per gli impianti sportivi, in quanto anche nelle piscine con
acquascivolo può effettuarsi attività natatoria, che è qualificabile come attività
sportiva, e pertanto debbono essere applicate le prescrizioni volte a garantire la
sicurezza dei frequentatori contro il rischio di cadute e di annegamenti."
Tuttavia, l'articolo 3 del citato d.m.
18
marzo 1996 emanato dal Ministro
dell'interno, dispone che:
"Il comune sottopone il progetto alla commissione provinciale di vigilanza, per
l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo
55
Cass. Pen. Sez. l, 9 febbraio 2005,
n.
8101.
56
In base al Tulps anche le piscine sono considerate locali di intrattenimento e, in quanto tali,
soggette alla licenza di cui all'art. 68 previa verifica dell'agibilità prevista dall'art. 80 del
medesimo testo unico.
57
Il d.m. 18 marzo 1996 reca "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi"
131

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 138/194
Unico delle leggi di pubblica Sicurezza approvato con regio decreto
18
giugno
1931, n. 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la
conformità dell'impianto alle presenti norme.
n
verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il
richiedente è tenuto a presentare al comune per la domanda di visita di
constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica,
nonché agli adempimenti previsti dal decreto del presidente della repubblica 29
luglio 1982, n. 577
58
,
ai
fini della prevenzione incendi.
La commissione provinciale di vigilanza esegue la visita di constatazione e redige
apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle
combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica
Sicurezza e all'art.
19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, che viene trasmesso al sindaco
ai
fini del rilascio della licenza di agibilità.
Alla commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un
rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato."
In pratica, sia la regola tecnica per gli impianti sportivi sia le disposizioni sottese
all'apertura di nuovi cinematografi (in attesa delle disposizioni regionali)
chiamano in causa la commissione provinciale di pubblico spettacolo. Starà
all'interprete, compito certamente arduo, sistematizzare le diverse disposizioni
58
Sui contenuti del d.P.R. 29 luglio 1982 n. 577 "Approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi antincendi" ci si è già soffermati, anche in relazione al fatto che questo
decreto è stato abrogato. A dimostrazione, tuttavia, della necessità di un intervento di
sistematizzazione complessivo della normativa in vigore mediante le predisposizione di testi unici,
si riporta, qui di seguito, la nota apposta al decreto in questione nella banca dati delle leggi
d'Italia:
TI
presente decreto è stato abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006,
n.
139,
limitatamente agli articoli
l;
2; 3, commi l e 2, numeri
l)
e 2); 7;
8;
10, successivamente
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del citato decreto legislativo
n.
139 del
2006; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del suddetto decreto legislativo
n.
139 del2006; 12; 17; 20,
ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto
di
cui
all'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo
n.
139 del 2006." In pratica, pare proprio che
ai
tempi attuali si tenga in nessuna considerazione ciò che,
ai
tempi della stesura del codice Pen. nella
Relazione al Re
Zanardelli affermava convinto che "le leggi devono essere scritte in modo che
anche gli uomini di scarsa cultura possano intenderne
i l
significato; e ciò deve dirsi specialmente
di un codice Pen.,
i l
quale concerne un grandissimo numero
di
cittadini anche nelle classi popolari,
ai
quali deve essere dato modo di sapere, senza bisogno d'interpreti, ciò che dal codice
è
vietato",
in Codice Pen. del Regno d'Italia, illustrato con le principali decisioni delle corti del Regno (a cura
di A.Bruno) XII ed. Barbera editore, Firenze, 1927
132

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 139/194
tenuto conto che il d.P.R. 577 del 1982 è stato abrogato, non è competenza del
sindaco il rilascio della licenza di agibilità e, fatto ancor più eclatante, non esiste
neppure una "licenza di agibilità" ma soltanto una "verifica" tecnica propedeutica
al
rilascio della licenza di esercizio.
14.
La commissione comunale
La composizione della commissione comunale di vigilanza pubblico
spettacolo, secondo quanto previsto dal d.p.R. 311 del 2001 sui cui contenuti e
imprecisioni ci si è già soffermati, mutua la composizione della commissione
provinciale ante riforma, con le uniche necessarie sostituzioni del sindaco o di un
suo delegato, che presiederà la commissione in luogo del prefetto. Il comandante
della locale polizia municipale che assumerà l'incarico di componente
al
posto del
questore e l'ingegnere capo del comune in luogo dell'ingegnere del Genio civile.
Restano immutati i componenti esterni, come il comandante dei vigili del fuoco, il
dirigente medico e l'esperto in elettrotecnica.
Non
c'è
stato sforzo di elaborazione nella modifica di questa composizione. Non
si è, in sostanza, analizzata la complessità di una struttura e le connesse
problematiche della sicurezza che, nel terzo millennio, sono riconducibili anche
ad altri settori oltre a quelli propri dell'elettricità. Ma la questione, alla fin fine, è
irrilevante per un duplice ordine di motivi. Il primo è quello connesso
al
fatto che
i consigli comunali già con l'art. 19 del d.P.R. 616 del 1977 sono titolati a
determinare procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio
delle funzioni. Il secondo motivo è che il novellato art.
117
Cost. dispone che "I
Comuni, [ ...] hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite."
La questione connessa all'autonomia normativa degli enti titolari di funzione è già
stata dettagliatamente presa in esame. Tuttavia, alcune riflessioni con riferimento
specifico alla disciplina del procedimento, cioè alla definizione delle regole che le
amministrazioni, una volta definita la loro organizzazione,
si
danno quanto allo
svolgimento delle attività è ancora utile, anche in relazione alla novella
133

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 140/194
dell'articolo 29 della
L
241 del 1990 introdotta dalla legge
15
del 2005 che, in
termini forse non chiarissimi, sancisce l'assenza di una riserva allo Stato in
materia di procedimento amministrativo.
Le regole sul procedimento sono in gran parte regole sull'organizzazione, nel
senso che l 'articolazione delle attività di esercizio di una funzione amministrativa
costituisce in buona misura una scelta relativa alla loro organizzazione. Poiché
però, le norme sul procedimento hanno effetto anche sulle posizioni giuridiche dei
cittadini coinvolti dall'azione dell'amministrazione (partecipazione, accesso,
accordi, termine e così via) si pone il problema di garantire una soglia minima di
uniformità (o dei principi generali sul procedimento sicuramente applicabili a tutte
le amministrazioni, anche se dotate di autonomia normativa).
Il legislatore statale ha cercato di dare una risposta esaustiva introducendo, con la
legge n.
15 del 2005 una nuova versione dell'art. 29 della legge
n.
241 del 1990;
che correttamente delimita il campo di applicazione diretto della legge sul
procedimento ai "procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali", proprio con riferimento
alla riserva statale della lett. g) dell'art. 117, comma 2 (a conferma della stretta
relazione tra organizzazione e procedimento)".
La
scelta di qualificare i principi della legge sul procedimento come principi
derivanti dalla Costituzione è avvenuta senza alcuna contestazione da parte delle
Regioni che non hanno eccepito i l difetto di competenza dello Stato nella materia,
con ciò facendo una sorta di "acquiescenza" rispetto a una scelta che nel caso
specifico non appare del tutto incongrua.
59
Se lo Stato, quindi, non solo può, ma deve, determinare principi e livelli essenziali
di prestazioni pubbliche la conclusione
è
che non sia configurabile, anche in
questo campo, alcuna riserva in favore dell'autonomia normativa locale, ma che
l'unica protezione possibile di quest'ultima risiede nei limiti entro i quali lo Stato
59
Merloni F.,
Riflessioni sull'autonomia normativa degli enti locali,
in
Le
Regioni", n. l febbraio
2008 p. 103
ss
134

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 141/194
può condizionare, con disposizioni relative ai principi e ai livelli essenziali delle
prestazioni la organizzazione delle funzioni.
Tale necessità riguarda ancor di più una materia, come quella in esame, in cui si
materializza il paradosso di una funzione assegnata
ai
comuni, con l'art.
19
del
d.P.R. 616 del 1977 rubricato "polizia amministrativa" che rientra, in parte, nelle
competenze esclusive dello Stato. L'attività di prevenzione ed estinzione degli
incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone,
rientrano, infatti, nell'ambito della cosiddetta "attività di pubblica sicurezza", di
cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione ratione materiae (Consiglio
di Stato- I Sezione parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979).
Comunque, questo è un aspetto che sarà successivamente preso in considerazione
proprio
in
relazione alla necessità di coordinare e sistematizzare l'attuale quadro
normativa di riferimento.
Ancor prima di prendere in esame la composizione della commissione, è utile
rilevare altre questioni contenute nella disciplina in questione.
Il
parere della commissione,
ad
esempio, afferma il VII comma dell'art.
41
bis del
reg. Tulps che il parere "deve sempre essere dato per iscritto e con l'intervento di
tutti i componenti." Sul contributo specifico che viene
ad
essere richiesto ai
componenti la giurisprudenza non è ricca ma, comunque, significativa laddove
afferma che "Per la formulazione di tali pareri alla commissione incombe
l'obbligo di acquisire, con istruttoria diretta (sopralluoghi) e in ogni altro modo
opportuno, documentazione e quanto altro ritenuto necessario. Salvi i casi di
delega previsti dalla normativa nell'espletamento dell'attività istruttoria, ciascun
componente ha il dovere di informarsi in ogni aspetto concernente la sicurezza e
l'igiene del locale di pubblico spettacolo e, contemporaneamente, ha diritto di
essere parimenti informato, sì da essere posto in grado di attendere, con pienezza
di cognizione, all'ufficio nel quale
è
stato chiamato, senza che rilevi distinzione
alcuna, sia in relazione alla posizione istituzionale (presidente) sia con riferimento
alla provenienza burocratica o sociocorporativa di ciascuno dei commissari.
Nell'ambito di tale divieto-dovere rientra anche quello di richiedere che gli altri
135

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 142/194
componenti la commissione si attivino, ponendo a disposizione le eventuali
specifiche competenze, ove a essa occorra far ricorso. La posizione
di
garanzia
attribuita alla detta commissione e a ciascun componente, sotto i profili sopra
considerati, comporta, nell'ipotesi in cui, per colpa, sia generica che specifica, cioè
per negligenza o imprudenza nell'espletamento del proprio ufficio, ovvero per
imperizia nell'individuazione delle "misure e cautele" atte ad impedire la
verificazione dell'evento a rischio, oppure per violazione di "leggi" regolamenti
ordini o discipline, a quello scopo finalizzati, non siano eliminate
le
situazioni
di
pericolo ovvero non siano state disposte le misure e le cautele necessarie a
prevenirle, qualora l'evento (dal legislatore) temuto
si
verifichi, e sia individuato
un rapporto di (con) causalità tra questo e la condotta (omissiva); ciascun
componente della commissione in questione legittimamente viene chiamato a
rispondere, a titolo
di
colpa,
di
quell'evento che la sua condotta ha concorso a
cagionare. (Fattispecie di incendio di locale adibito a cinema, con conseguente
morte
di
molte persone. La Corte ha ritenuto non fondata la tesi difensiva secondo
cui ciascun componente della commissione provinciale
di
vigilanza
rappresenterebbe
un
determinato ufficio
e,
pertanto, si attiverebbe ed
esprimerebbe parere solo in relazione alle specifiche competenze funzionali
attinenti tale ufficio. Il parere della commissione, cioè, unitario sotto l'aspetto
formale,
si
risolverebbe nella somma
di
pareri individuali, ciascuno incentrato
sulle competenze specifiche del componente interpellato).
60
La commissione
permane quindi un collegio perfetto.
15.
La
composizione della commissione
Specificatamente, per quanto riguarda la composizione della commissione,
l'art. 141-bis del regolamento, così come modificato dal d.P.R.
311
del
2001
prevede che:
60
Cass. Pen. Sez. fer. 9 agosto 1990, in Cass. pen. 1992, 757
136

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 143/194

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 144/194
sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo
prontamente in caso di incendio, non già per quanto riguarda la prevenzione in
materia acustica."
62
Sembra, a tale riguardo, in senso opposto
i l
contenuto del V comma del medesimo
art.
141
bis nella parte in cui prevede l'intervento della commissione comunale
non soltanto per questioni connesse alla prevenzione incendi bensì in
un'accezione più ampia legata, quindi, alla sicurezza in senso lato "quando sono
impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici,
elettromeccanici o elettronici" In
tal caso "è comunque richiesta una relazione
tecnica di un tecnico dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole
tecniche di sicurezza". La sicurezza per l'intero settore dello spettacolo viaggiante
è stata disciplinata recentemente. Le nuove norme sono contenute nel decreto del
Ministero dell'interno del 18 maggio 2007 pubblicato in G.U. del 14 giugno n.
136
che reca "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante". Il
decreto, a dire il vero, va ben al di là di quello che la rubrica recita, anche se
risolve la situazione di stallo che
si
era determinata con l'entrata in vigore del
decreto 8 novembre 1997. Con questo decreto, infatti, era stata sospesa
l'attuazione delle disposizioni del punto 7.7 della "regola tecnica" che riguarda
specificatamente le attrazioni per lo spettacolo viaggiante, allegata al decreto del
Ministro dell'interno
19
agosto 1996, "Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo" di cui
si
è già trattato.
Le norme sulla sicurezza emesse dal Ministero dell'interno sono diretta
conseguenza dell'emanazione delle norme UNI EN 13814 del2005, nel senso che
ogni aspetto tecnico inserito nel decreto di maggio è la riproposizione di quanto
dispone la norma tecnica uniforme.
Tra le competenze della commissione di vigilanza pubblico spettacolo rientra
anche quella di verifica dei giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425
63
e alle
62
In tal senso T.a.r. Lazio, Sez. Il, 27luglio
1994, n.
926
138

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 145/194
disposizioni del relativo regolamento di attuazione. D regolamento di attuazione
della legge 425 non
fu
mai emanato ma tutta
la
disciplina in materia di apparecchi
da intrattenimento, in relazione alla omologa dei prototipi, è di competenza
esclusiva dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
16. La
competenza del sindaco
A proposito della composizione della commissione (tecnica) di vigilanza,
prevista dall'art. 141bis
64
reg. Tulps e della partecipazione del sindaco ai lavori
63
Porta
la
firma dei deputati Gasparri, Rositani, La Russa, D'Onofr io, Cardiello, Mascone, Tagini,
Del Noce e Pezzoli, la proposta di legge presentata il 15 aprile 1994 che attraverso la modifica,
ancora una volta, dell'art. 110 del Tulps
ha
rivoluzionato il concetto stesso del trattenimento. Gli
intenti potevano essere lodevoli. Come risulta dai lavori parlamentari: "scopo delle modifiche è di
rendere giustizia ad un settore troppo dimenticato e di consentire che, oltre alla tipologia
universalmente riconosciuta di apparecchi da trattenimento (videogiochi, flipper,
elettrogrammofoni) il settore possa finalmente accedere all'utilizzo di questi apparecchi che
consentano, come di fatto già consentono nei luna park e nei parchi attrezzati
(nda vedi legge 18
marzo 1968
n. 337
e decreto interministeriale 23 aprile 1969),
la vincita di piccoli premi. Se ne
ricaverebbe, continua la relazione alla proposta di legge, un beneficio enorme sotto il profilo
morale: le modestissime vincite in natura scoraggerebbero
la
pratica del gioco d'azzardo in quanto
la gratificazione viene raggiunta appunto mediante il premio consentito; premio in natura che
certamente devierebbe dal premio in denaro, con beneficio sia dei gestori che dei fruitori.
La
vincita, in sostanza, appaga; quando essa rimane circoscritta nel modo da noi indicato, non è
socialmente pericolosa ma soddisfa semplicemente quella parte di vanità che è in ogni essere
umano".
Il disegno di legge, nella seduta dell'li luglio 1995, venne approvato all'unanimità dalla X
commissione della Camera dei Deputati. Il 2 agosto dello stesso anno, il testo licenziato fu preso in
esame dalla corrispondente commissione del Senato che dopo la pausa estiva lo approvò nella
seduta del 13 settembre 1995 non senza aver attentamente valutato i rischi che avrebbero potuto
conseguire alla diffusione di questi apparecchi da trattenimento. Alcuni componenti della
commissione del Senato, in pratica, manifestarono preoccupazione per la facilità con la quale gli
apparecchi da trattenimento potevano essere trasformati da leciti in illeciti consentendo il gioco
d'azzardo e i l rischio dell'infiltrazione della criminalità organizzata in questo bussines. Ma furono
inascoltati con le conseguenze che oggi sono davanti agli occhi di tutti.
64
Art. 141-bis reg. Tulps
Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza e' comunale e le relative
funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La
commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed e'
composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un
medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
t) da
un
esperto in elettrotecnica.
139

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 146/194
della stessa che, peraltro, è da lui presieduta, non si possono nascondere dubbi di
illegittimità della norma in questione.
E'
innegabile, come peraltro si
è
già
affermato, che nessuna elaborazione è stata svolta per determinare la
composizione della commissione. Si
è
chiarito, infatti, che laddove
c'era
il
prefetto è stato previsto, per assonanza, il sindaco.
Ma
se la presidenza affidata al
prefetto nella commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo la cui
composizione e funzioni sono disciplinate dal successivo art. 142
65
reg. Tulps
è
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra
disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle
rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione
professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici,
elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto,
dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di
cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o piu' supplenti.
Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che puo'
parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la
commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal
dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante
dei Vigili del fuoco o suo
delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
65
Art. 142 reg. Tulps
Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione
comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui
al primo comma dell'articolo
141
provvede la commissione provinciale di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal Vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo
delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un
medico dallo
stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio
civile;
f)
dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in
relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da
verificare.
Possono altresì' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle
rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione
professionale.
140

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 147/194
perfettamente giustificata, così non è per il sindaco che opererebbe, a proposito
delle funzioni trasferite, in qualità di capo dell'amministrazione e non in qualità di
autorità locale di pubblica sicurezza o di ufficiale di Governo.
Tra l'altro come appare dalla lettura dell'articolo 142 regolamento Tulps il
prefetto può essere sostituito soltanto dal vice prefetto con funzioni vicarie e non
da un qualsiasi altro soggetto seppur munito di delega.
l
convincimento che il sindaco presiede la commissione comunale in qualità
di
capo dell'amministrazione e non in veste di ufficiale del Governo è motivata non
dal fatto che la commissione in questione può essere presieduta anche da un suo
delegato,
(è
noto, infatti, che il sindaco anche in materia di Stato civile può
delegare funzionari comunali all'espletamento delle funzioni) bensì in relazione
ad altra disposizione contenuta all'interno dell'articolo 142 del medesimo reg.
Tulps.
In tale disposizione, e precisamente all'ottavo comma, è previsto che "Per
l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la
commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del
comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi
Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, commissione provinciale.
Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti,
il Questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di
polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito
dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.
Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con
l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo
dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione
provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o
impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo
comma dell'articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la
verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al
secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza
superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000
spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le
attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche
degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del
Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanità.
141

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 148/194
del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis."
L'articolo 141, primo comma lett. a, alla quale viene fatto riferimento, prevede tra
i compiti delle commissioni di vigilanza (sia provinciale che comunale) anche
quello di "controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele
imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo
all'autorità competente gli eventuali provvedimenti."
E'
chiaro, a tale riguardo, che l'autorità competente chiamata in causa è quella di
pubblica sicurezza preposta alla pubblica incolumità e, di conseguenza,
se
il
sindaco operasse in tale veste, la norma sarebbe priva di senso logico, in quanto
dovrebbe dialogare con se stesso.
Perplessità sulla legittimità del conferimento al sindaco della funzione di
presiedere la commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo sussistono
peraltro, con riferimento all'art.
118
Cost. che esclude l'allocazione delle funzioni
con uno strumento diverso dalla legge e, per quanto di specifico, con quanto
disposto alla lettera b) comma l dell'art. 54 "Attribuzioni del sindaco nei servizi
di competenza statale" del Tuel
66
: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovrintende [ ... ] allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia
di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria".
Il prefetto presiede la commissione provinciale di pubblico spettacolo chiamata ad
esprimersi, "eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per
i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza
superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza
superiore a 5.000 spettatori"
67
•
Si
è
già dato atto che il comma 3 dell'art. 20, del d.lgs
139
del2006
68
prevede che
il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti
responsabili omettano [ ... ] i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo
66
Si tratta del d.lgs. 18 agosto 2000
n.
267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"
67
La
disposizione
è
contenuta all'ultimo comma, lettera a) dell'articolo 142 reg. Tulps
68
Il decreto legislativo 8 marzo 2006,
n.
139 reca norme di "Riassetto delle disposizioni relative
alle funzioni ed
ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo
11
della
legge 29 luglio 2003,
n.
229"
142

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 149/194
ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico
per i quali i servizi medesimi sono obbligatori." Di conseguenza non
c'è
contraddittorietà tra le due disposizioni.
E'
evidente che questa regola trae legittimazione dal fatto che il prefetto
69
è
autorità provinciale di pubblica sicurezza; ha la responsabilità dell'ordine e della
sicurezza pubblica e presiede i l Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica. E' in relazione, quindi, alla sua specifica responsabilità nell'ordine
pubblico di cui si è visto l'incolumità pubblica si trova in una posizione collegata,
69
Certamente, oggi, la funzione fondamentale del prefetto che è quella di rappresentare, nella
provincia, il Governo nel suo insieme,: può passare in second'ordine vista la molteplicità delle
nuove funzioni attribuite. Insomma, pur
in
un contesto di marcato decentramento, il prefetto
continua a rappresentare i l nucleo centrale per la riaggregazione delle funzioni statali decentrate,
ora disperse e frantumate e, nel contempo, servire da cerniera tra centro e periferia e, soprattutto,
nel rapporto tra lo Stato e i l sistema delle autonomie locali.
Del resto, ridare un senso al prefetto che fa da cerniera all'impianto complessivo del Tulps ma la
cui figura è stata evidentemente ridimensionata con la nascita delle regioni, era compito che il
legislatore nazionale doveva necessariamente affrontare. Dagli anni 70 alla fine del secolo possono
essere individuatie
le
seguenti svolte che hanno fortemente condizionato la nascita
di
un diverso
ruolo istituzionale:
a)
La crisi della figura del prefetto a partire dagli anni settanta conseguente alla
nascita delle Regioni e al primo massiccio trasferimento delle competenze previsto dalla legge
22
luglio 1975
n.
382 e dal successivo d.p.r. 61611977; b) L'emergenza terrorismo in Italia e la svolta
nella figura dei Prefetti con la L.121181 (proprio a partire dalle competenze
di
ordine pubblico,
sicurezza e polizia amministrativa) c) La perdita di competenze di natura prettamente
amministrativa avvenuta fra gli anni
90
e 2000: invalidi civili, patenti, copie d'obbligo, etc . d) La
quasi parallela attribuzione di competenze legate alla depenalizzazione dei reati, al fenomeno
dell'immigrazione, alla garanzia dei diritti civili e di cittadinanza (da ultimo l'istituzione delle
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato incardinate nelle Prefetture e
presiedute da Prefetti non di sede e la creazione degli Sportelli Unici).
In questo contesto, e considerato l'attuale quadro costituzionale
in
materia di autonomie locali, la
figura del prefetto riprende particolare vigore quale rappresentante del Governo centrale sul
territorio, quale coordinatore degli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato (si veda le
disposizioni normative con riferimento alla creazione delle Prefetture - UTG), quale autorità
provinciale di P.S. a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica (si veda gli ultimi risvolti
normativi
in
base ai quali
i l
prefetto può espellere dal territorio nazionale, in specifici casi, anche
cittadini comunitari), ed infine quale ente a cui appartengono compiti di cosiddetta
amministrazione generale, da porre in essere con l'importante strumento delle conferenze
permanenti, intese quali organi che coadiuvano il prefetto nelle funzioni di coordinamento degli
uffici periferici dello Stato garantendo la leale collaborazione con il sistema delle autonomie
locali. (si veda i l d.P.R. 180/2006)
Da non dimenticare, infine, le competenze in materia di elezioni (ufficio provinciale elettorale),
racket, usura, antimafia, tossicodipendenze, pubblici spettacoli, polizia amministrativa (porto di
pistola per difesa personale, guardie giurate, istituti di vigilanza) detenzioni di animali esotici o
pericolosi, e tanto altro che è disciplinato, tuttavia, all'interno di quelle discipline speciali che
hanno caratterizzato la normazione statale dopo la codificazione e che tanta difficoltà determinano
nell'interprete.
143

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 150/194

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 151/194
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che ha attribuito ai
dirigenti (e non agli amministratori) degli enti locali tutti i compiti di gestione, tra
i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
degli stessi enti, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali
di indirizzo. Insomma, parrebbe inopportuno immaginare un provvedimento
emesso dal dirigente tecnico del comune sulla base delle valutazioni di carattere
tecnico espresse dal proprio sindaco.
Peraltro, l'articolo 107 "Funzioni e responsabiltà della dirigenza" del Tuel267 del
2000 prevede, al comma 4, che "Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del
principio di cui all'articolo l, comma 4, possono essere derogate soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative". Situazione questa
che, nel caso in esame, evidentemente non sussiste.
Ne consegue che la competenza del sindaco a presiedere la commissione prevista
dall'art. 141bis del regolamento Tulps, così come modificato dal d.P.R.
311
del
2001 viola il principio della separazione degli organi di amministrazione da quelli
di gestione.
La giurisprudenza, relativamente a questo aspetto,
è
univoca. L'emissione di
autorizzazioni (o nulla-osta e pareri) costituisce attività tipicamente gestionale, di
amministrazione concreta del territorio del tutto estranea alla funzione di indirizzo
politico. L'ordinamento degli enti pubblici ha subìto - con una serie significativa
di riforme realizzate dal 1990 ad oggi - una radicale modifica nella distribuzione
delle competenze tra gli organi politici e la dirigenza.
Il
principio guida espresso dai diversi provvedimenti legislativi ha sancito, in
pratica, la netta separazione tra le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di
direzione politica e le attribuzioni gestionali demandate ai funzionari: i primi,
infatti, fissano
a
monte" le linee generali dell'azione amministrativa mediante
l'adozione di direttive e l'elaborazione di programmi ed al contempo esercitano
a
valle" il controllo sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi
145

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 152/194
prestabiliti; i secondi assumono tutte le iniziative a rilevanza esterna esplicando
autonomi poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
71
•
L'art. 4 comma 2 del d.lgs. 30 marzo
2001
n.
165,
recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"
recita testualmente: "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della
gestione e dei relativi risultati." Analoga disposizione è stata prevista dal
legislatore all'art. 107 del d.lgs.
267
del2000.
72
In sostanza, secondo l'indirizzo dominante, il nuovo assetto dei poteri nelle
amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida ed effettiva separazione dei
rispettivi ruoli: da una parte i compiti di indirizzo, attribuiti al potere politico, e
dall'altra i poteri gestionali, che divengono poteri propri della burocrazia, intesa
come i l complesso degli apparati amministrativi chiamati a tradurre in pratica, nel
rispetto delle norme regolamentari poste dagli enti medesimi, gli indirizzi politici.
È stato pertanto stabilito che la ripartizione delle funzioni, delineata dalle
disposizioni vigenti, riduce gli spazi di autonomia statutaria degli enti alla sola
possibilità di disciplinare le modalità di esercizio delle competenze, mentre non
può incidere sulla loro titolarità stabilita dalla legge con chiarezza e puntualità.
73
71
T.a.r. Lombardia, Brescia, 5 ottobre 2004,
n.
1150
72
Nello stesso senso: T.a.r. Toscana Firenze, Sez. II, 16 ottobre 2008 , n. 2287; T.a.r. Sardegna
Cagliari, Sez. I, 29 settembre 2008 , n. 1794 Tra l'altro, degna di evidenza per l'argomento trattato
è "La circostanza che l'art. 54 comma
3,
d.lg. n. 267 del 2000 contempli una speciale funzione
sindacale in materia di orari di esercizi commerciali e pubblici esercizi, per far fronte a situazioni
di emergenza, non fa venir meno
i l
generale e ordinario potere di determinazione delle prescrizioni
relative alle singole autorizzazioni di polizia, ivi compresa
la
fissazione dell'orario di attività (ai
sensi dell'art. 9, Tulps), che fa capo ai dirigenti quali titolari dell'ordinaria competenza gestionale
ex art. 107, d.lg.
n.
267 del2000" T.a.r. Emilia Romagna Parma, Sez. I, 26 giugno 2008,
n.
326
73
Sempre nello stesso senso la sentenza T.a.r. Abruzzo Pescara, 12 aprile 2001
n.
408. Inoltre, in
relazione al fatto che statuti e regolamenti non sono abilitati ad incidere sul "catalogo" delle
attribuzioni dirigenziali, potendolo semmai ampliare ma giammai restringerlo per sottrazione di
competenze in favore dell'organo politico (T.a.r. Calabria Catanzaro, Sez. I 19luglio 2004
n.
1641;
T.a.r. Liguria, Sez. II 9 giugno 2003
n.
736).
146

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 153/194
Ed in tale chiave esegetica non può non rammentarsi che l'art. 4 comma 3 del d.
lgs. 165 del 200 l stabilisce in via generale che le attribuzioni conferite ai dirigenti
possono essere derogate "soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative", mentre l'art. 70 comma 6 puntualizza che
a
decorrere
dal 23 aprile 1998 le disposizioni che conferiscono agli organi di governo
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art.
4 comma 2 del presente decreto si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti".
Tali norme di chiusura introducono una clausola "interpretativa" generale che ha
portata ed efficacia innovativa delle previgenti disposizioni -legislative, statutarie
e regolamentari - assicurando l'obbligatoria devoluzione alla sfera di competenza
dirigenziale di tutti gli atti che non attengono all'ambito dell'indirizzo politico.
17. La
soppressione delle commissioni inutili
La legge 537 del 1993 (finanziaria 1994) nota, soprattutto, per aver
liberalizzato, con la riformulazione dell'art. 19 della legge 241 del 1990
l'esercizio delle attività economiche in tutti i casi in cui il rilascio della
autorizzazione non deve essere preceduto da valutazioni discrezionali, aveva (il
passato
è d'obbligo tenuto conto che sono trascorsi ormai più di quindici anni)
anche previsto, all'art. l comma 28, il riordino degli organi collegiali, attraverso
un percorso coerente e lineare che aveva il compito di raggiungere l'ambizioso
obiettivo di sopprimere quelli non più necessari, ovvero inutili in quanto in
contrasto con il processo di semplificazione in atto; e sostituire, laddove
necessario, gli organi collegiali con le conferenze di servizi previsti dalla legge
241 del 1990; trasferire, infine, ad organi monocratici o ai dirigenti le funzioni già
degli organi collegali, laddove possibile.
74
74
TI citato comma 28 dispone che: "Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n.
l. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al
riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di
collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e princìpi:
147

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 154/194
Non molto tempo dopo, secondo una procedura codificata dalla difficoltà di
effettuare una risolutiva ricognizione da parte di tutti gli enti per il riordino degli
organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di
collaborazione
ad
uffici pubblici, venne emanata una nuova disposizione.
n legislatore, in sostanza, seguendo la medesima procedura adottata per la
riformulazione dell'art. 19 legge
241
del 1990
75
,
e ancora una volta attraverso lo
strumento della legge finanziaria, prese in mano la situazione risolvendola con
legge.
Con l'art. 41, comma l della Legge 27 dicembre 1997
n.
449 "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica" venne disposte che:
l.
Al
fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei
procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con
provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario,
individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con
funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non
identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo
all'emanazione del provvedimento.
Le
relative funzioni sono attribuite all'ufficio
che riveste preminente competenza nella materia".
In sostanza, ancora una volta si utilizzava lo strumento della legge finanziaria per
dare vita, nella pubblica Amministrazione, a un sistema nuovo per fronteggiare i
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in
seguito all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo
14
della legge 7
agosto 1990,
n.
241;
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993,
n.
29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in
ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli
organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.
75
n sistema usato con la novella dell'art. 19 dell'art. 19 della legge 241 del1990 vanificò, di fatto,
i contenuti del regolamento 26 aprile 1992 n. 300"Regolamento concernente le attività private
sottoposte alla disciplina degli articoli
19
e 20 della legge7 agosto 1990
n.
241" il quale
individuava espressamente i procedimenti soggetti a denuncia di inizio attività e a silenzio
assenso.
148

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 155/194
costi della pletora di commissioni e collegi che, spesso, venivano
(e
vengono
purtroppo ancora) insediate per le più svariate finalità.
C'è da dire, a tale proposito, che la motivazione per la soppressione, come ha già
messo in rilievo la giurisprudenza, non
è
necessaria perché rappresenta
un
atto
dovuto; essa occorre invece per il suo mantenimento considerato che il
mantenimento è una eccezione alla regola
76
•
Peraltro, ad esempio, la commissione elettorale comunale, ad avviso del Ministero
dell'interno (nota n. 15900/64111-bis/legge 142 del22luglio 1999) non può essere
soppressa in quanto destinata a disciplinare una materia, quale è quella elettorale,
che
è
regolata da una normativa speciale e che
è
rimasta allo Stato anche alla luce
della legge n. 59 del 1997 sul decentramento delle funzioni e dei compiti dallo
Stato agli enti locali.
Va evidenziato ancora, a proposito della soppressione delle commissioni, che la
disposizione contenuta nella legge 449 del 1997 è stata riproposta, seppur con
riferimento agli enti locali, nell'art. 96 "Riduzione degli organismi collegiali" del
decreto legislativo 267 del 2000.
l. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei
procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive
competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni
76
La facoltà
di
soppressione della commissione edilizia quale organo collegiale non
indispensabile, accordata alle amministrazioni comunali dall'art.
41
comma l l.
27
dicembre 1997
n.
449, risponde sia
ad
una complessiva esigenza di autonoma conformazione delle modalità di
esercizio delle funzioni amministrative di competenza comunale, derivante dal nuovo testo degli
art.
118
e
119
Cost. rispettivamente introdotto dagli art. 4 e 5 l. Cost.
18
ottobre
2001
n. 3,
sia ad
esigenze
di
economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, presupposte - ormai - anche
quali veri e propri principi generali dell'ordinamento per effetto del combinato disposto degli art. 4
comma 3 lett. c) e 20 comma l l.
15
marzo 1997
n.
59 e successive modifiche ed integrazioni e
dell'art. l comma l l. 8 marzo 1999 n. 50; tuttavia la soppressione dell'organo in questione, non
determina
lo
svincolo dell'amministrazione da obblighi
di
istruttoria altrettanto penetranti ed
analitici, dovendosi dare conto delle ragioni non solo giuridiche, ma anche e soprattutto di
carattere tecnico che ostano all'accoglimento della domanda di condono, ad opera non già
di
un
organo collegiale, ma del responsabile del procedimento. T.a.r. Campania Napoli, Sez. II,
31
maggio 2007 , n. 5890 E ancora il T.a.r. Calabria Reggio Calabria, 28 gennaio 1999 ,
n.
48:
Dall'art. 41 comma l
l. 27
dicembre 1997
n.
449 si desume che la soppressione
di
taluni organismi
non identificati come indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione
ovvero dell'ente, è una conseguenza che discende direttamente dalla legge: mancando,
al
riguardo,
qualsiasi potestà di scelta dell'amministrazione la soppressione si configura, pertanto, come un atto
dovuto.
149

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 156/194
esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni
altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli
organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal
mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono
attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia."
Si potrebbe argomentare che la commissione comunale di vigilanza pubblico
spettacolo è commissione indispensabile ma questo riconoscimento deve,
necessariamente, essere preceduto da una valutazione che ne giustifichi il suo
mantenimento alla luce delle già indicate disposizioni normative orientate a
migliorare l'azione della pubblica amministrazione.
In sostanza, la semplificazione delle norme e delle procedure di cui tanto si parla
non può non mettere in discussione anche le cosiddette certezze. Solo in tal modo,
l'intrecciarsi e inquadrarsi nel più generale processo di ammodernamento del
sistema amministrativo
77
può rivolgersi progressivamente a valutare dapprima la
semplificazione dei procedimenti amministrativi, poi la formazione di nuovi
provvedimenti normativi, infine la revisione e riassetto del corpus normativo
vigente.
Ciò che occorre è trovare, in sostanza, la forma di tutela più efficace ma al
contempo meno onerosa per il sistema produttivo. A parità di efficacia nella tutela
di interessi collettivi, vi sono quasi sempre soluzioni meno onerose.
78
18.
Le competenze tecniche della commissione
Dalla lettura dell'art. 141 reg. Tulps si evince, inequivocabilmente, che i
compiti affidati alla commissione comunale e provinciale sono squisitamente
tecnici. Alla commissione, infatti, è richiesto di:
77
Bassanini F., Paparo S. e Tiberi G.
Qualità della regolazione: una risorsa
per
competere
in
astrid RASSEGNA anno l,
n. 11
de128 giugno 2005 www.astrid-online.it
78
Bassanini F., Paparo S. e Tiberi G.
Qualità della regolazione: una risorsa
per
competere,
cit.
150

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 157/194
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di
pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli
esistenti;
b)
verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e
di
igiene dei locali stessi o
degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia
nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e
degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità' pubblica;
d) omissis
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte
e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita'
competente gli eventuali provvedimenti.
In particolare ciò che si intende sottolineare con maggior evidenza, è il contenuto
di quanto disposto alle lettere a)
e b). In relazione all'espressione del parere sul
progetto previsto alla lettera a), è fuor di dubbio che la questione attiene
al
progetto edilizio per la costruzione di una nuova opera sia esso un teatro, un
cinema una discoteca, un night club.
E'
altrettanto fuori
di
dubbio che l'incarico
di esaminare il progetto, dal punto di vista tecnico, è incarico espressamente
conferito
al
responsabile dello sportello edilizio (ovvero si potrebbe anche ritenere
dal responsabile dello sportello unico per le attività produttive laddove costituito)
in base
al
più volte citato d.P.R. 380 del2001 testo unico per l'edilizia.
Riguardo i compiti individuati alla lettera
b)
del comma
l,
art. 141 reg. Tulps,
ovvero di verifica delle condizioni
di
solidità,
di
sicurezza e
di
igiene dei locali e
degli impianti nonché dell'individuazione delle misure e cautele ritenute
necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni,
c'è
da fare qualche precisazione.
Si è già avuto modo di osservare che, all'epoca della redazione del Tuls, ma anche
del regolamento Tulps, una delle maggiori preoccupazioni del legislatore era
quella legata alla salubrità dei locali. Contemporaneamente, non è possibile
151

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 158/194
ignorare che ali' epoca della redazione della norma i solai venivano realizzati in
legno.
Escludendo, quindi, la verifica delle condizioni di solidità che oggi prevede
specifiche competenze che possono anche non essere possedute dal dirigente
dell'ufficio tecnico comunale, che in molti dei più di 8000 comuni italiani
è
spesse volte un geometra, le restanti competenze: sicurezza e
di
igiene dei locali
determinazione delle misure e cautele ritenute necessarie nell'interesse dell'igiene
e della prevenzione degli infortuni, evocano inequivocabilmente le attribuzioni
conferite alle aziende per i servizi sanitari, in quanto strettamente connesse alla
tutela della salute.
Tra l'altro un parere preventivo, già a livello progettuale,
è
espressamente previsto
nella disciplina del procedimento per
l'
ottenimento del permesso di costruire
prima e del certificato di agibilità a lavori conclusi, così come dettagliatamente
illustrato nel primo capitolo, a proposito dell'esame della disciplina per il rilascio
del certificato di agibilità in base al testo unico per l'edilizia.
19.
La conferenza dei servizi in luogo della commissione
Peraltro, la legge 59 del 1997 ha ulteriormente posto la questione
dell'efficienza connessa agli organi collegiali prevedendo l'opportunità,
se
non la
necessità, di sostituire gli organi collegiali con conferenze di servizi, prevedendo
espressamente, all'art. 20, comma
5,
che i regolamenti di delegificazione devono
prevedere il "trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di
funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità,
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;"
Si tratta, in sostanza, di un chiaro indirizzo il cui mancato rispetto dovrebbe essere
giustificato in occasione della deliberazione che l'organo collegiale (giunta e
152

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 159/194
consiglio) deve adottare in base alla disposizione contenuta nel già indicato art. 96
del d.lgs 267 del 2000.
La commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo ha maturato, nella
sua lunga attività, un' ampia casistica utile
ai
fini
di
una precisa valutazione
propositi
va.
La commissione provinciale non opera sempre in collegio perfetto, con
l'intervento quindi di tutti i componenti, così come previsto obbligatoriamente dal
terzultimo comma dell'art.
141
reg. Tulps. In sostanza, nella pratica, è ritenuta
valida la riunione della commissione anche se non vi partecipano tutti i
componenti della commissione stessa, regolarmente invitati a partecipare
ai
lavori.
E'
superfluo rilevare che le decisioni emanate da un organo imperfetto non
sono valide, (sotto questo punto di vista la giurisprudenza è univoca). Ma quanto
attraverso questo elemento si intende evidenziare, è la difficoltà a riunire la
commissione nella sua integrità.
Decidere, di conseguenza,
di
ottemperare alle indicazioni del legislatore nazionale
fin dalla legge 537 del 1993, sostituendo la commissione comunale con una
conferenza dei servizi permanente, è uno dei modi per perseguire l'obiettivo di
acquisire il parere tecnico con modalità inconfutabili.
Del resto, non è superfluo rilevare che alcuni comuni, quali ad esempio il comune
di Varese, ha già dato pratica attuazione all'invito del legislatore, sostituendo la
commissione edilizia con una conferenza dei servizi. Detta conferenza, a V arese,
è organo tecnico composto dai Dirigenti (o loro delegati) dei settori interessati dai
procedimenti edilizi, integrata quando ne ricorrano i casi da esperti nelle materie
di volta in volta necessarie. Il parere della conferenza dei servizi permanente
costituisce mero atto interno di natura consultiva e comunque obbligatorio nei
procedimenti espressamente individuati. Anche il parere della commissione di cui
all'art.
141
bis è, in base alla costante dottrina e giurisprudenza, parere
endoprocedimentale.
153

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 160/194
L'aspetto di maggior vantaggio di una conferenza dei servizi rispetto alla
commissione è che non
c'è
la necessità di procedere a nomine, surrogazioni o
deleghe. Interviene in rappresentanza dell'ente, colui il quale viene incaricato
dall'organo deputato a rappresentarlo.
La conferenza, che
in
questo caso è conferenza istruttoria, è prevista dal comma l
dell'art 14 della legge 241 del 1990, il quale dispone che:
"Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce
di regola una conferenza dei servizi."
La volontà del legislatore è che la sua utilizzazione sia sempre più frequente non
essendovi procedimento che ormai non sia definibile come complesso. Una serie
sempre maggiore di norme di settore, al fine della tutela di altrettanti interessi,
introducono nuovi sub-procedimenti che andrebbero svolti avanti le
amministrazioni che sono state individuate come competenti?
9
Tra l'altro, gli
interessi pubblici considerati nel procedimento per la verifica dell'agibilità sono
già presi in considerazione, tutti, all'interno di altri procedimenti: permesso di
costruire, certificato di prevenzione incendi per tutti i locali capaci di accogliere
più di 100 persone, verifiche Asl medicina del lavoro (tanto per citarne alcuni).
E'
superfluo sottolineare che la natura tecnica della commissione comunale e
provinciale così come immaginata dal legislatore fin dalla redazione del Tulps ha
come fine l'accertamento tecnico collegato alla sicurezza degli edifici e dei luoghi
circoscritti ed è altrettanto superfluo evidenziare che lo strumento della
commissione era stato individuato, proprio, al fine di valutare congiuntamente gli
interessi pubblici coinvolti.
La conferenza è, quindi, lo strumento procedimentale, ottimale, di emersione e
comparazione di interessi pubblici, destinati a sintetizzarsi nel provvedimento
finale, in questo caso la verifica prevista dall'art. 80 Tulps.
79
Dapas A. Giadrossi A. Viola
L.,
Snellimento dell'attività amministrativa e riforma dell'ente
locale, GIAPPICHELLI, Torino 1998, p. 91
154

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 161/194
20. L'attività della conferenza
Il già indicato art. 80 del Tulps prescrive che l'autorità competente non può
concedere la licenza di un luogo
di
pubblico spettacolo, prima
di
aver fatto
verificare "la solidità e la sicurezza dell'edificio". Potrebbe, quindi, sembrare un
ambito
di
intervento limitato,
se
la prassi non avesse portato ad estendere, in
maniera inusitata la sua applicabilità, ben
al
di là di quella che è stata la originaria
previsione legislativa.
Infatti, a tutt'oggi, le commissioni comunali e provinciali operano sulla base della
già indicata circolare del Ministero dell'interno n.16
del15
febbraio
1951
"Norme
di
sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi
ed altri locali di spettacolo in genere. Con tale circolare, e precisamente con gli
articoli 16 e
17,
infatti, è stato "esteso", il concetto di locale che, quindi, va oggi
inteso come "l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o
trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi. Tra i locali di
pubblico spettacolo si annoverano, oggi, stadi, campi sportivi ed in genere luoghi
per divertimento o spettacolo all'aperto dove si presentano al
pubblico, in luogo
aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco
del pallone, palle
al
cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche,
automobilistiche, gare di calcio ecc."
In sostanza, sarebbero assoggettate
al
parere preventivo ex art. 80 Tulps, strutture
e attività che già dispongono
di
una specifica disciplina anche con riferimento alla
"regola tecnica" che necessariamente deve essere rispettata
ai
fini della cosiddetta
"prevenzione incendi". In tal modo è previsto l'obbligo
di
un ulteriore filtro le cui
maglie sono le stesse imposte da una disciplina già passato al vaglio.
Insomma pare proprio che non solo la commissione ma anche l'eventuale
conferenza
di
vigilanza pubblico spettacolo non potrebbe introdurre alcun
ulteriore elemento
di
utilità rispetto alla ponderazione
di
ogni singolo interesse già
considerato dai diversi enti preposti.
155

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 162/194

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 163/194
CAPITOLO QUARTO
UNA
PROPOSTA
DI
SEMPLIFICAZIONE
E
DI
RAZIONALIZZAZIONE
SOMMARIO: l. La direttiva Bolkestein e la riduzione degli oneri per le imprese. - 2.
La triplice funzione. - 3. L'incertezza della norma. - 4. Una proposta di
regolamento.
l.
La direttiva Bolkestein e la riduzione degli oneri per le imprese
Dieci anni dopo quello che avrebbe dovuto essere i l completamento del
mercato interno, si registra ancora un grosso divario tra la visione di un'Europa
economica integrata e la realtà vissuta dai cittadini europei e dagli operatori di
servizi. Secondo la Commissione UE, i l notevole potenziale di crescita e di
creazione di posti di lavoro che caratterizza i l settore dei servizi non ha ancora
potuto concretizzarsi a causa dei numerosi ostacoli che si oppongono allo
sviluppo delle attività di servizi
nel
mercato interno.
In particolare, le PMI sono troppo spesso scoraggiate dallo sfruttare le opportunità
del mercato interno in quanto non dispongono dei mezzi per valutare e premunirsi
contro i rischi giuridici di un'attività transfrontaliera e per far fronte alle
complessità amministrative. Allo scopo di agevolare
lo stabilimento in un altro
Stato membro è necessaria, quindi, una semplificazione amministrativa. Occorre,
in pratica, eliminare le restrizioni derivanti da procedure di autorizzazione
eccessivamente complesse, prive di trasparenza o discriminatorie nonché le
prescrizioni che ostacolano attualmente le strategie di stabilimento transfrontaliero
dei prestatori di servizi.
E'
questo, i l quadro
di
sintesi che ha indotto i Paesi europei a dare attuazione alla
direttiva Bolkestein che, presentata dalla Commissione europea nel febbraio 2004,
è stata definitivamente approvata da Parlamento e Consiglio, profondamente
emendata rispetto alla proposta originaria, il
12
dicembre 2006, divenendo
157

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 164/194
formalmente la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006. La direttiva deve
essere attuata entro il 2010 e vede all'opera Stato e regioni, ma l'Italia non ha
atteso la sua approvazione formale per iniziare a darvi attuazione, perlomeno a
livello di intendimenti. Infatti, già con legge
28
novembre 2005,
n.
246
"Semplificazione e riassetto normativa per l'anno 2005" al Governo è stata
conferita delega in linea con gli obiettivi della direttiva. In particolare, risulta utile
evidenziare quanto dispone il comma 2 dell'art. 5
1
della legge 246 del2005:
1
L'articolo 5 "Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle
imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive" della l. 246 del 2005
dispone che:
l.
Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza
legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in
materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali,
ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri
direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge
15
marzo 1997,
n.
59, e successive
modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche,
produttive e professionali interessate:
Nell'Accordo, in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo, è fissato anche l'obiettivo
di ridurre del 25%, entro il 2012, gli oneri amministrativi. A tal fine, le istituzioni si impegnano a
definire le modalità con le quali intendono individuare, misurare e ridurre i suddetti oneri.4)
sostituzione, ove possibile, delle norme prescritti ve con sistemi di incentivi e disincentivi;
b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei
tempi di conservazione degli stessi
ai
fini degli accertamenti amministrativi.
2.
Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o
concludono accordi, ai sensi dell'articolo
8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
dell'articolo 4, comma
l,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n.
281
del 1997, al
fine di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti
amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso,
comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;
b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli
adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;
c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo
svolgimento dell'attività d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle
migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli
enti locali;
d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli
adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese
artigiane;
e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle
informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese,
di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonchè a coordinarne i contenuti con i
processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;
158

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 165/194
"2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione
2
,
promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma l, del decreto legislativo 28
agosto 1997,
n.
281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del1997, al fine di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia
di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione,
di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di
impresa."
L'Italia si impegna, quindi, non soltanto ad eliminare gli ostacoli alla libertà di
stabilimento, ma anche a garantire la certezza giuridica necessaria all'effettivo
esercizio delle libertà fondamentali del trattato, così come richiesto dalla direttiva
Bolkestein, quella certezza giuridica, in pratica, che può scaturire soltanto dal
coordinamento della normazione e dell'esercizio delle funzioni.
f)
assicurare
la
rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo
31
marzo 1998, n. 112, nonchè l'estensione e lo
sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:
l)
l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e
demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire
adeguati livelli di funzionalità, nonchè il coordinamento e
la
cooperazione tra i diversi livelli di
governo;
2)
l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di
semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento,
trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, sia a fini
di
promozione
territoriale;
3)
l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli
unici;
4)
l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della
conoscenza del contesto territoriale.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per
la
finanza
pubblica, meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree
sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria
legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità
e agli obiettivi stabiliti dai commi da l a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma
l.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2
Secondo Roberto Bin, sarebbe vano cercare un preciso fondamento del principio di leale
collaborazione, perché esso affonda in strati più profondi dello stesso edificio costituzionale. Bin
R., Il principio di leale cooperazione nei rapporti tra poteri, in Riv. dir. Cost.le, 2001, 11 p. 12
159

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 166/194
A poco di più di un anno dalla scadenza del termine per l'adeguamento alla
direttiva, tuttavia, molto ancora deve essere fatto.
Per fare un esempio, la Regione Friuli Venezia Giulia, con legge regionale 20
novembre 2008
n.
13, ha recentemente innovato la disciplina per l'esercizio dei
locali pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prevedendo
indirizzi e criteri di programmazione che impassibilmente ignorano gli obblighi
della direttiva.
3
Nella circolare interpretativa
4
, gli uffici competenti hanno chiarito che "Gli
elementi di natura precipuamente economica, riferiti alla popolazione residente,
fluttuante e turistica (lettera a), alla situazione biennale delle vendite, anche per
singola zona (lettera b), e soprattutto alla promozione della competitività,
accessibilità e sostenibilità dei punti vendita allocati e da allocarsi nel territorio
comunale, di nuovo anche per singola zona (lettera d bis) sono prescritti al fine di
evitare il cosiddetto eccesso di concorrenza: sul punto,
si
pone in luce che una
3
Infatti, all'art. 69 della l.r. 29 del 2005, novellato dalla sopraindicata l.r. 13 del 2008, è previsto
che
l.
I Comuni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi del comma 2, determinano i criteri e
le condizioni relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni, anche in relazione a singole zone del
territorio e di quelli relativi al trasferimento di sede, nonche' le condizioni per l'esercizio delle
attivita' di somministrazione stagionale. Tali criteri e condizioni possono essere revisionati con
cadenza biennale.
2. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma
l,
i Comuni tengono conto
dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle
diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo,
correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi
insediamenti, per assicurare la migliore funzionalita' produttiva del servizio di somministrazione di
alimenti e bevande e il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo
l.
3. I Comuni, anche sulla base della loro suddivisione in zone, secondo le prescrizioni dei vigenti
strumenti di programmazione territoriale, rilevano in particolare:
a) la competitivita' dei pubblici esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione
alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai
servizi e ai flussi turistici tenendo anche conto di tutte le altre forme di somministrazione;
b) i livelli di accessibilita' al servizio da parte dei consumatori, tenendo conto delle caratteristiche
del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilita' di spazi pubblici o di
uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici
pubblici e privati, zone industriali e commerciali;
c) i livelli di sostenibilita' sociale e ambientale del territorio comunale, o di sue specifiche zone, in
particolare riguardo ai fattori di traffico, di inquinamento acustico, di sicurezza e di propensione al
consumo di alcol;
d) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.
4. I Comuni disciplinano le procedure di consultazione ai fini della determinazione dei criteri e
delle condizioni di cui ai commi l e 2."
4
La circolare della Direzione centrale delle attività produttive
è
la protocollo
n.
67/PROD.COMM
dell2
gennaio 2009.
160

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 167/194
consolidata giurisprudenza amministrativa qualifica il pericolo dell'eccesso di
concorrenza come l'alterazione dell'apparato distributivo, con eventuale lesione
del pubblico interesse, inteso quest'ultimo essenzialmente quale difesa del
cittadino - consumatore e mai come tutela delle rendite
di
posizione dei titolari
di
licenze già esistenti (Consiglio di Stato, sez.
V,
sentenze nn. 33411979 e
83311998; T.a.r Lombardia, MI, sez. III, sentenza n. 43711997, nonché T.a.r FVG,
sentenza
n.
511980)."
Non si può non rilevare, invece, che la più recente giurisprudenza
5
afferma
tutt'altro rispetto alla giurisprudenza citata dalla Regione che risale a più
di
dieci
anni
fa.
Infatti, la concorrenza può alimentare le migliori condizioni di fruibilità
del servizio e una più idonea e razionale organizzazione e gestione
dt:1lle
risorse,
con incremento dei posti di lavoro e aumento della sicurezza dei cittadini (cfr.
Sez. IV, ord. 30 marzo 2004, n. 1472; Sez. IV,
18
novembre 2003, n. 5076) e che
oggi la direttiva Bolkestein, all'art. 14, vieta "l'applicazione caso per caso di una
verifica di natura economica che subordina
il
rilascio dell'autorizzazione alla
prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla
valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla
valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di
programmazione economica stabiliti dall'autorità competente".
Il divieto, in sostanza, non concerne i requisiti relativi alla programmazione che
non perseguono obiettivi economici, ma sono dettati da motivi imperativi
d'interesse generale.
6
Le nuove politiche
di
semplificazione che
si
affermano a livello internazionale
(OCSE), europeo e statale coinvolgono, direttamente
le
amministrazioni regionali,
le quali, dopo la riforma del titolo
V,
sono titolari di gran parte delle competenze,
5
Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2008
n.
3875
6
Da emendamenti consolidati
18
ottobre 2005 del Parlamento europeo alla proposta di direttiva in
www
.europarl.europa.eu.
161

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 168/194
in materia di semplificazione amministrativa
7
oltre che per
la
disciplina delle
attività economiche dopo la novella del titolo V.
Inoltre, le indagini disponibili mostrano che raramente le regioni hanno sviluppato
proprie politiche di miglioramento della qualità della regolazione. Piuttosto,
hanno operato a traino delle riforme avviate dal livello statale.
E
dire che
i l
miglioramento della qualità della regolazione rappresenta uno dei principali
obiettivi dell'azione di governo della maggior parte degli stati membri
dell'Unione europea. Si tratta di un elemento essenziale per accrescere la
competitività degli Stati, riducendo barriere e costi amministrativi; tale obiettivo è
indicato nelle Conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 in materia
di Better Regulation.
La Conferenza unificata (Stato-regioni e autonomie locali) ha, comunque, recepito
le indicazioni del Consiglio europeo, siglando i l 29 marzo del 2007, l'accordo
sulla semplificazione normativa in cui sono definiti i principi comuni per
il
miglioramento della qualità e della trasparenza del sistema normativa, per
uniformare la tecnica legislativa tramite un raccordo costante tra Stato, regioni e
province. Inoltre, l'accordo, ha previsto che in conformità con le conclusioni del
7
Introdotta in via generale nell'ordinamento italiano con l'art. 20 della legge n. 59/1997, la legge
annuale di semplificazione è un'efficace arma per perseguire politiche di semplificazione, sia
normativa che amministrativa.
In
tale prospettiva, va anche detto, ad onor del vero, che
i l
nostro
ordinamento si è mosso con un certo anticipo rispetto alla maggior parte degli altri Paesi europei,
che hanno previsto leggi periodiche di semplificazione solo in tempi più recenti. L'ultima legge di
semplificazione emanata è stata, comunque, la n. 246/2005, recante "Semplificazione e riassetto
normativa per l'anno 2005". Con tale legge, ed in particolare l'art. 14, ha introdotto spunti di
innovazione sistematica di grande rilievo. E' stata, infatti, disciplinata sia l'Analisi di impatto della
regolamentazione (AIR), che la Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).Relativamente
all' AIR che molte regioni hanno già concretamente avviato sui diversi progetti di legge, c'è da dire
che
i l
progetto di miglioramento della qualità della legislazione incontra un grosso ostacolo nel
sistema di formazione delle leggi. Per fare un esempio, in Friuli Venezia Giulia, con legge 5
dicembre 2008
n.
14 è stata, all'art.
l,
introdotta una disposizione che avrebbe dovuto rimuovere
in vincoli previsti nell'ordinamento per l'impianto di nuovi distributori di carburante. Ciò era
necessario in quanto era stato già avviato
i l
procedimento di infrazione della UE nei confronti
dell'Italia per rispettare gli obblighi previsti dal diritto comunitario che non tollerano ostacoli alla
libertà di stabilimento. Lo Stato, a tale riguardo, è intervenuto un paio di mesi prima introducendo
l'articolo 83-bis, comma 17 nella legge 6 agosto 2008,
n.
133 di conversione del decreto legge 25
giugno 2008,
n.
112. Ebbene, la Commissione regionale, attraverso un emendamento al progetto di
legge, ha rinviato a giugno 2009 la decorrenza della legge. La Regione ha risolto, con un avviso di
rettifica, pubblicato sul BUR
n.
lO
dell'
11
marzo 2009, nel senso che
i l
rinvio a giugno 2009 non
riguarda
il
primo articolo della legge.
162

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 169/194
Consiglio europeo, è fissato anche l'obiettivo di ridurre del25%, entro il2012, gli
oneri amministrativi. A tal fine, le istituzioni si impegnano a definire le modalità
con le quali intendono individuare, misurare e ridurre i suddetti oneri.
2. La
triplice funzione
Si è già avuto modo di esaminare, in maniera dettagliata, quali sono gli
adempimenti al quale il dirigente tecnico, responsabile dello sportello edilizio è
tenuto ad adempiere in base al Titolo III, agibilità degli edifici, del d.P.R.
6
giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia".
In particolare, l'art. 24 comma
l
del d.P.R. 380
del2001,
nel definire la funzione
·del certificato di agibilità, stabilisce, in via generale, che esso "attesta la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto
dispone la normativa vigente". In sostanza il procedimento in questione prevede
che l'acquisizione di tutti i pareri tecnici, certificazioni o atti di assenso che dir si
voglia, deve precedere il rilascio del certificato di agibilità che ha natura
discrezionale.
E'
evidente, a tale riguardo, che l'esperienza del capoluogo lombardo che ha
anticipato di vent'anni almeno la commissione comunale di vigilanza pubblico
spettacolo rispetto il resto d'Italia dove la commissione comunale è stata
introdotta soltanto con il d.P.R. 311 del 200 l, deve essere guardata con attenzione
anche in relazione all'esperienza maturata.
Ebbene, mentre nella maggior parte dei comuni d'Italia, laddove è stata costituita,
gli adempimenti connessi alla convocazione
ed
ai lavori della commissione sono
riconducibili o al settore attività economiche o a quello della Polizia municipale,
163

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 170/194
nel Comune di Milano ed in altre rare realtà
8
,
la commissione
è
incardinata nel
settore tecnico - edilizio.
La scelta di incardinare la CVPS nel settore tecnico è di evidente coerenza, in
quanto l'agibilità di un immobile deve essere valutata sulla base dell'uso cui esso
è destinato, nel senso che è necessario domandare un nuovo certificato ogni
qualvolta l'edificio subisca un mutamento di destinazione d'uso, strutturale o
funzionale. Tenuto conto, di conseguenza, del variare delle regole tecniche di
prevenzione incendi in funzione della diversa tipologia di attività che verrà ad
essere esercitata risulta evidente che la sovrapposizione delle due agibilità quella
prevista dal testo unico per l'edilizia e quella prevista dal Tulps sono
assolutamente coincidenti.
Riguardo l'agibilità sanitaria prevista dall'art.
221
Tuls, si può ritenere che la
stessa sia da considerarsi ormai assorbita nell'una e nell'altra delle sopraindicate
agibilità edilizia e di pubblica sicurezza, in quanto come
si
ricorderà, tra i compiti
della commissione di vigilanza rientra anche "verificare le condizioni di [ ... ] di
igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute
necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni",
mentre l'articolo 25 del testo unico in materia edilizia dispone circa l'avvenuta
prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti.
In pratica
si
può anche affermare che l'attuale duplicazione dei procedimenti
previsti rispettivamente dall'articolo 80 Tulps e Titolo III del d.P.R. 380 del 2001,
viola quei principi di buon andamento della pubblica Amministrazione statuiti
dali' art.
97
Cost. in relazione al fatto che ambedue i procedimenti tutelano i
medesimi beni giuridici quello della sicurezza e quello del diritto alla salute.
Dopo la legge n. 241 del 1990, l'esercizio dissociato dei poteri che fanno capo allo
stesso ente per la realizzazione di più interessi pubblici, specie ove tra di essi
sussista un obiettivo collegamento, come è il caso dell'agibilità in esame,
si
pone
8
In Friuli Venezia Giulia, ad esempio, la commissione comunale per i pubblici spettacoli è
incardinata nei servizi tecnici al Comune di Lignano sabbiadoro.
164

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 171/194
contro il basilare criterio di ragionevolezza
e,
pertanto, in evidente contrasto con il
principio di buona arnministrazione.
9
Peraltro, si potrebbe anche propendere per una sostanziale abrogazione
dell'articolo 80 Tulps
10
in quanto le verifiche dallo stesso previste sono già
inserite in discipline speciali che, di conseguenza, dovrebbero prevalere rispetto
una norma nata nell' 800 per tutelare, genericamente, beni primari che oggi
dispongono
di
una tutela specifica.
11
E' difficile ritenere, in sostanza, che esistano reali motivazioni pratiche le quali
possano giustificare nel terzo millennio il mantenimento nell'ordinamento
di
una
disposizione elaborata alla fine dell'800 a tutela dell'incolumità pubblica. Se,
infatti, ali' epoca della redazione della norma la disposizione di cui ali' art. 80
Tulps e le relative disposizioni regolamentari, potevano trovare senso logico in
relazione alla inesistenza di una disciplina specifica e di organismi preposti alla
vigilanza
12
, oggi la situazione è completamente diversa, nel senso che esistono
9
Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2002,
n.
5656
10
L'art. 80 del Tulps si ricorda, prevede che: "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere
la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto
verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
11
Oltre alla normativa
in
materia di Certificato di prevenzione incendi, regolano specificatamente
il trattenimento e lo spettacolo viaggiante:
Decreto Ministeriale 19 agosto 1996: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo."
Decreto Dirigenziale 16 giugno 2008 "Approvazione del programma e delle modalità di
svolgimento dei corsi
di
formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività
di
spettacolo
viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma
3,
del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio
2007."
Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 "Norme
di
sicurezza per le attività di spettacolo
viaggiante."
Decreto Ministeriale 19 aprile 2005 "Disposizioni in tema dei soggetti, criteri e modalità
di
erogazione dei contributi a titolo
di
concorso per le spese di vigilanza e sicurezza
in
occasione
di
pubblici spettacoli."
Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2002, n. 293 "Regolamento di
semplificazione recante modifica all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940,
n.
635, e
successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo.
Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di in trattenimento e di pubblico spettacolo.
Circolare
31
maggio 1996,
n. 15
"Locali di pubblico spettacolo - Valori dei sovraccarichi nel
dimensionamento dei solai."
12
Ricorda V.Manzini nel Trattato di diritto penale che il codice penale del 1859, quello toscano
del 1853 e il regolamento toscano di polizia punitivas, rimasti in vigore fino al 1890, non
165

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 172/194

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 173/194
all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte
degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere
accertata e dichiarata da tecnici abilitati.
Allo stato attuale, la verifica dell'agibilità è prevista per tutti i locali in cui si
effettua attività di trattenimento o di pubblico spettacolo. Ma, nella sostanza ci si
interroga sul senso logico di sottoporre a sopralluogo per la verifica delle
condizione di sicurezza un locale le cui dimensioni contenute sono state
considerate irrilevanti nella predisposizione della regola tecnica di prevenzione
incendi.
Alla fin fine, a prescindere dai cinema, teatri, discoteche, palazzetti dello sport, in
pratica tutti quegli immobili che in relazione all'affluenza del pubblico devono
rispettare le regole tecniche predeterminate dal Ministero degli interni, la
questione in trattazione riguarda anche le migliaia di bar e ristoranti disseminati
sul territorio nazionale.
Di conseguenza, avendo ormai chiarito che l'agibilità dell'immobile riferita alla
specifica attività che si andrà ad esercitare deve opportunamente rientrare
nell'agibilità prevista dal testo unico edilizio che avrà cura di verificare il rispetto
di tutte le disposizioni di legge, regola tecnica di prevenzione incedi compresa
14
,
rimane da risolvere la questione connessa
ai
piccoli trattenimenti che si svolgono
all'interno dei pubblici esercizi.
Su questa specifica questione la dottrina tecnica e la giurisprudenza penale, fino a
quando l'art. 666 c.p. non è stato depenalizzato, sono intervenute elaborando delle
indicazioni utilizzate dalle commissioni di vigilanza pubblico spettacolo come
parametro di riferimento.
14
Il
dirigente tecnico potrebbe eventualmente integrare la commtsswne edilizia ovvero la
conferenza dei servizi di cui all'art. 141 reg.to tulps con le professionalità di volta in volta
necessarie.
167

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 174/194
Si è davanti, in pratica, ad un "relativismo storico" che porta verso risultati non
necessariamente univoci
15
•
Un esempio per comprendere il senso
di
tale
affermazione è che l'attivazione
di
un semplice piano-bar può ritenersi attività
libera, ovvero assoggettata ad autorizzazione ex art.
69
Tulps. La Prefettura
di
Modena, con propria circolare n.151 2° sett. del l febbraio 1995, intervenendo
espressamente sull'argomento a seguito
di
sollecito da parte degli uffici comunali
interessati, testualmente prevedeva: " .. .
al
fine dell'attribuzione del carattere
di
trattenimento pubblico e spettacolo ad un locale in cui vengano esercitate in
contemporanea altre attività occorre fare riferimento al criterio della prevalenza".
L'attività di piano-bar, secondo la Prefettura non deve concretizzarsi in spettacolo
o rappresentazione destinata ad un pubblico "... che vi assiste in maniera
incidentale e casuale".
Analoga problematica riguarda il cosiddetto Karaoke. Su tale apparecchio, la
giurisprudenza ha sempre assunto un orientamento particolarmente rigoroso.
Afferma infatti la Corte di Cassazione
16
proprio per meglio definire tale specifica
attività che " .. . per trattenimento si deve intendere qualsiasi riunione a scopo
di
divertimento alla quale partecipano attivamente gli intervenuti, sicchè in tale
concetto rientra anche l'attività
di
diffusione di musica con il supporto video e la
partecipazione del pubblico".
Parte della dottrina
17
,
invece, tende ad operare anche a questo proposito un
distinguo tra i l caso in cui il Karaoke sia installato in sale appositamente attrezzate
con la presenza di un animatore, che richiederebbe, in analogia con gli apparecchi
televisivi, sia l'autorizzazione ex art. 68 del Tulps, sia il collaudo del locale.
In pratica non esiste univocità
di
vedute al riguardo, con la conseguenza che non
potranno essere univoche neppure le conseguenze sanzionatorie e tale circostanza
15
Manzione A.,
In licenza di agibilità ed il certificato di prevenzione incendi: aspetti interessanti
l'attività di polizia amministrativa ed i controlli della P.M. Relazione al convegno nazionale di
Polizia locale
cit.
16
Cass, sez. 28 Ottobre 1996, in
Giust. Pen,
II, 441 ss
17
Malavasi C.,
Circoli privati e pubblici esercizi, Manuale operativo per l'attività di controllo e la
corretta gestione,
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2001, 273
168

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 175/194
non può non lasciare perplessi in relazione alla tassatività che dovrebbe
accompagnare le sanzioni previste dal codice penale.
La conclusione non può essere, quindi, che quella di privilegiare l'applicazione
dell'unica esaustiva disciplina, vale a dire la più volte indicata regola tecnica
di
prevenzione incendi. Questa disciplina, infatti, non contiene norme tecniche nel
significato già analizzato, bensì regole tecniche, nel senso di prescrizioni emanate
in tema di sicurezza dalle autorità preposte a legiferare su questa materia. Le
regole tecniche sono cogenti quando sono emesse dagli organi legislativi nazionali
ed europei, come è stato il caso della regola tecnica di prevenzione incendi
emanata il
19
agosto 1996 dal Ministro dell'interno, che ha puntualmente
individuato quali sono le attività che presuppongono la necessità del rispetto delle
regole poste al fine di garantire la sicurezza degli avventori in quanto idonee a
garantire quella protezione che il codice penale aveva voluto assicurare.
Relativamente a questo aspetto,
si
potrebbe anche affermare che l'introduzione di
regole tecniche, ovvero disposizioni prescrittive, diverse da quelle predeterminate
nella Regole tecnica di prevenzione incendi viola non solo il principio
di
tassatività in relazione all'art.
681
c.p. ma anche la Direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del
22
giugno 1998 che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche.
18
18
http://europa.eu/scadpluslleg/it/lvb/121003.htm. Procedura di informazione nel campo delle
regole tecniche:
Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni progetto di regola tecnica o di modifica di una
regola tecnica, le comunicano inoltre i motivi che lo rendono necessario e, se del caso, il testo
delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali direttamente in questione. Qualora il
progetto limiti la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza chimica per motivi di
salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche
dati pertinenti alle caratteristiche, agli effetti e i rischi del prodotto.
La Commissione comunica agli altri Stati membri il progetto notificatole. Nella stesura definitiva
della regola tecnica si terrà conto, per quanto possibile, delle osservazioni degli altri Stati membri.
Per permettere alla Commissione e agli altri Stati membri di reagire, gli Stati membri rinviano
l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione
ha ricevuto la comunicazione di cui sopra. Il periodo
di
status quo passa a quattro mesi per i
progetti aventi forma di accordo facoltativo e a sei mesi per qualsiasi altro progetto, quando gli
Stati membri e/o la Commissione formulano un parere circostanziato, secondo il quale la misura
proposta potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre qualora la
Commissione desideri proporre o adottare un atto legislativo applicabile allo stesso settore, oppure
169

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 176/194
Peraltro, si potrebbe anche sostenere che quanto non rientra nella regola tecnica di
prevenzione incendi, per volontà del legislatore rientra nell'irrilevante giuridico.
In sostanza, per i locali di trattenimento e pubblico spettacolo non potrebbero
essere imposte prescrizioni diverse da quelle contenute nella Regola tecnica di
prevenzione incendi di cui al d.m.
19
agosto 1996 "Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei
locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" pubblicata nel supplemento
ordinario della G.U. n.
14
del
12
settembre 1996.
Se così fosse, come pare, il ruolo stesso della commissione comunale
di
vigilanza
pubblico spettacolo quale organo tecnico preposto a fornire prescrizioni per
l'attività
di
trattenimento e svago, in base all'articolo 141 reg. Tulps ai fini del
rilascio della autorizzazione prevista dall'art.
68
Tulps sarebbe in contrasto con il
diritto comunitario nella parte in cui la commissione non si limitasse a far
rispettare le prescrizioni contenute nella già indicata regola tecnica del 1996 o
altre disposizioni contenute in altre fonti.
Tuttavia,
al
rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi già è
preposto altro organismo tecnico, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che,
strutturato a livello provinciale opera, proprio in riferimento alla specializzazione,
con competenza e professionalità come ben sanno le commissioni comunali
istituite che, senza eccezione alcuna, si adeguano alle relative posizioni del
Comando.
Diversa è, invece, la questione connessa alla commissione provinciale
di
vigilanza
pubblico spettacolo presieduta dal prefetto, in quanto dalla sua composizione:,
questore, dirigente medico Asl, comandante vigili del fuoco, si evince il ruolo di
se i l progetto verte su una materia che forma già oggetto di proposta da parte della Commissione,
lo Stato membro interessato deve rinviare l'adozione del progetto di dodici mesi. Qualora, entro
questo termine, il Consiglio adotti una posizione comune, il periodo di status quo
è
prorogato di
sei mesi (18 mesi in tutto).
La procedura di notifica non si applica né alle regole tecniche che costituiscono semplice
recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso
è
sufficiente una
semplice informazione alla Commissione, né alle regole nazionali che si conformano alle
specificazioni tecniche comunitarie o ad altre disposizioni del diritto comunitario.
Un quadro dettagliato delle relazioni, della giurisprudenza e delle statistiche riferite alla direttiva
in questione
è
disponibile nel sito specifico http://ec.europa.eu/enterprise/tris/about/index_it.htm
170

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 177/194
supporto che la commissione stessa può fornire al prefetto per questioni connesse
all'ordine pubblico.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenibile per la commissione
provinciale di vigilanza pubblico spettacolo, la commissione comunale è
commissione la cui operatività deve essere giustificata in riferimento nell'art. 96
"Riduzione degli organismi collegiali" del decreto legislativo 267 del 2000 il
quale prevede che annualmente devono essere individuati gli organismi
indispensabili. Infatti, la mera previsione della commissione comunale di
vigilanza pubblico spettacolo da parte del reg. Tulps non ne identifica
l'indispensabilità e, quindi, la sua legittimazione, per le motivazioni esposte.
Un intervento del legislatore nazionale finalizzato all'abrogazione
di
una
disposizione che "evoca" la tutela della sicurezza risulta, tuttavia, allo stato attuale
inimmaginabile, tenuto conto che l'attività del legislatore sta andando in tutt'altro
senso. E a poco si ritiene possano servire le conclusioni di una indagine svolta a
gennaio 2009 dalla Fondazione Cittalia-ANCI Ricerche sulla percezione della
insicurezza.
Dalla ricerca
19
, infatti, è emerso un dato, a dir poco, inatteso: "Tra ciò che il
proprio Comune deve fare per una città più sicura i residenti mettono
al
primo
posto l'esigenza di "promuovere il senso civico e il rispetto delle regole tra i
cittadini". Seguono il contrasto allo spaccio di stupefacenti, la necessità di
migliorare l'illuminazione stradale, il controllo delle bande giovanili, e
l'intervento sulla emarginazione sociale. Il tema del rispetto delle regole torna alla
ribalta quando
ai
cittadini viene chiesto cosa personalmente
si
sentono disposti a
fare per contribuire alla lotta alla criminalità e all'insicurezza. Subito dopo
l'impegno ad "avvertire le forze dell'ordine in caso di reati", viene infatti
19
L'indagine è stata condotta da SWG Publica Res mediante sondaggio con tecnica mista
CATICAWI (Computer Assisted Telephone/Web Interview),
su
un campione rappresentativo
degli universi di cittadini maggiorenni residenti in ciascuna delle 11 città metropolitane (Bari,
Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) in base a
parametri di sesso ed età. Le interviste sono state realizzate tra
i l
9 e
i l
14 gennaio 2009 in
www .cittalia.it.
171

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 178/194
l'impegno a "promuovere il rispetto delle regole e della legalità nella vita
quotidiana".
4. Una proposta di regolamento
La seguente proposta di regolamento comunale
20
è elaborata sulla base
delle considerazioni finora svolte e riconducibili alle seguenti finalità:
l.
Il regolamento viene predisposto in attuazione dell'art. 117 Cost. VI comma,
(potestà regolamentare comunale): "La potestà regolamentare spetta allo Stato
nelle materie
di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite."
21
20
Secondo Sergio Bartole, fermo restando il VI comma dell'art. 117 Cost. sarebbe opportuno per
una, seppur minima, uniformazione che i regolamenti comunali venissero adottati perlomeno a
livello provinciale. Bartole S. L'attribuzione di potestà regolamentare agli enti locali con effetti di
delegificazione
cit. Nello stesso senso Pitruzzella
G.
nell'editoriale
Quali poteri normativi
per
l'autonomia locale? Cit. secondo i l quale l'eccessiva disseminazione di poteri normativi potrebbe
costituire, in sé, una minaccia per i diritti.
21
Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del d.P.R. 616 del1977 che riconosceva la facoltà ai
comuni di determinare procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle
funzioni assegnate ai comuni, la novella del titolo V Cost. apre scenari nuovi. Tuttavia, afferma
Pitruzzella G., Quali poteri normativi per l'autonomia locale?, In "Le Regioni" n. l febbraio 2008
p. 7 a fronte del grande interesse che il tema ha suscitato in dottrina e le potenzialità insite nel VI
c. art. 117, gli enti locali hanno fatto un uso modesto o nullo della nuova competenza. Questo
motivo ha portato ad escludere una netta ripartizione di competenze ma anche ad interrogarsi sulle
condizioni per rendere effettiva l'autonomia normativa degli enti locali che potrà essere espressa
soltanto a fronte di una pre-condizione, quale quella dell'attribuzione certa di funzioni. E' il caso
trattato a proposito della sicurezza dei locali pubblici, laddove a fronte dell'attribuzione della
competenza in materia di verifica delle condizioni di sicurezza dei locali pubblici assegnata già
con il d.P.R. 61611977 i comuni pur avendo già allora la possibilità di regolamentare la funzione
non lo hanno fatto, con l'eccezione del Comune di Milano che, per esercitare il proprio diritto
ricorse al Consiglio di Stato contro la regione Lombardia e
il
Ministro dell'interno. In sostanza, il
mancato equilibrio in termini di "importanza" ovvero il timore reverenziale dei funzionari dei
piccoli comuni nei confronti del locale Comando dei vigili del fuoco, ha di fatto limitato il
contributo che la Commissione comunale avrebbe potuto fornire in termini propositivi.
Di
conseguenza, le disposizioni poste a base della verifica prevista dall'art. 80 Tulps continuano ad
essere esclusivamente quelle riferite alla prevenzione incendi e si ignorano, ad esempio, altre
problematiche connesse alla sicurezza in senso lato, quale ad esempio l'inquinamento acustico
che, invece, dovrebbe essere tenuto in considerazione, ma anche la tutela della salute. Se, infatti,
l'articolo 80 parla genericamente
di
verifica della solidità e sicurezza dell'edificio, d'altro canto la
commissione prevista dall'art.
141 reg. Tulps prevede anche la verifica dell'igiene dei locali, con
ciò presupponendo l'individuazione di competenze non esaustive ma meramente esemplificative.
172

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 179/194
2) Il regolamento determina la composizione, il funzionamento e l'attività della
conferenza dei servizi per la verifica dell'agibilità dei locali
di
pubblico
spettacolo.
3)
La scelta
di
procedere alla istituzione
di
una conferenza di servizi e non,
invece,
di
una commissione in base alle indicazioni fornite dall'art. 141 bis del
d.P.R.
311
del2001 è legata alle precise direttive contenute nell'art. l, comma 28,
della legge 53711993. (sostituzione di organi collegiali con le conferenze
di
servizi
previste dall'articolo
14
della legge 7 agosto 1990,
n.
241).
4) Il settore di intervento della conferenza di servizi per la vigilanza dei locali di
pubblico spettacolo non
è
riferito esclusivamente alle prassi consolidate delle
Commissioni provinciali precedentemente operative ed insediate presso le
prefetture, bensì viene determinato in funzione dell'accertamento del possesso dei
requisiti necessari atti a garantire la sicurezza degli utenti, già a livello edilizio,
compresa la valutazione di impatto acustico, attualmente non prevista dalla
disciplina.
5)
L'opportunità di procedere alla convocaziOne della Conferenza di servizi,
anche qualora venisse disposta l'abrogazione degli articoli 80 Tulps, e relativa
disciplina contenuta nel regolamento Tulps, è connessa anche all'elevato numero
dei comuni italiani che, per le limitate dimensioni, non dispongono
di
professionalità interne all'amministrazione comunale. Si rileva, a tale riguardo,
che l'onere per la verifica dell'agibilità in base al II comma dell'art. 80 Tulps è a
carico del richiedente.
L'attività della Conferenza istruttoria
22
, convocata ai sensi dell'art. 14 legge 241
del 1990, è esclusivamente di carattere tecnico e supporta l'attività del
22
Non
si
ritiene che l'intervento della Conferenza dei servizi assuma le caratteristiche della
Conferenza decisioria, anche se il responsabile dello sportello edilizio non potrebbe discostarsi dal
parere della Conferenza, in quanto la responsabilità e la titolarità della competenza al rilascio del
permesso
di
costruire e del certificato di agibilità rientra nelle competenze del responsabile dello
sportello edilizio. Del resto, l'art. 5 del d.P.R. 380 del 2001, testo unico
in
materia edilizia,
espressamente prevede che "Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture
ai
sensi del
Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato
173

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 180/194
responsabile dello sportello edilizia a cui spetta il compito di procedere al rilascio,
alla sospensione e all'eventuale revoca del certificato di agibilità che, come si
è
più volte evidenziato è, contrariamente a quanto originariamente previsto,
condizionato al rispetto di tutte le disposizioni normative riferite alla specifica
destinazione d'uso del locale e, quindi, si può anche affermare, delle specifiche
attività che all'interno dell'immobile vengono esercitate.
SCHEMA DI REGOLAMENTO
Visto l'art. 117, VI comma della Costituzione e la legge 5 giugno 2003
n. 131
Visto l'art. l, comma 28 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e l'art. 14 legge 7
agosto 1990
n.
241;
Visto l'art. 80 del R.d.
18
giugno 1931, n.773 e gli artt. 141 ss del R.d. 6 maggio
1940 n. 635;
Art.
l:
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento della Conferenza
dei servizi che opera per le finalità di cui all'art. 80 del Tulps (Testo unico legge
pubblica sicurezza) r.d. 18 giugno 1931 n. 773.
L'attività della Conferenza dei servizi sostituisce, nel Comune di (nome del
comune), la Commissione comunale di vigilanza di cui all'art. 141 bis del
regolamento Tulps (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931
n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) r.d. 6 maggio 1940 n. 635.
Art. 2: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI
SERVIZI.
Sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.". La questione dell'eguaglianza delle
funzioni assegnate ai Comuni, indipendentemente dalla loro dimensione, che vede
nell'associazionismo una possibilità offerta ai Comuni minori di poter esercitare in modo più
efficiente funzioni che singolarmente possono essere difficili o impossibili da esercitare, è presa
in
esame anche da Pizzetti F.,
Piccoli comuni e grandi compiti:
la
specificità italiana di fronte ai
bisogni delle società mature,
cit.,
p.
38. Sulla ragione di ritenere che, comunque, prima
di
una
conferenza decisoria
si
svolga una riunione preliminare dalle caratteristiche di una conferenza
istruttoria cfr. Talani
M.
La
conferenza dei servizi nuovi orientamenti giurisprudenziali.
Giuffrè,
Varese, 2008,
p.
51.
174

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 181/194
l.
La Conferenza dei servizi è presieduta dal dirigente o
i l
responsabile del
competente ufficio comunale preposto al rilascio del certificato di agibilità.
2. La Conferenza dei servizi, oltre al Presidente, è composta da:
a) dal Comandante dei Vigili del fuoco o un suo delegato
b) dal Comandante della Polizia municipale o un suo delegato
c) da un funzionario dell'Arpa o un suo delegato esperto in acustica
d) da un funzionario dell'Azienda per i Servizi sanitari esperto in sicurezza
e) da un tecnico esperto designato dall'Ordine degli ingegneri con riferimento alla
specifica destinazione d'uso;
t)
da un tecnico esperto in impianti termici
ed
elettrici designato dali' Ordine degli
ingegneri.
2. Qualora sia necessaria l'acquisizione di pareri o nullaosta di enti diversi da
quelli rappresentati dai componenti di cui al comma
l,
il presidente convoca gli
stessi per l'espressione del parere di competenza.
3 Il funzionamento della Conferenza istruttoria è regolato dall'art. l legge 241 del
1990.
4. Alla Conferenza prende parte un funzionario del settore tecnico, nominato dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, con funzioni di
segretario.
5. Qualora il responsabile dello sportello edilizio sia diverso dal dirigente o dal
responsabile del competente ufficio comunale, partecipa di diritto alle attività
della Conferenza.
Art. 3: ATTIVITA' DELLA CONFERENZA
l. La Conferenza dei servizi di cui all'art. 2 esprime parere:
a) circa la conformità del progetto per la realizzazione di teatri, cinema e di altri
locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, compresi i locali destinati
all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alla disciplina in
175

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 182/194

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 183/194
2.
Le convocazioni per le sedute della Conferenza sono trasmessi mediante lettera
raccomandata, fax, o via telematica, almeno cinque giorni prima dalla data della
riunione.
3. Alla convocazione
è
allegato l'ordine del giorno della seduta con l'indicazione
della data, del l'ora e del luogo in cui si tiene la riunione.
4. Le riunioni della Conferenza dei servizi, si svolgono nella sede comunale o nei
luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
5. Notizia della convocazione è inviata al richiedente il quale può far pervenire
prima della riunione, memorie e documenti.
6. Dalla data di indizione della Conferenza dei servizi, gli elaborati delle domande
all'ordine del giorno sono a disposizione per la visione da parte dei rappresentanti
degli enti convocati.
7. Su invito del Presidente della Conferenza può partecipare alla riunione, il
progettista, a fini tecnico consultivi in merito alle proposte progettuali avanzate
prima del rilascio del permesso di costruire e prima del rilascio del certificato di
agibilità.
Art. 5: FORMULAZIONE DEL PARERE
l . L'attività della conferenza dei Servizi è oggetto di verbalizzazione e si
conclude con l'espressione del parere motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge 241
del1990.
2. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti alla Conferenza dei servizi.
3.
Copia del verbale è trasmesso agli enti partecipanti.
4. Nel caso in cui un rappresentante degli enti convocati in Conferenza dei servizi
esprima parere contrario, lo stesso indica, oltre alle motivazioni, anche le
eventuali condizioni necessarie per la positiva valutazione della domanda; in tal
caso la Conferenza dei Servizi decide se richiedere eventuali modifiche al
progetto.
177

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 184/194
5. Nel caso in cui uno o più rappresentanti degli enti convocati in Conferenza dei
Servizi esprima il proprio dissenso, ma comunque si proceda alla determinazione
con esito positivo sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, le
motivazioni saranno adeguatamente argomentate.
Art. 6: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
l. Le spese per il funzionamento della Conferenza sono a carico del Comune.
2. Il compenso per i componenti esterni è pari al gettone di presenza previsto per i
componenti le commissioni consiliari; tale gettone non è dovuto nel caso in cui i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni intervengano in ragione del loro
ufficio; per tutti i componenti esterni
è
previsto il rimborso delle spese di
trasferimento, secondo i parametri in vigore, con riferimento alla sede di lavoro.
3.
E'
a carico del richiedente il pagamento dei diritti tecnici pari a (distinguere per
le diverse tipologie di accertamento)
4. Nulla è dovuto per i progetti del Comune.
Art. 7: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA VERIFICA
l. Per la verifica di cui al presente regolamento la domanda, in bollo, è corredata
dalla seguente documentazione:
a) Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dalle disposizioni tecniche
più recenti ....................................................................................
b) Relazione tecnica illustrativa l'effettiva attività che sarà esercitata
nell'immobile.
ART. 8 -Entrata in vigore
l.
Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo
Statuto.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono disapplicate, nel Comune di
Nome del Comune, le disposizioni del reg. Tulps in contrasto con il presente
regolamento.
178

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 185/194

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 186/194

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 187/194
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA
Corte Cost. 27 marzo 1987 n. 77
Corte Cost. con sentenza
15
aprile 1970
n.
56
Corte Cost. sentenza 19luglio 2005,
n.
285
Corte Cost., l ottobre 2003 n. 303
Corte Cost., 25 luglio 2001 n. 290
Cass. Pen. Sez. I, 26 settembre 2006 n. 31571
Cass. Pen. Sez. l, 7 aprile 2005 n. 13055
Cass. Pen. Sez. l, 9 febbraio 2005,
n.
8101
Cass. Pen. Sez. I, 3 maggio 2000 , n. 9542
Cass. Pen. Sez. I,
25
febbraio 1997, n. 2691
Cass. Pen. Sez. Un.
19
giugno 1996 n. 6816
Cass. Pen. Sez. III,
16
gennaio 1996,
n.
120
Cass. Pen. Sez. fer. 9 agosto 1990, in Cass. pen. 1992, 757
Cass. Sez. I,
25
maggio 1999,
n.
5056
Cass. Sez. III,
18
giugno 1996
n.
5889
Cons. Stato Sez. I, parere
12
gennaio 1979 n. 1571/78
Cons. Stato Sez. nor., parere 18 settembre 2000, n. 147
Cons. Stato, (Ad. gen.) parere 29 marzo 2001
Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 1987 n. 556 in Cons. Stato 1987, n.9
Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5656
Co ns. Stato, Sez. V,
28
giugno 2000,
n.
3639
Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2005 n. 1543
Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2008 n. 3875
Cons. Stato, Sez.V,
?luglio
2005 n. 3732
T.a.r. Calabria Reggio Calabria, 28 gennaio
1999,
n. 48
T.a.r. Campania Napoli, Sez. II, 31 maggio 2007 , n. 5890
T.a.r. Emilia Romagna Parma, Sez.
I, 26 giugno 2008, n. 326
T.a.r. Lazio, 22 settembre 2003, n. 7700
T.a.r. Lazio, Sez. II, 27luglio 1994, n. 926
T.a.r. Lombardia Brescia, 5 ottobre 2004,
n.
1150
T.a.r. Puglia Bari, Sez. II, 4 febbraio 2003, n. 489, Foro amm. TAR 2003
T.a.r. Sardegna 6 febbraio 2002 n. 115
T .a.r. Sardegna Cagliari, Sez. I,
29
settembre 2008 , n. 1794
T.a.r. Toscana Firenze, Sez. II, 16 ottobre 2008 ,
n.
2287
Trib. Massa, 6 agosto 2003 Poletti Riv. pen. 2003, 1017
Con eccezione delle citazioni a margine, la giurisprudenza è stata estratta da:
Per le sentenze della Corte costituzionale: www.giurcost.it
Per la giurisprudenza amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it
Per la giurisprudenza ordinaria: www.jurisdata.it
181

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 188/194
'l81

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 189/194
INDICE BIBLIOGRAFICO
Baldacconi A. e Nocchi E., La pratica ergonomica nella valutazione dei rischi
da
lavoro,
Ipsoa,2007
Barbuto
L.,
La potestà regolamentare delle regioni nel nuovo titolo v della
Costituzione, in www.diritto.it
Bartole S., L'attribuzione di potestà regolamentare agli enti locali con effetti di
delegificazione, atti convegno "Norme di attuazione dello statuto speciale
regionale e nuovo ruolo degli enti locali" Villa Manin - Codroipo, Maggio 2006
in www.regione.fvg.it
Bassanini F., atti convegno "Le riforme amministrative a dieci anni dalla riforma
Bassanini", Roma, Gennaio 2008, in www.astrid on line.it
Bassanini F. Paparo
S.
e Tiberi G., Qualità della regolazione: una risorsa per
competere,
in Astrid Rassegna
n.
11, 2005, in www.astrid on line.it
Bassanini F. Torchia
L.,
Sviluppo e declino. Il ruolo delle istituzioni per
la
competitività del paese, Passigli, Firenze 2005
Benedetti A., Certificato di agibilità. nuove norme e procedure, in Geopunto
bimestrale del collegio dei geometri di Roma
n. l,
Maggio 2004
Bin R., Il principio di leale cooperazione nei rapporti tra poteri, in Riv. Dir.
cast. le, 200
l, 11
Bitetto A., Problemi interpretativi e applicativi in tema di liberalizzazione del
commercio. in www.astrid-online.it
Borri D., Lessico urbanistico, Dedalo, Bari, 1985
Bruno A.,
Codice Penale del Regno d'Italia, illustrato con
le
principali decisioni
delle corti del regno (a cura di), XII Ed. Barbera Editore, Firenze, 1927
Caringella F. Delpino
L.
Giudice (del), F. Manuale di diritto amministrativo XXII
Ed., Simone, Napoli, 2005
Cariala A., voce Pubblica Amministrazione (Principi Cast.), in Il Diritto
Enc.giurid. Vol 12,
Il
Sole 24 Ore Spa Pirola, Bergamo, 2008
Casetta E.,
Manuale di diritto amministrativo, Giuffre', Varese 2007
Cerulli Irelli V. Narducci R., L'autonomia normativa degli enti locali, Cap.II
Statuti e regolamenti per gli enti locali: un contributo per l'attuazione della
nuova potestà normativa dell 'ente locale, in www.statuti.anci.it
Dapas.
A.
Giadrossi
A
Viola L.,
Snellimento dell'attività amministrativa e
riforma dell'ente locale, Giappichelli, Torino 1998
De Lise P., Potestà regolamentare dello stato, delle regioni e delle autonomie
locali dopo il Titolo V: riflessi sulla giurisdizione amministrativa e sulla
funzione consultiva del Consiglio di stato, Studi e contributi, in www.giustizia-
amministrati va i
De Martin G. L'autonomia normativa degli enti locali nel pensiero di Aldo M.
Sandulli, in www .amministrazioneincammino.luiss.it
Depuro G., La delegificazione, qualità della regolazione, coord. da A. Natalini e
G. Tiberi, in www.astrid-online.it
Desideri C., Lo sviluppo economico locale. Verso una nuova materia regionale?
In Rapporti su regioni e attività produttive, in www.issirfa.cnr.it
183

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 190/194
Donolato F. e Bombi M.,
La vendita e la somministrazione degli alcolici
luglio
2008, in www.astrid-online
Falcon G., L'autonomia amministrativa e regolamentare, in "Le Regioni", 2-3, Il
Mulino, Bologna, 2004
Felici M., La ripartizione delle competenze amministrative tra regioni, province,
comuni, Isae "Rapporto annuale sull'attuazione del federalismo", 2004
Foderino D., Il Parere dell'Asl e dei
W.F.
ai fini dell'agibilità In "Consulente
Immobiliare Sole 24 Ore", www.ilsole24ore.com
Gargiulo R., Nota a margine della sentenza Cass. Pen., Sez. III, 16 Gennaio 1996,
N. 120, in Cass. Pen. 1996, 9
Guastini R., Il Diritto come linguaggio lezioni, Giappichelli, Torino, 2001
Leoni B., La libertà e la legge, II rist, Liberilibri, Macerata, 1995
Malavasi C.,
Circoli privati e pubblici esercizi, manuale operativo
per
l'attività di
controllo e la corretta gestione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2001
Manzini V.,
Trattato diritto penale italiano,
Vol. 10, Utet, Torino 1986
Manzione A., La licenza di agibilità ed il certificato di prevenzione incendi:
aspetti interessanti l'attività di polizia amministrativa ed i controlli della P.M.
Atti convegno nazionale
di
Polizia locale, Riccione, Settembre 2005
Merloni F., Riflessioni sull'autonomia normativa degli enti locali, in Le
Regioni", n. l Febbraio 2008
Musolino S., I rapporti stato-regioni nel nuovo Titolo V Giuffrè, Varese, 2007
Ocse (1997), Oecd Report on regulatory reform, Parigi. in www.agcom.it
Oliveri L., I controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del testo unico sulla
documentazione amministrativa, in www lexitalia.it
Pajno A.,
La
"Sicurezza urbana" tra poteri impliciti e inflazione normativa
In
Astrid Rassegna n. 86 Febbraio 2009, in www.astrid-online.it
Pappalardo N., Commento al testo unico delle leggi sanitarie, Editrice Torinese,
Torino, 1935
Pitruzzella G., Quali poteri normativi
per
l'autonomia locale?, in Le Regioni" n.
l Febbraio 2008
Pizzetti F., Commento art. 4 legge La Loggia In C.Cittadino (A Cura Di) Legge
"La Loggia" commento alla
l.
5 Giugno 2003
N.
131 di attuazione del Titolo V
della Costituzione, Maggioli, San Marino 2003
Pizzetti F., Piccoli comuni e grandi compiti: la specificità italiana di fronte ai
bisogni delle società mature
In Formiconi D.(a cura di),
Comuni, insieme,
più
forti, Edk, Rimini, 2008
Razzano G.,
Le
fonti del diritto e
il
principio di sussidiarietà
nel
quadro dei più
recenti interventi legislativiper la «semplificazione», in Dir. Amm. 2001, 2-3
Rolla G., L'autonomia costituzionale delle comunità territoriali. Tendenze e
problemi, In Groppi T. (a cura di), Principio di autonomia e forma dello stato,
Giappichelli, Torino, 1998 15 Ss.
Romeo G., Locali di pubblico spettacolo, II Ed. Maggioli, Repubblica di San
Marino, 2002
Rota G. L. e Rusconi G.,
Edilizia. Urbanistica. Governo Del Territorio,
(a cura
di) Utet, Torino 2006
184

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 191/194
Rubertis (de) N.,
La legislazione di pubblica sicurezza,
IV Ed., Noccioli, Firenze,
1987
Scasserra M., I regolamenti governativi di delegificazione: limiti di applicabilità
alle regioni e alle province autonome prima e dopo
la
legge costituzionale
n.
3
del 2001 (sentenze
n.
302/2003 e
n.
303/2003 della Corte costituzionale),
in
www
.diritto.it
Verrienti L., voce
Regolamenti e potere normativa degli enti locali,
in
Dig. It.,
vol. XIII, Utet, 1997
185

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 192/194

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 193/194
A nessuno piacciono gli ordini arbitrari da parte
di re, funzionari statali, dittatori e così via.
Ma
la legi-
slazione non è l'alternativa appropriata all'arbitrio, per-
ché l arbitrio può essere ed è effettivamente esercitato,
in molti casi, con l'aiuto di regole scritte che la gente
deve sopportare, poiché nessuno eccetto un manipolo di
legislatori, partecipa a loro processo di formazione.
Bruno Leoni (La libertà e la legge)

8/11/2019 115127
http://slidepdf.com/reader/full/115127 194/194