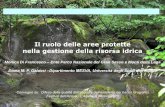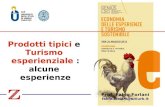Valorizzazione economica di una risorsa culturale esperienziale
-
Upload
mara-passuello -
Category
Government & Nonprofit
-
view
230 -
download
2
Transcript of Valorizzazione economica di una risorsa culturale esperienziale

Master World Natural Heritage
Management
3 ed.
Verifica conclusiva
Traccia 2
A partire da una breve presentazione della letteratura economica utile a
sostenere le vostre argomentazioni descrivete gli elementi principali alla
base della valorizzazione, dal punto di vista economico, di una risorsa
culturale a vostra scelta.
Allievo:
Passuello Mara

Mara Passuello World Natural Heritage Management 2015 Traccia 2
1
Inquadramento generale:
economia e cultura, un connubio recente
Fino alla prima metà del novecento non accadeva spesso di associare la parola “economia” a quella di “cultura”; è proprio dagli anni sessanta in poi che compaiono le prime pubblicazioni e con il libro Performing Arts: The Economic Dilemma, pubblicato nel 1966 a cura di due economisti americani William J. Baumol e William G. Bowen, partono gli studi su una possibile associazione tra le attività economiche e l’ambiente culturale in cui esse si manifestano.
L’ economia della cultura diventerà a tutti gli effetti disciplina economica solo nel 1994, anno di pubblicazione sul Journal of Economic Literature dell’articolo The Production and Consuption of the Arts A View of Cultural Economics di David Throsby, economista australiano; egli afferma che la «visione economica della cultura accetta semplicemente come un dato di fatto che le attività di produzione e consumo di beni e servizi culturali all’interno di un sistema economico comportino transazioni economiche, che queste attività possano essere raggruppate in qualche modo e che tutto ciò possa chiamarsi industria e possa essere analizzato come tale».
L’entrata della cultura nella sfera dell’economia è avvenuta non senza alimentare dibattiti e nutrire studi dedicati a stabilire una metodologia adeguata nella misurazione, in termini economici, del valore dei beni culturali oppure le funzioni di Stato, enti locali e privati in tema di finanziamenti o l’apparato legislativo necessario a regolamentare questo nuovo fenomeno e così via…
Scrive Giovanna Segre, in una pubblicazione di EyesReg Giornale di scienze regionali, che si identificano tre correnti di pensiero principali:
- un primo modello più tradizionale avvicina beni e attività culturali ad un bene pubblico e come tale destinatario di finanziamenti pubblici a prescindere dalla domanda di consumo di beni culturali da parte della comunità e tralasciando completamente le esternalità positive che ne derivano; l’avvicinare il bene e l’attività culturale ad un bene pubblico rinforza la tesi del finanziamento pubblico in quanto le caratteristiche tipiche di assenza di rivalità e non-escludibilità rendono difficile trarne profitto e, di conseguenza, l’autofinanziamento;
- il secondo modello, all’opposto, presuppone l’esistenza di vere e proprie industrie culturali che creano e distribuiscono secondo le regole di mercato, e i cui prodotti riportano le caratteristiche di un bene privato, che plausibilmente crea profitto in virtù dei principi di rivalità e ed escludibilità. L’intervento dello Stato in questo caso è escluso;
- da ultimo il più recente dei modelli, che vede principalmente nel ruolo della cultura per la crescita economica « un motore attraverso il quale perseguire uno sviluppo di livello qualitativamente più elevato».
A questo punto ben si colloca la distinzione riportata da Throsby in Economics and Culture tra Valore culturale e Capitale culturale: quest’ultimo risulta essere l’unione del valore culturale e di quello economico delle risorse culturali di cui è composto e ha a che fare col valore storico, ma anche sociale e prettamente estetico dei beni. Il capitale culturale indica come sia le risorse culturali tangibili, dotate quindi di un proprio valore economico derivante anche banalmente dallo scambio, sia quelle intangibili possano dare vita a benefici per la società.
La società d’altronde, nei tempi recenti, alla ricerca del prezzo concorrenziale sostituisce la ricerca di qualità, demandando i benefici ad una sfera simbolica ed esperienziale.
«Oggi» afferma Michele Tamma nel paper Prodotti culturali e territori: l’immateriale che “vive” nella materialità «si crea valore certamente attraverso processi in cui “risorse materiali (macchine, risorse naturali, energia manipolatrice del lavoro) si convertono in beni materiali (prodotti finiti), ma anche, in misura crescente, attraverso attività in cui la componente “immateriale” (conoscenza, informazione, significati, relazioni), sia dei prodotti che dei processi, risulta critica e prevalente».
In questo contesto si identificano prodotti di risorse culturali intangibili le idee, la creatività e l’innovazione che attraverso lo scambio e il dialogo fanno da driver ad uno dei benefici per la comunità più complesso e completo che è la qualità sociale. Ne Il governo della cultura Walter Santagata identifica la qualità sociale come «la misura in cui le persone sono capaci di partecipare attivamente alla vita sociale, economica e culturale e allo sviluppo delle loro comunità, in condizioni che migliorano il benessere collettivo e il potenziale individuale».

Mara Passuello World Natural Heritage Management 2015 Traccia 2
2
Secondo la European Foundation on Social Quality la qualità sociale può essere sviluppata attraverso diversi aspetti che caratterizzano la vita in comunità, partendo dall’inclusione sociale e quindi la partecipazione attiva all’interno del gruppo, il grado di autonomia e sicurezza dell’individuo, frutto dell’accesso al mercato del lavoro e ai servizi di base del vivere comune, la condizione di benessere fisico e ambientale e da ultimo la situazione favorevole all’empowerment ( inteso come realizzazione e crescita personale, culturale e professionale).
Appare chiaro come venga abbandonata progressivamente la concezione dell’arte per l’arte, a fronte di affidare alla cultura una funzione personale e sociale ben precisa e intrisa di aspettative, quale strumento di coesione e moltiplicatore di capitale umano da mettere a sistema per uno sviluppo sostenibile nella comunità ma anche nella società.
Questo lavoro mira a raccogliere e riportare le esternalità positive, di tipo economico ma anche qualitativo, generate da experience goods, in particolare festival tematici e manifestazioni ideate e realizzate a partire da collaborazioni tra pubblico, privato ed associazioni culturali e fruite gratuitamente dalla comunità. Verrà in particolare analizzato, anche attraverso un esempio esplicativo, il concetto di beni culturali esperienziali ed esaminato l’effetto economico da questi indotto senza essere registrato dal mercato attraverso il meccanismo del prezzo.
I festival di approfondimento culturale:
un bene esperienziale gratuito come risorsa culturale
Esiste una classe di beni e servizi culturali che possono essere definiti experience goods, per i quali la soddisfazione del consumatore dipende in parte da un background di esperienza pregressa, altresì conoscenza ed istruzione, e non può essere stabilita con sicurezza a priori. Per questo tipo di consumi culturali l’utilità marginale (cioè la soddisfazione generata dal consumo di unità addizionali del bene) aumenta all’aumentare delle quantità di bene consumate: maggiore si attesta l’uso di queste attività culturali, crescente sarà di conseguenza la domanda di queste attività [Campolo 2013].
Da un punto di vista personale l’esperienza coinvolge diversi fattori, partendo banalmente dal prodotto offerto, il luogo, il momento specifico, che insieme costituiscono il contesto, e che si mischiano in maniera permeabile con le emozioni e le esperienze passate dell’individuo. La centralità del soggetto è fondamentale per un bene esperienziale e si traduce, ad esperienza conclusa, in memoria e racconto.
Progettare e realizzare un’esperienza positiva significa rendere fruibili servizi e contenuti andando a sollecitare recettori simbolici ed emozionali nel pubblico, evocando immagini profonde e offrendo un’esperienza unica, appassionante e che crei dipendenza.
L’experience good su cui si focalizza l’attenzione è quello del festival di approfondimento culturale: quell’evento culturale in cui il pubblico cerca l’approfondimento insieme al valore esperienziale e alla trasmissione del sapere, caratterizzato da un periodo temporale finito e definito, luogo e tema [Cogoli 2008].
Simili manifestazioni hanno avuto una crescita esponenziale negli ultimi 10 anni in Italia (si parla secondo certe stime di 1600 mostre circa e oltre 1200 festival l’anno), seppur con un certo ritardo rispetto al resto d’Europa, e questo spostamento di interesse dai “beni” alle “attività” e dal “patrimonio” agli “eventi culturali” è gravido di conseguenze, nel sociale e nell’economico, che rimangono tuttavia ancora di difficile stima e quantificazione vista la relativa giovinezza del fenomeno.
1.Sistema produttivo collegato al fenomeno culturale
Secondo l’interpretazione di Maurizio Rispoli in Strumenti e concetti per l’analisi economico-gestionale dell’industria culturale l’industria culturale viene paragonata ad un macrosettore, ovvero ad un insieme ampio cui appartengono tutte le attività produttive, siano esse singole produzioni culturali e/o attori singoli e collettivi, organizzati in sottinsiemi produttivi a seconda del settore specifico. Ciò che li accomuna è perciò l’obiettivo identificabile con la produzione e diffusione di contenuti culturali diversificati ma comunque intesi a rendere fruibile quello che Francesco de Cesare chiama ring culturale (terreno di sviluppo e area di riferimento) [de Cesare 2010].

Mara Passuello World Natural Heritage Management 2015 Traccia 2
3
Possono essere raccolti tre fronti di impegno principali riscontrabili (o che dovrebbero esserlo) nell’attività delle organizzazioni culturali e tali sono l’eccellenza e l’integrità estetica, l’accessibilità e lo sviluppo dell’audience e l’efficienza nell’uso delle risorse a disposizione (che si traduce nel comportamento responsabile nei confronti degli stakeholders) [Chong 2002].
Per quanto riguarda l’eccellenza e l’integrità il focus è posto direttamente sull’impatto (positivo) del prodotto culturale sulla qualità sociale, inteso come la ricerca delle organizzazioni di offrire esperienze di valore e alta qualità, volte all’eccellenza e orientate a favorire lo scambio di idee e opinioni e la diffusione di conoscenza.
Dal punto di vista dell’accessibilità e dell’audience, l’obiettivo principale è la ricognizione della maggior quantità di pubblico lavorando su più fronti; se da un lato le proposte devono essere comprensibili e raggiungibili, dall’ altro è opportuno dotare il consumatore di strumenti cognitivi adeguati a comprendere l’esperienza in atto (accompagnandolo nelle fasi di pre e post fruizione). Fondamentale è anche la fase della comunicazione anche se, come spiegato da Walter Santagata in Economia della cultura la memoria e il racconto (sopra citati) sono driver importanti nei beni esperienziali di marketing sotto forma di passaparola e fidelizzazione che si traduce nella contemporaneità nei fenomeni di “partecipazione ad eventi” e “tag” georeferenziati sui social network.
Il rapporto con le risorse a disposizione, da ultimo, è fortemente influenzato da diversi fattori, quali ad esempio l’attenzione posta dalle organizzazioni culturali al tema del finanziamento e quindi della rendita economica finale (in quanto tema centrale o marginale), oppure la dimensione territoriale dell’azione oppure ancora la natura dell’organizzazione culturale, in quanto esclusivamente volta alla produzione di contenuti, alla diffusione o a entrambi, come nel caso analizzato di festival di approfondimento culturale.
2.Gestione e risultati di una produzione culturale
Nell’ambito della produzione di un evento culturale o festival si possono individuare tre principali dimensioni per la valutazione del prodotto offerto e sulla base delle quali orientarne le strategie di gestione; tali dimensioni riguardano, in accordo con la letteratura, la stima del valore culturale del prodotto, la quantificazione della domanda astratta e l’esame delle ricadute sul territorio generate da tali attività culturali [de Cesare 2010].
Per quanto riguarda la stima del valore del prodotto è opportuno identificare il focus dell’azione che, nel caso di un festival ad approfondimento culturale, è dedicato al valore didattico dell’esperienza e al grado di avvicinamento che si riesce a stabilire nei confronti di una determinata tematica o disciplina. A questo punto, a livello organizzativo è imperante mettere a punto una strategia di engagement ovvero, come già detto, un sistema di coinvolgimento del fruitore ex ante ed ex post l’esperienza atto a determinare quei fenomeni benigni di fidelizzazione, passaparola (e quindi marketing gratuito) e la messa a punto di una piattaforma per raccogliere spunti e critiche costruttive.
Quantificare la domanda per un prodotto culturale di tipo esperienziale per lo più gratuito, non è facile a priori, tuttavia rimane il fatto che il successo del prodotto è indiscutibilmente legato alla quantità di fruitori, perciò all’audience. L’impegno a far salire l’audience può essere portato avanti, in questi contesti di offerta, sia attraverso il broadening («trying to bring serious art to more people») che attraverso il deepening («developing a more coherent experience to those who are already interested in the arts») [Chong 2002].
Ancora una volta centrale è l’aspetto di comunicazione: il messaggio promozionale dovrà essere efficace e chiaro, di facile comprensione (proprio per l’obiettivo di broadening) e aspetto chiave sarà l’utilizzo contemporaneo di più strumenti di promozione (online/below the line). Il prodotto dovrà essere di semplice reperibilità per non escludere fasce di pubblico meno agiate ma che ricadono nell’obiettivo di deepening; nel caso specifico di eventi gratuiti il prezzo del biglietto non costituisce un problema, piuttosto è opportuno concentrarsi su tutti gli aspetti di reperibilità del prodotto (orario, location, modalità di fruizione ecc…).
Da ultimo, ma argomento centrale, è il ventaglio di ricadute (positive) sul territorio che le ospita; nonostante sia già stata affrontato il tema della difficoltà di valutazioni precise ex ante per un bene esperienziale, è opportuno anche ammettere la necessità di stime ex ante sulla base di modelli economici e strumenti scientifici recenti, quanto meno per andare incontro alle aspettative di eventuali (che per eventi gratuiti diventano indispensabili) stakeholders territoriali e finanziatori.
Possono essere raggruppate le ricadute territoriali in due macro-gruppi:

Mara Passuello World Natural Heritage Management 2015 Traccia 2
4
- Socioculturali, le quali raggruppano gli impatti sulla comunità a livello di opportunità di svago, crescita ed approfondimento, ma anche di socializzazione ed incontro; in una parola l’incremento di qualità sociale per la comunità.
- Economiche ed occupazionali; nel caso di eventi gratuiti le ricadute economiche immediate sono da ricercarsi nell’immediato nelle attività commerciali trasversali di supporto all’evento beneficiate dall’attrazione di un pubblico che altrimenti non si concentrerebbe in quel territorio, proveniente spesso da minori centri limitrofi; con una visione un po’ più a lungo raggio, benefici economici sono da ritrovarsi ad esempio nell’opportunità di creare una fidelizzazione che vada oltre l’evento, nella quotidianità, nei confronti dell’offerta culturale dell’organizzazione in questione attraverso ad esempio membership card e partecipazione ad incontri o corsi a pagamento. È impensabile infine non citare l’attrazione di giovani ragazzi verso determinate discipline tanto da incoraggiare in loro la scelta di una formazione universitaria in campo artistico, che possa anche beneficiare all’attrattività di talenti nel territorio e nelle Università locali. Dal punto di vista occupazionale, accanto alla costruzione di nuove professionalità attraverso la formazione sono da annoverare le ricerche di personale per sopperire alle necessità di forza lavoro a seguito di un ingente attività delle imprese coinvolte: necessità che verosimilmente verrà soddisfatta nel territorio. Da ultimo, vanno menzionate le ricadute economiche positive derivanti da una maggior visibilità del territorio garantita dalla risonanza di un evento ben riuscito, tra cui si riportano la crescente attrattività turistica e tutti gli effetti derivanti da un’immagine del territorio esaltata.
3.Relazioni tra stakeholder, amministrazioni pubbliche e organizzazioni culturali
Data la varietà degli eventi culturali e la non specificità con cui finora è stato trattato il problema è difficile mettere a punto un elenco universalmente valido di attori coinvolti nell’offerta di un prodotto culturale attraverso un festival tematico. Verrà presentata di seguito una coincisa panoramica, per esigenze di brevità, partendo dalla figura del fruitore dell’offerta che detiene all’unanimità una posizione di primo piano dal momento che il risultato della produzione culturale dipende da essi. Come già detto, è quindi importante la concentrazione delle organizzazioni sulla figura del fruitore prima, durante e dopo l’esperienza che ne vede i protagonisti.
Un secondo attore fondamentale è la produzione artistica, su cui non mi soffermo a causa della generalità dell’approccio allo studio.
È inoltre opportuno menzionare tutte le professionalità specifiche coinvolte nella realizzazione pratica dell’evento, che vanno dall’ambito artistico (galleristi, curatori, esperi di settore ecc.) a quello tecnico (impiantisti, tecnici luci, audio ecc.) e per completezza tutte le attività commerciali trasversali e il sistema istruzione.
A questo punto entra in campo la sfera dei finanziamenti esterni che, nel caso di un evento gratuito, risultano necessari e possono provenire dall’ambito pubblico e da quello privato. In primis vengono citati quelli che vengono definiti donor o patron, ovvero quei privati che decidono di contribuire alla realizzazione di una manifestazione culturale in cambio di vantaggi sociali (inviti a inaugurazioni o altro) o spinti da dovere morale. In epoca moderna sono stati istituiti veri e propri incentivi attraverso membership programs alla partecipazione come donor.
Differenti sono gli obiettivi riconducibili alla partecipazione di aziende in qualità di sponsor ; se da un lato è chiaro come questo investimento venga sfruttato come costo di pubblicità, promozione e visibilità sull’onda di offerte culturali ritenute particolarmente competitive, dall’altro possono essere individuati diversi altri benefici quali la creazione e il rafforzamento del network con altri stakeholders partecipanti al prodotto culturale o ancora finalità di rent-seeking , mirando ad agevolazioni fiscali ed impositive o più semplicemente volte ad ottenere e fornire benefit non economici ai manager dell’azienda in questione.
Altro importante attore all’interno dei finanziatori è la pubblica amministrazione che interviene come patrocinatore, sostenitore e regolatore beneficiando di tutto quanto menzionato al sotto-capitolo precedente.
Da ultimo, infine, si cita la fruttuosa e consigliata collaborazione con altre organizzazioni culturali operanti sul territorio, con lo scopo principale di networking al fine di garantire un offerta culturale più ampia e completa e chiaramente più produttiva su tutti i fronti.

Mara Passuello World Natural Heritage Management 2015 Traccia 2
5
Caso studio: PIAZZA MAGGIORE, PROIEZIONI GRATUITE
Festival di approfondimento cinematografico estivo nella Città di Bologna
É un’avventura partita nel 2009 dal nome “Sotto le stelle del cinema” quella della Cineteca di Bologna,
sorta nel 1963 e divenuta poi nel 2012 Fondazione, con lo scopo di offrire alla comunità «una presenza
sempre più propositiva e significativa nel campo della cultura cinematografica».
Da anni si impegna nelle funzioni di conservazione archivistica e di restauro, di promozione e diffusione
del cinema e dell'audiovisivo, di formazione, di ricerca e di produzione editoriale nel terreno fertile di
una città aperta alla sperimentazione e all’approdo di migliaia di studenti l’anno e si dispone da sempre
pronta ad arricchirsi, giorno per giorno, grazie al rapporto di vicinanza e stretta collaborazione con il
museo d’arte moderna MAMBO e gli spazi universitari del DMS e di Scienze della Comunicazione.
La manifestazione prevede la proiezione gratuita di classici della cinematografia italiana e
internazionale, seguendo un filone ben preciso identificato dal team artistico della cineteca. L’evento è
spalmato su diverse sere del periodo estivo (la prima edizione del 2009 contava 20 serate per tre filoni
tematici nel mese di luglio fino ad arrivare all’ultima edizione, in corso, che conta 52 serate, divise tra
diversi filoni tematici e spazi riservati agli inediti e ai concorsi, tra giugno, luglio e agosto) e si tiene nella
magnifica, pacifica e calda Piazza Maggiore (o Piazza Grande), dove rimane installato uno schermo e
un impianto di riproduzione audio e video per l’intera durata del percorso e vengono disposte sedie che
alla fine si rivelano sempre in numero insufficiente, data l’affluenza sempre maggiore ogni anno (cosa
che crea un’atmosfera ancora migliore alla vista di centinaia di persone sedute per terra o ai tavolini dei
bar antistanti la piazza o che assistono beati dai propri balconi).
L’Edizione del 2015, come detto, si estende fino ad agosto, organizza l’offerta in 52 serate suddivise tra
diversi percorsi a tema quali:
- “Cinema ritrovato”: una raccolta di grandi classici internazionali, rarissimi film in prestito dagli
archivi di tutto il mondo o addirittura film muti, riportati in vita grazie ai recenti restauri di pellicola.
- “Sotto le stelle del cinema”: serate all’insegna del grande cinema classico e contemporaneo
facendo omaggio ogni anno ai cineasti più famosi.
- “Nuovelle vague”: in anteprima quest’anno verranno ripercorsi i passi di un movimento
innovativo ed impetuoso attraverso la guida delle pellicole di Truffault.
Il valore aggiunto di questa offerta di approfondimento cinematografico è l’esperienza dello spettatore
resa completa dall’introduzione, e dal forum a proiezione terminata, da parte di artisti del calibro di
Giuseppe Tornatore, Helen Argo, Alice Rohrwacher, Pif, Tatti Sanguineti ecc…
Un’ulteriore importante menzione va ai concorsi cinematografici amatoriali e per ragazzi che si sono
moltiplicati nel giro di questi 6 anni; per citarne solo alcuni il Premio Pier Paolo Pasolini 2015 della
Fondazione cineteca di Bologna, il Premio Wired in collaborazione con la Facoltà di Scienze della
Comunicazione, il Concorso AIL per videomaker per la realizzazione di un cortometraggio di
sensibilizzazione in collaborazione con la cineteca e l’Università di Bologna…
Se da un lato l’avvicinamento alla cultura del cinema ha prodotto la nascita di numerose iniziative
invernali e rassegne largamente apprezzate e di successo grazie al numero sempre maggiore di
tesserati Cineclub e Sostenitori Cineteca (che hanno permesso ad esempio, grazie al sostegno
economico, il restauro di numerose pellicole) dall’altro ha fatto nascere in numerosi giovani, attraverso
appunto contest amatoriali e la gratuità dell’esperienza, l’apprezzamento per l’ambito di cineproduzione
con un conseguente aumento delle iscrizioni all’ Accademia del cinema di Bologna, al corso di Laurea
DAMS (musica arte e spettacolo) e alla Scuola Organica Rosencrantz & Guildenstern.
Da ultimo va detto come l’asset di sponsor e collaborazioni che hanno affiancato la produzione e la
gestione della Cineteca di Bologna, la coordinazione del Comune di Bologna e i contributi istituzionali
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema e della Regione Emilia-
Romagna – Assessorato alla Cultura sia andato aumentando vistosamente negli anni, sintomo di come
la manifestazione abbia raggiunto un successo condiviso; si citano i principali e continuativi : Gruppo
HERA (main sponsor), Fondazione Carisbo e Fondazione del Monte, Unipol Banca, Lega Coop, CNA,
Groupama Assicurazioni, Camst, Aeroporto G. Marconi di Bologna, Mare Termale Bolognese, Pelliconi,

Mara Passuello World Natural Heritage Management 2015 Traccia 2
6
Ascom Bologna, Ordine degli Ingegneri di Bologna, Ottica Garagnani, WP, Divinis, in collaborazione
con Alliance Française, Gaumont, SIAE, Molbil1, BluVanti, Incredible!ndia, Istituto Giapponese di
Cultura, Ambasciata di Svezia, Finnish Film Foundation, Bologna Welcome, Librerie.Coop
Ambasciatori, Cotabo, Tper, Hotel Cappello Rosso e con le sponsorizzazioni tecniche di Publierre e
Ferretti Impianti.


Bibliografia
Articoli
Campolo, Daniele, Il Bene Culturale come risorsa economica: aspetti metodologici
disponibile al sito web
https://www.academia.edu/6385606/_Il_Bene_Culturale_come_risorsa_economica_aspetti_metodologici_
Censis Fondazione, Centro studi, Lo spettacolo in Italia come risorsa socioeconomica e culturale
disponibile al sito web http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/component/docman/doc_details/282-lo-
spettacolo-in-italia-come-risorsa-socioeconomic-e-culturale?tmpl=component&Itemid=562
Franch, Mariangela, Le frontiere manageriali per la valorizzazione della cultura e dell’arte
disponibile al sito web www.sinergiejournal.it/rivista/index.php/sinergie/article/viewFile/.../343
Granelli, Andrea, Le risorse del patrimonio culturale e la loro valorizzazione
disponibile al sito web http://www.agranelli.net/DIR_rassegna/pres_berio.pdf
Guerzoni, Guido, Effettofestival. L’impatto economico dei festival di approfondimento culturale
disponibile al sito web http://www.efa-aef.eu/newpublic/upload/efadoc/11/effetto_festival_def2008.pdf
Mibac, Ufficio Studi, Il Patrimonio Culturale. Dalla creatività alla produzione di cultura
disponibile al sito web
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1262948677218_CAP._12_Patrimonio_Culturale.pdf
Rotino, Sergio, Il 2015 è sotto le stelle del cinema
disponibile al sito web
http://www.bolognacult.it/cinema/35-cinema/820-sotto-le-stelle-cinema-2015-programma-piazza-maggiore.html
Segre, Giovanna, Economia della cultura: facciamo il punto
disponibile al sito web
http://www.eyesreg.it/2011/economia-della-cultura-facciamo-il-punto/ Tamma, Michele, Prodotti culturali e territori: l’immateriale che “vive” nella materialità
disponibile al sito web www.sinergiejournal.it/rivista/index.php/sinergie/article/download/.../340

Libri
Caroli, Matteo Il marketing per la gestione competitiva del territorio, Franco Angeli, Milano 2014
Chong, Derrick, Arts Management, Routledge, London, 2002
Morelli, Ugo e De Fino, Gabriella, Management dell’arte e della cultura, Franco Angeli, Milano 2010
Rispoli, Maurizio, Sviluppo dell’impresa e analisi strategica, il Mulino, Bologna, 2002
Sacco, Pier Luigi e Tavano B., Giorgio, Distretto culturale in aree urbane in Economia della cultura, 2, 2005
Santagata, Walter, Il governo della cultura, il Mulino, Bologna 2014
Santagata, Walter, Libro bianco sulla creatività, Università Bocconi, Milano, 2009
Throsby, David, Economics and culture, Cambridge University press, Cambridge 2001