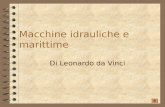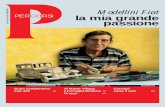Storia di Fileno. Un alter ego mariniano tra le «Rime marittime» e l’«Adone»
-
Upload
notabersano -
Category
Documents
-
view
1.925 -
download
2
description
Transcript of Storia di Fileno. Un alter ego mariniano tra le «Rime marittime» e l’«Adone»
UNIVERSIT DEGLI STUDI DI TORINO
Facolt di Lettere e Filosofia Corso di laurea in Lettere Moderne
Tesi di laurea
Storia di Fileno Un alter ego mariniano tra le Rime marittime e lAdone
Relatore Chiar.ma Prof.ssa Luisella Giachino
Laureando Daniele Bersano
ANNO ACCADEMICO
2010 - 2011
1
Indice
Premessa La poesia in volgare di ambito pescatorio e marittimo prima del Marino Le Rime marittime e Fileno Fileno nel canto IX dellAdone Bibliografia essenziale
I 1 18 29 43
2
I secentisti fecero un gran bene alla letteratura italiana che minacciava di sfasciarsi per iterazione e convenzionalismo. CARLO DOSSI, Note azzurre, n. 721
Intento delle pagine che seguono analizzare levoluzione del nom de plume Fileno intercorsa tra le giovanili Rime marittime (1602) e quel maturo pome de paix che lAdone (1623). Tra le due opere si infatti passati da una considerazione strettamente letteraria del nome, per la quale Fileno non che uno dei tanti amanti disperati che affollano le molteplici raccolte poetiche dellepoca -e valgano a dimostrarlo i numerosi riferimenti testuali agli autori analizzati allinterno del primo capitolo- ad una sua marcata tipizzazione autobiografica capace di avvicinare in grado maggiore lalter ego del Marino alla sensibilit del lettore moderno, qui proficuamente impegnato in quel gioco dello who is who che in altri contesti arriverebbe a compromettere gli inscindibili atti della ricerca e della critica letteraria.
Oltre alla Prof.ssa Luisella Giachino desidero ringraziare il Prof. Alessandro Martini, del quale ho avuto modo di frequentare un proficuo seminario friburghese sul Marino, e Luciana Pedroia, direttrice della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, per la sua disponibilit anche fuori dellorario di apertura.
Torino, Giugno 2011
1
La poesia in volgare di ambito pescatorio e marittimo prima del Marino
Nel sonetto proemiale alle Rime marittime Fileno-Marino invoca il possente dio Nettuno affinch gli conceda di adoperare quella nobil cetra le cui corde erano gi state pizzicate da Arione e dal gran Sincero Jacopo Sannazaro. Arretrando la nascita della poesia di ambientazione marittima in un mitico passato tramite la vicenda leggendaria del citaredo di Mitemna1 e facendo poi riferimento alle latine Eclogae piscatoriae dellautore dellArcadia, Marino non fa che dare al genere di cui ora si far prosecutore un retroterra classico, in tal modo nobilitandolo e legandosi a coloro che erano considerati i suoi pi grandi interpreti. Nella finzione poetica i suoi predecessori in volgare vengono cos relegati al rango di pescatori e nocchieri non degni di maneggiare il dolce plettro, con la precisa volont di celare la stretta dipendenza intertestuale che il Napoletano ebbe da questi. Sar perci utile, prima di soffermarsi sui componimenti mariniani, passare in rassegna i principali autori volgari di pescatorie e marittime2. Dopo Sannazaro, che alle Camene / lasciar fa i monti, ed abitar le arene 3, BERNARDO TASSO (1493-1569) pubblic nel 1534 a Venezia il secondo libro De gli Amori, nel quale inclusa legloga piscatoria dal marcato tratto elegiaco L dove i bianchi pi
1 Cfr. ERODOTO, Hist. I, 24 e OVIDIO, Fasti II, 115-16, ove presente limmagine che avrebbe ispirato la
formula mariniana londe affren: Ille, sedens citharamque tenens, pretiumque vehendi / cantat et aequoreas carmine mulcet aquas. 2 Utilizzando le parole di F. S. QUADRIO si pu dire che la poesia pescatoria non molto diversa da quella pastorale, salvo che, siccome in questa sintroducono pastorelle e pastori e ragionare di cose attinenti a pascoli, ad ovili (...) cos in quella sintroducono pescatori e pescatrici a ragionare co termini dellarte loro. La poesia marittima si distanzia invece da questultima in due cose. La prima , che dove nella pescatoria si ricerca nelle persone imitate una piena e abbondante scienza del pescare e de pesci; questa nella poesia marittima non necessaria. La seconda , che dove per la poesia pescatoria basta una scienza particolare di quel solo, o fiume, o seno, o golfo, dove si pesca (...); per la poesia marittima si ricerca nelle persone imitate una scienza universale della navigazione e di tutto ci che alla medesima sappartiene (Della storia e della ragione dogni poesia, Bologna, Pisarri, 1739-52, 4 voll., I, pp. 617-18).3 L. ARIOSTO, Orlando furioso XLVI, 17, 7-8.
1
lava il Tirreno4. Il componimento, lultimo di una serie di egloghe dedicate a Vittoria Colonna marchesa di Pescara, fu composto in occasione della morte del marito Francesco Ferdinando dAvalo in probabile5 competizione con BERARDINO ROTA (150974). Questultimo autore, oltre che di 33 componimenti in volgare di vario metro e di un canzoniere la cui princeps del 1560, di 14 Egloghe pescatorie per la stesura delle quali il modello fu il Sannazaro arcadico, come si desume dalla volont riportata nella lettera dedicatoria per mano di Scipione Ammirato di aggiugnere la prosa a queste egloghe, in modo da ordirla e tesserla; il progetto non and a buon termine a causa delle molte e varie occupazioni dellautore6. Nellegloga I il poeta, invocando le muse di Mergellina, chiede che gli vengano mostrate le orme di Licone-Sannazaro affinch possa seguirle: il Rota si propone dunque come successore del Sannazaro, allo stesso modo con cui operer G. B. Marino. Le egloghe seguono diverse tematiche tradizionali: lamenti per gelosia (XII), per lassenza (I, IV, VIII) o labbandono (II) della donna, scherzi (III) e indovinelli (X) tra pescatori, uso della magia per sottrarsi allamore (V), narrazione di miti e metamorfosi (VI, VII, XI), episodi encomiastici (in IX celebrato il giorno di nascita di NiceVittoria Colonna, con una lunga serie di adynata che coinvolgono lambiente marino). Peculiari risultano le ultime due egloghe: in Pocilla (XIII), come spiega largomento, il signor Berardino (...) essendogli morta la sua dolcissima et onoratissima moglie (...) sotto il nome di Berino piange Pocilla meditando negli ultimi versi il suicidio con formule convenzionali7; nella conclusiva Eco (XIV) avviene invece la redenzione di
4 De gli Amori di Bernardo Tasso, Venezia, Sabio, 1534; si utilizzata lediz. a cura di D. Chiodo e V. Martignone in B. TASSO, Rime, Torino, Res, 1995, 2 voll., I, pp. 283-87. 5 Secondo lipotesi di F. PINTOR, Delle liriche di Bernardo Tasso, Pisa, Nistri, 1899, p. 114. 6 I 33 componimenti sono raccolti nellantologia curata da L. DOLCE, Rime di diversi illustri signori
7 I versi 227-28 (O vita, vita no, ma polve e fango, / ecco a morte i mi dono, a te mi toglio) richiamano, come sottolineato da S. Bianchi (ivi, p. 299), per il primo verso lincipit del son. di J. SANNAZARO O vita, vita non, ma vivo affanno, per il secondo G. DELLA CASA, son. Io, che let solea vivere nel fango, 6, a te [Dio] mi dono, ad ogni altro mi toglio.
napoletani, Venezia, Giolito, 1552, mentre il canzoniere si intitola Sonetti et canzoni del S. Berardino Rota, Napoli, Scotto, 1560. Per le egloghe cfr. Egloghe pescatorie del Sig. Berardino Rota, Napoli, Scotto, 1560, ma si veda ora B. ROTA, Egloghe pescatorie, a cura di S. Bianchi, Roma, Carocci, 2005, con testo basato sulledizione del 1572 (Napoli, Cacchi), da cui si citato (p. 76). Sullopera cfr. anche D. CHIODO, Le Pescatorie del Rota tra egloga e idillio, in Critica letteraria, XXI (1993), 2, pp. 211-24.
2
Licida-Rota, che converte lamore passionale8 in amore verso Dio, che da la rete al cielo / chiam i pescator9. Seguendo dunque il modello dei Rerum vulgarium fragmenta Rota ha spostato il proprio interesse verso il saldo scudo de lafflicte genti / contra colpi di Morte et di Fortuna, / sotto l qual si triumpha 10, con una inaspettata traslazione dei piani profano e sacro che verr dal Marino mantenuta ma rivolta a ben altre divinit11. Sempre in area napoletana oper LUIGI TANSILLO (1510-68), autore di un vasto canzoniere contenente tre canzoni pescatorie12 tra loro strettamente collegate, oltre che da richiami intertestuali13, dalla sequenzialit narrativa: come illustrato dallargomento della prima canzone (lo stesso per lintera sezione), il pescatore Albano canta a pi del monte di Lipari il suo sfortunato amore per Galatea14. La tradizionale donna-pietra si fa nel Tansillo pi salda che scoglio e pi crudel che tutto il mare, in grado di provocare adynata come nfiammare londe e nfiorare i colli [rocce]15. Galatea ha sul cor s dure scaglie che la rendono impenetrabile non solo a saetta damor ma perfino di pietate 16. Le querele di Albano si perdono nel
8 9 10 11
RVF 366, 17-9 (rivolto alla Vergine). Forse con miglior sorte ir con Caronte / spero (se giusta legge ne lInferno) / londe a solcar di Stige e dAcheronte, Rime marittime, Fuggiam, legno infelice, ecco Aquilone (50), 12-4. 12 L. TANSILLO, Il canzoniere edito ed inedito secondo una copia dellautografo ed altri manoscritti e stampe, a cura di E. Prcopo, Napoli, Tip. degli Artigianelli, 1926 (rist. anastatica a cura di T. R. Toscano, Napoli, Liguori, 1996), 2 voll., I, pp. 203-24. 13 Nelle prime due canzoni, Lire del mar, che tempestoso sona (XIII) e Qual tempo avr giamai che non sia breve
Giovenil desio come in Rerum vulgarium fragmenta (dora in poi RVF) 360, 66. Cfr. RVF 4, 7-8: [Dio] tolse Giovanni da la rete et Piero, / et nel regno del ciel fece lor parte.
14 Sotto il nome di Albano si cela don Garzia di Toledo, figlio del vicer don Pedro, al cui servizio il Tansillo entr nel 1536. Galatea invece Antonia di Cardona contessa di Colisano, che prefer unirsi in nozze al pi titolato Antonio dAragona duca di Montalto. Cfr. la nota di E. Prcopo in L. TANSILLO, Il canzoniere edito ed inedito, cit., pp. 203-04. 15 XIII, 22. 16 XIV, 10-2.
(XIV) sono ravvisabili 3 versi (odimi, o re dei venti, / e fa, mentre daltrui teco mi doglio, / chabbian queste onde tregua e questo scoglio) iterati pi volte (37-9, 76-8, 115-17 in XIII; 37-9, 89-91 in XIV). La volont di legare tra loro le canzoni inoltre messa in evidenza dai primi due congedi che, diretti alla canzone in corso, chiamano in causa la successiva: Tu, canzon, nel cominciar sei stanca. / Or, poich a pianger tempo non ne manca, / (...) / escan da mezzo l cor laltre compagne (XIII, 121-24); Quanto pi lagrimando, / canzon, la doglia sfogo, / tanto di lagrimar pi mi fo vago; / ondio con le due sole non mappago. / Da quel medesmo luogo, / ondusciron le due, la terza or esca, / e, pur che l dolor scemi, il pianto cresca (XIV, 118-24).
3
vuoto a le sorde onde et a le mute arene 17, ma anche se lamata fosse in ascolto la situazione non muterebbe: oda o non oda le mie gravi pene, / effetto egual ne viene18. Il monologo del pescatore assume perci i tipici toni risentiti dellamante non ricambiato, che hanno il loro culmine nellinvocazione al re dei venti Eolo affinch abbian queste onde tregua e questo scoglio; sentenza spiegata solo nella seconda canzone dal fatto che da Galatea queste parole un d segnate furo: / Allor che Galatea non avr caro, / via pi che gli occhi, Albano, / liquido questo monte, e l mar fia duro!19. Il non mantenimento della parola rende possibile agli occhi dellamante levento prospettato dalladynaton, peraltro scritto sovra lumida arena in maniera da indicare linevitabile caducit di quelle parole subordinate agli agenti atmosferici. Nella canzone finale Tu che, da me lontana, ora gradita (XV) Albano si interroga sui motivi dellabbandono della donna: Forse mi lasci, perch tutta io fondo / sul mar la vita, dove / tanto fortuna opra sue leggi ingiuste? / (...) / O spregi queste carni aspre e robuste, / dalle fatiche aduste?20. Ma anche Proteo, divinit marina, guarda e regge, / sudando per gli scogli, il marin gregge; Glauco stesso, chor siede a mensa / coi dii (...) trasse al lido le scagliose prede21. Il mestiere di pescatore viene coi riferimenti mitologici nobilitato: Albano non peraltro un vil pescator dalla umil canna, ma segue col tridente (oggetto nelliconografia tradizionalmente simbolo del potere sullelemento acquoreo22) e foche ed orche, simboleggianti i Turchi ed i corsari che mediante scorrerie venivano a depredar le nostre rive. Dopo un elenco di doni (reti a bei lavor, ami dorati, arbuscei di bei coralli, pesci cheran scelti, augei) che la donna non pu che aver dimenticato23 lamante prima apostrofa Circe, affinch lo trasformi in bestia in maniera da cangiare le membra e al tempo stesso le voglie, poi chiede a Glauco che gli venga mostrato il lido ove quellerba nasce che volse il
17 18 19 20 21 22
XIII, 29. Ivi, 32-3. XIV, 16-9. XV, 14-6, 19-20. Ivi, 22-3, 24-6. Cfr. ad esempio il Ritratto di Andrea Doria in veste di Nettuno di A. Bronzino, datato al decennio 1540-50 e oggi conservato presso la Pinacoteca di Brera. 23 Come tuscir di mente / i doni, che s spesso / da queste mani, e cos rari, avevi?, 46-8 (lelenco degli oggetti citati si trova ai versi 53-65).
4
pescatore in pesce. Non ottenuta risposta ricorda la profezia di Proteo sullinfausto incontro di una nova fiera (...) pi rea di Scilla e di Cariddi da cui non si sarebbe riuscito a sottrarre, che assume immediatamente le fattezze dellamata. Ma allimprovviso un tuono introna laria interrompendo il pianto: destossi Albano, e attonito si tacque24. La forza prorompente dellelemento naturale ha la meglio sui vani piagnucolii dellamante disperato. In Piemonte, a Casale Monferrato, fu invece attorno al 1540 fondata lAccademia degli Argonauti25, che nel 1547 diede alle stampe una raccolta di Dialogi maritimi26; oltre ad alcuni dialoghi di G. I. Bottazzo, alle egloghe Hydromantia maritima di G. F. Arrivabene e Maritima sciolta di F. Bagno vi sono compresi 56 sonetti di NICOL FRANCO (1515-70) riuniti sotto il titolo di Rime maritime27, per i quali probabilmente per la prima volta si introduceva il tema nella pi tradizionale struttura metrica volgare. Nel sonetto proemiale Queta, o bellAdria, ogni turbato aspetto (I) Cloanto-Franco invoca la ninfa Adria di quietare il gran mar Adriatico e di sgombrare ogni vento affinch, ottenuto silenzio, lamata Galatea non possa non ascoltare il duol (...) aspro infinito delle sue preghiere damore. I duo be lumi della donna vengono seguiti alla stregua di un porto sicuro, ma causano ben presto doppia tempesta 28. Cloanto assuefatto dalla bellezza di Galatea, tanto che nessunaura soave, n le canzoni di famosi nochier, n la visione delle Nereidi Teti, Melite e Agave pu addolcire il suo cuore prima che egli veda il suo splendore (N per placido mar aura soave, IV); la stessa dea Venere, che appare in visione a mille nochier Lungo le salse rive di Citera (VI), assimilata dal navigante alla donna amata29.
24 Ivi, 111. 25 Sulla quale cfr. F. S. QUADRIO, Della storia e della ragione dogni poesia, cit., I, p. 62 e M. MAYLENDER, Storia delle accademie dItalia, Bologna, Cappelli, 1926-30 (rist. anastatica Bologna, Forni, 1976), 5 voll., I, pp. 332-33. 26 Dialogi maritimi di M. Gioan Iacopo Bottazzo et alcune rime maritime di M. Nicol Franco et altri diversi spiriti dellAccademia de gli Argonauti, Mantova, Ruffinelli, 1547. 27 Ivi, pp. 128-42. Nelle citazioni si proceduto, oltre che alla numerazione dei sonetti, ad un minimo ammodernamento della grafia e della punteggiatura. 28 E mentre a duo be lumi alzo la testa, / credo trovar (ohim) porto sicuro, / l dove trovo al fin 29 -Et io- disse Cloanto -o bella dea / per con gli altri mi tinchino ancora, / perchal vederti, i veggio Galatea, 12-4.
doppia tempesta, Qua, dove del mio mal scrivo e favello (III), 12-4.
5
Dopo un sonetto (Del mio Sebeto le dolcissime acque, X) che riepiloga con modalit tipicamente dantesca le localit nelle quali soggiorn il Franco sulla base delle acque che le bagnano30, e unapostrofe ai fiumi francesi Rodano e Senna 31 (Deh, perch londe tue varcar m tolto, XI), il poeta paragona in Mentre del tempo rio poco mi fido (XIII) la propria vicenda a quella di Leandro, il giovane dAbido travolto da una tempesta nel recarsi verso lamata Ero32, con la richiesta rivolta alle onde di risparmiarlo almeno durante il viaggio dandata33. In un dittico dambientazione notturna viene prima (Leva su gli occhi, Oronte, a la sorella, XIV) evidenziata la futilit del contare le stelle del cielo, cos numerose che ogni amante pu vedervi la sua donna34, poi (O de la notte guida et ornamento, XV) apostrofata la luna sulla possibilit che i due amanti stiano contemporaneamente ammirando il suo puro argento in maniera che i loro pensieri possano essere almeno per un istante conformi35. In Deh, qual oggi tra voi, saggi nochieri (XVI) avviene per una repentina scissione del fino a quel momento unitario sentimento amoroso, che si divide ora in maniera eguale tra Galatea e la nuova fiamma Cidippe36. Ad un sonetto (Si non tamo, o Cidippe, irato il mare, XVII) rivolto a Cidippe e ripartito tra lirreale ipotesi che Cloanto non la ami e il pi probabile contrario37, seguono due componimenti (Sovri pi eccelsi scogli, onde pi lice,
30 Per involarmi alle speranze salse / mattenni al lito in cui Fetonte giacque. / Indi, varcando poi lAdige, i vidi / lAdda, lAmbro, il Tesin, il Varo e assai / fiumi chhan seggio ne vicini lidi, 7-11, ove evidente il ricordo di Par. VI, 58-60. 31 Nel 1539 il poeta lasci Padova col progetto di riparare in Francia alla corte di Francesco I, ma di
32 Cfr. OVIDIO, Heroides XVIII e XIX. 33 Deh siatemi tranquille, onde, a landare, / siatemi infin che giunga al tesor mio: / poscia al partir da lui maffondi il mare, 12-4. 34 Tante nha seco la notturna dea / chad un tempo possiam, bench lontane, / tu [Oronte] Melite veder, io Galatea, 12-4. 35 Et forse, or chambi in te guardiamo a paro, / anchella pel desio cha ci madduce / pensa e parla di me, comio di lei. / Luna, segli mai ver, molto m caro / chalmen co mezzo di s bella luce / conformi sieno i suoi pensieri e i miei, 9-14. 36 a questo proposito interessante notare, al fine di accentuare la duplicit di fondo, la presenza degli aggettivi numerali (due fortune, 3; seconda stella, 9; primo ardore, 10), il verbo iterativo raddoppiar (11) e le bimembrazioni or questa, or quella (12), quandal lume lontan, quandal vicino (14). 37 Si non tamo, o Cidippe, irato il mare / contro la nave mia via pi si mostri, / onde con venti e con fortuna i giostri, / n mi vaglia ragion n arte usare. / (...) / Ma si tamo, Cidippe, o l lasso legno / torni al bel lito donde dipartillo / Fortuna ne laver mia pace a sdegno, / o n questo mar che dai miei occhi stillo / trovi
passaggio a Casale Monferrato fin per rimanervi fino al 1546: cfr. la voce Nicol Franco a cura di F. PIGNATTI in Dizionario biografico degli italiani (dora in poi DBI), Roma, Istituto dellEnciclopedia Italiana, 1960-segg., L (1998), pp. 202-06.
6
XVIII; Parmi per londe udir vaghe Sirene, XIX) di esortazione a sfruttare il tempo favorevole alla navigazione38 e a non ascoltare le piene voci di mago suon delle Sirene, in maniera da emulare lulissiaca altra via39. Dopo i sonetti Fermi sospiri miei, voi chEuro e Noto (XXII) e Ahi bella Galatea, come tu mhai (XXIII), giocati sullantitesi lontano-vicino 40, si ricorda alla donna-scoglio il precetto cortese per il quale il non ricambiare i sentimenti del proprio amante disconviensi a cor gentile (O superba e crudel, che per tuo stile, XXV): illustri navigatori (Enea, Ulisse) giunsero a lidi in cui alcune donne (Didone, Nausicaa) ebbero piet di loro, ma questo non il caso di Cloanto, che in Da londa combattuto empia rapace (XXVI) vede morta (...) in Cidippe ogni pietate. Dopo alcuni sonetti dinvocazione agli di marini Nettuno (Se sol da te, Nettun, mercede impetra, XXVIII), Borea (Per le catene che nel petto avvolte, XXX), Aurora (Deh, se madre de venti, o bella Aurora, XXXI) e Tritone (Che fai chiaro Triton, cha tanti voti, XXXII) un trittico encomiastico41 dedicato al vero figliuol di Giove, HERCOLE con excusatio sulle mancanti capacit marinaresche del poeta 42 rende partecipi della necessit di celebrare un non meglio identificato potente dellepoca. In Vinto dal sonno il misero Cloanto (XXXVII) descritto invece un incubo notturno del navigante, che vede lamata Galatea insidiata da altro nochier, mentre in Esaco aventuroso che nel mare (XXXVIII) richiamata la metamorfosi di Esaco in smergo, uccello marino chor sovra un sasso assiso, / et or sottacqua, or suol alto volare: lamante vorrebbe trovarsi nella stessa condizione, in maniera da potersi alzare in volo dal desio profondo damore nel quale ora sommerso al fondo43.
tosto per voi lucente segno / senza pi navigar porto tranquillo, 1-4, 9-14. 38 Seguite fidi miei, seguite intenti / il bel viaggio, allor che non appare / nubilo giorno o fatigosi venti. / Non vindugiate su per londe chiare / nel gir al porto che ne fa contenti, / ch cangia vista in picciol tempo il mare, XVIII, 9-14. 39 Ove, se vincerem la voglia ria / con chi solo la vinse in questo mare, / andrem compagni ancor per laltra via, XIX, 12-4. 40 A Galatea non giovarieno i miei sospir lontani, / se non giuvar le lagrime presenti (XXII, 13-4), mentre Cidippe, sembiante stella, fa scorgere il tuo [di Galatea] lontano lume (XXIII, 13-4). 41 Vero figliuol di Giove, HERCOLE (XXXIV), Finch il giro fatal non compie lora (XXXV), O de sacri nochier lume e tesoro (XXXVI). 42 Comad ogni or vorrei per farvi onore / temon, ancore, vele e remi oprare: / ma al fin non posso pi che darvi il core (XXXVI, 9-11). 43 Sulla vicenda mitologica cfr. OVIDIO, Metamorfosi XI, 749-95. La volont di emulare il volo dello smergo deriva probabilmente dal rovesciamento di un passo del Rota, ove era il volatile ad imitare lamante, questa volta nel
7
Il sonetto Questi ricchi coralli, o Galatea (XL) dedicato al tema del dono di oggetti preziosi alla donna amata, qui gemme e ricchi coralli (...) tolti dal fondo ai pi lontani mari; lamante desidera cos mostrare che pur nella lontananza mai ha dimenticato i lumi e la belt di Galatea, che gli hanno anzi fatto da guida per diversi liti. La narrazione dellamore non ricambiato del nochier Telone per la Nereide Teti (Ignudo e scalzo e per notar gi presto, XLI e Or che mille nochier per londa chiara, XLII) occasione per Cloanto, in Di tutti i mari omai tutte le sponde (XLIII), di prendere pace e conforto e riconoscere di non essere il solo cui la fortuna avversa 44. Dopo la visione della faccia sua squallida e trista riflessa nelle chiaracque del mare, sono presentate dallamante le prove fisiche dellamore verso la donna: oltre i lineamenti del volto, i componimenti poetici fin qui prodotti45. In Ben puoi creder omai stanco temone (XLV) limminenza di una tempesta oscura, preceduta dal fresco Aquilone e dalla vista dei curvi dorsi / dei pesci che portar salvo Arione, spaventa tutti i marinai eccetto Cloanto, che in Per ubbidir ai messi di Giunone (XLVI) accusa la sorte di avergli sottratto ogni bene 46. La tempesta sembra improvvisamente far spazio in O di che bel sereno se nandava (XLVII) al bel sereno, ma lillusione solo momentanea: senza Cidippe le tenebre e lorrore sono permanenti, determinando una perspicua diffrazione tra tempo atmosferico e condizione interiore. Il successivo toccar terra sulla spiaggia in cui vide Cidippe motivo in In questo lito ahi lasso, in questa amena (XLVIII) per Cloanto di ricordare alla maniera petrarchesca 47, tramite linsistenza su determinativi (in questo lito, (...) in questa amena / piaggia, 1-2) e deittici (qui le sante / luci, 2-3; qui la sola fra noi sacra sirena, 5; qui ferm le vaghe piante, 7), il rapporto instauratosi tra la donna e il luogo fisico sul quale si trov in
44 45 46 47
canto: E posto il volo e se stesso in oblio, / fermo su lali or questo mergo or quello / ad ascoltarlo stette, e le sue note / insieme accompagn cantando a gara, B. ROTA, Egloghe pescatorie, cit., egl. II, 133-36. Lo stesso uccello sar presente nel sonetto E tu pur (lasso) incontra me congiuri (18) delle Rime marittime, dove verr accusato dal Marino di turbare il sonno dellamante. Prendi dunque di ci pace e conforto, / miser Cloanto, e al cor ti sia men grave / vederti in questo mar preciso il porto. / Ecco ad altri nochier con parorgoglio / Fortuna aversa, e pur con la tua nave / ecco laltrui gi rotta ad uno scoglio, 9-14. Et poi che a s rio fin mha gionto amore, / mostrin le carte ogni or, e scovra il volto / che non finto il foco del mio core, Ne le chiaracque del tranquillo mare (XLIV), 12-4. Che vuoi tu pi da me, se gi mhai tolto, / Fortuna, ogni mio ben? Da ora inanzi / abbiti ignuda pur questa mia barca, 12-4. Cfr. RVF 112, 5-14; 125, 66-74; 126, 1-11; 243, 1-8.
8
passato, che ora ha perso quellaura che lo caratterizzava quando il lume era presente. Cloanto torna poi nuovamente in mare invocando la nave di andare alla deriva 48 alla ricerca delle acque pi insidiose (Averno, Scilla, orribil onde di Malea), purch Cidippe e Galatea conoscano fino a dove la loro ritrosia ha spinto lamante. Un nuovo sogno coglie Cloanto in Come bella dal ciel quaggi discese (L): Cidippe giunge a consolarlo delle tante lagrime e doglie vaneggiando spese (3-4), ma lillusione si palesa col risveglio trasformando la gioia del sonno nel dolore della dura realt49. Nel non veder terra il pescatore giunge poi ad invocare Glauco affinch il mare lo sommerga50, ma nel momento in cui sta sacrificando un agnello bianco agli Zefiri e uno nero a Fortuna51, manifestandosi perci classicamente per pius, che avviene la visione di un nuovo illustre raggio, / lucido segno di vedere il porto (13-4). Il toccar terra accompagnato da alcune lodi alte infinite a Nettuno, dallofferta di arabi incensi agli altari di Glauco e Anfitrite (Cantiam amico Anceo, che ben conviensi, LIII, 2-8), dalla consacrazione di due divoti altari e dalla presentazione di ex voto52 e dei panni di cui Cloanto era vestito, al fine di ricordare ai naviganti che hanno poco la mente (...) a Dio rivolta (14) di onorare le divinit protettrici della navigazione. La raccolta si conclude in Ecco chaccorto del mio strazio indegno (LVI) con il rendersi conto da parte dellamante di quel van desio che molte volte ha spinto a muoversi per mare il travagliato legno: la possibilit di viaggiare alla ricerca della propria amata non preclusa agli altri nochier (Solchi dunque Nettun chi vuole, 9), ma questo non potr che provocare pene e tormenti. Dopo la redenzione la donna ormai una vana e falsa imagine, e non resta che proteggersi da questa tramite i terreni numi Ferrando-Oceano, Isabella-Teti, sotto i quali si celano il vicer di Sicilia Ferrante Gonzaga e sua moglie Isabella di Capua53.
48 Vattene, nave mia senza governo, / rompi il temon, e dove orrido verno / pi fa Eolo in mar, te stessa mena, Poi che non speri pi luce serena (XLIX), 2-4. 49 Gioia al dormir Cloanto, e doglia fiera / ebbe al destarsi, 9-10. 50 Perch l fin sia corto / cuoprami o Glauco de tuo regni il seno, Mentre nel navigar consumo ogni opra (LI), 134. 51 Questagna bianca, o voi Zefiri, e questa / nera, o Fortuna, a vostri onor vedete / cader dal ferro mio, qua dove avete / stanca in lungo gridar lanima mesta, Perchagli scogli di s ria tempesta (LII), 5-8. 52 La sacra carta, in cui dipinta appare / lultima mia fortuna, e la figura / del gi rotto temon, chin bianca e pura / cera consacro al tuo divin altare, La sacra carta, in cui dipinta appare (LV), 1-4. 53 Alla principessa di Molfetta il Franco aveva gi dedicato la raccolta di epigrammi latini Hisabella, pubblicata a
9
Risale al 1582 la prima edizione della favola pescatoria di ANTONIO ONGARO (1560-93) Alceo54. Strutturata in 5 atti con la presenza del coro al termine di ognuno di essi (ad esclusione dellultimo, in cui inserito nella seconda scena) e preceduta da una lettera dedicatoria ai mecenati romani Girolamo e Michele Ruis, cui seguono alcuni componimenti in onore dellautore composti da vari letterati, la favola narra linnamoramento non ricambiato del giovane pescatore Alceo per Eurilla. Soltanto il tentato suicidio del protagonista far ravvedere lamata: la narrazione si conclude infatti coi preparativi per le nozze dei due giovani. Considerato trasposizione pescatoria della favola boschereccia Aminta, tanto da ricevere lappellativo di Amynta madidus55, lAlceo non si allontana dalla tradizione lirica fin dai primi versi. In I, 1 il ragionare per sentenze di Alcippe, nutrice di Eurilla, si compone di richiami a Bembo e Dante 56, e lesortazione ad amare condotta sul motivo dellomnes amantes: amano i pesci, gli uccelli, le piante e perfino le pietre, per cui Eurilla non pu che riamare a sua volta 57. Lamante canta inoltre le lodi della donna con versi da cittade, e non da lido, dimostrando perci di non essere rozzo e di poter
Napoli nel 1535 (Sultzbach & Cancer). 54 Alceo. Favola pescatoria di Antonio Ongaro recitata in Nettuno castello de Signori Colonnesi et non pi posta in luce, Venezia, Ziletti, 1582. 55 I. N. ERYTHRAEI (G. V. ROSSI), Pinacotheca imaginum illustrium, doctrinae vel ingenii laude virorum qui, auctore superstite, diem suum obierunt, Coloniae Ubiorum (Amsterdam), Kalcovium, 1643-48, 3 voll., I, p. 166: Antonius Ongarus, poeta perfacetus ac dulcis (...) edidit etiam insignem fabulam piscatoriam (...) et quia, per maritimos homines et in aqua more piscium vitam agentes, agebatur sicut illa [lAminta] ac terrestribus ac montanis, vulgo, joci causa, Amynta madidus appellabatur. 56 La sentenza Che colui che non ama essendo amato / commette gran peccato (p. 3r) ricalca e sopra ognaltro come gran peccato / commette, chi non ama essendo amato di Stanze III, 7-8, mentre la formula nave senza nocchiero in gran tempesta (p. 3v) presa in prestito da Purg. VI, 77. Questi e numerosi altri esempi nellarticolo di G. DALLA PALMA, Un capitolo della fortuna dellAminta: lAlceo di Antonio Ongaro, in Rivista di letteratura italiana, XII (1994), 1, pp. 79-128; cfr. anche ID., Aminta, Alceo, Tirena: una serie pastorale, in La poesia pastorale nel Rinascimento, a cura di S. Carrai, Padova, Antenore, 1998, pp. 307-47 e L. SPERA, Le reti testuali dellAlceo, in Studi secenteschi, XLVII (2006), pp. 105-36. 57 Il sargo ama la capra, / la raia ama lo squadro, / la sepia ama la sepia, / la triglia ama la triglia, / il persico locchiata, / e per la cara amata / il veloce delfin geme e sospira. / (...) / Ama il pavon le candide colombe, / ama le tortorelle il papagallo, / ama la merla il tordo, / e tra millaltri augelli / chora non mi ricordo grandamore. / Saman anco le piante: / aman le siepi i flessuosi acanti, / e ledere e le viti / amano gli olmi, e i tronchi lor mariti. / La palma ama la palma in guisa tale / che non sa viver sola, o se pur vive / vive infeconda e mesta. / (...) Amano i sassi / chhanno lessere appena: / ne le rigide pietre / stanno le fiamme ascose. / Ama il Hiacinto il riso e lallegria, / ama lambra la paglia, / ama lasbesto il fuoco, / altra pietra chaccesa / in mezo lacque avampa, / altra che in mezo a lacque anco saccende, / altra cheternamente / lagrima per amore: or tu da meno / esser vuoi de le pietre?, pp. 5r-6r.
10
aspirare ad ottenerne le grazie58. I lamenti di Alceo hanno fatto piangere gli di marini e i sassi ma non lamata, secondo il consolidato topos della donna-scoglio59, mentre nello svelamento ad Eurilla del proprio sentimento amoroso vi sono legami coi Rerum vulgarium fragmenta sia lessicali60 che evenemenziali61. Nel monologo di Tritone (II, 1), che tenter nellatto terzo di involare Eurilla ma verr fermato da Alceo, riproposto il motivo del rifuggire unaltra donna (in questo caso la nereide Cimotoe) pur di ottenere lamata sdegnosa, e si citano i tradizionali doni marini da questultima rifiutati: bianche perle, bei coralli, ebano e ambra, avorio e porpora, paragonati rispettivamente ai denti, alle labbra, alle ciglia e ai capelli, al viso e al seno della ragazza62. In II, 2 ricordato da Timeta-Ongaro, su modello dellAminta tassiano, il bel secol doro precedente quella falsa opinione / che da lignaro volgo detta onore. Si verificavano allepoca numerosi adynata: correano (...) di bianco latte londe, / erano lalghe e lerbe di smeraldi, / sudavano gli arbusti il dolce mele, / spiravano laurette arabi odori, / pendean luve da dumi, e le campagne / senza che il curvo ferro le offendesse / davan le bionde spiche e i dolci frutti 63. Segue poi, sempre da parte di Timeta, una palinodia dellamore rivolto ai sembianti giovanili di una certa Florinda, mutatosi ora in odio per ricambiare il rispettivo sentimento dingratitudine: odiandola le son tanto cortese / quantella ingrata fu mentre lamai64. Nella scena successiva invece inserito il tema del sogno premonitore in quanto vicino al sorgere del sole65: Alceo ha sognato il rapimento di Eurilla da parte di un
58 p. 6v. In III, 2 Alcippe tenter nuovamente di convincere Eurilla ad amare Alceo: questi non di te men bello, (...) / e di volto e detade a te simile, ricco in quanto figlio di Gildippo, / (...) che abbonda pi di ogni altro, possiede mille belle virtudi e inoltre rifiuta le avances di altre nobili donne: Resilla leggiadra, ch figliuola / di Partenope bella e di Sebeto, / per averlo gli fa mille lusinghe / e gli offre e gli promette in ricompensa / e dolci baci e cose altre e pi care. Citazioni dalle pp. 26v, 27r, 27v, 28r. 59 Ho sentito al pianto mio / piangere e sospirar Giunone, e Teti, / e Proteo, e Glauco, e Melicerta, e Ino, / e questi scogli, e questi sassi istessi; / ma non ho mai sentito n veduto / o sospirar o pianger te, chognaltra / in crudelt quanto in bellezza avanzi, / e sei pi di scoglio alpestre e dura, pp. 7v-8r. 60 Cfr. ad es. locchio (...) cerviero (p. 10r), che rimanda a RVF 238, 2. 61 Il fatto accadde il d terzo daprile, un anno e un lustro prima (p. 11r), a richiamare il d sesto daprile di RVF 211, 13 e 336, 13. 62 pp. 15v-16r. 63 pp. 17r-v. 64 p. 19v. 65 Sul quale cfr. almeno Inf. XXVI, 7: ma se presso al mattin del ver si sogna.
11
orribil mostro che si riveler essere Tritone, ma la visione sinterrompe col risveglio al momento del tentativo di salvataggio da parte del pescatore, con la creazione di una suspense che nella realt non potr che risolversi nella maniera migliore. La vicenda del salvataggio di Eurilla viene infatti narrata da Fillira a Timeta in III, 1 66, ma lo sdegno della fanciulla permane tanto da spingere lamante prima allo svenimento 67 e in seguito a porre al vento domande le cui risposte, date dalleco, lo indurranno a tentare il suicidio68. A IV, 1 vi invece una pausa nello svolgimento della vicenda principale con linserimento di un serrato dialogo tra i due pescatori Siluro e Mormillo, nel quale sono descritti i doni per le amate Aminta e Tibrina (un lucido cristallo e un nappo di faggio sul quale sono scolpiti episodi mitici, descritti con una prolungata ekphrasis alle pp. 37v-38r) e la bellezza delle due donne viene raffrontata a quella di pesci e animali marini69; segue una tradizionale gara dindovinelli di carattere ittico 70. solo a IV, 3, dopo che un nuncio narra del (tentato) suicidio di Alceo riportando le sue ultime parole, che Eurilla sente il core / schiantarsi per dolore e comprende fin dove pu condurre lamore; Alcippe le impedisce di trapassare le proprie carni col tridente e la conduce allo scoglio con la speranza che lamante non sia morto. Dopo V, 1, in cui Timeta promette di ergere un tumulo al suicida e di onorarlo nella memoria, a V, 2 il pescatore Glicone rivela di aver fortunosamente trovato nella propria rete Alceo, che ancora vivo. La vicenda si conclude perci a V, 3 con i preparativi del matrimonio dei due amanti, e Amore da ingiusto e crudo si converte
66 Parve a gli omeri e a pi chavesse lali, / tanto per aria and pria che toccasse / londe: caduto in mar si mise a nuoto a p. 24v segue il modello ovidiano di Metamorfosi IV, 711-12, ove il volante Perseo pedibus tellure repulsa / arduus in nubes abiit al fine di salvare Andromeda dalla fera che la minaccia. 67 Parla Alcippe: Eurilla, ohim, sostiello, oh miserello; / caduto tramortito, e sembra morto. / Io temo che sia morto: ecco gli effetti / della tua feritate, p. 35r. 68 Io fuggir la vita, / poich la vita mia / da me fugge, e sinvola. - Ola - / Ma chi mi chiama, e chi ragiona meco? - Eco - / Se vieni a darmi aita io la rifiuto, / poich nega di darmela colei / che darmela devria. - Ria - / Poi chella ria, sii tu pietosa almeno / a quel che son per chiederti rispondi. - Di - / Di, qual fin fa chi segue ingrato amore? - More - / Morir dunque conviemmi: / e quando vuol crudel Amor chio mora? - Ora - / (...) / Ma dimmi ancor: qual cosa / pu porger fine a le mie pene amare? - Mare -, p. 35v. 69 -SILURO- Vincono i biondi crini / di Tibrina, damor gioia e tesoro, / le belle macchie doro / chhanno ne le palpebre i fragolini. -MORMILLO- Vincono di colore / le righe, ond la fiattola dipinta, / de la mia vaga Aminta / le belle chiome onde mi strinse Amore, p. 38v. 70 pp. 39r-40r.
12
nelle parole di Alceo in giustissimo e pietoso71. Al poligrafo urbinate BERNARDINO BALDI (1553-1617) risalgono invece tre egloghe pescatorie (Tibrina, I pescatori, I pesci), contenute assieme ad altre 14 egloghe nella raccolta Versi e prose72. In Tibrina (VII) il topos dellamata duro scoglio, tronco, aspe ben evidente mediante il monologo del pescatore Alcone. Il cibo condito damarissimo pianto e il risveglio nel sonno sono tutti tipici elementi petrarcheschi 73, mentre lattesa di fronte lalbergo de lamata sotto la neve pu richiamare la celebre novella di Decameron VIII, 7. In una notte in cui tutto il mondo ha tregua (36) solo lamante non trova nei gravi martir posa o quiete. Dopo aver collegato il mento folto di nero pelo e il ciglio grosso et irsuto (88-9) alla necessaria mascolinit, allontanato il sospetto di vecchiezza con un aneddoto74 e affermato che ha gi rifiutato altre donne pur di ottenerla 75, Alcone propone a Tibrina una serie di doni non ordinarii (129): un tessuto in seta che da Bisanzio addusse / un nocchier peregrino, una spugna assai pi bianca / che non il bianco pan de cittadini, un pettine fatto dosso di dente delefante, una spina dun istrice marino, uno stuol danitrelle, un cigno candidissimo e canoro. Lamante sarebbe inoltre pronto a recarsi nei luoghi pi inospitali (arene bruciate dal sole, nevi de le pi nevose alpi) pur di soddisfare i desideri dellamata. Alcone si congeda lasciando il cuore in potere della donna, con la speranza che ella non luccida. Ne I pescatori (IX) il fanciullo Ila e il pi maturo Berino si trovano a dialogare sullamore; peculiarit dellamatore devessere la perseveranza verso la donna amata,
71 p. 52r. 72 Versi e prose, di Monsignor Bernardino Baldi da Urbino Abbate di Guastalla, Venezia, Franceschi, 1590. Precedono la sezione egloghistica una lettera e 4 sonetti di dedica al principe di Parma e Piacenza Ranuccio Farnese. Si cita dallediz. moderna B. BALDI, Egloghe miste, s.i.c., San Mauro, Res, 1992. 73 In RVF cfr. per il cibo di lagrime e doglia 342, 1-4; per il sonno fuggito 332, 31-4. 74 Quando tu nascesti, e nel tuo parto / venne mia madre a visitar tua madre, / seco menommi picciol s che a pena / sapea formar il passo, et io ti vidi / lavar da la nutrice, e n bianche fasce / involta por dentro la mobil cuna, 95-100. 75 E non un anno ancor (...) / che gran ricchezze a me per dote offerse / Licon, figlio di Glauco, sio volea / de la sorella sua marito farmi; / di Leucippe dichio, chancor non giunge / de let sua pi verde al quinto lustro, / e bella s, che dimandata viene / al fratello ogni d da mille amanti; / e pur la ricusai, n ci mincresce / sol per servirti, 112-21.
13
cosa mobil per natura (135), allo stesso modo in cui fa maggior preda solo il pescatore che paziente aspetta / fin che il pesce rimanga al fin trafitto (82-4). Berino riesce cos a racconsolare il giovane, in modo che nel suo cuore non regni mai ira o dolore per lamata Resilla. Ne I pesci (XIII) durante un temporale lanziano Alceo descrive al giovane Cibisto le caratteristiche fisiche e le abitudini comportamentali di vari animali marini, senza troppo distanziarsi dai tradizionali indovinelli 76. Notevoli risultano, per la loro sensibilit naturalistica da biologo marino ante litteram, le descrizioni della caccia della rana pescatrice77 e della pinna78. Tornato il sereno la descrizione deve forzatamente interrompersi, dal momento che trattare di tutti i pesci sarebbe come voler numerar tutte le stille / de la passata pioggia, o tutte londe / che muove il mar quando adirato ferve (332-34). Il napoletano GIULIO CESARE CAPACCIO (1552-1634) autore della raccolta di prose ed egloghe pescatorie Mergellina, la cui prima edizione a stampa risale al 1598 79. Alternate alle prose, caratterizzate da una accentuata dinamicit di ricerche formali con una disposizione ancora naturalistica anche se rivolta pi alla organizzazione di Wunderkammern80, le egloghe sono maggiormente legate alla tradizione della lirica amorosa. Dopo due egloghe in cui si loda pi che la caccia il pescare 81 e i pescatori Sifio e
76 Cfr. B. ROTA, Egloghe pescatorie, cit., egl. X, e A. ONGARO, Alceo, cit., pp. 39r-40r. 77 Odi. Una rana ha il mar che mai non gracida, / n vive derbe verdi, anzi nel fondo / sol di quei pesciolin chastuta prende / si nudre; ascondesi ella, e da larena / coperta manda fuori alcune fila / nervose e lunghe, a cui natura annoda / in cima un non che sembiante a lesca, / a cui per divorar corsi gli incauti, / pian pian da lei, cha s ritira lamo, / condotti son ne laffamata gola: / e perci pescatrice sappella, 280-90. 78 Questa, per s non atta a procacciarsi / cibo onde viva, un gamberetto alberga / ne largentata stanza, e con lui parte / e la casa e la preda: apre ella il chiuso / del cavo tetto, e porge a pesciolini / lallettatrice lingua; e intanto, quando / vede il cauto guardian glincauti sotto / laperto colmo, lievemente morde / la cieca sua compagna, et ella chiude / de la dura prigion le doppie porte, 296-305. 79 Mergellina. Egloghe piscatorie di Giulio Cesare Capaccio napolitano. Nuovamente posta in luce con le tavole degli argomenti e delle cose notabili, Venezia, Eredi di M. Sessa, 1598. Il nuovamente posta in luce potrebbe far pensare ad una precedente edizione di cui non vi traccia. 80 A. QUONDAM, Lideologia cortigiana di Giulio Cesare Capaccio, in ID., La parola nel labirinto. Societ e scrittura del Manierismo a Napoli, Roma-Bari, Laterza, 1975, pp. 187-225. La prosa della Mergellina specificamente trattata alle pp. 212-19 (le due citazioni provengono dalle pp. 212 e 214). 81 Alcone persuade Glauco, prima amante della caccia, della superiorit della pesca mediante tre diverse argomentazioni: la sua maggiore difficolt (Quando dei pesci la prudenza io miro, / e l sagace consiglio, il modo e larte / ondessi ai pescator fan mille inganni, / ch campano dagli ami e n reti involti / fuggon
14
Gripeo piangono la miseria de tempi nostri mediante il ricorrente tema dellet delloro82, nella terza Licida piange la morte di Filli, avvenuta dieci anni prima. Lanniversario celebrato dalla natura con segnali funesti 83, mentre il ricordo della donna amata avviene tramite trite metafore: membra ove pinse il ciel lucide stelle, / ove la terra di fiorito il lembo, / ove laria tranquilla al fiato, allaura / volando fea scherzar gli alati amori84. Licida invoca poi Glauco affinch gli riveli il nome dellerba con la quale trasformarsi in pesce 85 ma, non ascoltato, onora lamata promettendole ogni anno lelevazione di sette altari e il sacrificio di sette gran vitelli 86. Legloga si conclude con una descrizione elegiaca dellamante vedovo, che promette di scrivere per questi sassi / dInarime, e di Procida e Miseno / lamor di Filli e il suo dolore eterno87. Nellegloga seguente (Si fanno incanti e si biasma lamare, IV) i pescatori Alcone e Dorila cercano tramite incantesimi di volgere e s le donne amate, anche se la disillusione ha ormai la meglio: Dorila arriva ad affermare di aver messo in non cale ogni desiderio di amare, per cui il biasimo di Amore inevitabile e viene cantato dai due pescatori mediante laccompagnamento della cetra88. Dopo unegloga di ambientazione pastorale in cui sono narrati gli amori, la morte e lesequie del pastore Aminta, nellegloga VI Doreo narra lincontro con la ninfa
82 83 84 85 86 87 88
vittoriosi, allor ben dico / che larte del pescare ogni altra avanza, p. 23); la maggiore luminosit della costellazione Argo, che asconde tra lucenti stelle / lintiera prora, rispetto allAquila, al Tauro e al Capricorno (p. 24); loriginaria attivit di Cupido (E tu ben sai che Amore / fu prima pescatore, / ch nascendo dallacqua e dalla spuma / nel mar la face alluma; / e pescator, dentro la rete involge / senza il zelo donor Venere e Marte, p. 26). Il passato in cui le pendici ornaro il mirto e l lauro, / fra l musco odor spirava il fior vermiglio / e sedea lieta Astrea tra perle e ostri contrapposto al presente, in cui sorgono (...) dallarena orrendi mostri / che del prisco sentier turban le leggi / e empion di velen gli umidi chiostri, p. 46. N correr veggio alla dolce esca i tonni, / e insoliti corvi per gli scogli, / e le foliche a schiera entro le grotti / (lasso) fan risonar meste querele; / non guizzan mezi fuor curvi i delfini, / flebili sono londe e nellarena / arida, lalga il suo color natio / perdendo, ha fatto il mare orrido e mesto, pp. 74-5. p. 75. Quai mortiferi succhi e quai veleni, / qualerbe a tuo volere, o Glauco, ascose / faran chio lasci questusata forma / e nel liquido mar londe spumose / con le squame, col rostro e con la coda / per seguirti animal guizzoso io fenda?, p. 76. p. 78. p. 79. -DORILA- Prendi or la cetra, e allalto / suon de la voce snoda, / per s lieta aria, i pi sicuri accenti. - ALCONEAmore un vivo foco, / e consumar dovria a poco a poco; / ma sembra egli allInferno, / che non consuma e si pasce in eterno. -DOR.- Amor scherza con lali, / e dovria in alto star fuor dai mortali; / ma con finti lavori / fa, qual rapace augel, preda dei cuori. -ALC.- Amor si mostra ignudo / per allettare ai suoi piaceri il crudo, / ma le fere arme asconde / e inermi e sicuri ci confonde. / -DOR.- Lontani ora damore / vivremo lieti senza alcun dolore; / e n pi sicuro loco / sprezziamo arditi larme, lali e l foco, pp. 102-03.
15
Dirce presso una fonte. La donna si era innamorata della propria immagine riflessa nello specchio dacqua, alla maniera del Narciso ovidiano 89, quando il pescatore interruppe quellestatico momento con una lunga sequela di lamenti che, per lamico Cauno, aurian mossi a piet scogli e diaspri. Ma questo non avvenne con lamata, che l volto / cambi in un volto inviperato, e l labro / vermiglio tinse di color di morte; nel cuore di Doreo non rimangono che odio e dolore, trascurabili per Cauno col tranquillo piacer della pesca90. Nellegloga VII Melanuro e Bopide narrano i propri insuccessi amorosi: il primo ha infatti offerto un dentrice / di non pi visto pondo allamata Nisa, che gli ha fatto ripulsa del dono 91, mentre il secondo ha ottenuto i baci di Lamprote92, che se n poi andata lasciando una dolce rimembranza in cui si nutre / un soave martire93. Segue un contrasto nel quale i due pescatori si appellano vantator e mendace, e che si svolge prima sul tema delle proprie origini 94 e delle conoscenze marittime95, poi sulla celebrazione in rima delle amanti96, infine sulla lode al delfino che determina la vittoria di Bopide97. Legloga VIII unita alla successiva mediante la prosa intermedia, che narra lincontro di Talassio con Fausta. Dopo il breve monologo in cui il pescatore si autodefinisce preda damor tra fieri scogli / dostinati desir 98, a IX avviene il
89 90 91 92
Cfr. Metamorfosi III, 339-510. pp. 163, 164, 166. pp. 182-83. La descrizione avviene con la tipica metafora delle labbra-coralli: Poi mi avvent le strette braccia al collo, / e allavida bocca / la desiosa bocca ella congiunse. / Tra coralli e rubini, / come tra scogli londa / frangersi suol, pur cento baci franse, p. 185. 93 p. 186. 94 -MELANURO- Rozo / nascesti e rozo vivi, in volto agreste / pi che l mar gonfio da Aquilone, o quando / pasce del suo pastor lirata greggia. (...) -BOPIDE- Pescator tu non sei, sei ben del volgo / di quei che avezza intorno ai sassi il verde / manto lograno a Teti, pp. 188, 190. 95 -BOP.- Dimmi, dei navigar quando nel corno / oscuro Febe il nuovo foco accoglie, / o quando di rossor si tinge di velluto? / O pur dei navigar quando di macchie / il nascer tinge ascosto in nubi il sole, / o divisi tra loro spuntano i raggi?, p. 191. 96 Dopo la lode delle luci vaghe di Nisa e dei capelli di Lamprote, dai quali il cuore dellamante
97 La celebrazione del delfino quale re del mar condotta con laccostamento agli abitanti degli elementi aria e terra: -BOP.- Se tra dipinti augelli in aria impera / laugel di Giove, et il leone tra selve / magnanimo duce delle fiere, (...) / tra fiere natatrici in mezo a londe / il veloce delfin lo scettro regge, Ibid. 98 p. 213.
annodato, le due donne vengono paragonate ad una pianta e a varie specie di pesci: - MEL.- (...) a Nisa corro in grembo / per sanar la ferita quasi a dittamo cervo, et ei mi aita. -BOP.- Siegue il sargo alla capra, / e gli altri pesci a schiera / van seguendo il delfino; / io vo seguendo il mio lucente sole, / che rai di vita spira / et Elitropia a s mi volge e gira, p. 193.
16
confronto con lamata. Il definire la donna belt no, ma sembianza / del ciel, che l ciel somiglia non basta ad entrare nelle sue grazie: Talassio vorrebbe amare come Ceice amar volse Alcione, / come Orfeo Euridice, ma lunico amore di Fausta quello rivolto alla castitade99. Nessuna parola riesce a far mutare le volont della donna, per cui lardore di Talassio non pu che mutarsi in odio: e nel mio petto annidi / amor pi no, ma quel che damor nacque / odio pi amaro, e vincitor sia l vinto 100. La decima e ultima egloga si allontana invece dalla predominante tematica amorosa per descrivere le bellezze di Partenope. Palemone canta infatti il testo di unincisione fatta da un pescatore sovra un erboso scoglio: il seno di Mergellina tranquillo e ameno, luogo in cui fuggono i ceti e le balene, / ove il suo crin laurora / pi vagamente indora. In tale locus amoenus abitano inoltre divinit come i Tritoni, Dori, Astrea e Pomona, per cui in ultima battuta lautore, allepoca provveditore dei grani e degli olii della citt di Napoli 101, non pu che chiedersi: chi non servir desia / a Partenope mia?102.
99 pp. 236, 241. 100 pp. 245-46. 101 Eletto a tale carica nel 1593, Capaccio assumer nel 1602 lufficio di segretario della citt: sulla sua biografia cfr. la voce curata da S. S. NIGRO in DBI, XVIII (1975), pp. 374-80. 102 pp. 256-59. Le parole sono state proferite da Palemone appena prima della sua morte e vengono ora riportate dal suo amico fraterno Molgi, sotto cui si cela il Capaccio stesso.
17
Le Rime marittime e FilenoLe Rime marittime costituiscono la seconda sezione delle Rime pubblicate nel 1602 a Venezia presso Giovan Battista Ciotti1. I 50 sonetti da cui sono composte sono ordinati in maniera da creare una raccolta che pu essere divisibile in tre parti, distinte da due sonetti di ambientazione notturna posti alle posizioni +8 dallinizio e -8 dalla fine. Nei primi 7 sonetti, dopo il proemio La nobil cetra ondArion primero (1), il poeta si dedica a celebrare la bellezza dellamata Lilla, definita mio bel sol2 e paragonata a Venere3. Al sonetto ottavo (Tacean sotto la notte Austri e procelle) la situazione viene a mutare: nel sogno notturno il rispecchiamento del mare nel cielo provoca il reciproco scambio delle due entit, con lamante che credea solcar lo ciel, gir per le stelle. Ma il capovolgimento degli elementi conduce inevitabilmente alla caduta dellacqua dalla volta celeste, che finisce per sommergere il navigante, con il conseguente venir meno della distinzione tra le dimensioni onirica e reale4. Nella seconda parte (sonetti 9-42) le precedenti speranze di conquista dellamata si rivelano illusorie, tanto da spingere Fileno a invocare fin da subito la morte 5. N doni (10, 12), n lodi (23), n il dichiarare la nobilt della pesca (20, 21) mutano la ritrosia di Lilla, per cui la donna prima chiamata perfida, poi inessorabile e in seguito pi volte biasimata6. Dopo alcuni sonetti che coinvolgono altri amanti (32-41) in Pon mente
1 Rime di Gio. Battista Marino. Amorose, Marittime, Boscherecce, Heroiche, Lugubri, Morali, Sacre, & Varie. Parte prima. Allillustrissimo & Riverendis. Monsig. Melchior Crescentio, Venezia, Ciotti, 1602. Si cita dalledizione moderna a cura di O. Besomi, C. Marchi e A. Martini, Modena, Panini, 1988. Sullordinamento per generi dei componimenti cfr. gli importanti articoli di A. MARTINI, Marino postpetrarchista, in Versants, 7 (1985), pp. 1536 e ID., Le nuove forme del canzoniere, in I capricci di Proteo. Percorsi e linguaggi del barocco, Atti del convegno internazionale di Lecce (23-26 ottobre 2000), Roma, Salerno, 2002, pp. 199-226. 2 Spuntava lalba, e l rugiadoso crine (2), 14. 3 (...) invide scorgean londe marine / pi bella dea dAmor nascer da loro, Avea su per lo mar, del biondo crine (6), 7-8. 4 La mia leggiadra e piccioletta nave / quella parea che ne celesti giri / pi di nembo o tempesta ira non pave / quando, da lo spirar de miei sospiri / gonfia la vela, un mar profondo e grave / mi sommerse di pianti e di martiri, 9-14. 5 Cfr. O terror dogni rete e dogni nassa (9), rivolto al pescespada: Vien con lacuta punta e l cor mi passa / s chio traffitto in mezo al mar ne cada, 5-6, ove la fantasia di trapassamento anche interpretabile come non troppo velata allusione omoerotica, se nel sonetto Qual ti veggio di fin acciar lucente (42) delle Amorose si chiede allamante Ligurino che (...) l ferro aspro e pungente / sia dal bel fianco omai discinto e sciolto, 5-6. 6 Cfr. 13, 2; 15 (argomento); 17; 19, 12-4 ove paragonata ad un famelico polpo; 28; 29.
18
al mar, Cratone, or che n ciascuna (43) un nuovo notturno fa convertire il mare in cielo con il passaggio alla terza parte del canzoniere: S puro il vago fondo [del mare] a noi traspare / che fra tanti dirai lampi e facelle: / -Ecco in ciel cristallin cangiato il mare- (12-4). Ad alcuni sonetti doccasione (Ecco il monte, ecco il sasso, ecco lo speco, 44, dedicato alla sepoltura di Iacopo Sannazaro; Arpie del mar, che da lestreme sponde, 45, sui corsari che costeggiavano la riviera di Taranto; Questo il mar di Corinto: ecco ove lempio, 46, ove si descrive il golfo di Lepanto, dove nel 1571 fu rotta larmata del Turco) seguono tre sonetti (47-49) in cui il presagio della vicina tempesta si fa sempre pi probabile: la procella si rende palese7 e lio lirico vi si oppone con desiderio di sfida temeraria allelemento acquoreo e agli di suoi governanti. Allinterno di questa tripartizione il primo e lultimo sonetto sono inoltre posti in antitesi col dittico centrale 25-26: la vicenda di Fileno viene collegata in In questo mar, qual fulmine che piomba (26) a quella di Miseno narrata in Aen. VI, 156-235, ove il trombettiere di Enea sfid laraldo de lacque Tritone nel suonare la buccina e fu da questi fatto precipitare in mare. Il suo corpo senza vita venne per trovato e sepolto dai suoi compagni, mentre quello di Fileno destinato a vedersi negata lurna del marmoreo cor di Lilla. Nel sonetto, con una lieve variatio, il divin suon a risultare fatale a Miseno, ponendosi in antitesi con la cetra di Arione del sonetto proemiale, che al contrario londe affren e permise al citaredo di salvarsi. In Lilla, qualor veggio che l ciel savolga (25) Fileno, rivolgendosi allamata, dichiara invece il suo timore per gli di, non sul piano religioso ma per la possibilit che si possano invaghire anchessi di Lilla: Borea, Giove, Apollo e perfino Teti potrebbero arrivare a rapirla, per cui lamante manifesta qui i suoi affetti di Gelosia, sentimento gi ben trattato nella sezione amorosa e accennato nel sonetto precedente 8. Lantitesi
7 Ma il confine tra realt e immaginazione sempre labile, se nellargomento si parla di allegoria duna procella. 8 Cfr. Rime amorose, a cura di O. Besomi e A. Martini, Modena, Panini, 1987, sonetti 79 e 80: in particolare 79, 58, ove la donna definita Vipera in vasel dor cruda e vorace, / nel pi tranquillo mar scoglio pungente, / nel pi sereno ciel nembo stridente, / tosco tra fior, tra cibi arpia rapace e 80, 1-2, ove con un chiasmo esplicitata la sua discendenza da Amore: (...) di cieco padre occhiuta figlia, / figlia del genitor folle omicida (1-2). In Mentroggi assisa in su le piagge erbose (24) la gelosia era invece rivolta ad un dolfino (pesce che curvo anco ha il rostro, e n cento globi attorta / la coda inalza) che, attratto dal canto in riva al mare di Lilla,
19
con Fuggiam, legno infelice, ecco Aquilone (50) evidente, ma nel sonetto finale la competizione amorosa si trasforma in desiderio di venir sopraffatto per cercare nellinferno una legge pi giusta rispetto a quella determinata da Giove e Fortuna. Alla appena descritta divisione strutturale, ormai accettata dalla critica 9, si possono aggiungere alcuni elementi per aiutare a far luce sullo svolgimento della vicenda. I nomi dei protagonisti Lilla e Fileno compaiono rispettivamente a partire da 1 e 10, ma scompaiono dalla scena a 31 e a 29, lasciando spazio ad altri amanti per singoli sonetti o microsequenze: Cloanto (32, 34), Palemone e Irene (33), Ofelte e Cromi (378), un io lirico non identificato che si rivolge a Galatea (35-6), Nice (39) e Dirce (40-1). Questi sonetti furono composti prima della decisione di assemblaggio della raccolta, o comunque prima dellassunzione dei noms de plume di Fileno e Lilla, e la loro concentrazione in blocco al termine della seconda parte vuole accentuare lindeterminatezza del sentimento amoroso, che pu colpire indiscriminatamente chiunque non vi si opponga. I pescatori in pi sono tutti respinti dalle loro amanti, a generalizzare la tradizionale ritrosia che caratterizza le donne altamente lodate. Allinterno del corpus sono inoltre presenti un sonetto di encomio per la signora princessa di Stigliano e tre sonetti doccasione. Il sonetto Non cos bella mai per londa egea (4), dedicato a Isabella Gonzaga, descrive la navigazione della donna in ricca poppa assisa, per la quale lelemento fuoco riesce ad avere la meglio sullacqua 10. La destinataria del sonetto non viene nominata se non nellargomento, nella princeps del 1602 posto solo al termine di tutto il corpus delle Rime, in modo che la bionda e folta chioma potrebbe essere quella di Lilla, come avverr in Avea su per lo mar, del biondo crine
baciolle il piede e le suppose il dorso. Lanimale marino il corrispettivo del terrestre cagnolino di Amorose 65-7. Nellidillio Europa (1607) contenuto nella Sampogna sar il toro sotto sui si cela Giove a prostrarsi di fronte alla bellezza della figlia di Agenore: piega lalta cervice, il tergo abbassa, / e par che quasi, de begli occhi fatto / idolatra, ladori, 204-6 (ediz. a cura di V. De Mald, Parma, Guanda, 1993, p. 259). 9 Proposta dapprima da C. MARCHI nella tesi dattiloscritta Analisi delle Rime marittime di G. B. Marino, Fribourg, 1977, spec. pp. 13-25 e poi nelledizione da cui si cita, pp. 9-14; cfr. ora i pi recenti B. RIMA, Lo specchio e il suo enigma. Vita di un tema intorno a Tasso e Marino, Padova, Antenore, 1991, pp. 190-96; A. BATTISTINI, Le seduzioni barocche della Sirena Marina, in Vaghe stelle dellOrsa.... Lio e il tu nella lirica italiana, a cura di F. Bruni, Venezia, Marsilio, 2005, pp. 197-218, spec. p. 207. 10 Sospiravano i venti, e lacque stesse / al folgorar de la novella Aurora / damorose faville erano impresse, 911.
20
(6); la seconda terzina, velatamente centonata, mette poi in guardia sulluso di formule ormai stereotipate e quindi non pi impiegabili allo scopo di definire una ben precisa individualit11. I sonetti doccasione 44-6 sono invece posti nella terza parte in diretta sequenza, al fine di collocare geograficamente gli avvenimenti e al tempo stesso caratterizzare ci che sta avvenendo con unambientazione che del tutto opposta rispetto alle cerulee bellezze e mattutine dei primi 7 sonetti. In Ecco il monte, ecco il sasso, ecco lo speco (44) con un verso trimembre che focalizza visivamente il luogo mediante il reiterato uso del deittico, descritta la sepoltura del Sannazaro, attorno alle cui ossa ignude si muove uno stuol di meste sirene 12. Qui il mare piagne pietoso e laria sospira, mentre in Arpie del mar, che da lestreme sponde (45) le onde e le spiagge sono piene / di spavento e dorror a causa della minaccia dei corsari che costeggiano Taranto. Il non ancora esplicitato contrasto religioso si rende palese nel sonetto seguente, Questo il mar di Corinto: ecco ove lempio (46), dedicato alla vittoria presso il golfo di Lepanto (1571) della flotta cristiana, comandata dal giovinetto ibero don Giovanni dAustria, su quella musulmana 13. Il nemico formato dalle idolatre e false / squadre del fier Soldan, opposte al pi compatto gran navilio cristiano; Proteo e Tritone sono solidali con i futuri vincitori 14, per cui il liquido elemento finisce per riempirsi dei cadaveri e sangue nemici. Il sonetto dunque
11 E curvandosi il mar sotto la prora / con rauco mormorio parea dicesse: / -Et io minchino a riverirla ancora.-, 12-4 deriva da L. TANSILLO, cap. Era dunque ne fati, occhi miei cari (III), 48: e londa sotto i remi si corcava; N. FRANCO, son. Lungo le salse rive di Citera (VI), 7: Sol londe parean dir col mormorare; B. TASSO, egl. pescatoria L dove i bianchi pi lava il Tirreno, 92-3, [il mare] ecco che come / donna e regina sua, tinchina e onora. 12 Fan nido i cigni entro la dolce lira, / e ntorno al cener muto, a lossa ignude / stuol di meste sirene ancor saggira, 12-4; probabile il legame con le fantasie di morte di Fileno di O terror dogni rete e dogni nassa (9), dove lanima del defunto a girare intorno al corpo: Vien [il pescespada] con lacuta punta e l cor mi passa / s chio traffitto in mezo al mar ne cada, / e col corpo insepolto intorno vada / lombra errando di me dolente e lassa, 5-8. La sepoltura del Sannazaro era gi stata descritta in G. C. CAPACCIO, Mergellina, cit., p. 4: Quel gran pescatore Sincero, che nel tuo seno tra gelidi s, ma bianchi, ma vivi, ma rari marmi tra celesti numi accompagnato si giace, le cui ceneri sparse di rose emole sono alle ceneri del mantovano pastore. 13 Sullavvenimento e sulle sue ripercussioni in ambito letterario cfr. C. DIONISOTTI, La guerra dOriente nella letteratura veneziana del Cinquecento, in ID., Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967, pp. 20126, ID., Lepanto nella cultura italiana del tempo, in Lettere italiane, XXIII (1971), 4, pp. 473-92 e C. GIBELLINI, Limmagine di Lepanto. La celebrazione della vittoria nella letteratura e nellarte veneziana, Venezia, Marsilio, 2008 (il sonetto del Marino citato alle pp. 183-86 in parallelo col canto XXV dellAdone, ove la rievocazione di Lepanto pone laccento sul lutto dei vinti). 14 Raccolto Proteo il suo ceruleo armento / lalta strage predisse; e Triton poi / cantolla a suon dorribil corno al vento, 9-11.
21
funzionale allambientazione della tempesta finale e al tempo stesso smorza i toni per la possiblit di polemiche di argomento teologico riguardanti lultimo sonetto, nel quale le leggi divine vengono messe a soqquadro dal guanto di sfida lanciato da Fileno.
FilenoIl personaggio di Fileno non si allontana dal pescatore innamorato descritto dagli autori precedenti e contemporanei a Marino, soprattutto di area napoletana: il nome infatti non rappresenta ancora lalter ego dellautore, come accadr nellAdone, ma aderisce al topos del pescatore amante che cerca di conquistare lamata ritrosa secondo le modalit ben collaudate della tradizione lirica di area napoletana. I primi sonetti delle Rime marittime sono dedicati alla lode di Lilla. In Spuntava lalba, e l rugiadoso crine (2) si descrive il sopraggiungere dellalba, unica nella sua levit: tramite una notevole metonimia Clori scuote grembi di fior, mentre il mare viene per la prima volta a scambiarsi con il cielo15. I lidi e gli scogli si fanno di smeraldo, gli specchi dacqua argento incorniciato da zaffiri e perle: tutto questo a causa della prevedibile presenza dellamata, svelata da Marino solo nellultima terzina, per cui Fileno non pu che chiedersi -Or chi menar potea mai seco, / altri che l mio bel sol, s lieto giorno?- (13-4). Il sonetto Rotte gi londe da lardenti rote (3) simile al precedente per la descrizione del fenomeno atmosferico, ora il levarsi del sole, che si rivela subordinato allamata venendo definito come il simulacro di Lilla: il salutare il sole consigliato ai pescatori e alle Nereidi conduce quindi ad onorare la donna alla stregua di una entit ultraterrena 16. Ma le lodi non sono sufficienti senza lintervento di Amore, narrato in A due di duo begli occhi Orse fatali (5). Il figlio di Venere descritto nellatto della navigazione sulla materna conca; i suoi attributi tipici diventano gli strumenti fondamentali al periplo al
15 Le cerulee bellezze e mattutine / il mar dal ciel, il ciel dal mar prendea: / e tranquillo e seren senza confine / un mar il ciel, un ciel il mar parea, 5-8. 16 Sorgete (ecco ecco il sol, che l mar percote) / Craton, Sergesto, Oronte, et Alcinoo: / e voi di Nereo figlie e dAcheloo / salutatelo a prova in dolci note, 5-8. Si noti sul piano stilistico linusuale rima in -oo, ad esprimere lammirazione per il carro solare che si libra nellaria trainato da Piroo: Rotte gi londe da lardenti rote / fiammeggian l nel luminoso Eoo, / e fa laurato fren sonar Piroo / mentre che l salso umor dal crin si scote, 1-4.
22
fine di rendere pi realistica la situazione 17, mentre la motivazione del viaggio data con la tradizionale metafora del porto-cuore: Amore si dirige verso il cuore di Lilla, ove Fileno potr trovare lappagamento dei suoi desideri18. In Avea su per lo mar, del biondo crine (6) lamata descritta nellatto di spiegare la propria chioma sopra lacqua, realizzando nella pratica la trita metafora dei capelli considerati trappola per gli amanti19: i lacci tesi dalla donna fanno infatti abboccare i pesci, dun dolce foco in mezo lacque accesi. Solo lamante pu comprendere le loro parole, per le quali dolce morir fra s pompose reti20. Alle lodi dellamata seguono alcuni sonetti dedicati ai doni fatti dal pescatore a Lilla. In Un bosco di coralli in que confini (7) Fileno ha raccolto duo tronchi di corallo dotati ciascuno di cento rami, a sottolinearne il pregio. Ma allofferta si accompagna nellultima terzina una richiesta, determinata dalla metafora labbra-coralli: (...) ma se da me tu vuoi / di coralli s bei doni eccelsi / dona i coralli a me de labri tuoi. Dono pi disinteressato quello di Quante per queste mai piagge arenose (10), ove Fileno offre a Lilla un monil composto da perle. Le secrezioni dei molluschi derivano nella finzione poetica dalla solidificazione delle lacrime dellamante infelice, provocata dallo sguardo di Lilla (tutte [le lacrime] in lucide perle e preziose / de tuoi begli occhi il sol ratto le volse, 5-6). La collana far s che aggian tuttaltre ninfe invidia e scorno della bellezza della donna, ma i benefici saranno maggiori se Lilla far piangere Fileno non pi di dolore bens di dolcezza: Forse navrai di vie maggior ricchezza / se (tua merc) fia che l suo pianto un giorno / come fu gi di duol, sia di dolcezza, (12-4). Poich Lilla non ha ricambiato il sentimento, in Ricci pungenti, o misero Fileno (12) Fileno medita tra s quale dono le si conf maggiormente. La prima ipotesi, legata allambiente marittimo, quella di alcuni ricci pungenti, che possiedono spine e un
17 Egli larco timon, remi gli strali / fatto, e l candido lino agli occhi tolto / e n sembianza di vela a laria sciolto, / laure movea col ventillar de lali, 5-8, ove ventillar de lali espressione gi usata in Rime amorose, Giace inferma madonna. Amor che fai (70), 10. 18 Per dar al corso suo porto in costei, / fatto nocchiero e navigante Amore, 13-4. 19 Sulla metafora si soffermato O. BESOMI, Ricerche intorno alla Lira di G. B. Marino, Padova, Antenore, 1969, pp. 40-1. I molti esempi cinquecenteschi riportati fanno comprendere come essa fosse ormai convenzionale, ma il critico precisa che prima del Marino non appare per mai svolta oltre la semplice e sommaria indicazione capelli ondeggianti. 20 Evidente ladynaton dei pesci parlanti, che nellAdone verranno definiti popol muto (IX, 47, 8).
23
duro scheletro ma contengono un dolce frutto e gentil al proprio interno. Il cuore di Lilla ben pi duro21, per cui il pescatore opta dapprima per lorsa e per langue, poi per sostanze liquide come il suo stesso pianto o il suo sangue 22, dal momento che la donna gode nel vederlo soffrire. Nella seconda terzina c perfino spazio per lautobiasimo: solo chi desideroso di morire pu amare Lilla, letteralmente divenuta femme fatale (Chi non sa ci che sia malvagia sorte, / chi vago di morir vivendo langue, / ami costei, ch quantamar la morte). Dopo Se n te sdegno, in me duol pi sempre abonda (13), in cui esplicitato il desiderio di morte dellamante nel mare tempestoso tramite annegamento, che le condizioni climatiche non rendono possibile a causa del sol degli occhi di Lilla in grado di rasserenare lambiente, in Tal qual mi vedi, o dispietata Lilla (14) Fileno muta strategia per procacciarsi le grazie dellamata. Nelle quartine il pescatore afferma infatti che, pur di conservarsi per Lilla, rifiuta le avances della figlia pi degna di Nereo, Eurilla, innamorata di lui23; nella seconda terzina scusa invece la sua povert materiale rispetto allamata, tesoro del mar per il quale la cattiva sorte (povera stella) arricch comunque la mente e il cuore di Fileno24. Nei sonetti seguenti dato invece spazio al biasimo per il comportamento irriconoscente dellamata. In Tante non han su l crin falde nevose (15) si sottolinea lirrisione per i pianti di Fileno, che definisce la donna un vivo scoglio (...) assiso in scoglio che trascura le numerose ferite inferte da Amore al cuore dellamante 25. Lilla finge di non sentire i preghi e i pianti, per cui Fileno si rivolge in Triton, deh shai piet de miei tormenti (16) direttamente a Tritone e a Proteo affinch arrestino per qualche tempo le
21 Nel sonetto precedente, Pari al mio generoso alto desio (11), il cuore veniva assimilato allindica pietra, la calamita, che guida la navigazione ma al tempo stesso per la sua durezza spunta il dardo di Amore. 22 Dono le fia pi caro unorsa, un angue; / ma pi, segli averr che tu le porte / un vaso o del tuo pianto o del tuo sangue, 9-11. 23 Per me si strugge la famosa Eurilla. / Per me si strugge, e s dAmor sfavilla / chaccende di sospir lalghe vicine, / e questonde tranquille e cristalline / turba col pianto, che dagli occhi stilla, 4-8 . Il tema presente ad es. in A. ONGARO, Alceo, cit., p. 28r. 24 Ricco io non son, ma tu dAmor rubella / se tesoro del mar: di te mi feo / ricca la mente e l cor povera stella, 12-4. Si intendono in questo modo i versi 13-4, diversamente dal commento alledizione utilizzata, che vedeva unantitesi tra ricchezza della mente e povert del cuore, non ammessa per dalla 3 a persona singolare dellimperfetto feo. 25 Ma tu rigida mia, di questi lidi / ninfa non deggio dir, fera non voglio, / de pianti del tuo misero ti ridi. / Et hai s pari a la belt lorgoglio / che se pur, lasso, al mio pregar tassidi, / vivo scoglio rassembri assiso in scoglio, 9-14.
24
onde e i venti in maniera che lamata non abbia alibi per trascurare lamore a lei rivolto26
. Tutto ci non sortisce leffetto sperato: in Desta dal pianger mio, gi doro adorno (17) la
natura partecipe delle sofferenze di Fileno mediante laurora che fa cadere lacrime di rugiada, Cinzia (personificazione della luna) che si mostra pallida per doglia e piet e la notte che ha orrore della condizione dellamante, ma solo Lilla rimane impassibile sulla sua posizione di rifiuto27. In Questo, che quasi un pargoletto scoglio (19) Fileno si paragona invece ad unostrica che vive circondata da un ocean torbido ondoso rappresentato dallastio dellamata, alimentato da martir grave e feroce orgoglio. Ma il mollusco assomiglia alla stessa amata, pronta anche a dare la morte al cuore di Fileno (nella metafora un polpo) pur di difendersi28. Nei due sonetti successivi Fileno dichiara poi la nobilt del mestiere di pescatore, inserendosi perfettamente nel solco della tradizione di area napoletana. In Chio basso, io vile, io pescator mi sia (20) a questo scopo indicata la vicenda di Glauco, anchegli pescatore prima della sua elezione a divinit29; Fileno afferma inoltre di usare non una povera canna per ottenere il minimo indispensabile alla propria sussistenza, ma lo spiedo aguzzo e il tridente, al fine di insidiare animali pi grandi e feroci come foche, orche e pistrici30. In Perchio col curvo e pargoletto legno (21) invece, dopo aver paragonato il mondo al mare31, viene indicato Amore come esempio di noto pescatore,
26 Tornin tranquilli i molli campi azurri, / sia la foce dEolia in tutto chiusa, / restin taciti i venti, e londe immote. / Perch dal fremer lor, da lor sussurri / fatta sorda omai Lilla, empia si scusa / che i miei preghi, i miei pianti udir non pote, 9-14. Modello di riferimento il sonetto di N. FRANCO Queta, o bellAdria, ogni turbato aspetto (I), 9-14: (...) il duol di Cloanto aspro infinito, / per cui la vita e l fier destin accusa, / udir si facci al tuo tranquillo lito. / Et quindi Galatea, del tutto esclusa / la cagion desser sorda al pianto ordito, / nel gran fremer che fai non trovi scusa. 27 Freme il mar, trema lalga e geme il vento, / la notte stessa ha del mio stato orrore: / Lilla, e te sol non move il mio lamento, 12-4. 28 Anzi pur te rassembra, a cui se mai, / qual famelico polpo, il cor sen corre, / in pena de lardir, morte gli dai, 12-4. 29 Pesc pur egli il padre Glauco, e pria / che de limmondo suo con cento fiumi / purgato fusse de cerulei numi, / le scagliose del mar prede seguia, 5-8. Glauco citato come esempio da L. TANSILLO nella canzone Tu che, da me lontana, ora gradita (XV), utilizzata come fonte per il sonetto mariniano: Glauco, chor siede a mensa / coi dii, duro le mani e scalzo il piede, / non trasse al lido le scagliose prede?, 24-6. 30 Gi non son un de pescatori mendici / che l vitto, ignudo al sol, col fil pendente / da la povera canna si procaccia. / Ma con lo spiedo aguzzo e col tridente / dingorde foche e dorche e di pistrici / nate a la morte altrui, seguo la traccia, 9-14. Fonte ancora la canzone del Tansillo citata alla nota precedente: Non son vil pescator, che l d mi corche / sovra i sassi, e mendche, / con lumil canna, il cibo, onduom si vive; / ma seguo col tridente e forche ed orche, / che per londe nemiche / vengono a depredar le nostre rive, 27-32. 31 Ma che altro che mar il mondo tutto, / sempre commosso? Or par che scemi, or cresca, / e per venti sospir, per onde ha lutto, 9-11.
25
questa volta sul piano prettamente metaforico: il cuore di Fileno rimasto infatti irretito dalla sua esca, la bellezza di Lilla 32. Il mestiere in questione non dunque dostacolo ma idealmente funzionale alla soddisfazione del desiderio amoroso del suo rappresentante. In Or che laria e la terra arde e fiammeggia (22) Fileno invita lamata a godere sullarena dellombra procurata dalle fronde dellelce. In un momento in cui il mare saettato dal sole divenuto emulo del ciel e la sua acqua assimilata alla solida sponda tramite i rispettivi rappresentanti animali 33, il dissidio Lilla-Fileno pu venir meno e risolversi in concorde armonia 34. Fileno torna a questo fine a lodare la bellezza di Lilla con In vece di canzon queste parole (23), ove la donna descritta come una novella (...) Venere che ha reso il mare un novo paradiso, ma tutto ci si rivela inutile se in Mentroggi assisa in su le piagge erbose (24) e Lilla, qualor veggio che l ciel savolga (25) emerge la gelosia per tutti gli di e animali che potrebbero privarlo dellamata. Dopo il gi analizzato sonetto di assimilazione al personaggio di Miseno, In questo mar, qual fulmine che piomba (26), in N tante intorno a s, dentro e di fore (27) le bellezze dellamata vengono descritte come motivi di pena: i duo begli occhi sono ricchi di spine velenose come quelle della tracina, mentre il biondo crin tende reti, lacciuoli et ami allincauto amante. Non resta che chiedere, con lartificiosa rapportatio dellultima terzina, Ma tu, sola cagion de miei cordogli, / Lilla, la piaga, il foco, il nodo mio, / ch non sani, non tempri e non disciogli?: solo la donna causa di dolore, solo la donna pu guarire colui che ha fatto ammalare. Il non ricevere risposta provoca lo sdegno di Fileno in Abbia chi mai per te pianti e sospiri (28), che dapprima si ripercuote su se stesso facendo riemergere il desiderio di morte di O terror dogni rete e dogni nassa (9) e Ricci pungenti, o misero Fileno (12)35, poi su Lilla, orca ingorda pi dei mitici mostri Scilla e Cariddi36.
32 Amor (non chaltri) Amor naviga e pesca: / ahi, che l mio cor nuotando entro l suo flutto / preso rimase, e tua belt fu lesca, 12-4. 33 Vedrai scherzar su per la riva amena / il pesce con laugel, lombra con londa, 13-4. 34 Cfr. G. POZZI, Metamorfosi di Adone, in Strumenti critici, 16 (1971), pp. 334-56, spec. pp. 338-39. 35 Abbia chi mai per te pianti e sospiri / sparge, nemico il ciel, nemico il vento; / e l pi gli avolga in cento nodi e cento / brancuto pesce, e gi nel fondo il tiri, 1-4. 36 O pi che Scilla e che Cariddi ingorda, / orca, mostro maggiore del nostro faro, / pi che mar, pi che scoglio, iniqua e sorda, 12-4.
26
In Allor che f cangiando, il core e i passi (29) sono invece ricordate le parole damore tracciate da Lilla sulla spiaggia di Mergellina: Allor che f cangiando, il core e i passi / fia chaltrove rivolga, o che sasconda / Lilla dal suo Filen, dura questonda, / e questo scoglio liquido vedrassi37. Fileno apostrofa lo scoglio e londa affinch i due adynata vengano a verificarsi, dal momento che Lilla daltrui, Filen lasciato in pena, e rimane lo spazio per una conclusione di tipo moralistico sul valore delle parole espresse dalle donne che si inscrive nella tradizione lirica cinquecentesca38. Nella realt Lilla non ha mai amato Fileno, che solo in questi ultimi sonetti sembra rendersene conto. In Oggi l dove il destro fianco ad Ischia (30) sono elencati alcuni amori tra pesci (la conca, il nicchio, la biscia del mar, lalgente anguilla, occhiate e salpe39), rispetto ai quali la rigidAlpe del cuore di Lilla mai si ammorbidita 40. Nel ricordare lanniversario dellinnamoramento in Dal d che gli occhi a tuoi begli occhi femmi (31) avviene per un notevole ribaltamento per il quale sul fino allora celebrato Amore si addossano le colpe dellaffanno e pena, mentre Lilla viene privata di qualsiasi responsabilit: altro mai, Lilla mia, cibo non diemmi / chaffanno e pena, e quanto lui nincolpo, / tanto te del mio mal dolce discolpo, / te, che larene indori e lacque ingemmi (5-8). La donna davvero inespugnabile, e il pescatore avrebbe dovuto capirlo dal cattivo presagio della visione simultanea di una cornacchia e un gufo, tipici uccelli del malaugurio: Or mi rimembra, oim, che daridelce / col presso Pioppin con la sinistra / cornice il tutto a me predisse il gufo (12-4) 41. Il presentimento di sventura per la predizione dei due animali indovini si manifestato troppo tardi, tormentando inutilmente il cuore dellamante per tutti questi
37 La fonte ancora una volta una canzone di L. TANSILLO, Qual tempo avr gi mai che non sia breve (XIV): Allor che Galatea non avr caro, / via pi che gli occhi, Albano, / liquido questo monte, e l mar fia duro!, 17-9. 38 Folle chi crede (or men rammento e doglio) / a parole di donna, e scritte in rena, 13-4. La sentenza deriva dalla canzone del Tansillo prima citata: Ma tutte le promesse / e tutti i giuramenti, / che innamorate donne ad uom mai fenno, / su larene e sul mar scriver si denno, 33-6, sulla scorta di A. POLIZIANO, Stanze per la giostra I, 14. 39 Il tema degli amori tra gli abitanti del mare ben presente nella tradizione cinquecentesca: cfr. ad es. A. ONGARO, Alceo, cit., p. 5r e G. C. CAPACCIO, Mergellina, cit., pp. 36-7. 40 N per vidi mai, perfida Lilla / te fatta a me cortese, e se non rotta, / men dura del tuo cor la rigidAlpe, 12-4. 41 Fonte J. SANNAZARO, Arcadia, egl. X, 168-70: Gi mi rimembra che da cima unelice / la sinestra cornice, ohim, predisselo; / che l petto mi si fe quasi una selice; la cornix definita sinistra gi da VIRGILIO, Bucol. IX, 15.
27
anni. Il desiderio di morte torner perci a manifestarsi negli ultimi sonetti, non essendoci pi alcun motivo di esistere, e verr soddisfatto proprio grazie allassenza della donna, che con i suoi occhi non rendeva prima possibile la tempesta42.
42 Cfr. Se n te sdegno, in me duol pi sempre abonda (13), dove le lacrime di Fileno incrinano la staticit delle acque, ma lo sguardo di Lilla riporta tutto alla calma: Ch, se la pioggia, che s larga io stillo, / il perturba talor, tu tosto il fai / col sol degli occhi tuoi piano e tranquillo, 12-4.
28
Fileno nel canto IX dellAdoneDopo le Rime marittime il pescatore Fileno fa la sua ricomparsa nel canto IX dellAdone43. In seguito ai Trastulli del canto VIII Venere e Adone si recano ora in visita alla fontana dApollo, costruzione che segna il trionfo della poesia sulle altre attivit terrene. Il trasloco del Parnaso in Cipro non avvenuto in maniera immotivata, ma con lesplicita volont di segnare lelezione del genere amoroso al grado supremo del poetabile44. La finalit emerge subito a partire dalle prime sei ottave proemiali: linvocazione diretta agli occhi dellamata, affinch questi volgano i rai cortesi e diano lingegno e lo stile necessari al poeta si inserisce nella lirica cinquecentesca di genere amoroso gi utilizzata da Marino nelle Rime del 1602. Daltra parte il poeta desidera che il guiderdon per le sue fatiche poetiche sia corona di mirti e non dallori, prendendo cos le distanze dal pi nobile poema epico. Cupido stesso, allottava 4, a permettere materialmente la scrittura, dal momento che ha fornito al Marino la penna: Dalali del pensier che spiega il volo/ l donde poi qual Icaro trabocca, / anzi pur dala sua, svelse la penna / con cui scrivo talor quantei maccenna (5-8) 45. Alle ottave 5 e 6 viene invece anticipata la lite tra i cigni-poeti descritta solo a partire dallottava 165; con il procedimento della recusatio Marino afferma infatti che, se fosse uno degli augei saggi e canori, eleverebbe il proprio rozzo stil al fine di cangiar Venere in Marte, il plettro in tromba e seguire cos i modelli di Tasso e Ovidio46: ma siccome ci non possibile, non resta che proseguire il gi intrapreso
43 Nelle Rime del 1602 Fileno compariva ancora nella seconda parte nella canzone degli Amori notturni, dove giungeva finalmente al possesso fisico di Lilla: da le sue labra il fior de lalma coglio; / e mentre il molle seno avien chio tocchi. / e vo tra pomi suoi / scherzando, e mille baci or dono, or toglio, / tal, che lasso parea, / pronto si desta e leva, / ondio pur di morir dolce minvoglio, 91-7. Laccentuata sensualit del componimento cost al Marino la prima censura ecclesiastica: cfr. C. CARMINATI, Giovan Battista Marino tra inquisizione e censura, Padova, Antenore, 2008, pp. 13-4. Il personaggio era ritornato anche nella Sampogna, seppure in ambito pastorale: cfr. Idilli pastorali, La bruna pastorella, ove Lidio rivela allamata Lilla la partenza di Fileno-Marino per la Francia del gran pastor di Senna Luigi XIII. Fileno compare ancora nella stessa sezione ne La ninfa avara in veste di pastore invaghito di Filaura, esplicitando il proprio amore secondo le tradizionali modalit bucolico-pastorali (riferimenti alla mitologia e alla natura, tema del carpe diem, promesse di cantare la bellezza della donna) che vengono schernite dalla donna (Fileno, il tuo discorso / vago e dotto invero; / ma s trito e commune, / e gi s antico omai, che sa di vieto, 272-75), fino alla lode delloro dei versi 501-45, che rovescia la condanna delle Stanze per la giostra di Poliziano e del Pastor fido di Guarini. 44 G. POZZI nel Commento a G. B. MARINO, LAdone, a cura di Id., Milano, Adelphi, 1988, 2 voll., II, p. 414. 45 Per il tema cfr. il sonetto del Tansillo Amor mimpenna lale, e tanto in alto (II). 46 Il primo riguardo al poema epico, il secondo a quello cosmogonico: E l duce canterei famoso e chiaro / che,
29
canto di Venere e Adone. Si vedr tuttavia che alle ottave 56-8 Venere prometter a Fileno-Marino, in cambio della narrazione dei suoi diletti e dolor per Adone, il reciproco innamoramento di Lilla e il postumo ingresso dellanima del poeta nel felice drappel de cigni: tutto questo a marcare la parit dimportanza tra il poema in molli versi e i pi celebrati epico e cosmogonico, raggiunta solo grazie a Marino. Venere e Adone si recano sul carro costruito da Vulcano appositamente per la dea, trainato in mare da duo mostri simili a sirene 47, sotto la guida della ninfa Idrilia. Durante la navigazione i pesci guizzanti in acqua si rendono simili a stelle dargento, sullesempio del sonetto marittimo Pon mente al mar, Cratone, or che n ciascuna (43)48, mentre Amore come da tradizione pesca le anime dei due amanti (Amor con altro laccio e con altresca / di Ciprigna e dAdon lanime pesca, 17, 7-8); la vegetazione dellisola tende invece a fondersi con lacqua marina, favorendo il dialogo tra le divinit dei due elementi (Tra smeraldi e zaffir lombre con londe / scherzano gareggiando assai vicine; / ed han commercio insu le ripe estreme / le verdi dee con le cerulee insieme49) e il miscuglio tra i loro prodotti 50. Lio lirico afferma poi di aver visto un luogo del tutto simile a questo, non fosse che si trova su di un fiume, l dove trae la bella Polidora / dala Dora e dal Po nome immortale (23, 3-4): il primo riferimento autobiografico del canto dunque rivolto al soggiorno torinese degli anni 1608-14 51. La fontana stata innalzata da Vulcano in onore di Apollo dopo che questi gli ha rivelato il legame adultero tra Venere e Marte: la sua edificazione in un luogo cos prominente, seppur accorsa in seguito a un avvenimento a tutta onta della dea, starebbe comunque a simboleggiare la poesia amorosa in quanto sovvertitrice di tutte le anime,
47 48 49 50 51
di giusto disdegno in guerra armato, / vendic del Messia lo strazio amaro / nel sacrilego popolo ostinato; e canterei col Sulmonese al paro / il mondo in nove forme trasformato, 6, 1-6. noto che Marino aveva intenzione di emulare i due poeti rispettivamente con la Gerusalemme distrutta e le Trasformazioni: cfr. E. RUSSO, Marino, Roma, Salerno, pp. 220-30, 247-50. Duo mostri il tranno: han duomo e di delfino / questi le membra e dambo un misto fassi; / umana forma ha quella parte chesce / delacque, il deretan termina in pesce, 11, 5-8. Cfr. ivi, Ve come van per queste piagge e quelle / con scintille scherzando ardenti e chiare / volti in pesci le stelle, i pesci in stelle, 9-11. 20, 5-8. La descrizione dello specchiamento tra terra e acqua dipende dal sonetto marittimo Or che laria e la terra arde e fiammeggia (22) e Adone VIII, 23: cfr. G. POZZI, Metamorfosi di Adone, cit., pp. 336-37. Quante cadder tra perle e tra coralli / i pomi che pendean poco lontani / e la vendemmia che accolsero i cristalli, / gi di vivo rubin gravida i grani, 22, 1-4. Sul quale cfr. E. RUSSO, Marino, cit., pp. 87-148.
30
delle umane come delle divine. Lofferta di doni a Venere da parte di una sirenetta leggiadra52 offre poi il pretesto per il primo intermezzo mitologico del canto: la narrazione da parte della madre di Amore della nascita della perla (28-46). Il tema tratto dalla Naturalis historia di Plinio (l. IX, 106-11), con leggere variazioni destinate ad accentuare la preminenza dellisola di Venere su tutti i loci amoeni terrestri. Cos le isole elencate nel testo latino non producono perle in gran quantit come Cipro (Sappi che di ricchissime rugiade / lIndia, lArabia, Eritra e Trapobana / tanta copia non hanno o Paro o Gade, / o daustro il mare o il mar di tramontana, / quanta in queste felici alme contrade / ne versa ognor del ciel grazia sovrana 53), mentre con una notevole immagine i colombi sacri alla dea le inghiottono e le rimandan fuor con gli escrementi / pi perfette, pi pure e pi lucenti (30, 7-8). Le perle sono lodate per la loro nobile origine (generoso alto concetto), per la gran virt con la quale sono capaci di confortar lanime meste, per qualit estetiche (lo splendor reca diletto) e perch le conchiglie da cui nascono sono state fondamentali nella biografia di Venere: Queste diero la cuna al nascer mio, / queste per barca e carro ancor volsio54. Al formarsi della perla, narrato alle ottave 33-5, concorrono diversi elementi. Con il giungere mattutino dellaurora la picciola stilla dacqua cade dal cielo e, condensata in rugiadoso gelo dallaria, viene accolta nel cavo sen di una conca lasciva che provveder al concepimento del candido frutto. La possibilit che la perla assuma diversi colori a seconda delle condizioni climatiche, come specificato da Plinio55, non viene contemplata dalla dea, dal momento che Marino con una lieve variatio fa corrispondere il colore della concrezione alla purit del corpo molle del bivalve, in grado di vincere de lalba i luminosi albori. Alle ottave 36-40 viene invece
52 Lunica tra le tre figlie dAcheloo ancora vivente, come verr spiegato a 41-5, poich le due sorelle si ucci