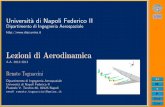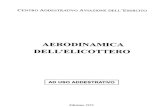Sopra alcuni problemi di aerodinamica
Click here to load reader
-
Upload
luciano-orlando -
Category
Documents
-
view
220 -
download
4
Transcript of Sopra alcuni problemi di aerodinamica

,t6
Nora di LUCIANO ORLA:NDO.
Nella Br iga ta specialisti de1 Genie milila~~ avente sede
in Roma, esiste un vent i la tore molto potente e molto ben co- struito, il quale, mediante oppor tuna camera di compressione, pus fornire , da una luce di o t tanta per o t tanta cent imetr i , una cor ren te d' al'ia n o n vor t i co sa della ~'elocit'~ di ventici-
que met~i al secondo. Approfittando del cortese consenso del sig. Comandante
la Bt'igata, io he potuto, col concorso del sig. tenente Crocco, uMciale addetto al r ipar to aerodinamico, inst i tuire una settle
di curiosi esperimenti , t~ivolti a ce rcare la spiegazione di un fenomeno che he qui l' onore di descrivel-e ~).
Innanzi ella bocce del vent i la tore o~a detto pl 'esentiamo la par te piana di un bastoncello semicilindrico, impernia to ad un manub~io, in mode che sia l ibero di ro ta re in un sense o nell'alt~-o, ma non di re t rocedere . Se assumiamo pet �9 pr.ecisare le idee, un sistema di coordinate car tes iane ortogonali , e sup- poniamo che il vento venga dalla direzione positive dell ' asso delle x, il solido che noi consider iamo sal~. il luogo dei punti
col ' r ispondenti a queste limitazioni :
x=<o, x'+z'_<_~ ~, -~_<y_<~
dove assegniamo ad ~ la lunghezza, per esempio di un cen- timet~'o, e a k la lunghezza di sette cen t imet r i e mezzo. II pera io att~ave~'ser~ il bastoncello secondo l' asse delle x, e ii
1) II sig. Patrick, in un;~ ConmniC, azione ai IY Congrosso d'aerostazione~ tenu•osi in Pietmburgo hell 'estate 1905, dimostl'b d ' ave r osservato un case molto simile ~, quello al quale si riferisee l~ fig'. i . II sig. 1)atrick praticava una scanalatura loagitu- diaale snllu faccia piana del semieilindro. Ma gih nel 1897 il sig. P. La Cour arena applicato ai molini a vonto questo ordine di ideo (ForsSg reed smoa M61leJ~modeller. IageniSren 1897). Reeenteale~te il sig. Riabouschi,lslCy~ coadiuvato d~ egregi studiosir ha instituito, in un laboratorio eccellente, uua serio di notevoli esperienze. Vedel'e il BoulletiJ~ de l'I~,.~tilut .Adrodh~ami~te de Kotttch/no~ fast. I~ 1906~ peg. 18 e seg.

PROBLEM[ D[ AERODINAMICA '~7
manubcio starh nella reg ione delle x negat ive. II solido e r a definite ~ libero di rota te , sWisciaudo colla sua faccia piana sul piano yz, ma il contrasto del venlo gl ' impedisce di avan- zare verso le x positive, e i l contrasto del manubrio g t ' i m - pedisce di re t rocedere verso le x negat ive.
P~'esentato senz ' altro, nel mode e ra descritto, il baston- cello a l l ' a z ione del vento, esso r iceve un sistema di spinte paral lele che si scaricano sul pernio, e, se anche riceve, come vedremo, altve spinte, la s immet r ia di queste ~ tale che esso r imane immobile. Ma se invece impr imiamo al hasten- cello un movimento di rotazione int(wno a l l ' a s se delle x, Ma
in un sense, come anche nel sense opposlo, noi vediamo che questa rotazione si accelera e tende a d iven ta re molto note- ve lmente veloee.
L ' intel~a spiegazione, quant l ta t i va del fenomeao si p~e- senta molto difficile: sarebbe, nel presente state della fisica matematica, un arduo problema quello di voler de t e rmina te [ 'azionalmente 1' espeessione aaal i t ica delle Ieggi di questo mote. Ma, senza pregiudizio di un ul ter iore esame, pifi mate-
matico, noi possiamo abbastanza facilmente tbrmarci una spie- gazione qe~al#atlva, aw, alorata , come si vedrh, da cara t te r i - stici espetqmenti.
z~
note che, se un corpo si muove ne l l ' a l ' i a , ed in gene- tale in ua mezzo resistente, esiste, in te rne alia p~opa del corpo, una zona di molecole del fluide, che non hanno velo- cits relat iva rispetto al mote del corpo. Tale zona costituisce la cosiddetta pro~a fluida, la presenza della qtmle ~ stata da molto tempo osservata per ]e navi nell ' aequa, e per le palle lanciate dalle a rmi da fuoco nell ' aria. La na tura prat ica del presente lavoro c' impedisee di en t r a r e in discussioni analiti-

48 L. ORLANDO
che relat ive a questo fenomeno, che b stato a t t en tamente e va r i amen te studiato.
Supponiamo che al semicil indro da noi considerato si impeima una rotazione inizia le : per iissare le idee, suppo- niamo che inizialmente si faccia diminuire con violenza la z del punto (0, k, r) , che ch iameremo punto A; con cib dimi- nuir'k in ugual misura la z del punto (0, k, - - r ) che chiame- r emo B, e c resceranno in ugual misura quelle di (0, - - k, r )
CO, - - ~ , - - ~-). In torno allo spigolo definito dalle relazioni x z O , z : =
-=---- ~', 0 _<_ y_< Is, come anche intorno all ' a l tro definito da x - - 0 , z~--~', O>=y~--It, si former's una prova fluida. Que- sta sarg dovuta a due diverse azioni, una che l ' a r i a spinta dal vent i la tore esevcita sulla faccia piana del bastoncello che le si oppone, l' a l t ra che l' a r ia eserci ta resistendo alla rota- zione del bastoncelto.
Se, pet" semplicit'a, censider iamo soltanto la sezione ese- guita col piano l imitante y-----k, noi possiamo all ' incirca rap- peesentarci la peora fluida come risulta dalta par le t ra t teg- giata dalla fig. 1. Cib a v v e r r e b b e ugua lmente se c ' immagi- nassimo soppresso il ven t i l a to re ed animato 1' apparecchio, non soltanto della rotazione nel senso da A verso B, ma an- che di un ' oppor tuna t raslazione verso le x positive.
Cosl stando le cose, la nuova aria, che sopravviene dal x'entilatore, non t rova da invest i re una faccia piana, ma in- veste, come si vede dalla figura, una ve ra paletta di elica, dunque accr la rotazione nel senso da A verso B.
Ma, ol t re a questo, l ' a r ia spinta dal vent i la tore , tende anche a distaccare la p rora fluida dalla parete cu rva poste- ~qore del semicilindro, e de te rmina , in contat to con questa paeete, un forte risucchio ; l' azione t h e ne risulta cospira a
far ro t a t e il sistema nel verso indicato.
Non ~ ancora tutto. Un ' a l t ra azione cospirante a larlo cosi ro ta t e ~ dovuta al mollente, che si forma nelle vici- nanze di A (e di tut to il re lat ivo spigolo, e, s immetr icamente , in modo cospirante, anche dalla par te delle y negat ive) . I fi- letti fluidi, spinti dal vent i la tore , sfiorando A, r ich iamano r io . l en temente le molecole d' ar ia pifi vicine, che stanno nella

PROBLEMI Did AERODINAMICA 49
regione D velat ivamente t ranqui l la ; le alWe molecole della stessa regione, le quali si tcovano alquanto pitl lontane, si pt,ecipitano a sostituire le al t re che pifi velocemente hanno seguito il filetto fluido; ed alcune, battendo in punti come C (fig. ]) imprimono una vera spinta ~'erso il basso.
Nelle corrent i d 'acqua molto veh)ci, per esempio l 'Adige, che presenta, in alcuai trat t i ed in alcune stagioni, velocit.h supe~fiori ai quattvo me~i al secondo, basra ua piccolo two- montorio, una pila di polite, uno zattevone ancovato, pet" de- tei 'miaat'e il fenomeno ova descritto del mot len te : i bav- caiuoli conoscono bene i pericoli di questi tagli di corren te . Per ve(tere che importanza abbia questo fenomeno nell ' aria, noi abbiamo, sul l 'esempio di Kousnetzov ~), costvuito un al- teo modellino, ed eseguita una decisiva esperienza.
Consideriamo un solido, costituito dalla rigida, geome- tvica unione di un cubo e di due prismi tviangolari, cosi de- finiti nel pvecedente sistema :
- l<v=<l , 2 . - - l _ < x < _ l , x - - z > O ,
3 . - - 1 < x < _ l , : c @ z < O ,
- - l _ < z _ < l ,
- - l _ < z _ < l ,
_ ] < z < l
= y = 7 , 5
- - l _ - - < y _ - < - (7 , .~}
dove i humeri espvimono centimetri . Chi volesse vederne la figura in pvospettiva, potrebbe consultare il citato Bollettino di Riabouschinsky a pag. 19.
Limitiamoci intanto a esaminave una sezione piana, per esempio quella col piano limite y-=-: tt.
Esponendo la faccia AB al ventilatove, noi vediamo che, anche senza una spinta iniziale, il bastoncello incomincia ab- bastanza rapidameate a ~'ota,'e nel vez~so da A a B. Ci5 ~ de- tecminato dalia spinta che il mollente i m v i m e nei punti come C, o, per meglio dire, dalla compoaente vert icale di questa spinta.
Ma noi possiamo subilo osservave, con un 'esperienza sulla quale richiamiamo in modo speciale t' at tenzione del lettore, che l ' az ione dovuta a! mollente ova detto ~ notevolmente meno efficace delle altve dovute alia prora fluida. 1~ i facile r e -
1) Riabouschinsky~ Ioc. elL, pag. 19.

~ 0 L . O R L A N D O
deve che, se incliniamo di una tventina di geadi, a sinist~'a, rispetto alla dieezione del vento, l' appar'ecchio, in modo cio8 che il pel-nio non segua pill l 'asse della x, ma, per esempio,
la I'etta z - - 0 x-] -y g 3 = 0 , l ' appaeecch io funziona a t l ' i n - cit'ca come un' elica e si metre ~'apidamente a ~'ota~'e da B
Z. _ _ ~B
...<-
vecso A, con una ~'otazione contravia, cio6, a quella the as- sume quando si espone f~ontalmenle, nel modo sopra indi- cato, al vent i la tore . Se la votazione u l t imamente deseri t ta (da B ~,et'so A) ~ diventata su/7~ciente~nente ~'apida, r ipor- tando l' apparecchio in posizione fi-ontale, noi vediamo che il movimento cont inua nello stesso senso. Se la rotazione non era su/7~.cientemente ~'apida, l' appa~'ecchio a poco a poco si ferma, e poi si metre a eotave invel ' samente (da A verso B).
/Z7
Non insis~erb molto sopva altvi especimenti , che potreb- bm'o iuiziare una serie di osseevazioni non soltanto qualita- t i ve : mi basterk d ' a c c e n n a c e c h e l a sezione indicata nolla fig. I, esposta col doeso cucvo verso il vento, anche con un there impulso iniziale, reade rapidsimente a fecmarsi, e che fva le sezioni desc~'itte nella fig. 3, il fenomeno si p~'esenta notevole per le sezioni I e II, meno notevole peL" la III , meno ancora pel" la IV, e non si p~'esenta per la V. Pro" la sezione IV

PROBLENII DI AERODINAMIC.4. 51
necessaria una fortissima velocitA iniziale di rotazione ed una forte ~,elocits della co r ren te d' aria, affinch~ il fenomeno si presenti .
Debbo agg iungere che ho r ipetuto questi esperimenti , con identico successo, in una grossa carrozza automobile, spinta a velocith different i ; in tale caso, r ar ia incont ra ta presen- Lava rispetto a me una veloeith relat iva, ident icamente para- gonabile alla velocits dell ' a r i a del vea t i la tore .
Riserbandomi di studiai~e in modo pi~t esaur iente questi r fenomeni, anche nelle corrent i d' acqua ~), credo che non sia male ave r accennato a t re e lement i di spiegazione, dei quali, in uuo studio razionale det fenomeno, nemmeno ~uno dow~A essere h~ascurato.