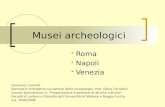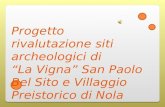Siti Archeologici Provincia Di Bologna e Ferrara
-
Upload
dheannainsugradh -
Category
Documents
-
view
16 -
download
4
description
Transcript of Siti Archeologici Provincia Di Bologna e Ferrara

SITI ARCHEOLOGICI PROVINCIA DI BOLOGNA
Cava Filo
Cava Filo è un sito paleontologico risalente al Pleistocene superiore.
Si trova in provincia di Bologna, presso la località "Il Castello" (Croara) ad una quota di 240 m s.l.m. Il nome
del giacimento deriva dallo sfruttamento per fini economici da parte dell'uomo della roccia di gesso
affiorante; i piastroni di gesso venivano tagliati con la tecnica del filo diamantato. Durante lo sfruttamento
della cava sono venuti alla luce resti di ossa appartenenti a specie oggi estinte.
I primi scavi del giacimento si sono succeduti durante gli anni '60, quando la cava era ancora in funzione.
Ulteriori indagini sono state portate avanti dal Museo Luigi Donini e dalla ditta Paleostudy a partire dal
2006 fino al 2011. I reperti sono attualmente in corso di studio presso il Museo di San Lazzaro di Savena
(Bologna).
La fauna fossile fino ad ora determinata nei diversi strati consiste in: lepre, Marmota marmota primigenia,
Canis cf. lupus, Vulpes vulpes, Mustela erminea, Meles sp., Sus scrofa, Megaloceros giganteus, Capreolus
pygargus, Bos primigenius, a cui si somma il maggior numero di reperti appartenenti a Bison priscus fino ad
ora recuperati da uno stesso giacimento in Italia.
Alla fauna si aggiungono resti botanici di Pinus e Betula negli strati più superficiali, Pinus sp., Alnus sp.,
Ulmus sp., Quercus sp. e Corylus sp. in quelli più profondi.
La datazione del sito varia dagli strati più superficiali risalenti a 11.000 anni fa agli strati più profondi
(attualmente in corso di scavo) datati a circa 20.000 anni BP, durante il culmine dell'ultima glaciazione
(chiamata Wurmiana).
Il giacimento fossile si è originato dallo scioglimento del gesso messiniano che ha creato un pozzo
verticale/subverticale dove gli animali o i loro resti scheletrici cadevano, accumulandosi e sedimentandosi
nel fondo, strato dopo strato.
Claterna
Claterna era una città posta sulla via Emilia fra le colonie romane di Bologna (Bononia) e Imola (Forum
Corneli).
Claterna sorse probabilmente come centro abitato atto a una tappa nel tragitto fra le due citate colonie,
come tanti altri centri che costellano la via Emilia, tutti a una distanza pressoché regolare l'uno dall'altro.
Con l'inizio della colonizzazione romana della Gallia Cisalpina e la costruzione della via Emilia, in parte forse
sul tracciato di un antico sentiero pedecollinare [1], Claterna fu fondata alla confluenza nell'Emilia di un'altra
strada romana che attraversava l'Appennino, forse la via Flaminia Minor, che congiungeva la via Emilia con
Arezzo.
La città, di medie dimensioni per quei tempi, sorse dunque verso l'inizio del II secolo a.C. (ufficialmente il
187 a.C.) e se ne perdono le tracce poco dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente nel V secolo d.C.;
è un raro esempio di città scomparsa in Emilia-Romagna.

Oggi poco o nulla è di essa visibile sul territorio ozzanese: l'antica città dorme sotto i campi ed i fabbricati.
La localizzazione di Claterna è fra la frazione di Maggio ed il torrente Quaderna - affluente dell'Idice - da cui
la città prende il nome [2].
Gli scavi ed i ritrovamenti
Il ritrovamento di primi reperti - dovuto all'aratura dei campi - diede la spinta a una serie di scavi effettuati
tra il 1890 e il 1933. La guida era affidata a Edoardo Brizio, direttore del Museo Civico di Bologna, e poi a
Salvatore Aurigemma, commissario della Soprintendenza alle Antichità. Altre ricerche, dirette da Guido
Achille Mansuelli, si svolsero nel corso degli anni cinquanta e sessanta.
Questi scavi si limitarono, inizialmente, a piccole esplorazioni della città antica, e misero in luce alcuni tratti
stradali, ambienti e parti di case private tipicamente romane (domus) con pavimentazioni a mosaico e
cocciopesto. Furono trovati anche edifici di funzione più dubbia (come una struttura absidata scavata
parzialmente nel 1959). Ovviamente si rinvennero anche grandi quantità di reperti vari (ceramiche,
monete, vasi di vetro, eccetera). Negli anni trenta si rinvennero alcune pavimentazioni di particolare
interesse, le quali sono oggi esposte al Museo Civico Archeologico di Bologna. Da allora le occasioni di scavo
furono molto limitate, e circoscritte in massima parte alla fine degli anni ottanta; altri interventi di scavo
furono più che altro rinvenimenti casuali dovuti alla realizzazione di nuovi impianti Enel, Hera e fibre
ottiche.
Dagli anni ottanta un gruppo archeologico organizzato da volontari e appassionati,[3] in collaborazione con
archeologi professionisti, ha riavviato campagne di scavo e animato una mostra permanente (inaugurata
alla fine del 2006 a Ozzano).
Rimane ancora parecchio da scoprire di questa antica città, sia sulla sua genesi (vi sono anche alcune
evidenze di precedenti insediamenti etruschi e celtici) sia come caso di studio particolare, dovuto al fatto
che in pochi altri casi in Italia una città è rimasta dimenticata e sepolta quasi intatta sotto i campi.
Villanova (Castenaso)
Monumenti e luoghi d'interesse
Villanova di Castenaso è celebre per la necropoli dell'Età del Ferro, primo ritrovamento della civiltà
villanoviana (da cui derivano gli Etruschi).
Villa Gozzadini e la necropoli etrusca
Nella frazione sorge Villa Gozzadini, nota per essere stata centro degli scavi del conte archeologo Giovanni
Gozzadini (1810-1887), che nel 1853 portò alla luce vasti sepolcreti dell'Età del Ferro[2], i cui principali
reperti sono stati sino ad oggi conservati in tre musei:
il Museo Civico Archeologico di Bologna;
il Museo Archeologico "L. Donini" di San Lazzaro di Savena;
il Museo Civico Archeologico Paleoambientale di Budrio[3].

Villa Gozzadini fu fatta erigere dall'omonima famiglia nel XVI secolo e nei secoli successivi vi furono
apportate delle modifiche. Attualmente (anno 2012) versa in stato d'abbandono.
Villa Manaresi
Villa Manaresi (prima villa Silvani), nota anche come la Pederzana, venne fatta costruire nel 1627 da
Marcantonio Pederzani, ricco commerciante di legnami.
Chiesa di Sant'Ambrogio
La parrocchia di Villanova è intitolata a Sant'Ambrogio. Secondo la leggenda il celebre santo milanese si
fermò da queste parti durante la sua visita a Bologna.
Oratorio di San Matteo della Pederzana
Altra testimonianza architettonica del XVII secolo è l'oratorio di San Matteo della Pederzana, di struttura
semplice, a pianta rettangolare e con campanile a vela. Sul fronte si trova una formella in cotto raffigurante
San Matteo. Questo oratorio fu edificato nel 1658 e faceva parte delle pertinenze della villa Silvani-
Manaresi.
MUV: Museo della Civiltà Villanoviana
Al conte Gozzadini faceva capo anche il cosiddetto predio di Casa Sant'Anna, un complesso rurale costituito
da una serie di edifici, tra cui un fienile e un forno-pollaio, realizzati agli inizi del XX secolo, oggi di proprietà
del comune di Castenaso. Proprio da questi due edifici si è pensato di trarne un "Centro Villanoviano".
Dopo un intervento di restauro, che permise di riportare le due costruzioni all'aspetto originario, il giorno 8
maggio 2009 è stato inaugurato il MUV, ovvero il Museo della Civiltà Villanoviana, che raccoglie i reperti
degli scavi di Marano di Castenaso e delle zone circostanti[4]. Obiettivo principale del museo è quello di
raccogliere ed ampliare le conoscenze sulla civiltà villanoviana, per poi divulgarli al pubblico, in modo da
avvicinarlo a questa antica civiltà[5][6]. L'ingresso al MUV è gratuito.
Economia
Villanova è anche un importante polo commerciale: vi sono numerosi ipermercati, magazzini e mercati
all'ingrosso, ed è qui che ha la sua sede legale la Coop Adriatica.

SITI ARCHEOLOGICI PROVINCIA DI FERRARA
Necropoli romana di Voghenza
Voghenza era un insediamento romano chiamato Vicus Aventinus o Vico Habentia, fulcro amministrativo di
vaste proprietà imperiali.
Gli scavi archeologici hanno portato alla luce un'area sepolcrale e monumentale di una certa rilevanza
databile dalla metà del I secolo d.C. alla metà del III.
I materiali ritrovati sono costituiti da ceramica comune (coppe, tazze, lucerne), balsamari di vetro e onice,
ornamenti in oro e ambra, oggi esposti al Museo Civico di Belriguardo.
Tra le 67 sepolture (inumazioni e cremazioni), spiccano il grande sarcofago marmoreo di Ulpia Pusinnica e
due recinti funerari con tombe segnalate da cippi iscritti.
Situata appena fuori dall'abitato, la necropoli non è accessibile per le visite, ma è comunque visibile nel suo
complesso da Via Dante Alighieri.
Pieve di Santa Maria in Padovetere
Nell'area di Valle Pega si trovano i resti della antica pieve paleocristiana di Santa Maria in Padovetere, un
impianto ecclesiale risalente al VI sec. d.C. che si compone di un'aula absidata, un battistero poligonale e un
campanile.
Le fondamenta della costruzione sono emerse durante i lavori di bonifica idraulica che hanno portato al
prosciugamento di gran parte delle valli di Comacchio. Il suo nome è legato all'antico ramo del Po, Padus
Vetus, che scorreva nelle vicinanze.
In questo sito sono visibili anche alcune sepolture laterizia della necropoli di Spina.
Spina (città)
Spina fu un'importante città portuale etrusca affacciata sul mar Adriatico, presso il delta del fiume Po. Fu
una delle città più importanti dell'Etruria padana, assieme a Felsina (Bologna) e Misa presso l'attuale
Marzabotto.
La città di Spina venne scavata in seguito alla riscoperta legata alle opere di prosciugamento delle valli di
Comacchio. Nella necropoli sono state trovate più di 4.000 tombe, alle quali vanno aggiunti gli scavi di una
parte dell'abitato.
Fiorì a partire dal 540 a.C., come emporio che faceva da cerniera tra mondo etrusco e mondo greco, grazie
ai collegamenti marittimi che provenivano dall'Ellade. Tra i prodotti, che venivano scambiati con le
ceramiche attiche (ne sono state trovati numerosi esemplari di fattura ateniese, spesso di qualità migliore
di quelli scavati in madrepatria), c'erano i cereali, vino e altri prodotti agricoli, oltre alle carni di maiale
salate (i "prosciutti" emiliano-romagnoli, testimoniati ampiamente sin dall'epoca etrusca). I miti vogliono
che la fondazione della città fosse ad opera dei discendenti degli "Argonauti". La fortuna di Spina decade
con l'arrivo della crescente influenza romana e dell'impero, sebbene già l'invasione celtica dell'etruria
padana fosse stata un colpo, che probabilmente non ridusse le dimensioni e la prosperità della città, ma
limitò notevolmente la sua capacità di crescere. I traffici si spostarono verso sud nella zona del ravennate,
area che sarebbe divenuta poi centrale sul finire dell'Impero Romano. Ravenna fu infatti capitale
dell'Impero Romano d'Occidente (402 - 476). Spina, inoltre, in balia delle continue modifiche del territorio
costiero e vallivo venne infine sommersa.

Nella necropoli sono stati trovati numerosi corredi funerari, con manufatti dal gusto sfarzoso, che
testimoniano la prosperità dell'insediamento. Sono state reperite oltre 4.000 tombe. Le tombe sono
generalmente singole in associazione alle quali si trovavano i corredi. Al momento della sepoltura una
"moneta" di bronzo veniva posta assieme al defunto come obolo.
L'abitato aveva invece un'edilizia più spartana, in legno e paglia. Spina fu uno dei pochi insediamenti
etruschi del nord a superare l'invasione celtica del quarto secolo a.C., restando attiva fino al secondo secolo
a.C., quando venne abbandonata. La necropoli di Valle Trebba fu riscoperta già dagli anni '20 mentre gli
scavi di Valle Pega iniziarono dopo il '54.
I reperti di Spina si trovano esposti al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Altri reperti sono conservati
invece al Museo Archeologico di Delfi.