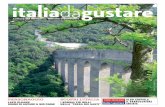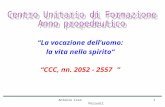PROF. MICHELE ONORATO Anno accademico 2013/2014 II semestre 1 DIRITTO PRIVATO.
sezione III penale; sentenza 7 aprile 2004; Pres. Rizzo, Est. Onorato, P.M. Izzo (concl. conf.);...
Click here to load reader
-
Upload
roberto-caso -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
Transcript of sezione III penale; sentenza 7 aprile 2004; Pres. Rizzo, Est. Onorato, P.M. Izzo (concl. conf.);...

sezione III penale; sentenza 7 aprile 2004; Pres. Rizzo, Est. Onorato, P.M. Izzo (concl. conf.); ric.Vullo e altro. Conferma Trib. Agrigento, ord. 10 novembre 2003Author(s): Roberto CasoSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 11 (NOVEMBRE 2004), pp. 609/610-613/614Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200331 .
Accessed: 28/06/2014 17:24
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA PENALE
rale della repubblica presso la corte territoriale che la denuncia
per violazione di legge e carenza o manifesta illogicità della
motivazione limitatamente alla pronuncia di assoluzione degli
imputati. Motivi della decisione. — Con un sostanzialmente unico
mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente denuncia
la sentenza per violazione ed errata applicazione dell'art. 512
c.p.p., nonché per vizi della motivazione in ordine all'affermata
inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone offese dai reati di favoreggiamento e sfruttamento
della prostituzione. Si osserva che la prevedibilità dell'evento, costituito dalla
successiva irreperibilità delle dichiaranti, è stata desunta dalla
corte territoriale dai soli dati di fatto costituiti dalla mancanza di
fissa dimora e di un regolare permesso di soggiorno, astratta
mente considerati ed estrapolati dalle condizioni di tempo e di
luogo in relazione alle quali occorreva formulare la prognosi in
questione, avendo i giudici di merito omesso di valutare un ulte
riore elemento, considerato nella sentenza di primo grado, co
stituito dal fatto che le predette dichiaranti erano state accompa
gnate dalla polizia presso una struttura protetta, destinata pro
prio all'accoglienza di cittadini extracomunitari in attesa di
permesso di soggiorno. Si deduce inoltre che la motivazione, con la quale la sentenza ha escluso l'applicabilità dell'art. 512
c.p.p., risulta fondata su un'ulteriore argomentazione inconfe
rente e sganciata dalle risultanze processuali, e, cioè, sul rilievo, che la successiva irreperibilità delle ragazze moldave ne avreb
be impedito una identificazione certa, con conseguente lesione
dei diritti della difesa. Si richiama, infine, la giurisprudenza di questa corte che, in casi analoghi, ha ritenuto correttamente
motivata la valutazione dei giudici di merito che avevano esclu
so la prevedibilità dell'evento verificatosi.
Il ricorso è fondato.
È opportuno premettere che «a norma dell'art. 512 c.p.p.
(lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione), an
che dopo la modifica dell'art. 111 Cost., possono essere lette ed
acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da
un teste nella fase delle indagini, qualora lo stesso, per cause
imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile, in
quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impos sibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dal
citato art. Ill Cost.» (sez I 30 aprile 2001, Bentouiza, Foro it.,
Rep. 2001, voce Dibattimento penale, n. 102). Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa cor
te, inoltre, «in tema di letture dibattimentali, la valutazione del
l'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizio ne dell'atto precedentemente assunto e che ne legittima la lettu
ra ai sensi dell'art. 512 c.p.p., è demandata in via esclusiva al
giudice di merito, il quale deve formulare in proposito una 'pro
gnosi postuma', che deve essere sorretta da motivazione ade
guata e conforme alle regole della logica» (sez. II 11 novembre
1998, Bajrami, id., Rep. 1999, voce cit., n. 144; sez. I 23 gen naio 1995, Comberiati e altro, id., Rep. 1995, voce cit., n. 143).
Peraltro, proprio in relazione a fattispecie analoghe a quella in esame, questa corte ha reiteratamente ritenuto legittima la
lettura delle dichiarazioni rese da cittadina straniera entrata
clandestinamente in Italia e dedita alla prostituzione, ritenendo
che quanto sopra non rendeva prevedibile ex ante l'irreperibilità della stessa (sez. III 21 maggio 1998, Mazreku J., id., Rep. 1998, voce cit., n. 146; conf. sez. II 15 maggio 1996, Vassiliev,
id., Rep. 1996, voce cit.. n. 148).
Orbene, la sentenza impugnata nell'affermare la prevedibilità dell'allontanamento delle cittadine extracomunitarie, sentite
dalla polizia giudiziaria in ordine ai delitti di favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione ascritti agli imputati, ha omesso
totalmente di considerare un elemento di giudizio rilevante, evi
denziato nella sentenza di primo grado e, cioè, la circostanza
che le predette dichiaranti, dopo il loro esame da parte degli or
gani di polizia giudiziaria, non furono lasciate libere di andare
via, bensì ricoverate presso una struttura protetta della pubblica sicurezza.
Su tale circostanza di fatto la pronuncia di primo grado ha
fondato il convincimento espresso dai giudici di merito della
imprevedibilità della successiva irreperibilità delle dichiaranti,
con motivazione logica, che invece difetta in quella impugnata,
Il Foro Italiano — 2004.
genericamente fondata sul rilievo che si trattava di cittadine ex
tracomunitarie e dedite alla prostituzione. Inoltre il rilievo dei giudici della corte territoriale, afferente
all'incertezza delle identità delle cittadine moldave di cui si
tratta, si palesa anche esso carente di motivazione, non essendo
state indicate le ragioni per le quali è stata ritenuta l'incertezza
dell'identificazione delle predette dichiaranti.
Infine gli ulteriori argomenti addotti in sentenza a sostegno della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini di polizia giudiziaria dalle predette cittadine moldave, in quanto la loro lettura implicherebbe una violazione del diritto di difesa
degli imputati, per carenza di contraddittorio nella verifica della
loro attendibilità, e farebbe assumere al processo i connotati del
giudizio con il rito abbreviato, senza che gli imputati fruiscano
dei benefici previsti per tale rito, costituiscono una motivazione
apparente. Si tratta, invero, di considerazioni che escluderebbero, in ogni
caso, l'applicabilità del disposto di cui all'art. 512 c.p.p., la cui
permanenza nell'ordinamento processuale è stata, invece, af
fermata dalla citata giurisprudenza di questa corte, che ne ha ri
levato la compatibilità con l'art. 111 Cost, nella sua attuale for
mulazione.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con
rinvio limitatamente ai reati di cui alla 1. 75/58, unificati sotto il
vincolo della continuazione (capo 1), per un nuovo giudizio che
tenga conto dei rilievi che precedono in punto di applicazione dell'art. 512 c.p.p.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 7
aprile 2004; Pres. Rizzo, Est. Onorato, P.M. Izzo (conci,
conf.); ric. Vullo e altro. Conferma Trib. Agrigento, ord. 10
novembre 2003.
Diritti d'autore — Violazione — Misure tecnologiche di elu sione — Fattispecie (L. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art.
171 ter, 171 octies).
La detenzione e la commercializzazione di apparecchiature che
consentono di fruire, su più televisori, di programmi satellita
ri ad accesso condizionato è da considerarsi vietata ai sensi
dell'art. 171 ter, lett. f bis), l. 633/41, in quanto le suddette
attrezzature hanno lo scopo di eludere efficaci misure di
protezione. (1)
(1) La sentenza si può leggere in Foro it., 2004, II, 479, con nota di richiami di G. Colangelo.
Se ne riproduce la massima per pubblicare la nota di R. Caso.
* * *
Il (declino del) diritto d'autore nell'era digitale: dalle misure
tecnologiche di protezione al «Digital Rights Management». (*)
I. - La sentenza in epigrafe costituisce una delle prime applicazioni
giurisprudenziali della disciplina delle misure tecnologiche di protezio
(*) Le considerazioni che seguono nel testo costituiscono la sintesi di ragionamenti effettuati nell'ambito di una monografia e di un saggio: cfr. R. Caso, «Digital Rights Management». Il commercio delle infor mazioni digitali tra contratto e diritto d'autore. Padova, 2004, nonché
«Digital Rights Management»: il potere tecnologico ai confini tra con tratto e norma, in G. Pascuzzi, Diritto e tecnologie evolute del com mercio elettronico, Padova, 2004, 43 ss. A questi scritti si rinvia per i riferimenti legislativi, giurisprudenziali e dottrinali.
This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE SECONDA
ne contenuta nel nuovo art. 102 quater 1. dir. autore. Le protezioni tec
nologiche costituiscono un tema centrale del diritto dell'era digitale che merita un'attenta riflessione.
La fruizione dell'informazione (e della conoscenza) passa sempre più attraverso le tecnologie digitali. Ciò che ieri poteva essere rappre sentato e comunicato solo attraverso la carta, il vinile o le onde radio, oggi può essere tradotto in codice binario e diffuso attraverso le reti di
gitali. Alla traduzione in codice binario vengono associati software ed hardware con funzioni in grado di governare ogni passaggio della pro duzione e della distribuzione dell'informazione. Alcune di queste fun zioni perseguono uno scopo non nuovo: la protezione del copyright. Le
protezioni tecnologiche di ultima generazione però non si limitano ad
impedire all'utente la copia, ma piuttosto mirano a conformare l'uso dell'informazione. In altre parole, le tecnologie digitali consentono di
predeterminare come, dove e quando l'informazione potrà essere fruita. Ad esempio, è possibile predeterminare se un file di testo potrà essere solo letto o anche modificato e stampato.
Le maggiori imprese titolari di diritti di proprietà intellettuale, in collaborazione con alcune imprese produttrici di hardware e software, stanno investendo massicciamente nella produzione e nella diffusione delle protezioni tecnologiche.
Lo scenario abbozzato è in rapida trasformazione. Più che di misure
tecnologiche di protezione si sente parlare di Digital Rights Manage ment (DRM).
Nei linguaggi informatico ed economico la formula DRM assume va ri significati. Nell'accezione più ampia, DRM denota sistemi in grado di definire, tutelare e gestire, le regole — in gergo: «diritti» — di ac cesso e di utilizzo su contenuti digitali. Con maggiore precisione si può dire che un sistema di DRM si basa su:
a) un business mode! di riferimento; b) una serie di «diritti», cioè di regole per l'utilizzo del contenuto
digitale, espressi in un linguaggio «comprensibile al computer» deno minato Rights Expression Language;
e) misure di protezione incentrate su alcune tecnologie di base: crit
tografia, watermarking e fingerprinting. Tali tecnologie oltre a tutelare le regole poste alla base del DRM, perseguono anche scopi strumentali alla tutela come l'identificazione ed il rintracciamento del contenuto, del sistema informatico e dell'utente;
d) tecnologie deputate a governare funzioni accessorie come la ge stione dei pagamenti per ottenere forme di utilizzo dei contenuti digita li.
La differenza tra semplici misure tecnologiche di protezione e siste mi di DRM sta dunque nel fatto che questi ultimi non si limitano a blindare il contenuto digitale, ma piuttosto rappresentano l'infrastruttu ra tecnologica di un mercato di contenuti blindati. Chi promuove tali si stemi intende collocarli al centro del futuro ambiente digitale dove si
punta a far convergere hardware e software per la fruizione di Internet, televisione digitale, telefonia cellulare. In proposito l'ultima promessa (o minaccia) è rappresentata dal Trusted Computing: lo sviluppo da parte di un gruppo di imprese leader del settore dell'hardware e del software di un'architettura informatica «sicura».
Sebbene i sistemi di DRM attualmente siano estremamente diversifi cati e non convergano su standard universali, essi sono già presenti sui nostri computer, palmari, telefoni e televisioni digitali.
Al momento i sistemi di DRM sono prevalentemente utilizzati per commercializzare contenuti digitali prodotti dall'industria dell'intratte nimento e dell'editoria. In questa prospettiva il DRM è, innanzitutto, uno strumento per il governo di operazioni economiche che avvengono sul mercato delle informazioni digitali: ad esempio, l'acquisto di un file musicale o di un e-book attraverso Internet.
Nell'operazione economica presidiata da un sistema di DRM si fronteggiano soggetti con diverso potere contrattuale. Vi è, da una par te, chi ha il controllo della tecnologia, dall'altra, chi è un mero fruitore della stessa. Questa operazione è differente dal tradizionale contratto finalizzato al consumo di prodotti culturali: ad esempio l'acquisto di un libro o l'acquisto di un biglietto per assistere ad uno spettacolo.
Nel contratto governato dal DRM la fruizione di un contenuto digi tale è sempre associata a condizioni generali di contratto (c.d. End User License Agreement: EULA). Tali condizioni generali di contratto diffe riscono da quelle tradizionali, poiché il loro contenuto può essere im mediatamente tradotto nelle regole del DRM: ad esempio, la clausola che vieta di effettuare copie private trova immediato riscontro nella protezione tecnologica che inibisce la copia. Le regole del DRM altro non sono che il funzionamento di un sistema informatico complesso: esse sono ancor più intrasparenti delle consuete condizioni generali di contratto. Il contratto, il suo oggetto e la sua tutela finiscono per identi ficarsi nella macchina.
Nel contratto governato dal DRM la fruizione del contenuto digitale avviene sotto la sorveglianza di chi ha il controllo della tecnologia. La privacy legata al consumo dell'informazione è pesantemente minac ciata.
Il DRM è dunque fonte di un potere contrattuale con implicazioni giuridiche, le quali vanno oltre l'apparente semplicità dell'operazione
Il Foro Italiano — 2004.
economica: prezzo contro fruizione dell'informazione. Contraccolpi di
questo potere si risentono almeno sul piano del diritto d'autore, della
privacy, dell'autotutela privata, della formazione del contratto.
II. - Pur essendo oggetto dell'attenzione di organi governativi e le
gislativi il DRM, inteso come architettura informatica complessa, non è ancora regolamentato. Le misure tecnologiche di protezione invece co noscono già alcune forme di regolamentazione. In particolare, la disci
plina delle misure tecnologiche di protezione si pone al culmine della
risposta normativa dei sistemi giuridici occidentali alla c.d. sfida digi tale al diritto d'autore. Tale risposta normativa inizia a delinearsi negli anni ottanta del secolo scorso, è dominata dall'attivismo legislativo statunitense e si snoda attraverso nuovi accordi (e nuove dinamiche di
contrattazione) internazionali, nonché attraverso l'opera di armonizza zione comunitaria. La sua tendenza è chiara: inserimento di nuove ope re nel novero di quelle protette (in particolare, il software), rafforza mento dei diritti di esclusiva, restringimento delle prerogative riservate
agli utenti (ad esempio, il/a;> use), attribuzione ai titolari dei diritti di esclusiva di una percentuale sul prezzo di vendita degli strumenti e dei
supporti per la riproduzione domestica e, appunto, regolamentazione delle misure tecnologiche di protezione. Alla base di questo progetto espansivo del copyright (e della disorganicità delle nuove norme) ci so no interessi lobbistici e nazionali. Il legislatore occidentale appare più che mai preda dei gruppi che spingono per la creazione di un ambiente
digitale caratterizzato dal controllo privato dell'informazione. La prima rilevante forma di tutela giuridica delle misure tecnologi
che di protezione si deve ai World Intellectual Property Organization Treaties del 1996. I legislatori statunitense ed europeo sono andati an che oltre il mandato internazionale emanando il Digital Millennium
Copyright Act del 1998 e la direttiva 2001/29/Ce. Semplificando dra sticamente. Il nucleo comune delle norme sta nel doppio divieto:
a) di elusione delle protezioni; b) di produzione o diffusione di tecnologie «finalizzate» all'elusione
delle protezioni. Non è difficile immaginare come uno degli snodi più controversi e
problematici rimanga la (pretesa) distinzione tra tecnologia «buona» e «cattiva».
La regolamentazione delle misure tecnologiche di protezione ha già prodotto negli Stati uniti esiti giudiziali paradossali. Molti dei soggetti colpiti dai primi giudizi non sono i c.d. pirati digitali, ma persone che
operano nel mondo della scienza, della tecnologia e dell'editoria. Il so
spetto è che si sia mostrato un bersaglio (i c.d. pirati), volendo colpirne (almeno anche) un altro: coloro che sono in grado di sviluppare e dif fondere nuove e competitive tecnologie.
A margine delle attuali regolamentazioni sulle misure tecnologiche di protezione si può rilevare che:
a) esse consacrano di fatto una libertà (o meglio, un potere) con trattuale che si traduce in controllo assoluto dell'informazione, distor cendo il bilanciamento degli interessi che dovrebbe essere alla base dei diritti sulle opere dell'ingegno; in un ambiente già sovraffollato di di ritti di proprietà intellettuale, l'attuale regolamentazione delle misure
tecnologiche di protezione rischia di infliggere un colpo definitivo al
pubblico dominio ed alla libera manifestazione del pensiero; b) nel mondo le corti già lavorano alla connessione tra norme sulle
protezioni tecnologiche e tessuto giuridico dei vari sistemi giuridici di riferimento; la capacità di comprendere le importanti implicazioni che stanno a ridosso di questo lavoro interpretativo dipende da caratteristi che sistemologiche come la presenza e l'impostazione di una clausola costituzionale sulla proprietà intellettuale o il rilievo del diritto d'autore nella riflessione dottrinaria; a tal proposito vi è da rilevare che una parte autorevole ed estesa della dottrina nordamericana ha mosso pe santi critiche alle norme in questione, e che alle medesime critiche fa eco l'attivismo delle associazioni che difendono le libertà fondamentali e i diritti civili nell'era digitale;
c) fuori dalle aule giudiziarie le protezioni tecnologiche sono sotto poste alla sfida di sempre; la loro vulnerabilità trova quotidiana con ferma, ma le lobbies che ne promuovono la diffusione non indietreg giano, e puntano ad egemonizzare — anche con pressioni su Stati ed organizzazioni internazionali — gli standard tecnologici.
III. - Le protezioni tecnologiche diventano sempre più sofisticate, pervasive e ricche di implicazioni giuridiche. Mentre la loro regola mentazione appare arretrata, semplicistica e sbilanciata. Le leggi attuali trascurano la complessa relazione che si instaura tra contratto e prote zioni tecnologiche.
In proposito, non convince la teoria giureconomica che, in connes sione con l'uso crescente di tecnologie come il DRM, raccomanda una politica normativa volta alla riduzione o alla cancellazione dei limiti del diritto d'autore. In base a tale teoria, il controllo privato dell'infor mazione, basato su protezioni tecnologiche e libertà contrattuale, do vrebbe condurre ad un accrescimento del benessere della società. Le protezioni tecnologiche darebbero finalmente fondamento alla (va gheggiata) idea della proprietà sull'informazione. Proprietà e contratto
This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA PENALE
sarebbero in grado di far funzionare il mercato dei contenuti digitali come quello delle mele o delle lavatrici.
Altri ragionamenti giureconomici, la considerazione di valori diversi dall'efficienza e l'osservazione della realtà inducono a smentire queste predizioni.
A dispetto dalla fuorviarne assonanza tra le due categorie, la pro prietà intellettuale è cosa totalmente diversa dalla proprietà delle cose materiali. La proprietà intellettuale si regge su un compromesso — rag giunto in epoca recente all'interno della tradizione giuridica occiden tale — strumentale al raggiungimento di uno scopo: la collettività rico nosce un incentivo, cioè un'esclusiva limitata in ampiezza e durata, al
privato che è in grado di produrre nuova informazione e conoscenza. Le misure tecnologiche di protezione dell'informazione rompono il com
promesso. Il controllo tecnologico, in quanto preventivo, invasivo e
potenzialmente illimitato, è assai più forte e penetrante di quello garan tito dalla proprietà intellettuale. Esso, inoltre, si riflette sui caratteri del
contratto, spianando la strada ad un inedito potere di autotutela di re
gole unilaterali ed intrasparenti. Chi promuove la diffusione del DRM, d'altra parte, non si limita a
reclamare libertà contrattuale e legittimazione dell'utilizzo (nonché tu tela contro l'elusione) delle misure tecnologiche di protezione. Oltre al contratto il diritto dell'era digitale conosce un'altra fondamentale fonte di produzione delle regole: gli standard tecnologici. Come accennato è
all'egemonia su questi ultimi che puntano i promotori delle misure tec
nologiche di protezione. E dunque necessario rimarcare l'importanza della conservazione dei
limiti al controllo privato dell'informazione anche, ed a maggior ragio ne, nell'ambiente digitale. La conservazione di limiti come quelli for
giati, talvolta accidentalmente, dalla storia per il diritto d'autore — ad
esempio, la distinzione tra forma espressiva ed idea o il principio nord americano del fair use — mantiene in vita quella dinamica virtuosa che aiuta lo sviluppo e la diffusione della conoscenza. Nuove forme di pro duzione dell'informazione — si pensi al software libero e aperto o alle architetture Peer io Peer per la condivisione di files — cercano spazio nel mondo digitale. Nuovi modelli istituzionali — si pensi alla General Public License o al progetto Creative Commons — si fanno avanti. 1 limiti al controllo privato dell'informazione sembrano uno strumento
giuridico indispensabile a garantire a nuovi mercati ed assetti istituzio nali la possibilità di emergere.
Più in generale, è necessario riconsiderare nella prospettiva dell'im
perati vità i limiti al controllo privato dell'informazione, limiti come
quelli interni ed esterni al diritto d'autore ed alle altre forme di pro prietà intellettuale. Riconsiderare l'imperatività di tali limiti significa anche esplorare la possibilità di incorporarli a monte negli standard
tecnologici alla base dei sistemi di DRM.
Tuttavia, a margine di questa che è la frontiera ultima e problematica del dibattito sul DRM va quantomeno rilevato che lo stato attuale delle
tecnologie non consente di precipitare in un codice binario l'elasticità e la forza latente di un principio giuridico, le quali tanta parte hanno nel l'evoluzione del nostro diritto.
Roberto Caso
Il Foro Italiano — 2004.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 18 marzo 2004; Pres. Zumbo, Est. Franco, P.M. Favalli (conci, diff.); ric. Pugliese. Annulla senza rinvio Trib. Crotone, ord. 21 novembre 2003.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Tavole costi tuenti il piano di calpestio di ponteggi — Autorizzazione ministeriale — Necessità — Esclusione (Disp sulla legge in generale, art. 12; d.p.r. 7 gennaio 1956 n. 164, norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, art.
23, 30,31,32, 33,38, 77).
Non è tenuto a richiedere l'autorizzazione alla costruzione e
all'impiego di cui all'art. 30, 4° comma, d.p.r. 7 gennaio 1956 n. 164 colui che impieghi o intenda impiegare tavole co stituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed
impalcati di servizio, sia di ponteggi di legno, sia di ponti metallici e di ponteggi le cui strutture portanti sono costruite totalmente o parzialmente da elementi metallici. (1)
Svolgimento del processo. — Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Crotone confermò il decreto emesso il
14 ottobre 2003 dal pubblico ministero presso il medesimo tri
bunale, che aveva convalidato il sequestro operato dalla polizia
giudiziaria ex art. 354 c.p.p. di novanta tavole zincate acquistate dal Pugliese, titolare di un'impresa di costruzioni, dalla ditta
Fashion di Pignolo Maria Rita, senza farsi rilasciare dal fabbri
cante (che non ne era munito) copia dell'apposita autorizzazio
ne ministeriale per la costruzione e l'impiego, in relazione al
reato di cui all'art. 30 d.p.r. 7 gennaio 1956 n. 164.
Osservò, tra l'altro, il tribunale che le tavole in questione era
no comunque passibili di essere impiegate per la costruzione di
un ponteggio, sicché era ipotizzabile il reato contestato che si
consuma al momento dell'acquisto e non in quello dell'effettiva
utilizzazione nel ponteggio. Il Pugliese propone ricorso per cassazione deducendo:
a) erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 30 d.p.r. 7
gennaio 1956 n. 164. Osserva che, da un'interpretazione siste
matica della normativa in questione, emerge che la citata dispo sizione di cui all'art. 30 riguarda esclusivamente i ponteggi le
cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici, mentre la disciplina degli intavolati è
contenuta nella diversa disposizione di cui al precedente art. 23, il quale stabilisce le caratteristiche che devono avere le tavole
costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed
impalcati. La necessità di autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 30 per la costruzione e l'impiego è quindi applicabile solo per le strutture metalliche portanti dei ponteggi e non anche
per i semplici intavolati — quali sono le novanta tavole seque
strate — per i quali si applica invece la disciplina di cui all'art.
23. Non è quindi nemmeno astrattamente configurabile il reato
ipotizzato; '
b) violazione dell'art. 324, 5° comma, c.p.p. Osserva che la
decisione del tribunale del riesame è intervenuta tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 324, 5° comma, c.p.p. perché la ri
chiesta di riesame venne depositata il 14 novembre 2003, l'u
dienza camerale si tenne il 21 novembre 2003, ma la decisione del tribunale del riesame è stata depositata solo il 27 novembre
2003. La misura cautelare reale ha quindi comunque perso effi
cacia.
Motivi della decisione. — Il primo — ed assorbente — moti
vo è fondato, in quanto nella specie non è neppure astrattamente
configurabile, sulla base degli elementi posti a base del seque stro, l'ipotizzato reato di cui all'art. 30, 4° comma, in relazione
all'art. 77, lett. c), d.p.r. 7 gennaio 1956 n. 164.
Il citato d.p.r. 7 gennaio 1956 n. 164 (recante norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) contie
ne un capo IV, relativo ai «ponteggi e impalcature in legname»,
(1) Non constano precedenti in termini. Nell'annullare l'ordinanza
con la quale era stato confermato il decreto di convalida del sequestro operato, ex art. 354 c.p.p., in relazione a tavole zincate acquistate da un
imprenditore edile senza farsi rilasciare l'autorizzazione di cui all'art.
30, 4° comma, d.p.r. 7 gennaio 1956 n. 164, la Suprema corte ha con
cluso nel senso che dette tavole, destinate a costituire piano di calpestio di qualunque struttura, sono soggette alle sole prescrizioni di cui all'art. 23 d.p.r. cit.
This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions