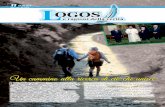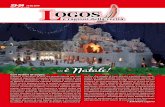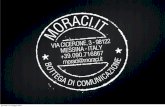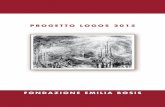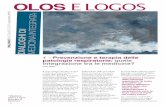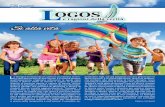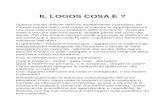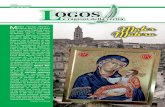Sequeri, P. Il Logos Corrispondente
-
Upload
john-silva -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Sequeri, P. Il Logos Corrispondente
-
7/27/2019 Sequeri, P. Il Logos Corrispondente
1/9
ILLOGOSCORRISPONDENTE.Estetica teologica della verit di Dio
Pierangelo SEQUERIFacultat de Teologia dItlia Septentrional (Mil)
1. Anticipazione e prefigurazione dellesperienza di Dio. Lermenuti-ca incompiuta della seconda adaequatio del PROSLOGION
In un primo momento lascerei giocare liberamente i termini di unintuzioneanselmiana sulla seconda adaequatio estetico-affettiva dellunum argu-
mentum, che mi sembra alquanto trascurata dalla critica.1
O luce somma e inaccessibile, o verit totale e beata, quanto sei lontana da me,che ti sono cos vicino! Quanto sei remota dal mio sguardo, mentre io sono cospresente al tuo! Tu sei dovunque tutta presente, ma io non ti vedo. In te mi muovo ein te sono, ma non posso accedere a te. Tu sei dentro di me e intorno a me, ma ionon ti sento. Ancora ti nascondi allanima mia, o Signore, nella tua luce e nella tuabeatitudine, e per questo essa si rivolta ancora nelle sue tenebre e nella sua miseria.Infatti si guarda intorno e non vede la tuta bellezza. Si mette in ascolto e non ode latua armonia. Annusa e non percepisce il tuo profumo. Gusta e non riconosce il tuosapore. Tocca e non sente la tua soavit. Tu infatti, hai queste qualit in te, o Signo-
re Dio, in un tuo modo ineffabile, tu che le hai date alle cose da te create secondo illoro modo sensibile; ma i sensi della mia anima si sono irrigiditi, sono diventatiinsensibili, sono stati istruiti dallantica malattia del peccato.2
1. Per una pi specifica illustrazione di questo aspetto, mi sia permesso rimandare a duesaggi gi pubblicati: Retractatio mystica della filosofia?, in: A. Molinaro E. Salmann, a c.di, Filosofia e mistica, SantAnselmo, Roma 1997, 129-160; Lavvento della libert secondoAnselmo dAosta, in: I. Biffi C. Marabelli (eds.),Anselmo dAosta educatore europeo, Mila-no: Jaca Book 2003, 117-134 (con bibliografia specifica).
2. Anselmo, Proslogion, XVII, edizione italiana a c. di I. Sciuto, testo a fronte, Milano:Bompiani 2002, 342-343.
RCatT XXXIII/1 (2008) 177-185 Facultat de Teologia de Catalunya
-
7/27/2019 Sequeri, P. Il Logos Corrispondente
2/9
Il testo arriva, nel movimento della celebre opera anselmiana, nel punto disvolta segnato dal capitolo XIV, quando Anselmo sigilla la ripresa dellargu-mentum mettendo a fuoco lo iato fra il piano della certezza pensata e quellodellevidenza percepita. Lo scarto tuttaltro che secondario. La mente cerca-va Dio e ha trovato che egli lente sommo, di cui non si pu pensare alcunacosa migliore; che questo ente la stessa vita, la luce, la sapienza, la bontleterna beatitudine e la beata eternit; e che questo ente dovunque e sem-pre. Lente trovato non parte e non ha parti: la sua natura avvolgente per-vasiva per definizione. Dunque Perch la mia anima non ti sente Signore?.Linterrogativo cruciale, perch il suo contraccolpo in grado di aprire unabisso dentro lapprodo stesso dellitinerarium che ha conseguito il legamefra la nominazione di Dio e il senso esclusivo dellessere che gli compete: ilquale di suo perfettamente intuibile e intelligibile juxta sua propria
principia. Se infatti non hai trovato il tuo Dio, in che modo egli ci che haitrovato e che hai compreso con una verit cos certa e con una certezza cosvera? Se invece lo hai trovato, come accade che tu non senta ci che hai tro-vato?
Non ci interessa qui, al momento, la struttura speculativa dellaporia: ciinteressa limpianto teorico della sua formulazione. Essa suppone infatti chelintenzionalit credente relativa al riconoscimento di Dio debba trovare il suocompimento nel tratto estetico-affettivo di una corrispondente percezione sen-
sibile della sua illimitata pienezza. Il sentire estetico-affettivo ora la costella-zione dirimente di questa impensabile scissione impensabile per il pensie-ro che ferisce il logos della perfezione di Dio che stata intuita: appare lagiustezza della verit pensata, ma non si presenta la giustizia della effettivitimplicata.
Il confronto di Anselmo con laporia, come vedremo, sortisce una soluzio-ne geniale e ricca di implicazioni. In primo luogo, supera definitivamente lapregiudiziale platonica e neoplatonica (e a maggior ragione quella gnostica)relativa allesperienza del divino. Lesperienza del divino, proprio in ragionedella sua perfezione totale e onniavvolgente nei confronti dellessere, include
la sfera dellaffettivo-sensibile. In secondo luogo, la soluzione anselmianainaugura la dignit ontologica della figura evangelica dellagape di Dio,riconducendo la forma specifica della manifestazione beatifica dellesseredivino allesperienza dellessere-beato-della-beatitudine-dellaltro. Precisa-mente in questo consiste la natura beatificante del divino: che, naturalmente,non pu essere aggiunta estrinsecamente alla qualit del divino, ma trovanella sua intrinseca beatitudine il logos e il nomos della sua abissale veritontologica.
ACTES DEL CONGRS PARAULA DE DU, PARAULA SOBRE DU178
-
7/27/2019 Sequeri, P. Il Logos Corrispondente
3/9
2. Linee di sviluppo dellanticipazione prefigurante di Dio, secondola soluzione estetica anselmiana: LOGOS della rivelazione e NOMOS
del desiderio
La forma adeguata dellanticipazione (conjectatio) di questo lato estetico-affettivo delladaequatio cercata, va colto secondo la soluzione anselmia-na ricercando nellesperienza illuminata dalla fede la forma dellanticipazio-ne corrispondente al logos e al nomos della verit di Dio come ha da essere(ossia della verit di Dio secondo la sua giustizia). Lanticipazione si producelungo il duplice asse della dimensione estetico-affettiva del compimento, prefi-gurato dalla rivelazione.
Intanto, il logos divino del compimento, il nomos divino della beatitudine,deve riguardare lumano che : anima e corpo, spirito e mondo.
Oh, che cosa avr e che cosa non avr colui che godr di questo bene! Certa-mente avr tutto ci che vorr e non avr ci che non vorra. Avr sicuramente benidel corpo e dellanima, quali n occhio vide n orecchio ud n cuore umano hapensato [...] Infatti che cosa ami, carne mia, che cosa desideri, anima mia? E l, l tutto ci che voi amate, tutto ci che voi desiderate.3
Segue una libera e spregiudicata sequenza di proiezioni della pura e sempli-ce felicit dellesistere: Se ti piace la bellezza... se ti piace la velocit o la
forza o la libert del corpo, in modo che nulla gli si possa opporre... Se ti piaceuna vita lunga e salubre... la saziet ... lebbrezza ... la musica... qualsiasi godi-mento puro.... E poi la sapienza, lamicizia, la concordia; ma anche il potere,lonore e le ricchezze, la sicurezza priva di insidie. Lo sfondamento antignosti-co della beatitudine verso lestetica della redenzione della creatura lineare.Lestetica sensibilit: senza felice pervasivit del sensibile la verit di Dionon consegue la sua giustizia, letica dellatto creatore manca il suo senso.
Il secondo tratto dellanticipazione, rende comprensibile lintrinseco carat-tere di donazione, di gratuit, di incanto inviolabile e insieme condiviso, chesegna il tratto estetico della giustizia del mondo che come ha da essere os-sia bello:
[...] ma quale e quanta la gioia, dove tale e tanto il bene? O cuore umano,cuore indigente, cuore provato dalle tribolazioni, anzi sommerso dalle tribolazioni:quanto gioiresti se tu abbondassi di tutti questi beni? [...] Ma certamente se qualcunaltro, che tu amassi veramente come te stesso, avesse la stessa beatitudine, la tuagioia sarebbe raddoppiata, perch gioiresti non meno per lui che per te stesso. E sepoi quella beatitudine lavessero due o tre o molti di pi, se tu amassi ciascunocome te stesso gioiresti tanto per ciascuno di loro quanto per te stesso. [...] e poich
P. SEQUERI, ILLOGOSCORRISPONDENTE. ESTETICA TEOLOGICA DELLA VERIT DI DIO 179
3. Anselmo, Proslogion, XXV, 353.
-
7/27/2019 Sequeri, P. Il Logos Corrispondente
4/9
ognuno giosce del bene di qualcuno tanto quanto lo ama, come in quella perfettafelicit ciascuno amer senza paragone pi Dio che s e tutti gli altri con s, cos
gioir inestimabilmente pi per la felicit di Dio che per la propria e per quella ditutti gli altri con s.4
Lintima affezione per la gioia di Dio, infinitamente diffusiva, pervasivae inclusiva di sempre nuovi interlocutori (Non tutta intera quella gioia ...entrer nei beati, ma tutti i beati entreranno in quella gioia, ibid., XXVI, 359), appunto lessenza di questa anticipazione. Lemozione di questa percezione lanticipazione in noi della presenza di Dio come ha da essere, ossia secondo lasua giustizia: solo mediante lestetica irradiata dalla scena del suo compimentonella felicit di altri, essa consegue anche lemozione corrispondente alla per-
cezione di ci che Dio anche per noi, qui ed ora, in statu viae.Linteresse di questa figurazione, in termini di sviluppo ontologico-trascen-
dentale della coscienza credente, notevole. La felicit del sentire il cui tema la felicit dellaltro oggettivamente trascendente e libidicamente incorrutti-bile: sta in campo anche nellesperienza attuale dellangoscia, della mancanza,delloscurit dellesperienza. Essa anticipa la struttura dellattitudine etico-reli-giosa in quanto tale. E cos che essa attinge lessere di Dio e nella suamanifestazione se ne riconosce toccato, precisamente in questo modo: altri-menti impensabile. E il vero approdo dellunum argumentum: certo che Dionon pu essere meno di questo.
Lorientamento prefigurato dal genio anselmiano, per lelaborazione delquale forse proprio ora incominciamo ad avere linguaggio (Lacan), sottrae lalogica di eros allorizzonte della saturazione, e libera lamore in ci correg-gendo anche uninclinazione neoplatonica del venerato maestro, Agostino, cheper altro non cesser di operare nelle teologia successiva da una sua derivaperfettamente omologa a quella del godimento fusionale e autoriferito. Un taleimpianto, affine a quello del godimento narcisistico, proietta in Dio stessolombra di una autoreferenzialit dellamore che svuota radicalmente il teso-ro dei misteri principali della rivelazione cristiana: trinit, creazione, incarna-
zione. Nellontologia anselmiana della seconda adaequatio, invece, lesse-re di Dio la vita di Dio, la vita con Dio sottratto alla pericolosa derivache lo trasforma in oggetto sostitutivo e sublimato della forma puramente libi-dica del desiderio. E aperta invece la strada alla comprensione, anzi allemo-
zione ontologica, del mistero di tutti i misteri: Dio agape, la cui somma feli-cit nel godimento della felicit dellaltro. Fin dallorigine abissale di tutte leorigini possibili, il principio non principiato del senso stesso di ci chesignifica vita: lessere-Dio di Dio, quo maius cogitari nequit.
ACTES DEL CONGRS PARAULA DE DU, PARAULA SOBRE DU180
4. Anselmo, Proslogion, XXV, cit., 357.
-
7/27/2019 Sequeri, P. Il Logos Corrispondente
5/9
3. Fenomenologia neotestamentaria dellevento della manifesta-zione cristologica: limpossibile possibilit della JUSTITI A DEI come
AGAPE e la critica religiosa della religione
Proporrei ora, nellottica teologico-fondamentale, una brevissima e sinteti-ca riconfigurazione della manifestazione neotestamentaria di Ges, ovvero diquella che io chiamo la sponda fenomenologica della rivelazione cristologica,colta e formulata nella fede dei discepoli. Lasse delleidos che intendo illu-strare, mentre trae la sua ispirazione di fondo dal tema della verit di Dionellottica della seconda adaequatio anselmiana, si colloca nella prospettivadi un ulteriore approfondimento dellapproccio estetico alla figura dellarivelazione.
La lezione di von Balthasar ha mostrato brillantemente linteresse di unaiscrizione dellunit neotestamentaria della rivelazione di Ges, e della fededel credente, nellorizzonte di una estetica della manifestazione e del rapimen-to. Balthasar ha esplicitato la sua congruenza con lesperienza dei sensi spiri-tuali e con la trasfigurazione della forma sensibile. Dopo di lui, la connessionedella rivelazione con lo splendore della manifestazione di Dio in Ges, nellatotalit del suo accadere storico fino alla risurrezione inclusivo del misterokenotico dellessere Umano e Crocifisso del Figlio ci sono ridiventate abi-tuali. E necessario tuttavia andare oltre, cercando di articolare il rapporto di
questa apertura con il nesso verit-decisione implicato nelformarsi della fede:nesso certamente irriducibile allanticipazione trascendentale della sua eviden-za, ma anche essenzialmente eluso dalla sua risoluzione nel puro effetto dellamanifestazione. Sui termini di questo superamento ritorneremo con maggioreprecisione, seppur sinteticamente, in sede di conclusione.
Entrando direttamente in argomento, domandiamoci dunque, in primoluogo: che cosa corrisponde, nellevangelo della manifestazione di Ges, alrapimento e allo scompiglio dellevidenza che annuncia un singolare assoluto,per riferimento alluniversale di Dio? In altri termini: dove sta il thauma e iltrauma che innesca la percezione di un evento decisivo, nellorizzonte (gi
sempre oggetto di attesa) dellavvento definitivo di Dio? Nulla che abbia a chefare, in prima istanza, con ci che noi intendiamo come bellezza o come esteti-ca. E nemmeno come splendore e come gloria.
Il thauma, secondo la narrazione evangelica, ha il suo punto di innesco inuno speciale tratto del parlare e dellagire di Ges, in rapporto alle cosesacre, che sono in molti modi e da sempre specifica prerogativa di Dio.Il suo dispiegamento, attraverso gli eventi, ha il suo punto di impattonellimmediatezza pi evidente per la percezione immediata del meravigliosoe dello stupefacente: le dynameis che Ges compie, che noi traduciamocomunemente miracoli, appunto. Nel registro della parola, leffetto dipotenza che corrisponde a quella straordinaria presa sullevento infausto per
P. SEQUERI, ILLOGOSCORRISPONDENTE. ESTETICA TEOLOGICA DELLA VERIT DI DIO 181
-
7/27/2019 Sequeri, P. Il Logos Corrispondente
6/9
luomo, che nella disponibilit di Ges, il suo speciale modo di parlarecon autorit, come traendo direttamente da s la forza del suo modo di pro-
nunciarsi sulle cose sacre: lexousia, appunto, della quale altrettanto sponta-neamente le folle si meravigliano. Le folle si meravigliano, ma la meravi-glia attinge, con diverso grado di consapevolezza, ad un preciso punto diimpatto di quellimmagine di pieni poteri che emana da Ges. Le poten-ze che Ges esercita nei confronti del suo interlocutore hanno ununicaforma: sono atti di liberazione dal male. Essi sono anche, in molti modi, cari-chi di trasgressione nei confronti della figura tradizionale e universalmentecondivisa del sacro. Intanto, sono per lappunto univocamente indirizzati alriscatto e alla salvazione. Giovanni Battista, per primo, indotto a dubitaredella corrispondenza messianica di Ges, della quale era certo, a motivodellunilateralit di una manifestazione della potenza dellinviato che manca,incomprensibilmente, della sua ovvia parte distruttiva. Sono indirizzati inol-tre, in modo apparentemente indiscriminato, ai religiosamente devoti e ai reli-giosamente compromessi. I racconti, anzi, restituiscono con evidente inten-zione lesemplarit dei destinatari religiosamente anomali di questi segnidella potenze virtuose (dynameis), destinata a suscitare la speranza e a con-fermare la fede. Non solo. I gesti della potenza salvifica contraddicono ognipresunta legalit divina della offerta salvifica: si tratti dellimpurit del ma-le patito o dellestraneit alla comunit devota, della sacralit del sabato
o dellautorizzazione dei sacerdoti.La parola del Signore sigilla il carattere irrevocabile della perfetta rivelazio-ne di Dio che quei gesti restituiscono allevidenza. La felicit del riscattodellaltro lumano ferito, avvilito, separato, imprigionato nella sua condizio-ne peccaminosa discriminante suprema per la qualit religiosa della reli-gione.
Le opere della liberazione dal male non sono il titolo di merito della bene-volenza di Dio, n la semplice conseguenza morale della coerenza della fede.Esse sono il vettore di orientamento della rivelazione dellessere di Dio: cio,della verit di Dio come ha da essere creduta, e della giustizia in cui deve esse-
re pensata. Il credente, losservante, il devoto, contraddicendo questa radicaleteologia di Ges, accumulano distanza da Dio, anche se presumono di osser-varne il comandamento. E ne attirano il giudizio, anche se ne scrutano conogni diligenza, e persino ossessivamente, i segni rivelatori. La parabola miraa provocare la consapevolezza del fatto che il risentimento opposto alla praticadellevangelo in realt contraddittorio dal punto di vista della religione mede-sima, se si pone mente a Dio come ha da essere.
Lo skandalon, del resto, ossia laltra faccia del thauma, previsto e messoin conto. Ges definisce la parola e la pratica dellevangelo nella cornice di unavera e propria critica religiosa della religione. Lautoreferenzialit della reli-gione, non la semplice incoerenza della sua pratica, colpita al cuore.
ACTES DEL CONGRS PARAULA DE DU, PARAULA SOBRE DU182
-
7/27/2019 Sequeri, P. Il Logos Corrispondente
7/9
4. Prospettive di elaborazione della JUSTITIADEI come tema di antici-pazione etico-trascendentale della verit e di etica della giusti-
ficazione della fede. Una soluzione per lANALYSIS FIDEI
Il punto di sintesi con il tema della credibilit cristiana facile da indivi-duare. Soltanto una parola e un gesto che scaturiscono dallintimit di Dio pos-sono configurare la rivelazione del giudizio di Dio in questa forma radicale dicritica religiosa della religione; intendendo al tempo stesso di poter/dover esse-re ricevuti come pura e semplice verit della religione: di ogni religione sullafaccia della terra: quella dellelezione, e ogni altra.
Levangelo di Ges levangelo di Dio che Ges fa appello alleviden-za di un logos perfettamente intelligibile e ontologicamente corrispondenteallattesa e al desiderio di Dio come ha da essere. Nel gesto di dare, riscattare,restituire la vita alla sua giustizia risplende sempre la verit del fondamento:quella che giustifica lessere del mondo e lo destina alla vita di Dio. La naturavivente del divino segnata, oscuramente e luminosamente al tempo stesso,dalla sorpresa infinita per il movimento della donazione che precede abissal-mente anticipa e sconfigge lautoreferenzialit dellassoluto. La sorpresaabita lintimit stessa del divino, dove il movimento della donazione istituiscela relazione come ha da essere. La necessit del dono, qui, il risvolto perfettodella libert della relazione. E la necessit della relazione, la forma compiuta
della libert del dono, come ha da essere. Non c deduzione possibile, qui, dauna natura del divino astrattamente separata dalla sua vita immanente. N arbi-trio possibile di un nomos della libert che precede lessere, destinandolo allaforma della vita senza logos.
Il Logos corrispondente alla divina generazione (il Figlio) restituisce sem-pre, a quella sua intima sorpresa, la manifestazione della verit e della giu-stizia che con essa si danno. Sempre. IlNomos in cui si raccoglie e si riverberala sorpresa dellispirazione divina della vita come ha da essere (lo Spiri-to), ne ispira la risolutiva coerenza e ne dispiega la forza necessaria. Dovun-que.
In altri termini, penso che lelemento trasversale della singolarit dellamanifestazione divina in Ges debba anzitutto essere riconosciuto proprionella fermezza, totalmente spregiudicata, con la quale egli attesta la fermezza(episteme e pistis) del tratto originario del divino, che non vuole essere feritoda nessuna alternativa dialettica. Non per caso la religione il luogo in cui talemanifestazione realizza la massima incisivit della sua dialettica con la resi-stenza delle potenze maligne (exousia), ed sottoposta alla prova cruciale(kenosis) della sua stabilit indefettibile. Da un lato, infatti, la religione illuogo in cui lestetica e la drammatica della condizione creaturale sono messea confronto con il mistero radicale della giustificazione dellessere e delladestinazione del mondo. Lintimit del divino non meno che questo il
P. SEQUERI, ILLOGOSCORRISPONDENTE. ESTETICA TEOLOGICA DELLA VERIT DI DIO 183
-
7/27/2019 Sequeri, P. Il Logos Corrispondente
8/9
luogo della verit, per questo enigma. Lesteriorit del divino il sacro ilterreno di prova della sua giustizia. Dallaltro lato, la religione lorizzonte
allinterno del quale la debolezza peccaminosa dellumano contamina il sacroe oscura leco della destinazione del desiderio: impressa e offerta con la crea-zione dellumano. Lumano, infatti, creatura voluta come immagine e somi-glianza, destinata a fronteggiare e a interpretare lintimit di Dio, nelbene e nel male. Dio non vuole essere subto nella ineluttabile verit della suaabissale assolutezza. Bens amato nel libero riconoscimento della giustizia incui vive e fa vivere.
Linclinazione allautoreferenzialit della beatitudine, che infrange la logicadel felice compimento di s che ciascuno riceve dallaltro dono gi offertocon la creazione, che lumano allucin subito di strappare a Dio, separandose-ne mortalmente loscuramento di ogni verit e di ogni giustizia dellessere.E ferisce la bellezza dellemozione ontologica pi alta possibile del compimen-to: godere della beatitudine dellaltro, ricevere la propria allo stesso modo.
La giustizia del vivere, come deve compiersi, e la giustizia di Dio come hada essere, sono il tema di una nostalgia che pu essere voluta e sperata comeunanticipazione congiunta della verit che deve essere. Possibile a Dio,impossibile agli uomini. E in questo punto esatto che, secondo la mia opinio-ne, pu essere elaborata la struttura antropologica dellanticipazione dellim-possibile giustizia che ha da essere, ogni volta restituita allevidenza thauma
e skandalon, miracolo e ostacolo della manifestazione effettiva del FiglioGes. La coscienza in grado di anticipare la verit di Dio come ha da essere.E lelemento estetico-trascendentale della costituzione della coscienza creden-te. E tuttavia questa anticipazione della verit di Dio, adombrata nel desideriodi riscatto per s, confermata solo nella felicit per il riscatto dellaltro. Elelemento etico-antropologico della coscienza credente. Daltro canto, la cor-rispondenza del logos e del nomos anticipati, non pu essere formulata se nontramite il credito prestato alla figurazione della critica cristologica della religio-ne, che si dispone nellorizzonte della radicale purificazione religiosa di ognireligiosit che rappresenti la giustizia di Dio in modo difforme dalla sua giusti-
zia. E lelemento testimoniale-giudiziale della coscienza credente, che agiscedialetticamente sempre nello spazio della cura per la religione: non in alternati-va ad essa.
La decisione di prestar credito incondizionato a Ges, su questo punto esat-to, accetta la sovrapposizione definitiva fra lanticipazione dellessere-di-Dio,e labisso dellEssere che giustifica lassoluto di agape. Ossia di quella intimitinviolabile di Dio che custodisce la verit e la giustizia dellessere Assoluto,del quale non si pu pensare il maggiore. Libera decisione sempre esteticamen-te sorpresa e drammaticamente inquietata dalla manifestazione del Figlio.Eppure ogni volta felicemente certificata della sua impensabile evidenza, guar-dando, con ogni speranza e contro ogni speranza, a Ges autore e perfeziona-
ACTES DEL CONGRS PARAULA DE DU, PARAULA SOBRE DU184
-
7/27/2019 Sequeri, P. Il Logos Corrispondente
9/9
tore della fede. E la fede nella quale Egli stesso cresce e conduce, mediantelattestazione ecclesiale dellevangelo e la splendida forza dello Spirito, al feli-
ce approdo delladorazione di Dio secondo verit.
Pierangelo SEQUERICiro Menotti, 8I 20129 MILANO (Itlia)E-mail: [email protected]
Summary
The first part of the paper presents the importance of the argument, analyzing thepassage from Saint Anselms Proslogion (c. XIV), in which he refers to experiencingGod. After having reestablished the existence of God as a reality that implies the maxi-mum perfection of existence, Saint Anselm wonders why it is not presented to the liv-ing experience of the soul. Why does not my soul perceive you, oh Lord? Through theexperience of a love that delights in the joy of the other, Anselms reply to this questionopens up the horizon of a perfection of God that could turn into the idea of a con-science that can appreciably apprehend the truth. The road to the theological develop-ment of this intuition is reached through revealing the centrality of the Christological rev-elation of Gods love for man as the Critical Principle of religious experience.
P. SEQUERI, ILLOGOSCORRISPONDENTE. ESTETICA TEOLOGICA DELLA VERIT DI DIO 185