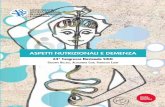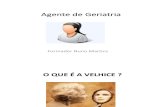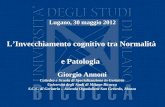ROMA 15 17 MAGGIO 2014 - GERIATRIA – Rivista · 2015. 10. 30. · SOCIETÀ ITALIANA DI GERIATRIA...
Transcript of ROMA 15 17 MAGGIO 2014 - GERIATRIA – Rivista · 2015. 10. 30. · SOCIETÀ ITALIANA DI GERIATRIA...


Direttore Responsabile
Segreteria Scientifica
Editore
Ufficio amministrativoe Pubblicità
Fotocomposizione
Stampa
Progetto di copertina: Gaia Zuccaro
ANTONIO PRIMAVERA
Via Cremona, 19 - 00161 RomaTel. 06.44.290.783
C.E.S.I. - Via Cremona, 1900161 Roma - Tel. 06.44.290.783www.cesiedizioni.com E.mail: [email protected]
Via Cremona, 19 - 00161 RomaTel. 06.44.290.783 - Fax 06.44.241.598
C.E.S.I.
Litografica IRIDE - Via della Bufalotta, 224Roma • Finito di stampare per conto della C.E.S.I. nel mese di Novembre 2013.
Paolo Chioatto (Vicenza)Antonio De Giovanni (Pavia)Vincenzo Fiore (Tivoli)Gianfranco Fonte (Torino)Andrea Galanti (Tivoli)Matteo Grezzana (Verona)
Rosa Maria Mereu (Cagliari)Salvatore Raffa (Roma)Barbara Rosso (Torino)Domenico Sabatini (S. Benedetto del T.)Rosanna Termini (Palermo)
Gianfranco Conati (Belluno)Silvio Costantini (Rimini)Carlo D’Angelo (Pescara)Francesco De Filippi (Sondrio)Alberto Ferrari (Reggio Emilia)Filippo Luca Fimognari (Cosenza)Massimo Fini (Roma)Fabrizio Franchi (PiacenzaLuigi Giuseppe Grezzana (Verona)Biagio Antonio Ierardi (Potenza)
Enzo Laguzzi (Alessandria)Antonio Nieddu (Sassari)Michele Pagano (Palermo)Lorenzo Palleschi (Roma)Massimo Palleschi (Roma)Demetrio Postacchini (Fermo)Manuela Rebellato (Torino)Bernardo Salani (Firenze)Stefano Maria Zuccaro (Roma)
COMITATO SCIENTIFICO
COMITATO DI REDAZIONE
GERIATRIARIVISTA BIMESTRALE - ANNO XXV n. 4 Luglio/Agosto 2013 – Poste Italiane S.p.A. - Sped. in Abb. Postale D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 N. 46) Art. 1 Comma 1 - DCB Roma
ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETà ITALIANA DI GERIATRIA OSPEDALE E TERRITORIO (S.I.G.O.T.)
DIRETTORE
LUIGI DI CIOCCIO
DIRETTORE ESECUTIVO
PIERLUIGI DAL SANTO
REDATTORE CAPO
MASSIMO MARCI
Condizioni di abbonamento per il 2013: E 30,00 (Enti: E 52,00) da versare sul C/C N. 52202009 intestato a CESI - Estero E 70 • Unfascicolo singolo: E 20,00 - Estero E 40. Arretrato: E 25,00 • L'abbonamento non disdetto prima del 31 dicembre si intende rinno-vato • Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 201/89 del 18/04/1989.
ISSN: 1122-5807

SOCIETÀ ITALIANA DI GERIATRIA OSPEDALE E TERRITORIO
ROMA 15-17 MAGGIO 2014
ANNUNCIOPRIM
O
Segreteria OrganizzativaCONGRESS LINE
Via Cremona, 19 – 00161 Roma
Tel. 06.44.29.07.83 - 06.44.241.343 Fax 06.44.24.15.98
E-mail: [email protected]

Ai lettori – Palleschi M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Editoriale: Oggi Enea è donnaGrezzana L.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Quali percorsi assistenziali per la persona con polipatologia cronica? L’esperienza del modello integrato senese di A.CRO.POLI.S.Bellini M.A., De Lalla A., Vannini P., Colonna C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
L’attività fisica in pazienti anziani affetti da deterioramento cognitivo lieve (MCI) ipertesi e nonRonsisvalle M.G., Leotta C., Toscano V., Vacante M., Maugeri D., Toro V., Schifilliti C., Laquinta M.T., Luca S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Iperuricemia cronica: dalla malattia da deposito di urati a fattore di rischiocardiovascolare residuoVendemiale G., Tusiano M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Nutrizione parenterale o enterale: criteri e limiti alla luce di recenti acquisizioniFranchi F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Up to date nello scompenso cardiaco: la terapia farmacologica dello scompensocardiaco cronico Gabrielli D., Savini E., Benvenuto M., Di Gioacchino L., Perna G.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Caso Clinico: Una strana cirrosiZocca N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
RUBRICHE
Vita agli anniSabatini D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Geriatria nel mondoZanatta A., Galanti A., Fiore V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Calendario Congressi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto 159
SOMMARIO

per ordini spedire a c.e.S.I. - Via cremona, 19 • 00161 roma anche via fax
Volume rilegato, Edizione 2007210 pagine circa E 20,00
Cognome ....................................…….......... Nome ……………………… Tel. ………………………………………………
Via .........................................................……………… CAP …………… Città ………………………………………………Firma .................................………………….... Contributo fisso spese imballo e spediz E 3,00 TOTALE E ..............……...........
■ Anticipato a mezzo Assegno Bancario (non trasfer.) allegato intestato a CESI ■ A mezzo vers. C/C N. 52181005 intestato a CESI ■ American Express (c/c N. ………………… Validità ……………… Firma ………………………………………………)
Per ordini telefonici 06.44.290.783 - 06.44.241.343 Fax 06.44.241.598 Via Cremona, 19 - 00161 Roma
Partita IVA ........................................................ (solo per chi desidera la fattura)
■■ Sì, desidero ricevere Il gIuramento dI Ippocrate – attualità tra mitologia, storia e tradizione al prezzo di E 20,00
✄

Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto 161
Carissimi,oggi vi vorrei intrattenere su un argomento che mi sta molto a cuore
e sul quale abbiamo avuto modo di dire qualcosa già in altre occasioni:gli innumerevoli modi di fare opera di promozione e sensibilizzazionegeriatrica.
L’occasione mi è stata offerta dalla pubblicazione di un libro, “La stra-ge degli innocenti. Terza età: anatomia di un omicidio sociale”, scritto dalDott. Roberto Gramiccia, mio collaboratore di tanti anni fa all’Ospedaledi Tivoli, insieme al giornalista Vittorio Bonanni.
Molto spesso, e non solo riferendoci all’argomento del quale stiamoscrivendo, quando si danno giudizi molto severi e si impiegano terminicrudi, si ha l’impressione che si voglia fare del sensazionalismo.
Va detto subito invece che chi conosce sul campo la realtà clinico-assi-stenziale dei malati anziani, non rispondente a criteri di scientificità diuna moderna Medicina, ma neppure a criteri medici empirici attendibili,non rimane affatto scandalizzato delle espressioni forti usate per descri-vere i “maltrattamenti” riservati agli anziani.
Il libro che ha la prefazione della famosa astrofisica Margherita Hackè costituito da due parti, una di carattere per così dire generale sul temadel “maltrattamento”, della discriminazione e dell’inadeguata assistenzaalla persona anziana, di grado tale da suggerire agli autori il titolo inparte provocatorio con cui viene edito il volume, la seconda da una serienumerosa di interviste sull’argomento, delle quali una al sottoscritto edun’altra al senatore Ignazio Marino.
Anche da un punto di vista etico-solidaristico, non ci si può meravi-gliare del titolo di questo pregevole libro, perché se da una parte i peg-giori delinquenti a volte evitano il carcere, dall’altra persone che hannodato tanto alla società e alla famiglia come gli anziani vengono collocatiin istituzioni definite “precimiteri”.
Quest’ultima espressione offre vari spunti di riflessione, ma risultamolto efficace per quanto riguarda la denuncia sull’emarginazione deglianziani, costretti spesso a vivere fuori del proprio ambiente, delle proprieabitudini, dei propri ricordi.
Tutto questo viene favorito da una spregiudicata imprenditoria priva-ta, rivolta più a facili guadagni, che al benessere degli anziani.
Mi rendo conto che l’istituzionalizzazione della persona anziana disa-bile può a volte costituire la soluzione meno dolorosa e pertanto svolge-re un servizio socio-sanitario importante, ma vorrei che venisse presa inconsiderazione sempre come ultima spiaggia.
La strage degliinnocenti
Massimo Palleschi
AI LETTORI

Corso di ii livelloelettrocardiografia
clinica deduttiva
Presidente del Corso: G. StaziDocenti: P. Delise, P. Zeppilli
Aprilia 12 Aprile 2014
Enea Hotel - Via del Commercio, 1
Segreteria OrganizzativaCONGRESS LINE
Via cremona, 19 – 00161 roma
tel. 06.44.29.07.83 - 06.44.241.343 Fax 06.44.24.15.98
e-mail: [email protected]

EDITORIALE Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto 163
Achille, bambino, viene affidato dal padrePeleo, ad un precettore, il Centauro Chirone, chegli insegna l’arte della caccia e della guerra.Eppure, il vero eroe dell’Iliade non è Achille, ma èla forza. Una forza usata dagli uomini e che sotto-mette gli uomini. La forza rende, chi la subisce, unoggetto.
Nel poema, le persone ci sono e poi non ci sonopiù. Sono solo comparse. Il primo attore è la forza.Non il conforto, non la consolazione, non la gloriaper chi ha combattuto ed è morto. La guerra sem-bra un gioco. Le vite distrutte sono poca cosa.Come un giocattolo rotto. Le vicende si svolgonosul campo di battaglia lontano dal ristoro di unacasa. Quasi tutto il poema procede lontano daibagni caldi, cioè dalla dolcezza e dalle carezze.Vinti e vincitori si alternano continuamente.
L’eroismo è esasperato e contaminato dall’o-stentazione. L’eroe si sente irresistibile perchéprotetto dal suo dio. La guerra gli sembra facile.Quando, però, la morte coglie i compagni amati,la battaglia smette di essere un gioco e il guerrie-ro ne coglie il dramma. È una realtà dura, troppodura per essere sopportata, in quanto racchiude lamorte. Il soldato vincitore è come un flagello. Èposseduto dalla guerra. Ha il potere di trasforma-re gli uomini in cosa. Questa peculiarità raggiun-ge il più alto grado sul campo di battaglia. I guer-rieri vengono paragonati al fuoco, al vento, a unfiume in piena, a bestie feroci o a qualsiasi causacieca di disastro. Oppure, ad animali impauriti,alberi, acqua, sabbia.
Da un giorno all’altro, Greci e Troiani vedonoalternarsi le sorti della guerra. È un gioco altale-nante. Solo Patroclo, amico di Achille, “seppeessere mite verso tutti”. Non commette atti bruta-li o crudeli. In questo scenario, si coglie che laforza domina. Però emergono momenti luminosi,brevi, in cui gli uomini hanno un’anima.
Nell’Iliade sono rappresentate quasi tutte leforme pure dell’amore fra gli uomini: l’amore delfiglio per i genitori, del padre e della madre per ilfiglio, l’amore fraterno, l’amore coniugale.
Il trionfo più puro dell’amore è l’amicizia chesgorga dal cuore di nemici mortali. Priamo, padredi Ettore, va da Achille a chiedere le spoglie delfiglio. Giunto al suo cospetto, si inginocchia, gli
bacia la mano destra che gli ha ucciso Ettore, ilfiglio primogenito. Malgrado tutto ne subisce ilfascino: “Príamo si pose maravigliando a contem-plar d’Achille le divine sembianze, e quale equanto il portamento”. A sua volta, Priamo fu col-pito da Achille che “il venerando volto n’ammira-va e il parlar pieno di senno”. Sono momenti digrazia, rari nell’Iliade, ma bastano a far sentirecon dolore ciò che la violenza fa e farà perire.
Ulisse, l’eroe dell’Occidente, cantato daOmero, è il primo eroe moderno, mutevole e mul-tiforme, capace di trasformazioni e travestimenti.
Al suo confronto, Achille sembra molto lonta-no con le sue ire smisurate e il suo eroismosovraumano. Ulisse è uno di noi. Ama le cosemortali e sente nostalgia per la sua terra, la suadonna, suo figlio. È un uomo che “patisce moltidolori”. Non rifiuta nulla della vita. Accoglie tuttocon curiosità. Di volta in volta, sa ingannare, temegli dei, è amante, mago, scienziato, narratore coin-volgente, vendicatore implacabile, difensore dellapatria e della proprietà privata, custode degliaffetti coniugali.
Itaca, la sua isola, è il centro di tutto. Ulisse haanche un’altra faccia. Quella dura, compatta, for-giata dalla sopportazione del dolore, capace disopravvivere a tutti i disastri per giungere ad unaconoscenza più profonda.
È la storia del vero eroe occidentale dal qualenoi tutti discendiamo. Le lodi di Ulisse sono can-tate dai poeti, però, Penelope è la vera eroina delpoema per la sua forza morale. Ulisse non vuolediventare immortale come Achille e la riconquistadi Itaca equivale al ritorno nella realtà. Ulissedesidera soltanto la sua patria, la sua donna, il suoletto. In questo se ne riconosce la grandezza.
Sua moglie, il suo vino, i suoi maiali, i suoimontoni. Nasce da qui il sentimento sacro delpossesso che avrebbe, poi, sempre distintol’Occidente. La città di Troia è in fiamme. Enea, frala polvere delle case distrutte e le urla dei soldati,finalmente giunge alla sua casa che sorgeva lonta-na e appartata. Trova i suoi sani e salvi, ma il vec-chio Anchise, suo padre, già sfinito dagli anni einfermo, rifiuta di abbandonare quei luoghi nel-l’ora estrema della patria. Vuole morire con lei.Rinuncia a quel poco che ancora gli resta da vive-re. Insiste nel suo proposito ed esorta gli altri allafuga. Enea, dopo aver tentato invano di convin-cerlo, si accinge di nuovo ad uscire per combatte-re e morire almeno con le armi in mano, ma
OGGI ENEA è DONNA
Grezzana L.G.
Direttore Scuola Medica Ospedaliera, Corso Superiore di Geriatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona
Indirizzo per la corrispondenza:Prof. Luigi Giuseppe GrezzanaE-mail: [email protected]

Creùsa, la moglie, lo implora di pensare alla suafamiglia. A quel punto della narrazione, accadeun prodigio divino. Una stella solca il cielo e illu-mina la via di fuga. Anchise, allora, cede al voleredegli dei. “Dunque, su, caro padre, sulle spalleponiti presto: non ne avrò fatica!”
Sono le parole che Enea rivolge al padreAnchise, nel II libro dell’Eneide. Enea, con ilpadre sulle spalle, cammina e trepida al minimorumore. Ha paura. Crede di essere inseguito dainemici. Alle esortazioni del padre accelera la fuga.Giunto nel luogo convenuto con i servi, primadella partenza, non trova più Creùsa. Disperatotorna indietro a cercarla ripercorrendo lo stessocammino, fin dentro la città, ma invano. Vede unospettacolo desolante di ciò che avevano potuto lefiamme e i nemici. La sua casa è trasformata inrogo. I templi distrutti, lunghe file di donne e dibambini prigionieri. Ritorna sgomento al luogodel convegno e trova molti troiani, pronti aseguirlo per mare, in ogni dove.
A detta dei critici più attenti, il II libro è il piùprofondo e umano di tutto il poema. Virgilio èvicino alla sorte dei vinti e degli infelici ed è lon-tano dalla furia omicida dei vincitori.
Particolarmente commovente, nell’ultimaparte del libro II, è l’immagine del vecchioAnchise. Di grande efficacia ci appare la figura diEnea in fuga, la sua rassegnata mestizia, la dolcez-za delle sue parole pronunciate da un uomo in cuivivono soltanto comprensione e bontà. Nel IIIlibro, si racconta l’errare di Enea nella speranza diuna nuova terra che lo accolga con la sua gente. Èuna peregrinazione forzata. Enea è alla ricerca diun po’ di pace. È un vinto che non ha più patria,che viaggia col rimpianto del passato e l’incertez-za dell’avvenire.
Arrivato in Sicilia, “Di qui la riva e il porto,ahimè funesti, m’accolsero di Drepano. Ivi ilpadre, vinte del mar insiem tante tempeste, d’o-gni pena conforto ed ogni rischio, persi per sem-pre. Ahimè, qui mi lasciasti da tanti rischi invanotratto in salvo, ottimo padre...”
Dopo la descrizione del viaggio attorno allaSicilia, la poesia cambia improvvisamente tono esi fa profondamente drammatica. L’ottimo padre“d’ogni pena conforto ed ogni rischio” muoreprima di poter toccare la terra promessa. La perdi-ta del padre, dopo tante pene sofferte insieme,suggerisce ad Enea parole accorate. Il dolore è taleche non può neppure essere paragonato a quellodelle tante e gravi avversità che gli erano stateprofetizzate. Lo sforzo, però, non è stato inutile. Èstato importante averlo fatto. Enea si è preso cari-co del padre ammalato e questo è quello checonta. Senza scendere in una critica letteraria dicui, oltretutto, non sono all’altezza, ho semprepensato che nel susseguirsi dello studiodell’Iliade, dell’Odissea e dell’Eneide, ci sia un
insegnamento che non può sfuggire. Nell’Iliade,viene cantata la forza quasi a mitizzarla. Quando,però, ci si avvicina all’Odissea, si rimane affasci-nati dalla conoscenza che Omero canta con gran-de fantasia. Ulisse, infatti, è il simbolo dell’uomocurioso che vuole sapere e conoscere. Di fatto,senza giudicare il valore dei poemi, la conoscenzava oltre la forza. Con l’Eneide, però, si va ancorapiù in là. Per fare un Virgilio ci vuole il dolore.Vengono cantate le grandi sventure pubbliche,oltre le piccole private ed è in quest’ottica cheviene sottolineata la solidarietà. Nell’Eneide è rac-contato il dolore per le sventure umane, per lapatria perduta immeritatamente, per gli affettifamiliari spezzati, per l’amore che illude e delude.
Tutti i sogni di pace, di lavoro, di bellezza,sono disconosciuti e frustrati. Il dolore è dubbio,disperazione, pianto, abbandono, rassegnazione,tristezza e stanchezza. Eppure, malgrado tutto,l’uomo affronta le avversità, forte della suacoscienza e della sua passione. Non vi sono vinci-tori nell’Eneide, ma tutti sono dei vinti. Nessunoama la guerra, tutti aspirano al riposo. L’eroedegno di pietà resta pur sempre Enea.L’immagine di quel padre in spalle e il figlio trot-terellante per mano, lo hanno reso immortale. Hacompreso che gli dei sono ingiusti, ma non cedemai alla speranza e tende con ogni sforzo allapace. La realtà demografica del nostro tempovede un aumento della fascia dei soggetti moltoanziani che, spesse volte, presentano inevitabil-mente qualche disabilità.
È sotto gli occhi di tutti che a prendersi caricodi loro sono soprattutto le figlie, le nuore, le nipo-ti. Conciliare i molti problemi del lavoro, dellafamiglia, con l’assistenza ad un anziano non èfacile. Un’altra categoria che è entrata con forzanello scenario dell’assistenza agli anziani è quelladelle badanti.
Inoltre, nel nostro mondo, la figura del medi-co, dell’infermiere, dell’assistente sociale è ormai,con netta prevalenza, basta guardarsi intorno,femminile. Da sempre, la dolcezza, la pazienza èal femminile. È quasi una questione di genereprendersi carico di chi sta male. Stupisce, però,non poco, che dinanzi ad una mole di lavoroimpressionante, legata ai tanti bisogni dei moltis-simi anziani, le donne non siano venute meno alloro impegno né tanto meno lo abbiano demanda-to agli uomini. Di fatto, con grande generosità esacrificio, si sono adeguate alle necessità dando almeglio tutte le risposte possibili. Ed è per questoche ho voluto dare come titolo a questo incontro”Oggi Enea è donna”.
La figura di Enea che si porta sulle spalle ilvecchio padre è passata alla storia, è diventataimmortale. Mi sembra sia l’essenza del poema diVirgilio ed un segno doveroso di pubblico ricono-scimento di una realtà indiscutibile.
164 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto

165
INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIOLe patologie croniche sono la prima causa di
morte e disabilità in quasi tutto il mondo; in
Europa provocano oltre 9 milioni di morti l’annosecondo le stime OMS e rappresentano la vera epropria emergenza epidemiologica del terzo mil-lennio (1,2).
I dati Istat (3) indicano che il 45,6% della popo-lazione italiana al di sopra dei sei anni di età, èaffetto da almeno una malattia cronica; in partico-lare sono colpite più di 25 milioni di persone,delle quali 7,6 milioni soffrono di una patologia
QUALI PERCORSI ASSISTENZIALI PER LA PERSONACON POLIPATOLOGIA CRONICA? L’ESPERIENZADEL MODELLO INTEGRATO SENESE DI A.CRO.POLI.S.
Bellini M.A.°, De Lalla A.°°, Vannini P.°°°, Colonna C.°°°°
°Dirigente Medico, Direttore U.O.S.A. A.CRO.POLI.S., Azienda Ospedaliera Universitaria Senese °°Dirigente Medico U.O.S.A. A.CRO.POLI.S., Azienda Ospedaliera Universitaria Senese°°°Responsabile Uff. Epidemiologia e Statistica Sanitaria, Direzione Sanitaria, Azienda Ospedaliera°°°°U.O. Affari Generali - Settore Informazione e Promozione della Salute, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Riassunto: Le patologie croniche sono la prima causa di morte e disabilità in quasi tutto il mondo, rappresentan-do una emergenza epidemiologica soprattutto in età geriatrica. In questa prospettiva, tenendo conto delle mutatecondizioni economiche e dell’invecchiamento demografico, al fine di migliorare l’efficacia delle cure, la continuitàassistenziale e realizzare consistenti economie per il sistema e per il cittadino, è necessario adattare il sistema daun meccanismo basato sulle patologie acute a uno più focalizzato sulle malattie croniche, che allontani il più pos-sibile la necessità della ospedalizzazione. Sulla base di queste premesse, l’Azienda Ospedaliera UniversitariaSenese tramite l’Unità Operativa A.CRO.POLI.S. (Assistenza alla Cronicità nella Polipatologia a Siena) ha istitui-to un servizio ambulatoriale dedicato all’assistenza ai soggetti più fragili, quelli che convivono con le malattie cro-nico-degenerative a rischio di instabilizzazione del quadro clinico. Questi pazienti, su segnalazione del Medico diMedicina Generale, sono stati inseriti in un percorso diagnostico e terapeutico personalizzato finalizzato a preve-nire e ridurre le riacutizzazioni, con un medico Geriatra a coordinamento tra le varie figure professionali coinvol-te. Sono stati presi in carico per 12 mesi 189 soggetti, 110 donne e 79 uomini, di età media 80 ± 9,6 anni: in questapopolazione sono state osservate, dopo la presa in carico da parte di A.CRO.POLI.S. e rispetto all’anno preceden-te, una riduzione statisticamente significativa del 20,4% del numero medio di giornate di degenza al mese (*p: 0,01)e della durata media dell’eventuale ricovero successivo alla presa in carico (-53,8%; **p:0,001), il numero medio diaccessi in PS al mese del 26,17% e della probabilità di ricovero ospedaliero dopo eventuale accesso in ProntoSoccorso del 17%. Ciò è riconducibile al miglioramento delle condizioni di salute e si riflette conseguentementenella maggior disponibilità delle risorse per i malati più urgenti.
Parole chiave: polipatologia, modello assistenziale integrato, percorso.
Which pathways for the patient with multiple chronic diseases? The experience of the integrated care model of Siena A.CRO.POLI.S.
Summary: Chronic diseases are the leading cause of death and disability in almost all over the world, representing an epide-miological emergency especially in the elderly. In this perspective, taking account of changing economic conditions and anaging population, in order to improve the effectiveness of care, continuity of care, and realize savings for the system and forthe citizen, it is necessary to adapt the health system by a mechanism based on acute pathologies to one more focused on chro-nic diseases, that reduces as much as possible the need for hospitalization. Based on these premises, the University Hospitalof Siena through the Unit A.CRO.POLI.S. (Assistenza alla Cronicità in Polipatologia in Siena) established an outpatient ser-vice dedicated to assist those with chronic-degenerative diseases and at risk of destabilization of the clinical picture with aGeriatrician in coordination between the various professionals involved. These patients, on the recommendation of the GeneralPractitioner, were included in a diagnostic and therapeutic pathway to prevent and reduce exacerbations. 189 patients, 110women and 79 men, mean age 80 ± 9.6 years, were taken into care for 12 months; in this population a statistically significantreduction of the mean number of days in hospital per month (- 20,4%, * p: 0.01) and the mean duration of any hospitaliza-tion following the enrollment (-53,8%; **p:0,001), the average number of accesses to emergency room in the month (- 26.17%)and the probability of hospitalization after any access to the emergency department (- 17%) have been observed comparing theyear after the enrollment by A.CRO.POLI. S. and the previous year. This is attributable to the improvement of health condi-tions and consequently leads to a greater availability of resources for the most urgent patients.
Keywords: multiple chronic diseases, integrated caremodel, pathway.
Indirizzo per la corrispondenza:Dott. Marco BelliniPoliclinico Santa Maria alle Scotte - U.O.S.A.A.CRO.POLI.S.Viale Bracci - 53100 SienaE-mail: [email protected]

cronica grave e 8,1 milioni risultano affette con-temporaneamente da tre o più malattie croniche.Le donne in particolare sono le più colpite dallapresenza di più malattie croniche con un tassoquasi doppio rispetto agli uomini.
Se la Relazione sullo Stato di Salute del nostroPaese evidenzia che gli italiani sono sempre piùlongevi e che la speranza di vita è una delle piùalte al mondo (78,8 anni per gli uomini e 84,1 perle donne), l’aumento della durata della vita siaccompagna però all’insorgenza di patologie cro-niche (4). Benché le patologie croniche non sianoun problema esclusivo della terza età in quanto nerisultano soffrire 2 milioni di cittadini italiani dietà compresa fra i 6 e i 24 anni (5, 6), la cosiddettaterza età è la fascia ove si concentrano più casi dipatologie croniche gravi in quanto è stato stabili-to che oltre il 60% delle persone affette da malat-tie croniche ha più di 65 anni (7,8).
Il forte impatto delle malattie croniche ha com-portato l’avvio di un radicale processo di trasfor-mazione nel Servizio Sanitario Nazionale che hacondizionato un progressivo spostamento dell’of-ferta di servizi sanitari dall’ospedale al territorio,insufficiente però a fornire equità di accesso aun’assistenza adeguata.
Se si fa riferimento alla sola popolazione conpiù di 65 anni di età, vale a dire quella che mag-giormente necessita di cure presso il propriodomicilio, emerge che soltanto 3,27 anziani su 100sono beneficiari di tale servizio, con forti differen-ziazioni tra le regioni (9-11).
La Toscana è una delle regioni d’Italia conun’alta percentuale di popolazione anziana, circail 20% del totale, e ciò significa che se da un lato laqualità della vita è molto alta, con un’elevatacapacità di cura e tempestività con cui vengonoportati i soccorsi sanitari, dall’altro questa fetta dipopolazione richiede necessariamente cure eattenzioni particolari. Gli anziani residenti nellaRegione Toscana con almeno 3 malattie cronichesono stimati in circa il 9% degli ultrasessantacin-
quenni (oltre 70.000 persone). I 4/5 delle presta-zioni sanitarie in Toscana sono richieste per il trat-tamento della cronicità.
La città di Siena in particolare ha un indice divecchiaia (rapporto fra n° di residenti ≥ 65 anni en° di soggetti ≤ 14 anni X 100) particolarmente ele-vato, pari a 244.8, con una media provinciale di194, contro una media nazionale di 144,5 (Fig. 1).
Se attualmente quindi le malattie croniche rap-presentano l’onere più alto per la maggior partedei sistemi sanitari (complessivamente gravanoper circa il 70% del bilancio dei sistemi sanitarieuropei) appare evidente la necessità di migliora-re l’efficacia delle cure e la continuità assistenzia-le realizzando quindi consistenti economie per lacomunità e per il singolo cittadino.
In questa prospettiva diventa necessarioorientare il sistema da un meccanismo basatosulla gestione delle patologie acute a uno piùfocalizzato sulla gestione delle malattie cronico-degenerative attraverso la prevenzione dellecomplicazioni e della necessità di ospedalizzazio-ne e la ottimizzazione dei servizi di assistenzaterritoriale (12-15).
Come si può quindi affrontare il problemadella ottimizzazione delle risorse per il migliora-mento della qualità delle prestazioni, tenendoconto delle mutate condizioni economiche e del-l’invecchiamento demografico (16,17)?
La risposta può arrivare dalla prevenzione(18,19); occorre cioè passare da un modello di curadisegnato sulle malattie acute e basato sull’attesa,cioè sulla risposta alla domanda, ad un modellodi “sanità di iniziativa”, basato cioè su un approc-cio proattivo in grado di garantire al pazienteinterventi adeguati e differenziati in rapporto allivello predefinito di rischio (20,21).
La “Sanità di Iniziativa” è stata introdotta nelPiano Sanitario Regionale Toscano 2008-2010 e poiripresa nel Piano Sanitario e Sociale IntegratoRegionale 2012-2015, in risposta alla necessità diorientare i sistemi socio-sanitari verso un’organiz-zazione in grado non solo di curare il bisognoacuto, ma soprattutto di prevenire la cronicità e lesue complicazioni.
La “Sanità di Iniziativa” si basa sul concettoche un approccio proattivo che vada incontro aibisogni del cittadino raccogliendo la sua doman-da di salute anche quando inespressa e comunqueprima che si aggravi o si complichi è sicuramentepiù vantaggioso che aspettare il cittadino sullasoglia dell’Ospedale.
Sulla base di queste indicazioni, applicando icriteri di appropriatezza e di riqualificazione/riconversione della rete ospedaliera, l’AziendaOspedaliera Universitaria Senese aveva dato vitaad un progetto sperimentale di sanità di iniziati-va dedicato proprio alla cura delle malattie croni-che, della durata di sei mesi, il progetto
166 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto
Fig. 1 – Tasso di ricovero ospedaliero 2010: Regione Toscana– Zona Senese.

Bellini M.A., De Lalla A., Vannini P., et al. - Quali percorsi assistenziali per la persona con... 167
A.CRO.POLI.S. (l’acronimo sta per “Assistenzaalla Cronicità nella Polipatologia a Siena”), inte-grato tra Azienda Ospedaliera UniversitariaSenese, Azienda USL 7 e Medici di MedicinaGenerale, con la collaborazione dell’Ordine deiMedici, in risposta al progetto regionale basatosulla medicina d’iniziativa e sulle organizzazionisanitarie che si riferiscono al “chronic caremodel” (22).
Superata la fase sperimentale con risultatipositivi, il servizio dedicato all’assistenza ai sog-getti più fragili, quelli che convivono con le malat-tie cronico-degenerative a rischio, è stato istituitoin modo permanente presso il nosocomio senese,con l’Unità Operativa (U.O.) A.CRO.POLI.S.
L’idea di fondo è stata quella di istituire unsistema capace di svolgere un ruolo di interrela-zione tra la Medicina Generale e la MedicinaSpecialistica, garantendo così la continuità assi-stenziale ad una popolazione di pazienti cronicifragili portatori di pluripatologie ad elevatorischio di instabilizzazione, per far sì che l’orga-nizzazione dei servizi sanitari potesse essere pro-gettata per aumentare la capacità di risposta assi-stenziale nei confronti dei pazienti affetti da pato-logie croniche, riducendone le riacutizzazioni.
L’attività assistenziale di A.CRO.POLI.S. haprevisto una reale presa in carico del paziente, conun medico Geriatra a coordinamento tra le variefigure professionali coinvolte, per organizzare unpercorso diagnostico terapeutico personalizzatosul modello “case management” e definire unadeguato timing dei controlli, allo scopo di ridur-re il numero dei ricoveri potenzialmente evitabili.
In questo lavoro si presentano quindi i risulta-ti preliminari ottenuti dall’U.O. del progettoA.CRO.POLI.S.
MATERIALI E METODINel periodo 1/1/2011-31/12/2011 sono stati
presi in carico da parte della U.O. A.CRO.POLI.S.n.189 soggetti, 110 donne e 79 uomini, di etàmedia 80 ± 9,6.
Questi stessi soggetti, affetti da polipatologiacronica a rischio di instabilizzazione del quadroclinico, avevano effettuato nel corso dell’annosolare precedente (2010): - n. 68 ricoveri, pari a 854 giornate di degenza
(l’intero gruppo dei 189 soggetti aveva effet-tuato una media di 71,16 giornate di degenzaal mese);
- n. 133 accessi in Pronto Soccorso (l’intero grup-po dei 189 soggetti aveva effettuato una mediadi 11,08 accessi/mese).I soggetti in questione sono stati selezionati ed
inviati alla struttura A.CRO.POLI.S. delPoliclinico senese soprattutto dai Medici diMedicina Generale ed in misura minore daSpecialisti Ospedalieri. Dopo aver concordato con
il Medico proponente il piano di cura e il calenda-rio dei controlli, tutti i soggetti sono stati sottopo-sti a Valutazione Multidimensionale ed inseritisecondo il livello di rischio in un percorso diagno-stico e terapeutico personalizzato e coordinato,basato sul modello “case management” ed ingrado di offrire risposte diagnostiche e terapeuti-che differenziate (esami di laboratori, esami stru-mentali, consulenze specialistiche) non solo diffe-ribili ma anche rapide (queste ultime tramitecanali preferenziali per l’accesso alle prestazioniospedaliere urgenti), fornendo anche un supportocontinuo all’autogestione della malattia da partedel paziente.
Al termine del percorso sono stati effettuati: 1. Eventuale prescrizione e somministrazione di
farmaci urgenti per via endovenosa in sedemediante day-service;
2. Rinvio del paziente al proprio domicilio conprescrizione di terapia, consegna farmaci e/ocompilazione ricetta;
3. Osservazione presso U.O. “Pronto Soccorso eMedicina d’Urgenza”;
4. Ricovero ordinario.
RISULTATINel periodo 1/1/2011-31/12/2011, i 189
pazienti arruolati nel progetto A.CRO.POLI.S.,hanno effettuato n. 730 giornate di degenza, di cui106 successive a ricoveri in elezione e 624 succes-sive a ricoveri in urgenza.
Delle 730 giornate di degenza effettuate, 306sono state effettuate prima della presa in carico e424 (delle quali n. 106 giornate successive a rico-veri in elezione) dopo l’inserimento nel percorsodi A.CRO.POLI.S. Il periodo medio di presa incarico nell’arco del 2011 è stato di 7,3 mesi.
Nel periodo 1/1/2010-31/12/2010 i 189pazienti successivamente arruolati daA.CRO.POLI.S., avevano effettuato n. 854 giorna-te di degenza.
Suddividendo il numero delle giornate didegenza per il periodo medio (in mesi) di presa incarico, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 2010• 854 giornate di degenza/12 mesi: 71,16 giorna-
te di degenza/mese;• 68 ricoveri/12 mesi: 5,6 ricoveri/mese.2011• 306 giornate/4,6 mesi (periodo medio prima
della presa in carico da parte diA.CRO.POLI.S.): l’intero gruppo dei 189 sog-getti ha effettuato una media di 66,5 giornatedi degenza/mese;
• 424 giornate/7,3 mesi (periodo medio succes-sivo alla presa in carico): l’intero gruppo dei189 soggetti ha effettuato una media di 57 gior-nate di degenza/mese.Confrontando il numero complessivo di gior-

168 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto
nate di degenza effettuate dai 189 soggetti presi incarico da A.CRO.POLI.S. nel corso del 2010 con ilnumero di giornate di degenza effettuato daglistessi soggetti nel corso del 2011, si sono registra-te 124 giornate di degenza in meno, con una ridu-zione del 14,5% (Fig. 2).
Il confronto 2010-2011 mostra una riduzionestatisticamente significativa del 20,4% del numeromedio di giornate di degenza al mese (*p: 0,01 testchi-quadrato). Per quanto riguarda gli accessi inPronto Soccorso nel 2010, i 189 soggetti che l’annosuccessivo sarebbero stati presi in carico daA.CRO.POLI.S. avevano effettuato 133 accessi inPS a cui erano seguiti 68 ricoveri, in media unricovero ospedaliero ogni 1,9 accessi. Nel 2011 imedesimi 189 soggetti hanno effettuato dopo lapresa in carico da A.CRO.POLI.S, n. 90 accessi inPS, a cui sono seguiti 31 ricoveri (in media unricovero ospedaliero ogni 2,9 accessi), pertantodopo la presa in carico di A.CRO.POLI.S. si ridu-ce del 17% la probabilità di ricovero ospedalieroin caso di accesso in PS (Fig. 3). In particolare, nelperiodo 1/1/2011 - 31/12/2011, sono stati effet-tuati 166 accessi in PS, dei quali 76 prima dellapresa in carico e 90 dopo.• 76 : 4,6 = 16,4 accessi/mese• 90 : 7,3 = 12,1 accessi/mese
Quindi la frequenza di accessi in ProntoSoccorso dopo la presa in carico nel progettoA.CRO.POLI.S è diminuita del 26.17%/mese (Fig. 4).
Per quanto riguarda la durata media dei ricove-ri, il confronto mette in evidenza che nel 2010 i sog-getti che l’anno successivo sarebbero stati presi incarico da A.CRO.POLI.S. avevano effettuato 68ricoveri della durata media di 22,39 giorni.
Nel 2011, gli stessi soggetti presi in carico daA.CRO.POLI.S. hanno effettuato 31 ricoveri delladurata media di 10,34 giorni.
Si evidenzia pertanto che dopo la presa in cari-co di A.CRO.POLI.S. si riduce del 53,8%, in modostatisticamente significativo rispetto al 2010, ladurata media di un eventuale successivo ricovero(**p: 0,001 test chi-quadrato) (Fig. 5). La mortalitàdei soggetti in esame è stata del 6,3% (età mediadei deceduti 86,08 ± 5,94) nel corso dell’anno sola-re di riferimento (2011) (Fig. 6).
CONCLUSIONII dati ottenuti (Fig. 7) dimostrano come succes-
sivamente alla presa in carico nel progetto assi-stenziale A.CRO.POLI.S. si è osservata una ridu-zione statisticamente significativa del numeromedio mensile delle giornate di degenza e della
Fig. 2 – Confronto 2010/2011 del numero totale di giornate didegenza.
Fig. 4 – Anno 2011: confronto tra il numero medio mensile diaccessi in Pronto Soccorso prima e dopo la presa in carico diA.CRO.POLI.S.
Fig. 3 – Confronto 2010/2011 tra il numero di accessi in ProntoSoccorso e conseguente ricovero ospedaliero.
Fig. 5 – Confronto 2010/2011: durata media del ricovero suc-cessivo all’accesso in Pronto Soccorso prima e dopo la presa incarico di A.CRO.POLI.S.

durata media di un eventuale ricovero successivoalla presa in carico.
La riduzione del numero totale di giornate didegenza, associata alla riduzione del numeromedio di accessi in PS al mese ed alla probabilitàdi ricovero ospedaliero dopo accesso in ProntoSoccorso, è riconducibile alla maggiore disponi-bilità di alternative al ricovero ospedaliero e allafacilitazione del difficile processo di dimissionecon conseguente maggiore disponibilità di risor-se per i malati con patologie necessitanti di rico-veri urgenti. Ciò a dimostrazione che l’approccioassistenziale più adatto a questa tipologia di sog-getti “fragili” non può che essere quello maggior-mente dinamico, adattato a garantire la rispostapiù adeguata a seconda del livello di rischio, cheprevede una reale presa in carico del paziente edil suo inserimento in un percorso personalizzatoe coordinato.
Questi risultati positivi sono stati resi possibiligrazie ad una forte integrazione tra le diverse ti -po logie di professionisti, in primis i Medici di Me -dicina Generale, che hanno creduto in questo tipodi attività, “a ponte” tra la Medicina Generale e laMedicina Specialistica Ospedaliera e che hannodimostrato che è possibile realizzare un sistemaassistenziale integrato nel quale i soggetti coinvol-ti possano svolgere il proprio ruolo senza sovrap-posizioni, garantendo maggiormente al pazienteun’appropriatezza delle cure fornite in base al
livello di rischio, favorendo la continuità assisten-ziale e migliorando il collegamento e l’integrazio-ne ospedale-territorio e territorio-ospedale.
È possibile pertanto aumentare concretamentela capacità di risposta assistenziale ai cittadiniaffetti da patologie croniche per ridurre e cercaredi evitare le riacutizzazioni, ridurre accessi impro-pri al pronto soccorso ed i ricoveri ripetuti neipazienti affetti da polipatologia cronica, prose-guendo nello stesso tempo nella direzione dellasanità di iniziativa.
Bellini M.A., De Lalla A., Vannini P., et al. - Quali percorsi assistenziali per la persona con... 169
Fig. 6 – Ricoveri ordinari in Medicina Generale e Geriatrianell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese dei soggetti >65 anni.
Fig. 7 – Sintesi dei risultati ottenuti da A.CRO.POLI.S. nel 2011.

170 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto
1. BARNETT K., MERCER S.W., NORBURY M., et al.: Epidemiology ofmultimorbidity and implications for health care, research, and medical educa-tion: a cross-sectional study. Lancet 2012; 380: 37-43.2. DIEDERICHS C., BERGER K., BARTELS D.B.: The measurement of mul-tiple chronic diseases--a systematic review on existing multimorbidity indices.J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2011; 66: 301-311.3. Istituto Nazionale Statistica (ISTAT). Condizioni di salute, fattori di rischioe ricorso ai servizi sanitari. ISTAT Roma 2005.4. Ministero della Salute italiano. Relazione sullo Stato Sanitario del Paese.Roma 2009-2010.5. CRICELLI C., MAZZAGLIA G., SAMANI F., et al.: Prevalence estimatesfor chronic diseases in Italy: exploring the differences between self-report andprimary care databases. J Public Health Med. 2003; 25: 254-257.6. MENOTTI A., MULDER I., NISSINEN A., et al.: Prevalence of morbidityand multimorbidity in elderly male populations and their impact on 10-yearall-cause mortality: The FINE study (Finland, Italy, Netherlands, Elderly). JClin Epidemiol. 2001; 54: 680-686.7. MARENGONI A., ANGLEMAN S., MELIS R., et al.: Aging with multi-morbidity: a systematic review of the literature. Ageing Res Rev. 2011; 10: 430-439.8. CORSONELLO A., ANTONELLI INCALZI R., PISTELLI R., et al.:Comorbidities of chronic obstructive pulmonary disease. Curr Opin PulmMed. 2011; 17 Suppl 1: S21-28.9. BINDMAN A.B., GRUMBACH K., OSMOND D., et al.: Preventablehospitalizations and access to health care. JAMA. 1995; 274: 305-311.10. ANTONELLI-INCALZI R., ANCONA C., FORASTIERE F., et al.:Socioeconomic status and hospitalization in the very old: a retrospective study.BMC Public Health. 2007; 7: 227.
11. RIZZA P., BIANCO A., PAVIA M., et al.: Preventable hospitalization andaccess to primary health care in an area of Southern Italy. BMC Health ServRes. 2007; 7: 134.12. BIANCO A., PILEGGI C., ANGELILLO I.F.: Non-urgent visits to a hospi-tal emergency department in Italy. Public Health. 2003; 117: 250-255.13. ANGELILLO I.F., RICCIARDI G., NANTE N., et al.: Appropriateness ofhospital utilisation in Italy. Public Health. 2000; 114: 9-14.14. DIXON T., SHAW M., FRANKEL S., et al.: Hospital admissions, age, anddeath: retrospective cohort study. BMJ 2004; 328: 1288.15. MARCANTONIO E.R., MCKEAN S., GOLDFINGER M., et al.: Factorsassociated with unplanned hospital readmission among patients 65 years of ageand older in a Medicare managed care plan. Am J Med. 1999; 107: 13-17.16. SANDERSON C., DIXON J.: Conditions for which onset or hospitaladmission is potentially preventable by timely and effective ambulatory care. JHealth Serv Res Policy. 2000; 5: 222-230.17. MUENCHBERGER H., KENDALL E.: Predictors of preventable hospita-lization in chronic disease: priorities for change. J Public Health Policy. 2010;31: 150-163.18. FRIES J.F.: Aging, natural death, and the compression of morbidity. 1980.Bull World Health Organ. 2002; 80: 245-250.19. MOR V.: The compression of morbidity hypothesis: a review of research andprospects for the future. J Am Geriatr Soc. 2005; 53: S308-309.20. FANI MARVASTI F. AND STAFFORD R.S.: From sick care to health care.N Engl J Med 2012; 367: 889.21. TEMPLE R.M., KIRTHI V., PATTERSON LJ.: Is it time for a new kind ofhospital physician? BMJ. 2012; 344: e2240.22. COLEMAN K., AUSTIN B.T., BRACH C., et al.: Evidence on the ChronicCare Model in the new millennium. Health Aff (Millwood). 2009; 28: 75-85.
BIBLIOGRAFIA

171
INTRODUZIONEL’attività fisica è considerata un fattore deter-
minante nella salute degli adulti e soprattuttodegli ultrasessantenni. L’attività fisica regolareproduce adattamenti cardiovascolari, atti adaumentare la resistenza dell’organismo all’eserci-zio, essa inoltre impedisce lo sviluppo della malat-tia coronarica (CAD) e riduce i sintomi nei pazien-ti con malattia cardiovascolare. L’esercizio fisicoesplica un effetto benefico sui fattori di rischio ate-rosclerotici: ipertensione arteriosa, insulino-resi-stenza e intolleranza al glucosio, ipertrigliceride-mia, ipercolesterolemia e ridotti livelli di coleste-rolo HDL. Inoltre, in combinazione con la riduzio-ne di peso corporeo, può diminuire la concentra-zione sierica di lipoproteine a bassa densità (LDL-C). Un dispendio energetico di circa 1600 kcal
(6720 kJ) a settimana è ritenuto efficace nell’arre-stare la progressione della malattia coronarica, edun dispendio energetico di circa 2200 kcal (9240kJ) a settimana ha mostrato essere associato aduna riduzione dello spessore di placche ateroma-siche nei pazienti con insufficienza cardiaca.L’esercizio fisico agisce riducendo la frequenzacardiaca e la pressione arteriosa a riposo: è possi-bile dimostrare una diminuzione media dellapressione sistolica e diastolica di 3,4 e 2,4 mmHgrispettivamente. Si assiste ad una migliore perfu-sione e quindi ossigenazione del miocardio, men-tre si riduce la risposta vasocostrittrice anomalaall’acetilcolina (1). Infine negli anziani l’attivitàmotoria riduce significativamente le concentrazio-ni sieriche di RAGE, radicali dell’ossigeno, costan-temente correlati con il danno endoteliale e l’in-sorgenza di patologie aterosclerotiche (2).
SCOPO DEL LAVOROScopo del nostro lavoro è stato quello di valu-
tare gli effetti di un programma di attività fisica
L’ATTIVITà FISICA IN PAZIENTI ANZIANI AFFETTI DA DETERIORAMENTO COGNITIVO LIEVE (MCI) IPERTESI E NON
Ronsisvalle M.G., Leotta C.1, Toscano V.1, Vacante M., Maugeri D., Toro V., Schifilliti C.,Laquinta M.T., Luca S.
Dipartimento di Chirurgia, Sez. Geriatria, Università di Catania 1 Mov.i.s. Onlus, Giarre (Catania)
Indirizzo per la corrispondenza:Prof. Maugeri Domenico Ospedale Cannizzaro, CataniaE-mail: [email protected]
Riassunto: Scopo del nostro lavoro è stato quello di esaminare gli effetti dell’attività fisica su 59 pazienti autosuf-ficienti affetti da deterioramento cognitivo lieve (MCI), paragonando gli ipertesi con i normotesi.I soggetti arruolati sono stati testati con il MMSE all’inizio del programma di allenamento e dopo sei mesi.Per confrontare i risultati ottenuti nei pazienti ipertesi rispetto ai normotesi abbiamo utilizzato il Paired T test. Ilpunteggio al MMSE test è stato di 25,74±2,9 e 26±2,93 rispettivamente nei pazienti ipertesi e nei normotesi. Doposei mesi di esercizio fisico il punteggio è stato di 26,3±3,64 (P= 0,37) negli ipertesi e di 27,15±3,69 (P= 0,013) neinormotesi.Dai risultati ottenuti si evince che l’attività fisica riduce il deterioramento cognitivo nei soggetti anziani.Comunque nei pazienti ipertesi i risultati ottenuti non sono statisticamente significativi, probabilmente perché essiposseggono un profilo vascolare scadente. L’ipertensione, infatti, è correlata con aterosclerosi, stroke e malattia diAlzheimer.
Parole chiave: attività fisica, pazienti anziani ipertesi, deterioramento cognitivo lieve.
Physical activity in elderly patients with hypertension and MCI
Summary: We used the Paired T test to compare results in patients with hypertension and patients without hypertension.The MMSE test score was 25,74±2,9 and 26±2,93 in patients with hypertension and in patients without hypertension respec-tively. After six months of aerobic exercise the score was 26,3±3,64 (P= 0,37) in elderly with hypertension, while in elderlypatients without hypertension it was 27,15±3,69 (P= 0,013).Physical activity in elderly patients reduces cognitive impairment. However, in patients with hypertension this result is notstatistically significant, probably because they have a poor vascular condition. Hypertension is related with atherosclerosis,stroke and Alzheimer disease.
Keywords: physical activity, elderly patients with hypertension, MCI.

aerobica dedicato a soggetti ultrasessantacin-quenni con Mild Cognitive Impairment (MCI) (3),autosufficienti ipertesi, rispetto ad un gruppo diultrasessantacinquenni con MCI non ipertesi.
MATERIALI E METODIPer questo studio sono stati arruolati, in un
arco di tempo di 4 mesi, 59 soggetti, con un’etàmedia di 69,7 anni, afferenti all’associazioneMOV. I. S. Onlus di Giarre, operante in convenzio-ne con la Scuola di Specializzazione in Geriatriadell’Università degli Studi di Catania.
I pazienti sono stati suddivisi in 2 sottogruppi:1 - composto da 32 soggetti ipertesi (12 donne
con un’età media di 69,3 anni e 15 uomini conun’età media di 69,5 anni);
2 - composto da 27 soggetti normotesi (10 donnecon un’età media di 69,7 anni e 13 uomini conun’età media di 69,6 anni). Per tutti, i criteri di inclusione sono stati:a) Età ≥ 65 anni; b) MMSE (Mental State Examination) (4)compreso tra 24 e 28 (MCI)c) Autosufficienza valutata mediante ADL eIADL (5-6) (Activities of daily living eInstrumental activities of daily living) accerta-ta solamente all’atto dell’arruolamento.
Ogni mese tutti i soggetti sono stati sottoposti a:• Misurazione del peso corporeo e della circon-
ferenza vita;• calcolo del BMI (7-8).
All’inizio ed alla fine del periodo di studio(previsto in sei mesi), tutti i soggetti hanno ricevu-to la somministrazione del MMSE.
L’attività fisica è stata svolta dai nostri utenticon una frequenza trisettimanale, in sessioni di50 minuti guidate da personale medico e tecnicospecialistico.
La sessione era composta da:• 15 minuti di riscaldamento; • 10 minuti di corpo libero;• 10 minuti di cyclette;• 15 minuti di defaticamento.
I soggetti sono stati testati al tempo 0 (T0) edopo 6 mesi (T1).
RISULTATIPer valutare i risultati ottenuti nel confronto
tra pazienti ipertesi e pazienti normotesi, abbiamoutilizzato il paired T test.
I risultati ottenuti sono stati di grande rilievo.Infatti, come si evince dalla tabella 1, i pazientinormotesi trattati con attività fisica hanno ottenu-to un miglioramento statisticamente significativodel livello cognitivo, valutato mediante MMSE.
Per quanto riguarda, invece, i pazienti ipertesi,comunque trattati con attività fisica, si assiste ad unmiglioramento delle performance cognitive seppur
senza raggiungere la significatività statistica.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONICome si evince dal nostro studio, l’attività fisica
controllata favorisce un rallentamento del declinodelle performance cognitive negli adulti ultrases-santacinquenni, siano essi ipertesi o non ipertesi.Nei soggetti ipertesi però, i dati ottenuti sono menosoddisfacenti; questo perché, probabilmente, essipartono da una condizione vascolare già scadente.Infatti, molti studi confermano un’associazione traqueste patologie e la demenza.
L’ipertensione è sicuramente una delle princi-pali cause di demenza vascolare. Studi recenti,però, dimostrano un suo coinvolgimento anchenell’insorgenza di malattia di Alzheimer e nelleMCI (7). The Honolulu Asia Aging Study del1995, ha dimostrato che per ogni aumento di 10mmHg della pressione arteriosa sistolica si assistead un incremento di rischio di sviluppare deficitcognitivo del 10%. Soggetti ipertesi non trattatihanno un rischio del 4,3% di andare incontro adeclino cognitivo, mentre per i soggetti trattati ilrischio è solo dell’1,9% (8).
L’ipertensione arteriosa agisce sia sul sistemavascolare cerebrale, che direttamente sul cervello.Sicuramente essa determina un aumento delrischio di aterosclerosi, ictus o infarto cerebrale, chea loro volta sono strettamente correlati al declinocognitivo. Probabilmente elevati livelli di pressionearteriosa determinano deterioramento delle picco-le arterie cerebrali, con conseguente atrofia cerebra-le, infarti multipli e danno della sostanza bianca. Ipazienti con ipertensione mostrano una riduzionedei nuclei del talamo e del volume dei lobi tempo-rali, ottenendo risultati peggiori nei test di linguag-gio e di memoria.
Questo suggerisce che l’area temporale e leregioni occipitali siano più vulnerabili all’atrofiacerebrale correlata all’ipertensione. Inoltre que-st’ultima si accompagna a rigidità delle pareti vasa-li ed arteriosclerosi, con ulteriore peggioramentodella perfusione encefalica.
Elevati livelli di pressione arteriosa sono asso-ciati anche alla comparsa di numerosi groviglineuro-fibrillari nella corteccia e nell’ippocampo,analoghi a quelli riscontrabili nell’AD. Le lesionidella sostanza bianca cerebrale, rilevate da studi dirisonanza magnetica effettuati in pazienti ipertesi,suggeriscono che l’ipertensione può causaredemielinizzazione della materia bianca e conse-
172 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto
Tab. 1 - Risultati a T0 e T1 e significatività statistica
T0 T6 P
MMSE i 25,74 ± 2,9 26,3 ± 3,64 0,37
MMSE n 26 ± 2,93 27,15 ± 3,69 0,013*
i = ipertesi; n = normotesi.

Ronsisvalle M.G., Leotta C., Toscano V., et al. - L’attività fisica in pazienti anziani affetti... 173
guente declino cognitivo (7). Da quanto detto si evince che promuovere e
facilitare la pratica regolare di attività aerobicaanche negli anziani è particolarmente importante,
perché questo gruppo di popolazione è moltospesso poco attivo e basse sono le percentuali disoggetti che raggiungono i livelli di attività fisicaraccomandati.

1. THOMPSON P.D., BUCHNER D., PIÑA I. L., et al.: Exercise and PhysicalActivity in the Prevention and Treatment of Atherosclerotic CardiovascularDisease. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 2003; 23; 42-49.2. KOTANI K., CACCAVELLO R., SAKANE N., et al.: Influence of PhysicalActivity Intervention on Circulating Soluble Receptor for Advanced Glycationand Products in Elderly Subjects. J Clin Med Res 2011; 3: 252-257.3. GAUTHIER S., REISBERG B., ZAUDIG M., et al.: Mild cognitive impair-ment. The Lancet, 2006; 367: 1262-270.4. FOLSTEIN M.F., FOLSTEIN S.E., MC HUGH P. R.: Mini-mental state. Apractical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J.Psychiatric Res., 1975; 12: 189-198.
5. KATZ S., FORD A.B., MOSKOWITZ R.W., et al.: Studies of illness in theaged. The index of ADL: a standardized measure of biological and psychologi-cal function. JAMA 1963; 185: 914-919.6. LAWTON M.P., BRODY F.M.: Assesment of old people: self-maintainingand instrumental activities of daily living. Gerontologist, 1969; 9: 179-186.7. NAGAI M., HOSHIDE S., KARIO K., Hypertension and Dementia.American Journal of Hypertension, 2010; 23: 116-124.8. The Honolulu Asia Aging Study. JAMA, 1995; 274: 1846-1851.
BIBLIOGRAFIA
174 Geriatria 2013 Vol. XXV n. 4 Luglio/Agosto

INTRODUZIONEL’iperuricemia cronica torna a riproporsi all’at-
tenzione dei medici a causa di un progressivo econtinuo aumento, soprattutto nei paesi sviluppa-ti, dei casi osservati di una malattia che ha colpito
re e illustri personaggi nei secoli scorsi, comeAlessandro Magno e Galileo Galilei: l’iperurice-mia cronica con deposito di urato (gotta).Considerando i dati di un recentissimo studio sta-tunitense, la malattia occuperebbe, infatti, ilsecondo posto dopo l’artrosi fra le malattie reu-matiche più frequenti e la prevalenza nella popo-lazione adulta raggiungerebbe ormai il 3.9% (1).In Italia si stima inoltre che ne siano affette circa 1milione di persone (2). Etichettata come “la malat-tia dei re e dei papi”, si comprende bene l’associa-
Indirizzo per la corrispondenza:Prof. Gianluigi VendemialeDipartimento di Medicina Generale Università di FoggiaVia Luigi Pinto, 1 - 71122 Foggia E-mail: [email protected]
Riassunto: L’iperuricemia cronica con deposito di urato richiama, attualmente, sempre maggiore attenzione inambito medico, innanzitutto per il crescente aumento della popolazione interessata, ma soprattutto per la strettaassociazione con ipertensione arteriosa, sindrome metabolica e altri disturbi cardio-metabolici. Inoltre, da recentistudi l’iperuricemia sembra svolgere un ruolo predittivo di disfunzione renale. L’iperuricemia cronica pertantosecondo un approccio più moderno dovrà essere inquadrata come malattia sistemica e pluriorgano, e considerataquale “fattore di rischio cardiovascolare residuo”. Gran parte degli effetti lesivi dell’acido urico appaiono legatiallo sviluppo di danno vascolare. L’enzima chiave nella produzione dell’acido urico è la xantino ossido-reduttasi(XOR), che in condizioni normali esplica la sua azione come forma ridotta, ma in caso di stress ossidativo (infiam-mazione, ipossia) o fenomeni di ischemia-riperfusione di tessuti, viene convertita in forma ossidata portando allaformazione, oltre che di acido urico, di specie reattive dell’ossigeno. La XOS, modificandosi strutturalmente, pos-siede la capacità di legare i glicosamminoglicani dell’endotelio in particolare a livello delle placche, modificandoil danno mediato dal processo aterosclerotico. L’acido urico è in grado di stimolare la produzione di interleuchina1 beta, interleuchina 6 e TNF alfa da parte di cellule mononucleate umane esplicando inoltre azione pro-infiam-matoria. Una migliore definizione del ruolo dell’iperuricemia cronica come fattore di rischio cardio-metabolico erenale potrebbe quindi avere una serie di potenziali implicazioni favorevoli per una più efficace gestione terapeu-tica, con l’obiettivo non solo di mantenere l’uricemia al di sotto della soglia raccomandata dall’EULAR (≤6mg/dl),ma soprattutto di ottenere considerevoli benefici in termini di miglioramento degli outcome clinici pluriorgano.Controllare efficacemente i livelli di acido urico può, infatti, essere utile per abbattere la quota di “rischio residuo”in ambito cardio-metabolico e renale, ossia quella quota significativa di rischio che permane a carico dei pazientimalgrado il controllo di fattori di rischio “tradizionali”.
Parole chiave: acido urico, rischio cardiovascolare, stress ossidativo, iperuricemia, xantino, ossido-reduttasi.
Chronic hyperuricemia: from gout to residual cardiovascular risk factor
Summary: Chronic hyperuricemia with urate deposition is now becoming an appealing topic for the number of people affec-ted and also for the close association with hypertension, metabolic syndrome and other cardio-metabolic diseases. Moreover,recent studies have suggested that hyperuricemia may play a role in the prediction of renal dysfunction. Chronic hyperurice-mia should be considered a systemic disorder and treated in the field of “residual cardiovascular risk factor”. Most of the dan-gerous effects of uric acid are dependent on its capacity to induce vascular injury. In fact, xantino-oxide reductase (XOR), thekey enzyme in the production of uric acid, in a oxidative milieu (Inflammation and ischemia injury) is converted to its oxidi-zed (XOS) form leading to the formation of reactive oxygen species as intermediates. XOS is able to bind to glycosaminogly-cans of the endothelium, and at atherosclerotic plaque level, releases ROS products and increases atherosclerotic processes.Uric acid also stimulates the production of Interleukin 1 beta, IL-6 and TNF alpha from mononuclear cells that act as pro-inflammatory molecules. A better definition of the role of chronic hyperuricemia as a cardiovascular and renal risk factor couldhave a number of potential therapeutic implications. Accordingly, serum uric acid level should be maintaned below the thre-shold recommended by EULAR (≤ 6 mg/dl) to reduce CV risck.
Keywords: uric acid, cardiovascular risk, oxidative stress, hyperuricemia, xantino, oxide reductase.
IPERURICEMIA CRONICA: DALLA MALATTIA DA DEPOSITO DI URATI A FATTORE DI RISCHIOCARDIOVASCOLARE RESIDUO
Vendemiale G.°, Tusiano M.°°
°Cattedra di Medicina Interna e Geriatria°°Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Foggia
175

zione con un tenore di vita elevato, quindi conabitudini alimentari piuttosto ricche e uno stile divita sedentario, sempre attualmente più diffusonella popolazione occidentale, a cui vannoaggiunti gli effetti indesiderati di alcuni medicina-li sempre più utilizzati, come diuretici e acido ace-tilsalicilico a basso dosaggio, e all’incrementodella longevità (3). Inoltre, la malattia sta assu-mendo caratteristiche nuove rispetto a quelle noteda tempo: coinvolgimento sempre più frequentedel sesso femminile, interessamento di articola-zioni diverse da quella caratteristica (alluce).Ancora, bisogna considerare che gli anziani dientrambi i sessi costituiscono una categoria parti-colarmente a rischio perché l’elevata incidenza diun preesistente danno articolare, dovuto all’artro-si o ad altre condizioni degenerative, rappresentaun substrato per la deposizione di acido uricointra-articolare. La diffusione del sovrappeso, illargo uso di farmaci e la ridotta funzione renalefanno degli anziani la fascia di popolazione più arischio di iperuricemia cronica, soprattutto al disopra dei 75 anni.
Da classico fattore causale della malattia dadeposito di urati, oggigiorno, l’acido urico, staassumendo un ruolo critico nel grande panoramadelle malattie cardiovascolari (4).
Il concetto che l’acido urico potesse esserecoinvolto nel determinismo del rischio cardiova-scolare risale a oltre un secolo fa. Infatti, nel 1879un medico e ricercatore inglese, Akbar Mohamed,notava, in un suo articolo pubblicato su uno deiprimi fascicoli della rivista The Lancet, che moltidei soggetti da lui seguiti in ambulatorio presen-tavano una familiarità positiva per patologia got-tosa ed ipotizzò che l’acido urico potesse svolgereun ruolo integrante nello sviluppo dell’ipertensio-ne arteriosa essenziale, ma per molti anni questaipotesi rimase dimenticata (5).
Dal 1960, numerosi studi epidemiologicihanno confermato l’associazione tra livelli diacido urico sierico, depositi tissutali di urato evarie patologie cardiovascolari quali l’ipertensio-ne arteriosa, l’aterosclerosi, l’ictus cerebrale ditipo ischemico, lo scompenso cardiaco acuto e cro-nico (6). È interessante notare come una correla-zione sia stata osservata già con livelli di uricemiadi 5-5.5 mg/dl (6), inferiori cioè al target di urice-mia ≤ 6 mg/dl raccomandato dall’EuropeanLeague Against Rheumatism (EULAR) neipazienti con iperuricemia cronica con depositi diurato; ciò sembra suggerire un comportamentodei livelli circolanti di acido urico non dissimiledai comuni parametri metabolici associati a unaumentato rischio cardiovascolare (7).
È emersa inoltre, in questi ultimi anni, l’evi-denza che il panorama del rischio cardiovascolaresia molto più ampio di quello prospettato dall’ap-proccio proposto dalla tradizione epidemiologica
basata sullo studio di Framingham, in ragionedell’intervento di una serie di ulteriori determi-nanti del rischio cardiovascolare, spesso ampia-mente modificabili ed in grado di condizionarequello che viene conosciuto come “rischio CVresiduo” e che condiziona un’aumentata probabi-lità di complicanze cardiovascolari anche in pre-senza di un controllo adeguato dei principali fat-tori di rischio (8).
Tutto ciò spinge inevitabilmente alla ricerca dinuovi elementi che concorrono allo sviluppo dellemalattie cardiovascolari in maniera indipendenteo integrata con quelli già ampiamente codificati,con la finalità di avvicinarsi sempre più ad una“prevenzione cardiovascolare efficace”, il cui rag-giungimento ha un significato fondamentale inun’ottica nella quale ogni intervento deve produr-re il massimo di beneficio commisurato all’entitàdelle risorse disponibili (8).
Secondo tali premesse l’iperuricemia cronicaandrebbe pertanto a collocarsi tra quei fattorimodernamente definiti di “rischio cardiovascola-re residuo”.
ACIDO URICO: MEDIATORE DI DANNOVASCOLARE
Gran parte degli effetti lesivi dell’acido uricoappaiono legati allo sviluppo di danno vascolare,come dimostrato da evidenze nell’animale daesperimento e nell’uomo e tale relazione risultaancor più evidente nei soggetti ad elevato rischiocardiovascolare (popolazione diabetica e/o iper-tesa) se comparata alla popolazione generale (9).
La produzione di stress ossidativo, e la conse-guente riduzione della biodisponibilità di ossidonitrico (NO) indotta dall’acido urico, è in grado dideterminare disfunzione endoteliale, riduzionedella distensibilità arteriosa, aumento dello spes-sore medio-intimale carotideo. L’acido urico,secondo tali premesse, pertanto, promuoverebbeil processo aterosclerotico e, in ultima analisi,aumenterebbe l’incidenza di eventi cardiovasco-lari (Fig. 1) (9).
È il caso di rammentare che lo stesso acidourico possiede, in condizioni fisiologiche, attivitàantiossidante. Gli urati plasmatici possono, infat-ti, avere un’azione scavenger sulle specie reattivedell’ossigeno, e sono in grado di chelare metalli ditransizione e prevenire la degradazione dell’enzi-ma superossido-dismutasi (10).
La questione appare di conseguenza focalizza-ta sul reale nesso di causalità esistente fra acidourico e quadri patologici: l’acido urico rappresen-ta un tentativo di risposta in senso protettivo del-l’organismo o un fattore patogenetico nelle malat-tie cardiovascolari? Per cercare di far luce su que-sta rilevante tematica, nel corso dell’ultimo decen-nio grande interesse è stato rivolto all’approfondi-mento dei meccanismi fisiopatologici responsabi-
176 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto

Vendemiale G.,Tusiano M. - Iperuricemia cronica: dalla malattia da deposito di urati... 177
Fig. 1 – Iperuricemia e danno vascolare.
li del danno d’organo vascolare in condizioni diiperuricemia cronica.
Esistono evidenze che l’iperuricemia cronicarappresenti uno stimolo potente in grado diindurre aterosclerosi e arteriolosclerosi, che si rea-lizzano attraverso tipiche alterazioni morfologi-che e funzionali della parete vascolare come: laproliferazione delle cellule muscolari lisce, l’incre-mento delle componenti della matrice extracellu-lare e l’ispessimento intimale. Tali alterazioni rap-presentano la manifestazione finale di numerosecondizioni patologiche e sono indotte e portateaventi mediante varie vie molecolari.
LE BASI MOLECOLARI DI UN DANNOSILENZIOSO
I più potenti meccanismi di danno vascolaresono da ricondursi alla ridotta biodisponibilità diNO e all’attivazione del sistema renina-angioten-sina (9). L’iperuricemia cronica sarebbe pertantoin grado di indurre entrambi questi fenomeni (11).L’acido urico è in grado di penetrare nelle celluledella parete vascolare attraverso il trasportatoredegli anioni organici attivando così la proteinchi-nasi ad attività mitogena (MAPK) (11), stimolan-do la produzione di molecole ad attività infiam-matoria (tra cui la PCR) (12), fattori di crescita,chemochine (tra cui monocytechemoattractantprotein-1) e sistemi enzimatici (tra cui la ciclossi-genasi di tipo2) (13), conducendo all’ipertrofiadelle cellule muscolari lisce e favorendo il proces-so di disfunzione endoteliale.
L’enzima chiave per la formazione di acidourico è la xantina ossido-reduttasi (XOR), codifi-cata da un unico gene, che, a seconda dell’am-biente, può utilizzare 2 substrati diversi.
In condizioni normali la XOR esiste comeforma ridotta, la XDH, e catalizza la conversione
della xantina in acido urico usando NAD+ comesubstrato accettore di elettroni. L’enzima è localiz-zato prevalentemente nella mucosa intestinale enel fegato, organi ad alta attività NAD+. In caso distress ossidativo (infiammazione, ipossia) o feno-meni di ischemia-riperfusione di tessuti, le modi-ficazioni metaboliche risultanti da questi processitrasformano la XDH in XOS (forma ossidata). Lareazione enzimatica catalizzata dall’enzima xanti-na-ossidasi porta alla formazione, oltre che diacido urico, di specie reattive dell’ossigeno (inparticolare superossido e perossido di idrogeno)che sono in grado di reagire con l’NO per forma-re perossinitrito, una specie ossidante di naturanon radicalica (14).
Questa reazione porta ad un duplice effettonegativo: da un lato la degradazione dell’NO siaccompagna a uno sbilanciamento della funzioneendoteliale in senso pro-aterogeno, pro-tromboti-co, vasocostrittore; dall’altra il perossinitrito diper sé è una specie altamente reattiva che amplifi-ca gli effetti dello stress ossidativo (15).
Durante il metabolismo dei radicali liberi e lostress ossidativo, la XOS è la maggior fonte cellu-lare di O2- e il suo ruolo come fattore concausan-te il danno da ischemia-riperfusione è ben docu-mentato (16). Inoltre, la XOS è una fonte di radi-cali liberi dell’ossigeno all’interno dei polimorfo-nucleati, delle cellule endoteliali, epiteliali e con-nettivali (16). La XOS, modificandosi struttural-mente, possiede la capacità di legare i glicosam-minoglicani dell’endotelio in particolare a livellodelle placche.
Un incremento dell’attività dell’enzima xanti-na-ossidasi è stata, infatti, dimostrata in sezioni ditessuto proveniente da placche aterosclerotichema non da tessuto vascolare di soggetti sani (17)(Fig. 2). Pertanto è stato proposto che, a seguito di

178 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto
Fig. 2 – Alterazioni della parete vascolare ad opera della xantino-ossidasi. A) sezione di tessuto proveniente da arteria carotideadi un soggetto sano (400*). B) sezione di tessuto proveniente da una placca ateromatosa carotidea (400*). La freccia indica la pre-senza di xantino-ossida si legata all’endotelio e all’interno nell’intima, mediante tecnica che utilizza anticorpi anti-xantinaossida-si marcati. (da P. Patetsios et al. Am J Cardiol, 88(2001), pp.188-191).
Figg. 3, 4 – Meccanismi patogenetici implicati nella progressione del danno renale mediati da elevati livelli di acido urico.
uno stimolo lesivo, si determini un aumento del-l’attività dell’enzima xantina-ossidasi a livellovascolare, con aumentata produzione di acidourico che, attraverso la generazione di specie reat-tive dell’ossigeno, causa riduzione della biodispo-nibilità di NO (18). Considerando il ruolo svoltodal NO a livello dell’albero circolatorio (controllodel tono della parete vasale, prevenzione dell’ade-sione leucocitaria, inibizione dell’adesione e del-l’aggregazione piastrinica, inibizione della prolife-razione dell’intima) si comprende come i processiche comportano la riduzione della sua biodisponi-bilità causino inevitabilmente una riduzione del-l’omeostasi a livello dell’albero cardiovascolare.
Un altro meccanismo attraverso cui l’acidourico può influenzare la funzione vascolare è
attraverso la sua azione pro-infiammatoria. Gliurati sono, infatti, in grado di stimolare la produ-zione di interleuchina 1 beta, interleuchina 6 eTNF alfa da parte di cellule mononucleate umanee la loro infusione in ratti causa l’incremento deivalori di TNF alfa circolanti (19). Studi epidemio-logici condotti in soggetti anziani hanno ancheevidenziato una correlazione tra i livelli plasmati-ci di uricemia e i marcatori di infiammazionesistemica (globuli bianchi, PCR, citochine, TNF)suggerendo che l’iperuricemia possa contribuireallo stato infiammatorio che si riscontra nei qua-dri di patologia cronica con diretta ripercussionesulla funzione endoteliale (20). Da ultimo è possi-bile che una condizione di flogosi cronica dovutaall’iperuricemia possa contribuire al manifestarsi

Vendemiale G.,Tusiano M. - Iperuricemia cronica: dalla malattia da deposito di urati... 179
degli eventi cardiovascolari (21), come già eviden-ziato in corso di artrite reumatoide e di lupus eri-tematoso sistemico (22). In linea con questa ipote-si è l’evidenza derivante dall’analisi dei dati delTawanese National Death Registri che dimostracome la presenza dei depositi di urato incrementiulteriormente il rischio cardiovascolare neipazienti con iperuricemia cronica (23).
Recentemente è stata messa in evidenza l’asso-ciazione di elevati livelli di acido urico con il peg-gioramento della funzionalità renale, quale fatto-re di rischio indipendente nello sviluppo di insuf-ficienza renale cronica, non correlato alla deposi-zione intra-renale di cristalli di urato all’ostruzio-ne dei tubuli renali (24). La progressione deldanno renale sembra essere mediata dall’attiva-zione del RAS, non solo attraverso effetti emodi-namici (aumento della pressione sistemica e glo-merulare), ma anche mediante la stimolazionediretta della fibrogenesi nelle cellule renali evascolari (Figg. 3 e 4). Inoltre verrebbe a determi-narsi un danno dei vasi afferenti glomerularimediato dalla stimolazione della COX-2 e conse-guente ateropatia obliterativa (24,25). Apparequindi evidente che nei soggetti con iniziale
danno renale, e quindi elevato rischio di sviluppa-re insufficienza renale cronica, come nei soggettiaffetti da diabete mellito, ipertensione arteriosa odi età avanzata, bisogna porre attenzione ai livel-li di acido urico.
CONCLUSIONIIn conclusione è possibile attualmente inqua-
drare l’iperuricemia cronica come malattia siste-mica e pluriorgano. La stessa rappresenterebbe,tra l’altro, un predittore di sviluppo di disfunzio-ne renale. Pertanto si rende necessario un migliorinquadramento diagnostico dell’iperuricemia cro-nica e una più efficace gestione terapeutica, conl’obiettivo non solo di mantenere l’uricemia al disotto della soglia raccomandata dall’EULAR (≤ 6mg/dl), ma soprattutto di ottenere considerevolibenefici in termini di miglioramento degli outco-me clinici pluriorgano.
Controllare efficacemente i livelli di acidourico può, infatti, essere utile per abbattere laquota di “rischio residuo” in ambito cardio-meta-bolico e renale, ossia quella quota significativa dirischio che permane a carico dei pazienti malgra-do il controllo di fattori di rischio “tradizionali”.

1. ZHU Y., PANDYA B.J., CHOI H.K.: Prevalence of gout and hyperuricemiain the US general population: the National Health and Nutrition ExaminationSurvey 2007-2008. ArthritisRheum. 2011; 63 (10): 3136-3141.2. PREVETE I., IULIANO A., SEBASTIANI G.D., et al.: Crhonichyperur -icemiawithuric acid crystals: needing of menagementcommunityhealtheduca-tion. Reumatismo 2013; 65 (S1): 5-11.3. DOHERTY M.: New insightsintoepidemiology of gout. Reumatolo 2009;48: ii2-ii8.4. ZHU Y., PANDYA B.J., CHOI H.K.: Comorbidities of gout and hyperurice-mia in the US general population: NHANES 2007-2008. Am J Med. 2012; 125(7): 679-687.5. MOHAMED F.A.: On chronic Bright’s disease, and its essential symptoms.Lancet 1879; 1: 339-401.6. NISKANEN L.K., LAAKSONEN D.E., NYYSSONEN K., et al.: Uric acidlevel as a risk factor for cardiovascular and all-cause mortality in middle-agemen: a prospective cohort study. Arch Intern Med 2004; 164: 1546-1551.7. ZHANG W., DOHERTY M., BARDIN T., et al.: EULAR StandingCommittee for International Clinical Studies Including Therapeutics. EULARevidence based recommendations for gout. Part II: Managenent. Report of a taskforce of the EULAR Standing Committee for International Clinical StudiesIncluding Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2006; 65: 1312-1324.8. COUTINHO T.A., TURNER S.T., PEYSER P.A., et al.: Association ofserum acid with markers of inflammation, metabolic syndrome, and subclinicalcoronary atherosclerosis. Am J Hypertens. 2007; 20: 83-88.9. KANBAY M., SÀNCHEZ-LOZADA L.G., et al.: Microvascular diseaseand its role in the brain and cardiovascular system: a potential role for uric acidas a cadiorenal toxin. Nephrol Dial Transplant. 2011; 26 (2) : 430-437.10. CORRY D.B., ESLAMI P., YAMAMOTO K., et al.: Uric acid stimulatesvascular smooth muscle cell proliferation and oxidative stress via the vascularrennin-angiotensin system. J Hipertens. 2008; 26 (2): 269-275.11. RAO G.N., CORSON M.A., BERK B.C.: Uric acid stimulates vascularsmooth muscle cell proliferation by increasing platelet derived growth factor A-chain expression. J BiolChem 1991; 266: 8604-8608.12. KANG D.H., PARK S.K., LEE I.K., et al.: Uric acid-induced C-reactiveprotein expression: implication on cell proliferation and nitric oxide productionof human vascular cells. J Am SocNephrol. 2005; 16(12): 3553-3562.13. SÀNCHEZ-LOZADA L.G., NAKAGAWA T., KANG D.H., et al.
Hormonal and cytokine effects of uric acid. CurrOpinNephrolHypertens. 2006;15(1): 30-33.14. PUDDU P., PUDDU G.M., CRAVERO E., et al.: The relationshipsamong hyperuricemia, endothelial dysfunction, and cardiovascular disease:Molecular mechanism and clinical implications. Journal of Cardiologist 2012;59: 235-242.15. MUNZEL T., GORI T., BRUNO R.M.: Is oxidative stress a therapeutictarget in cardiovascular disease? Eur Heart J. 2010; 31 (22): 2741-2748.16. YOUNG CHUNG H.Y., SOOKBAEK B., SONG S.H., et al.: Xanthinedehydrogenase/Xanthine Oxidase and Oxidative Stress - Department ofPharmacy and Department of Molecular Biology, Pusan National University,Gumjung-ku, Pusan, 609-735.17. PATETSIOS P., SONG M., SHUTZE W.P., et al.: Identification of uricacid and xanthine oxidase in atherosclerotic plaque. Am J Cardiol 2001; 88-191.18. NETEA M.G., KULLBERG B.J., BLOK W.L., et al.: The role of hyperuri-cemia in increased cytochine production after lipopolysaccharide challenge inneutropenic mice. Blood. 1997; 15 (2): 577-582.19. FERRUCCI L., CORSI A., LAURETANI F., et al.: The origins of age-rela-ted proinflammatory state. Blood. 2005; 105 (6): 2294-2299.20. DANESH J., WHINCUP P., WALKER M., et al.: Low grade inflammationand coronary heart disease: prospective study and updated meta-analyses. BrMed J 2000; 321: 199-204.21. SNOW M.H., MIKULS T.R.: Rheumatoid arthritis and cardiovasculardisease: the role of systemic inflammation and evolving strategies of preven-tion. CurrOpinRheumatol 2005; 17: 234-241.22. FULL L.E., RUISANCHEZ C., MONACO C.: The inextricable linkbetween atherosclerosis and prototypical inflammatory disease rheumatoidarthritis and systemic lupus erythematosus. Arthritis Res Ther 2009; 11: 217.23. KUO C.F., YU K.H., SEE L.C., et al.: Elevated risk of mortality amonggout patients: a comparison with the national population in Taiwan. Joint BoneSpine. 2011; 78 (6): 577-580.24. KANG D., NAKAGAWA, FENG L., et al.: A rolefor uric acid in the pro-gression of renaldisease. J amsocnephrol 13: 2888-2897, 2002.25. ZOPPINI G., TARGHER G., CHONCHOL M., et al.: SerumUric AcidLevels and IncidentChronicKidneyDisease in PatientsWithType 2 Diabetesand PreservedKidneyFunction.Diabetes Care 2012; 35: 99-104.
BIBLIOGRAFIA
180 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto

INTRODUZIONEIl rischio di malnutrizione e la malnutrizione
stessa nell’anziano sono diventati negli anni itemdi conoscenza comune fondamentali nella praticaquotidiana, nonché dimostrati fattori prognosticidai quali non si può prescindere.
Ne è conseguita, di fatto, una crescente ricercain ambito diagnostico (es. scale di valutazionecome Mini Nutritional Assessment) e preventi-vo/terapeutico, con attualmente disponibili faciliscreening dello stato nutrizionale e moltissimipresidi nutrizionali non solo in ospedale bensì inqualunque setting, domicilio compreso.
Tuttavia accanto ad una esplosione di espe-rienze in ambito soprattutto della nutrizione arti-ficiale, sono aumentati contestualmente gli eventiavversi da mal practice, anche fatali, che impon-gono alcuni spunti di riflessione su quale sia lostato dell’arte del livello di competenze degli ope-ratori sanitari.
Ad esempio (1) si è riscontrato che accanto aduna maggior facilità “prescrittiva”, l’osservanzadelle linee guida esistenti o la consulenza di spe-cialisti nutrizionali sono spesso disattese in molterealtà, preferendo un comportamento “più auto-nomo” nonostante l’importanza di un team nutri-zionale sia stata ampiamente ed esaustivamente
dimostrata. Anche i criteri utilizzati di identifica-zione del soggetto malnutrito non sono omoge-nei, e spesso il ”need to feed” conduce ad un ove-ruse di presidi nutrizionali esponendo i soggettiad una maggior probabilità di complicanze nonnecessarie.
È superfluo sottolineare che non tutti i pazien-ti ospedalizzati malnutriti sono “clinicamente”uguali, in parte per la patologia/e di base nonchél’ambito di ricovero (terapie intensive, chirurgiadi emergenza vs. reparti medici).
Indicriminatamente, si assiste all’uso di paren-terale o di nutrizione enterale (vedi LLGG ESPEN2006 e 2009 sulle indicazioni della nutrizione artifi-ciale nell’anziano) (2,3), come anche al considerareprioritariamente il fabbisogno energetico anziché ilfabbisogno di componenti nutrizionali, particolar-mente nelle fasi acute di malattia. Non potendo ilpresente lavoro affrontare tutte le tematiche perti-nenti la nutrizione artificiale, sarà proposto un sin-tetico risalto alle più recenti acquisizioni.
CENNI AL RUOLO DEL MICROBIOTAINTESTINALE
Ancora oggi, non è debitamente considerato ilruolo e livello immunitario (innato e acquisito)dell’ospite e quanto la composizione e funziona-lità del microbiota (e virobiota) (4) intestinale(modulabili dalla qualità e quantità dei nutrienti)influenzi un corretto stato di salute, sia locale chesistemico. In proposito, si è riscontrato come lanutrizione parenterale possa condurre in pochigiorni – se non accompagnata da un supporto peros – ad ipofunzione/atrofia nell’intestino tenuedelle cellule del Paneth, (5) deputate a secerneremolecole antimicrobiche (es. defensine, lisozima,
Indirizzo per la corrispondenza:Dott. Fabrizio Franchi Dipartimento di non autosufficienza e riabilitazioneUnità Operativa Complessa di GeriatriaOspedale Guglielmo da SalicetoVia Taverna 49 – 29100 PiacenzaAzienda Sanitaria Locale di PiacenzaTel: +39 0523 302705E.mail: [email protected]
Riassunto: Recenti acquisizioni, unitamente al ruolo del microbiota intestinale, evidenziano nuovi fattori causalinell’insorgenza di diverse complicanze legate all’impiego della nutrizione artificiale, che potrebbero pertanto esse-re efficacemente combattute. Dall’analisi della letteratura più accreditata, un sintetico tratteggio degli aspetti dimaggior rilievo e importanza clinica.
Parole chiave: malnutrizione, microbiota, disbiosi, sepsi, nutrizione artificiale, formulazioni enterali standard, Ph,osmolarità, timing.
Enteral or parenteral nutrition: criteria and limits according to recent evidence
Summary: In last years new ethiopathogenetic factors (gut microbiota included) involved in the incidence of some compli-cances/adverse effects of artificial nutrition were discovered. In this review the Author highlights some important evidences
Keywords:malnutrition, microbiota, dysbiosis, sepsis, artificial nutrition, standard solutions enteral, Ph, osmolarity, timing.
NUTRIZIONE PARENTERALE O ENTERALE:CRITERI E LIMITI ALLA LUCE DI RECENTI ACQUISIZIONI
Franchi F.
UOC Geriatria, Ospedale Guglielmo da Saliceto, AUSL Piacenza
181

REGIII-α) e proteggere l’organismo da traslocazio-ni batteriche. Inoltre, l’importanza fisica ma anchefunzionale della salute epiteliale dell’intestino intoto – più in generale comprese le tigh-junctions –rende l’organismo meno vulnerabile al passaggiodi lipopolisaccaride (che determina uno statoinfiammatorio via Toll like receptors, TLRs, inparticolare il 4), di altre sostanze tossiche batteri-che e di germi intestinali, con conseguenti SIRS,sepsi e infezioni polmonari. L’intestino crasso è lasede del nostro organismo maggiormente popola-ta di microrganismi.
La stessa disbiosi (modificazione del microbio-ta, con diminuzione ad esempio dei Bifidobacterissp o delle varietà di specie microbiche, più ingenerale) determinata dall’uso di antibiotici, daun cattivo stato di salute dell’intestino (es. ische-mia intestinale), dall’impiego di alcuni farmaci(vasopressori, PPI, opioidi) (6), da condizioni cri-tiche o da malnutrizione può aumentare la per-meabilità intestinale, predisporre ad uno statoinfiammatorio locale e sistemico, con relative con-seguenze (7): di fatto organismo e microbiota agi-scono in simbiosi nel promuovere e migliorare ledifese immunitarie (8).
Inoltre la stessa diminuzione del microbiota (innumero e diversità di specie) predispone alla cre-scita di germi patogeni (esempio Cl. difficile).Modificazioni del microbiota intestinale nei sog-getti critici con SIRS sono state correlate a morbi-lità e mortalità (7). Le interrelazioni ospite-micro-biota-sistema immunitario sono molteplici e com-plesse. Per brevità, saranno descritti alcuni aspetti.
Ad esempio la specie commensale umanaBacteroides fragilis produce il polisaccaride A(PSA) che governa la maturazione del sistemaimmune dei mammiferi, in particolare promuoven-do lo sviluppo e la funzione delle cellule CD4+T.PSA da B. fragilis aumenta la funzione antiinfiam-matoria delle cellule Treg direttamente via TLR2sulle cellule CD4+T. Treg costituiscono una popola-zione di T linfociti con potente azione immunosop-pressiva e antiinfiammatoria. Il microbiota intesti-nale svolge quindi un ruolo protettivo sistemico,anche verso manifestazioni allergiche (8-12).
Interventi volti a modulare la composizionedel microbiota (probiotici, prebiotici, simbiotici)sembrano promettenti nei pazienti critici (13-15).
La somministrazione di probiotici qualiLactobacillus GG, Bifidobacterium lactis Bb-12 eSaccharomyces boulardii ha dimostrato unaaumentata produzione e secrezione di IgA trami-te la modificazione del milieu citochinico dellamucosa intestinale. È stato anche dimostrato cheprobiotici inducono l’espressione cellulare diTGFβ e IL-10 come anche IL-6 che potenzia la pro-duzione di IgA attraverso la maturazione B cellu-lare e una class-switching in favore di IgA.
Le batteriocine invece sono peptidi microbici
che contribuiscono alla diretta eliminazione dibatteri patogeni e agiscono come segnali per ilsistema immunitario dell’ospite. Tuttavia nelDutch Acute Pancreatitis Study Group, si è osser-vata un’aumentata mortalità nei soggetti con pan-creatite acuta severa che ricevevano profilassi conprobiotici. Minori rischi nel modulare il microbio-ta possono essere ottenuti con prebiotici (prodottialimentari non digeribili che aumentano la cresci-ta di germi intestinali “benefici”), anche se sononecessari ulteriori studi per garantirne la sicurez-za nei soggetti trattati in terapia intensiva (15,16).
I cosiddetti metaboliti microbici dieta-dipen-denti includono tra gli altri gli acidi biliari, gliacidi grassi a catena corta (SCFA), vitamine, ami-noacidi e acidi grassi (17-19). Prodotti microbicinon direttamente legati alla dieta sono invece illipopolisaccaride (LPS) e peptidoglicani.
I SCFA, alla cui sintesi è essenziale il microbio-ta intestinale, esercitano anche una azione antiin-fiammatoria in molte cellule del sistema immunee quindi una disbiosi potrebbe essere nocivaall’organismo. L’acido butirrico ad esempio, nutrei colonociti, esplica azione saziante, antiinfiam-matoria, anticarcinogenetica, mitigante lo stressossidativo e promuovente la funzione intestinaledi barriera (8).
Alcune specie di batteri commensali sintetizza-no vitamine essenziali come quelle del gruppo B eK. In particolare i metaboliti intermedi di sintesivitaminica del microbiota intestinale (es. riboflavi-na e invariant T cellule che producono IL-17 andIFN-γ) esercitano azione modulante sul sistemaimmunitario. Il microbiota intestinale è ancheimportante nell’estrazione, sintesi o assorbimentodi alcuni aminoacidi, quali alanina, aspartato, glu-tammina (ciclo dell’acido citrico), glicina (neurotra-smettitore) e triptofano. Ancora, arginina, leucina,glutammina, triptofano regolano il sistema immu-nitario. Il triptofano influenza la proliferazionedelle cellule T e regola la risposta immune in alcu-ni quadri patologici (8). La disbiosi sembrerebbegiocare un ruolo anche nella malnutrizione calori-co proteica (PEM), forse per il ruolo del microbiotanel sintetizzare, estrarre e assorbire aminoacidicome anche quello di produrre acidi grassi (20).
MISCELE ENTERALI E SEPSIÈ indubbio che le tecnologie (high tech) abbia-
no migliorato la prognosi di molte malattie, ma èaltresì vero che quelle di tipo invasivo hannoaumentato effetti indesiderati “pericolosi” comeinfezioni-sepsi, associate alle cure (21).
In tal senso anche la nutrizione artificiale nonsi sottrae a questo rischio, ma se è ben conosciutoper quella parenterale meno noto è che anche laenterale non è esente da complicanze infettivo set-tiche. Verrebbe subito da pensare alle conseguen-ze delle polmoniti ab ingestis (o meglio da aspira-
182 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto

zione) oppure alle infezioni della stomia nellaPEG, ma in questo caso si intendono infezioni apartenza intestinale. Le possibili spiegazioni deri-vano dal riscontro, dapprima in studi animali e inseguito nell’uomo, che alcune formulazioni stan-dard enterali, povere di omega-3 e fibre (es. oligo-fruttosaccaridi o FOS, inulina) si correlavano astati infiammatori e ad aumentata traslocazionebatterica dall’intestino, fin dalle fasi iniziali disomministrazione, soprattutto in individui clini-camente compromessi. Si è visto recentementeche una frazione della membrana cellulare deibatteri Gram negativi intestinali, il lipopolisacca-ride (LPS), aumentava transitoriamente in circolocon cibi particolarmente ipercalorici e ricchi digrassi saturi a lunga catena (sistema linfatico viachilomicroni) ma anche per altri componenti pre-senti o assenti nel pasto oppure conseguentemen-te a disbiosi, che aumenta la permeabilità intesti-nale (22,23). Nutrienti come olio di oliva, omega-3, latte e derivati, noci, frutta (fragole) sembrereb-bero invece contrastare il passaggio di LPS, anchea parità di introito calorico.
Di fatto andrebbe sconsigliato un apporto ipercalorico enterale nella 1-2a settimana di iniziodella nutrizione artificiale. Il LPS determina nel-l’uomo una aumentata produzione di fattori pro-infiammatori con diminuzione delle difese immu-nitarie e insulino resistenza (endotossiemia meta-bolica, comunque 10-50 volte inferiore alla sepsi).LPS che entra in circolo si lega alla LPS bindingprotein (LBP), con successive attivazione di CD14e TLR4 e produzione di citochine pro-infiammato-rie (TNF, IL1 and IL6). Queste, tramite la fosforila-zione della serina del recettore substrato 1 insuli-nico (IRS1) nel muscolo e tessuto adiposo, deter-minano insulino-resistenza periferica(24).
Nei soggetti obesi si riscontra una maggiorconcentrazione di LPS, che per molti autori sareb-be all’origine della sindrome metabolica (25).Infine, attenzione all’impiego di vasopressoridurante l’infusione di nutrizione enterale (6).
È interessante sottolineare che tra i fattori etio-logici dell’obesità il microbiota potrebbe svolgereun ruolo di rilievo, prevalentemente via LPS edun’alterata omeostasi lipidica con blocco di atti-vità del FIAF (fasting-induced adipose factor).FIAF blocca la lipoproteinlipasi del tessuto adipo-so e promuove l’ossidazione dei grassi (26,27).Negli animali obesi si registra inoltre un incre-mento plasmatico e nel tessuto adiposo di attivitàdel sistema endocannabinoide (eCB) (aumentodel tono eCB), che è determinato dal microbiotaintestinale. Il tono del sistema eCB intestinale puòregolare la permeabilità intestinale e i livelli pla-smatici di LPS, in modo che LPS potrebbe control-lare il metabolismo adiposo bloccando la cannabi-noid-driven adipogenesi (azione pleiotropica diLPS) (28). Per quanto riguarda il ruolo delle spe-
cie microbiche intestinali nella genesi dell’obesitàsono stati chiamati in causa il rapportoFirmicutes/Bacteroidetes, alcune specie dellefamiglie Enterobacteriaceae e Desulfovibriona-ceae (phylum Proteobacteria), Mollicutes, Entero-bacter cloacae str. B29, e Akkermansia muciniphi-la, quest’ultima per l’azione anti obesogena(24,29,30).
Alla luce di queste considerazioni, soggettiparticolarmente critici potrebbero essere predi-sposti a sepsi con soluzioni enterali standard ren-dendo necessario invece un approccio con altreformulazioni, più “specialistiche”, o condotto damani esperte. Anche la rialimentazione in chi èstato a digiuno per lungo tempo necessita dimolte attenzioni, considerata l’elevata mortalitàin anziani per sindrome da refeeding (31).
CORRETTA DIAGNOSI DI MALNUTRIZIONECome premesso, esistono numerosi strumenti
di facile impiego come le scale di valutazione.Purtuttavia non esiste un gold standard ricono-sciuto, anche se in ambito geriatrico lo strumentomaggiormente usato è il mini nutritional asses-sment (MNA). Andrebbe preferito in setting piùriabilitativi anziché ospedalieri. Tra i limiti deivari strumenti vi sono quelli di non identificarecon precisione condizioni borderline o lievi dimalnutrizione, di discernere tra malnutrizioneprimitiva o secondaria a malattia, e di non essereaffidabili nel saper predire gli outcome di inter-venti nutrizionali (32), e non ultimo di essere poco“sensibile” alle modificazioni lievi-moderatedello stato nutrizionale dopo terapia.
FABBISOGNO PROTEICO NEL PAZIENTEACUTO
Generalmente i clinici non esperti privilegianoil calcolo del fabbisogno energetico, “dimentican-dosi” ad esempio di un adeguato calcolo dell’ap-porto proteico in quelle condizioni ipercataboli-che (senza citare la necessità di tanti altri micronu-trienti), variabile da 1.3-1.5 a 2 gr/kg e più. Lemiscele di nutrizione enterale generalmente nonforniscono in questi soggetti più del 50% del fab-bisogno proteico, se non aumentando “senzanecessità” la quantità di miscela da somministra-re e determinando un overfeeding calorico, con lerelative nocive ripercussioni sullo stato di salute.In queste condizioni un approccio complementa-re e sinergico con aminoacidi via parenterale evi-terebbe al soggetto di essere “povero” di proteinee quindi più cagionevole. È importante ricordareche la carenza nutrizionale di alcuni micronu-trienti ostacola l’anabolismo proteico (33,34).
Infine, nel soggetto acuto la glicemia andrebbecontenuta al di sotto dei 200 mg/dl, senza peraltrocercare di raggiungere forzatamente valori “eugli-cemici” (35).
Franchi F. - Alimentazione parenterale o enterale: criteri e limiti... 183

SOMMINISTRAZIONE MEDICAMENTI VIASNG/PEG
Un altro capitolo riguarda l’utilizzo del sondi-no naso-gastrico/PEG come via di somministra-zione di medicamenti in formulazione liquida. Imedicamenti liquidi somministrati per sondinoenterale possono presentare elementi di intolle-ranza (osmolarità) e di incompatibilità (pH).
In relazione alla quantità di medicamentosomministrata, il carico osmotico può determina-re dolori crampiformi e diarrea. Il pH (acido/aci-dico) predice potenziali interazioni di incompati-bilità con soluzioni enterali, in particolare con leproteine “intatte”. In questo caso, può verificarsiocclusione del sondino: le proteine a contatto conalcuni medicamenti a basso pH formano unaostruzione simil gel; altri farmaci formano unamassa più solida; altri invece granulosità che puòcontribuire all’ostruzione del sondino. Necessariosempre un adeguato risciacquo del sondino perminimizzare il contatto con la miscela enterale!
Alcuni prodotti in formulazione liquida (desa-metasone, ergocalciferolo, furosemide, gabapentin,isoniazide, and ioduro di K) presentano una osmo-larità fino a 25-50 volte superiore al range gastroin-testinale (127–357 mOsm/kg). L’intestino tenue èestremamente sensibile a carichi osmotici; unasomministrazione “diretta” in duodeno e digiunodetermina significativa intolleranza (diarrea osmo-tica) che viene spesso attribuita alla miscela entera-le stessa. La osmolarità ottimale nello stomaco è >700 mOsm, in parte tamponata dal volume resi-duo. La osmolarità ottimale nel digiuno è < 300mOsm, in quanto presenza di minor volume resi-duo per tamponare il carico osmotico. Per ovviareagli inconvenienti del carico osmotico è stata pro-posta una formula di diluizione del medicamento(mOsm medicamento/mOsm desiderato x volumedose = volume finale diluito) (36).
NUTRIZIONE ENTERALE: PEG O SNG?Recentemente sono stati pubblicati i risultati di
posizionamento (in blind) postpilorica di sondinonaso-gastrico da dietiste esperte, dimostrandosiuna metodica sicura, cost-effective in soggettiospedalizzati (37,38). La metodica della PEG,tanto propagandata in anni recenti, sarebbe con-troindicata negli oldest old, nei soggetti anzianicon severo stato infiammatorio (PCR > 10 mg/l),in coloro con basso BMI o con diabete per il rischiodi aumentata mortalità (39). Spesso impiegata insoggetti con demenza avanzata, più per richiestedei caregivers o per “gestione facilitata”, non hadeterminato benefici in termine di sopravvivenzae qualità di vita. Il tutto non preclude una nutri-zione artificiale di lunga durata in determinatipazienti (40,41). Una recente metanalisi a tale pro-posito, ha validato il ruolo gestionale della équipemultidisciplinare (comprendente anche caregiver
e paziente) con audit programmati, senza tuttaviaidentificare una correlazione tra risultati e tipolo-gia dell’équipe e/o di interventi. Quantunque siapercepibile un miglioramento del soggetto nutritoartificialmente, le evidenze non dimostrano diffe-renze statistiche in termini di complicanze, infe-zioni e rericoveri ospedalieri rispetto a un metododi gestione più tradizionale. Un modesto beneficiostatisticamente significativo riguarda solo la ridu-zione del costo medio, di circa 620 dollari (42).
TIMING DI INIZIO DELLA NUTRIZIONEARTIFICIALE (NE E NP)
Una precoce nutrizione (orale o SNG/PEG) inambito chirurgico si associa significativamente aridotte complicanze complessive (rispetto al tra-dizionale approccio nutrizionale) e non influenzanegativamente gli outcomes tipo mortalità, dei-scenze anastomotiche, ripresa della funzione inte-stinale, o durata della degenza. Anche dopo ana-stomosi gastrointestinale, la nutrizione orale pre-coce (o enterale artificiale) è non solo sicura macontribuisce anche a migliore recupero e minoricomplicanze. Iniziata entro 24 h dall’ingresso inospedale è ben tollerata da pazienti con lieve-moderata pancreatite acuta.
Inoltre, quando confrontata con NPO (nil-by-mouth), riduce significativamente intensità edurata del dolore addominale, necessità di oppia-cei, e rischio di intolleranza alimentare, ma non ladurata di degenza complessiva (43,44). La preco-ce somministrazione di nutrienti (come compo-nente della terapia per pazienti critici in AreaCritica, Unità intensive e chirurgie) è quindi rac-comandata da numerose LLGG internazionali(nutrizione enterale rappresenta la prima opzionee andrebbe iniziata entro 24-48 h dopo ammissio-ne a una ICU).
Studi recenti hanno dimostrato che sia la NEche la NP arricchite di immunonutrienti migliori-no il recupero e riducano le complicanze dipazienti critici, senza modificare significativa-mente la mortalità (45,46). Sebbene il target calori-co iniziale “preciso” sia ancora dibattuto, il con-sensus “generale” sconsiglia protratti regimi siaipocalorici che ipercalorici. È ancora incerto iltiming “ottimale” di inizio della NP (quando NEnon praticabile o non sufficiente) specialmente inpazienti chirurgici “di elezione”, che non sonomalnutriti. Due studi recenti di fatto hanno dimo-strato che quando NE non è praticabile, una NPprecoce non si associa a “palpabili” benefici.Quali consigli si possono suggerire, almeno inambito chirurgico?A- In un paziente chirurgico diagnosticato “mal-
nutrito”, il supporto nutrizionale dovrebbe ini-ziare almeno 7–10 gg antecedenti l’intervento.
B- I soggetti la cui alimentazione non riprende inquinta giornata dopo l’intervento chirurgico
184 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto

Franchi F. - Alimentazione parenterale o enterale: criteri e limiti... 185
dovrebbero beneficiare di una NE, o NP se nonpossibile la NE.
C- Rispetto alla NP, la NE si associa a minori com-plicanze, a diminuita durata degenza, e a uncosto minore complessivo. Tuttavia quantunque la NE si dimostri supe-
riore alla NP per le ragioni in gran parte riportate,dobbiamo considerare il dibattito ancora apertosoprattutto in quei pazienti critici che ricevendo“solo” NE sono da considerarsi “proteino privi”,almeno nelle prime 2 settimane (34,47).

186 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto
1. BAKER S., THOMPSON C.: Initiating artificial nutrition support: a clini-cal judgement analysis. J Hum Nutr Diet 2012. doi: 10.1111/j.1365-277X.2012.01260.x.2. VOLKERT D., et al.:ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics.Clin Nutr 2006; 25: 330-360.3. SOBOTKA L., et. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Geriatrics.Clin Nutr 2009; 28: 461-466.4. Human Microbiome Project Consortium. Structure, function and diversityof the healthy human microbiome. Nature 2012; 486, 207-214.5. HENEGHAN A.F., et al.: Parenteral Nutrition Decreases Paneth CellFunction and Intestinal Bactericidal Activity While Increasing Susceptibilityto Bacterial Enteroinvasion. published online 26 July 2013 J Parenter EnteralNutr; DOI:10.1177/0148607113497514.6. WELLS D.L.: Provision of Enteral Nutrition During Vasopressor Therapyfor Hemodynamic Instability: An Evidence-Based Review. Nutr Clin Practpublished online 11 June 2012; DOI: 10.1177/0884533612448480.7. SCHUIJT T.J., et al.: The intestinal microbiota and host immune interac-tions in the critically ill. Trends in Microbiology 2013; dx.doi.org/10.1016/j.tim.2013.02.001.8. BRESTOFF R.J., ARTIS D.: Commensal bacteria at the interface of hostmetabolism and the immune system. Nature Immunology JULY 2013;doi:10.1038/ni.2640.9. CHINEN T., RUDENSKY A.Y.: The effects of commensal microbiota on immu-ne cell subsets and inflammatory responses. Immunol. Rev. 2012; 245: 45-55.10. ABT M.C., ARTIS D.: The dynamic influence of commensal bacteria on theimmune response to pathogens. Curr. Opin. Microbiol. 2013; 16: 4-9.11. KAMADA N., et al. Role of gut microbiota in immunity and inflammatorydisease. Nat. Rev. Immunol. 2013; 13: 321-335.12. PEARCE E.L ., PEARCE E.J.: Metabolic pathways in immune cell activa-tion and quiescence. Immunity 2013; 38: 633-643.13. WINTER S.E., et al. Host-derived nitrate boosts growth of E. coli in theinflamed gut. Science 2013; 339: 708-711. 14. TREHAN I. et al.: Antibiotics as part of the management of severe acutemalnutrition. N. Engl. J. Med. 2013; 368: 425-435.15. QUIGLEY E.M.: Prebiotics and probiotics: their role in the management ofgastrointestinal disorders in adults. Nutr. Clin. Pract. 2012; 27: 195-200.16. CROOKS N.H., et al.: Clinical review: probiotics in critical care. Crit. Care2012; 16: 237.17. MCGAHAT.L., et al.: Amino acid catabolism: a pivotal regulator of innateand adaptive immunity. Immunol. Rev. 2012; 249: 135-157.18. SAYIN S.I., et al.: Gut microbiota regulates bile acid metabolism by redu-cing the levels of tauro-beta-muricholic acid, a naturally occurring FXR anta-gonist. Cell Metab. 2013; 17: 225-235.19. NICHOLSON J.K., et al.: Host-gut microbiota metabolic interactions.Science 2012; 336: 1262-1267.20. SMITH M.I., et al. Gut microbiomes of Malawian twin pairs discordant forkwashiorkor. Science 2013; 339: 548-554. 21. BENGMARK S.: Nutrition of the Critically Ill-A 21st-CenturyPerspective. Nutrients 2013; 5: 162-207.22. DE LA SERRE C.B., et al.: Propensity to high-fat diet-induced obesity inrats is associated with changes in the gut microbiota and gut inflammation.Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 2010; 299: G440-G448.23. GHOSHAL S., et al. Chylomicrons promote intestinal absorption of lipo-polysaccharides. J. Lipid Res. 2009; 50: 90-97.24. ZHAO L.: The gut microbiota and obesity: from correlation to causality.Nature Reviews Microbiology/AOP, published online 5 August 2013;doi:10.1038/nrmicro3089.25. SUN L., et al.: A marker of endotoxemia is associated with obesity and related meta-bolic disorders in apparently healthy Chinese. Diabetes Care 2010; 33: 1925-1932.26. TCHERNOF A., DESPRES J.P.: Pathophysiology of human visceral obe-
sity: an update. Physiol. Rev. 2013; 93: 359-404.27. VRIEZE A., et al.: Transfer of intestinal microbiota from lean donors increa-ses insulin sensitivity in individuals with metabolic syndrome. Gastroenterology2012; 143: 913-916.28. MUCCIOLI G.G., et al. The endocannabinoid system links gut microbiotato adipogenesis. Mol. Syst. Biol. 2010; 6: 392.29. XIA Q. , GRANT S.F.: The genetics of human obesity. Ann. NY Acad. Sci.2013; 1281: 178-190.30. EVERARD, A. et al.: Cross-talk between Akkermansia muciniphila and inte-stinal epithelium controls diet-induced obesity. Proc. Natl Acad. Sci. USA 2013.31. DROR Y., et al.: The Impact of Refeeding on Blood Fatty Acids and AminoAcid Profiles in Elderly Patients : A Metabolomic Analysis. J Parenter EnteralNutr 2013; 37: 109.32. VAN BOKHORST-DE VAN DER SCHUEREN MAE, et al.: Nutritionscreening tools: Does one size fit all? A systematic review of screening tools forthe hospital setting, Clin Nutr 2013; dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2013.04.00833. SINGER P., COHEN J.D.: To Implement Guidelines: The (Bad) Exampleof Protein Administration in the ICU. published online 11 March 2013 JParenter Enteral Nutr; DOI: 10.1177/0148607113481063.34. HOFFER L.J., BISTRIAN B.R.: Why Critically Ill Patients Are ProteinDeprived. published online 4 March 2013 J Parenter Enteral Nutr; DOI:10.1177/0148607113478192.35. KUPPINGER D., et al.: In search of the perfect glucose concentration forhospitalized patients: A brief review of the meta-analyses. Nutrition 2013;dx.doi.org/10.1016/j.nut.2012.11.019.36. KLANG M., et al.: Osmolality, pH, and Compatibility of Selected OralLiquid Medications With an Enteral Nutrition Product. published online 17January 2013 J Parenter Enteral Nutr; DOI: 10.1177/0148607112471560.37. ROLLINS C.M., et al.: Blind Bedside Placement of Postpyloric FeedingTubes by Registered Dietitians: Success Rates, Outcomes, and Cost-Effectiveness. published online 7 June 2013 Nutr Clin Pract; DOI:10.1177/0884533613486932.38. STAYNER J.L., et al.: Feeding Tube Placement : Errors and Complications NutrClin Pract published online 12 October 2012; DOI: 10.1177/0884533612462239.39. ZOPF Y., et al: Predictive Factors of Mortality After PEG Insertion :Guidance for Clinical Practice J Parenter Enteral Nutr 2011; 35: 50.40. SAMPSON E.L., et al. Enteral tube feeding for older people with advanceddementia. Cochrane Database of Systematic Review 2009; issue 2: DO 10-1002/1465 1858.41. MONOD S., et al.: Ethical Issues in Nutrition Support of SeverelyDisabled Elderly Persons : A Guide for Health Professionals. J Parenter EnteralNutr 2011; 35: 295.42. MAJKA A.J., et al.: Care Coordination to Enhance Management of Long-TermEnteral Tube Feeding : A Systematic Review and Meta-Analysis. published online25 March 2013 J Parenter Enteral Nutr; DOI: 10.1177/0148607113482000.43. PETROV M.S., et al.: Early nasogastric tube feeding versus nil-by-mouthin mild to moderate acute pancreatitis: A randomized controlled trial. ClinNutr 2013 ; dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2012.12.01144. DE AGUILAR-NASCIMENTO J.O., et al.: Optimal timing for the initia-tion of enteral and parenteral nutrition in critical medical and surgical condi-tions. Nutrition 2012; 28: 840-843.45. DA SILVEIRA G.R.M., et al.: Effectiveness of immunonutrient-enricheddiets in the decrease of infections and mortality in the critically ill. Nutrition2013; 29: 485-490.46. GIGER-PABST U., et al.: Short-term preoperative supplementation of animmunoenriched diet does not improve clinical outcome in well-nourishedpatients undergoing abdominal cancer surgery. Nutrition 2013;dx.doi.org/10.1016/j.nut.2012.10.007.47. ABUNNAJA S., et al.: Enteral and Parenteral Nutrition in thePerioperative Period: State of the Art. Nutrients 2013; 5: 608-623.
BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONELo scompenso cardiaco o insufficienza cardia-
ca (IC) è una sindrome complessa causata da unaserie di alterazioni strutturali e funzionali ingrado di determinare una disfunzione ventricola-re. La causa principale dello scompenso cardiacoè la malattia coronarica seguita da ipertensionearteriosa, patologie valvolari, cardiomiopatie emiocarditi (1,2).
Le stime sulla prevalenza di scompenso car-diaco sintomatico nella popolazione europeavariano in un range compreso tra 0,4% e 2%. LaSocietà Europea di Cardiologia ha calcolato che
nel nostro continente vi siano almeno 10 milionidi individui con scompenso cardiaco (3).
I dati epidemiologici dimostrano chiaramenteche lo scompenso cardiaco costituisce una vera epropria epidemia destinata ad aumentare ulte-riormente se si considerano alcuni aspetti come ilprogressivo invecchiamento della popolazione, lamaggiore sopravvivenza a eventi acuti, la ridu-zione della mortalità per le altre cause cardiova-scolari, la maggiore frequenza della diagnosianche con l’inclusione delle forme non dovute adisfunzione sistolica del ventricolo sinistro (4).
Di qui l’importanza di una corretta gestionedel paziente con scompenso cardiaco per ridurrela mortalità e la morbilità attraverso il migliora-mento della qualità della vita e la diminuzione deltasso di ospedalizzazione.
Sebbene anche le Linee Guida sottolineino
Indirizzo per la corrispondenza:Dott. Ettore SaviniCell.: 335 8187005E-mail: [email protected]
Riassunto: Lo scompenso cardiaco è una sindrome complessa causata da una serie di alterazioni strutturali e fun-zionali in grado di determinare una disfunzione ventricolare.I dati epidemiologici dimostrano che lo scompenso cardiaco, costituisce una vera e propria epidemia in costanteaumento. Di qui scaturisce l’importanza di una corretta gestione del paziente, la terapia farmacologica resta il car-dine del trattamento per ridurre la mortalità e la morbilità, attraverso il miglioramento della qualità della vita e ladiminuzione delle ospedalizzazioni. In questo scritto abbiamo esaminato i capisaldi della terapia farmacologicadello scompenso cardiaco in riferimento alle più recenti Linee Guida Internazionali e applicati nella pratica clini-ca. I vari studi ed i trials hanno confermato la validità dell’associazione terapeutica per la gestione del paziente.ACE-Inibitori (o Antagonisti dei Recettori dell’Angiotensina), Beta Bloccanti e Antagonisti degli Anti-Aldosteronici assumono un ruolo preponderante, in associazione con l’Ivabradina, e andrebbero sempre utilizza-ti nei pazienti con disfunzione sistolica sintomatica.
Parole chiave: scompenso cardiaco, scompenso cardiaco congestizio, terapia farmacologica, insufficienza cardia-ca, trial clinici, cardiopatia ischemica, frequenza cardiaca, enzima di conversione dell’angiotensina.
Up to date on heart failure: the pharmacological therapy of cronic heart failure
Summary: The heart failure is a complex syndrome caused by a series of structural and functional alterations able to deter-mine a ventricular dysfunction. Epidemiological data prove, that heart failure, constitutes a real epidemic in constant increa-se. Hence arises the importance of proper management of the patient, where pharmacological therapy remains the mainstay oftreatment to reduce mortality and morbidity by improving the quality of life and decreased the hospitalizations. In this wri-ting we examined the mainstay of pharmacological therapy of heart failure, traits, especially, from the latest InternationalGuidelines and applied in clinical practice.The various studies and trials have confirmed the validity of the association for the therapeutic management of the patient.ACE Inhibitors (or Angiotensin Receptor Blockers), Beta-Blockers and Aldosterone Receptor Antagonists play a dominantrole, in association with Ivabradine, and should always be used in patients with symptomatic systolic dysfunction.
Keywords: heart failure, congestive heart failure, pharmacological therapy, heart disease, clinical trial, ischemic heart disea-se, heart rate, angiotensin convertin enzyme.
UP TO DATE NELLO SCOMPENSO CARDIACO:LA TERAPIA FARMACOLOGICA DELLO SCOMPENSOCARDIACO CRONICO
Gabrielli D.°, Savini E.°, Benvenuto M.°, Di Gioacchino L.°, Perna G.P.°°°Unità Operativa Complessa di Cardiologia Ospedale “A. Murri” Regione Marche ZT 4, Fermo
°°Unità Operativa Complessa di Cardiologia Ospedaliera, OO RR di Ancona, Dipartimento di Malattie CardiovascolariLancisi Via Tenna Ancona
187

l’importanza di un corretto stile di vita nei pazien-ti scompensati, la terapia farmacologica resta ilcardine nel trattamento del paziente con insuffi-cienza cardiaca e si avvale di una serie di farmacivalidati a livello internazionale e ormai considera-ti imprescindibili (5-6), faremo riferimento in par-ticolare alla terapia farmacologica della disfunzio-ne sistolica ventricolare sinistra.
Obiettivi del trattamento sono migliorare i sin-tomi ed i segni della malattia, prevenire l’ospeda-lizzazione ed aumentare la sopravvivenza (7).
ACE-INIBITORI (ACE-I)In assenza di controindicazioni, l’uso di un
ACE-Inibitore è raccomandato in tutti i pazienticon scompenso cardiaco congestizio sintomaticoed una frazione di eiezione (FE) 40% (Classe diraccomandazione I, livello di evidenza A) (5-6).
È chiaramente dimostrato come il trattamentocon ACE-Inibitore migliora la funzione ventrico-lare sinistra, aumenta la sopravvivenza (riduzio-ne del RR di circa il 20%) e accresce il benesseredel paziente, riducendone l’ospedalizzazione peril peggioramento dello scompenso cardiaco, spe-cie nei pazienti ischemici post-infartuali (studiSAVE, AIRE e TRACE) (8,9).
Gli ACE-Inibitori rappresentano attualmente,insieme con i Beta-Bloccanti, il fondamento dellaterapia dell’insufficienza cardiaca (IC), essendostata dimostrata in maniera concorde in numerositrials farmacologici (CONSENSUS I, SOLVD e VHEFT II etc.) la loro efficacia nel ridurre sia lamortalità che il peggioramento della sindrome daIC. Solo il 10% o meno dei pazienti non tollera gliACE-Inibitori, al di fuori delle fasi di grave insta-bilizzazione/refrattarietà (10).
Gli effetti collaterali degli ACE-Inibitori sonol’edema angioneurotico, l’insufficienza renale(controindicati con eGFR < 30 mL/min), l’iperka-liemia e la tosse (dovuta all’accumulo di bradichi-nine). La titolazione del farmaco nei pazienti conIC avanzata e valori di PA tendenzialmente bassidovrà essere particolarmente attenta. Il monito-raggio della pressione arteriosa e della kaliemia incorso di adeguamento della dose andranno stabi-liti sulla base delle caratteristiche del paziente edella risposta alle dosi iniziali.
Nello studio ATLAS (Assessment of Treatmentwith Lisinopril and Survival) è stato valutato l’im-piego di ACE-inibitori ad alte dosi ed è emersoche nel gruppo di pazienti con scompenso cardia-co trattato con 20 mg/die di Lisinopril si è verifi-cata una riduzione del rischio per l’end-pointcombinato morti-ospedalizzazione, rispetto algruppo di controllo che riceveva un dosaggio di5mg/die, questo fa pensare che convenga tenderealla dose massima prevista o, comunque, alladose massima tollerata, per ottenere il maggiorbeneficio (11,12).
BETA BLOCCANTII Beta Bloccanti (quelli indicati dalle linee
guida dell’AHA sono il Bisoprololo, iI Carvediloloed il Metoprololo) dovrebbero essere usati in tuttii pazienti con scompenso cardiaco sintomatico eFE≤ 40% (Classe di raccomandazione I, livello dievidenza A) (5,6). Migliorano la funzionalità ven-tricolare e il benessere del paziente, riducono l’in-cidenza di ricoveri per il peggioramento delloscompenso e incrementano la sopravvivenza(riduzione del RR di morte > del 20%). Quandopossibile, nei pazienti ospedalizzati, il trattamen-to dovrebbe essere iniziato con cautela primadella dimissione (13,14).
Nei pazienti con insufficienza cardiaca avan-zata, l’impiego dei betabloccanti non è agevole,ma esistono i presupposti teorici e di sperimenta-zione clinica per la loro utilità. Il farmaco deveessere avviato in condizioni di accettabile stabilitàdel compenso, quindi al di fuori delle fasi diaggravamento del quadro congestizio e a distan-za dalle eventuali fasi di refrattarietà come dimo-strato nello studio Copernicus con Carvedilolo,che ha comunque evidenziato buona tollerabilità.Anche per i Beta-Bloccanti è necessaria una atten-ta titolazione, rimane aperto il discorso se privile-giare una molecola rispetto ad un’altra e se con-venga iniziare il trattamento farmacologico conAce-Inibitore o Beta-Bloccante ed aspettare la tito-lazione dell’uno prima di inserire l’altro oppure seiniziare con ambedue i farmaci contemporanea-mente (15,16).
ANTAGONISTI DELL’ALDOSTERONE(MRA)
Le ultime Linee Guida ESC del 2012 edell’AHA del 2013 mostrano un allargamento del-l’indicazione degli Antagonisti dei Recettoridell’Aldosterone (MRA) a tutti i pazienti con FEridotta (35%) e persistenza dei sintomi (5,6). Lasomministrazione di basse dosi di un Antagonistadell’Aldosterone deve essere considerata in tutti ipazienti con FE ≤ 35% e scompenso cardiaco sin-tomatico, e quindi con una classe funzionaleNYHA II-IV (17), in assenza di iperkaliemia einsufficienza renale significativa (Classe di racco-mandazione I, livello di evidenza A), in associa-zione a ACE-I (o ARBs se non tollerati) e Beta-bloccante.
Gli Antagonisti dell’Aldosterone riducono l’o-spedalizzazione per peggioramento di scompen-so e aumentano la sopravvivenza, con significati-va riduzione della morte improvvisa, quandoaggiunti ad una terapia di base che includa unACE-I, come dimostrato negli studi RALES eEPHESUS. Attualmente si sta rivalutando il loroutilizzo precoce nel post-infarto per gli effettifavorevoli sul rimodellamento ventricolare.
L’Eplerenone (ancora non in commercio in
188 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto

Italia) (18), nello studio EMPHASIS-HF, (aggiuntoalla terapia standard), in pazienti con scompensolieve-moderato (Classe NYHA II e FE ≤ 30%), haridotto significativamente, rispetto al placebo, ilrischio di morte cardiovascolare e l’ospedalizza-zione per scompenso cardiaco (19).
ARBS (ANGIOTENSIN RECEPTORBLOCKERS)
In assenza di controindicazioni, l’uso di unARBs è raccomandato in tutti i pazienti con scom-penso cardiaco e con una FE ≤ 40% che rimango-no sintomatici nonostante un trattamento ottima-le con ACE-I e Beta-Bloccanti, a meno che ipazienti siano trattati anche con un Antagonistadell’Aldosterone.
Il trattamento con ARBs migliora la funzioneventricolare sinistra, il benessere del paziente eriduce il ricovero ospedaliero, per peggioramentodello scompenso cardiaco, ed il rischio di morteprematura (Classe di raccomandazione I, livellodi evidenza A) (5,6).
Il trattamento con ARBs è raccomandato perridurre il rischio di ospedalizzazione in pazienticon FE < 40% e persistenza dei sintomi (NYHA II-IV), nonostante il trattamento con ACE-I e Beta-Blocc. e che non tollerano l’MRA (Classe di racco-mandazione I, livello di evidenza A).
Gli ARBs vengono, inoltre, utilizzati in alterna-tiva agli ACE Inibitori nei pazienti intolleranti aquesti ultimi, ed è questo l’utilizzo attualmentepiù frequente (20), dal momento che l’alternativacostituita dall’impiego di Idralazina + IsosorbideDinitrato non è praticabile per l’indisponibilitàdell’Idralazina sul mercato italiano (21).
In questi pazienti gli ARBs riducono il rischiodi morte da cause cardiovascolari e il ricoveroospedaliero per peggioramento dello scompensocardiaco. Nei pazienti ospedalizzati, il trattamen-to con un ARBs dovrebbe essere iniziato primadella dimissione (Classe di raccomandazione I,livello di evidenza B).
Analogamente allo studio ATLAS, l’HEEAL(Heart Failure Endpoint Evaluation of AII-Antagonist Losartan) è stato condotto su pazienticon scompenso cardiaco in trattamento con ARBspiuttosto che con ACE-Inibitori per intolleranza aquesti ultimi. Sono stati reclutati quasi 4.000pazienti di cui alcuni sono stati trattati con 50mg/die di Losartan e altri con 150 mg/die (11-22).
Da un’analisi effettuata al follow-up è emersoche l’utilizzo di un dosaggio più elevato di ARBsera associato ad una riduzione del 10% del rischiorelativo (considerando come end-point primariocombinato la mortalità per tutte le cause e l’ospe-dalizzazione per insufficienza cardiaca) rispettoalla dose più bassa.
Tale differenza sembra essere dovuta soprat-tutto ad una riduzione del rischio di ricovero per
insufficienza cardiaca. Anche in questo caso, irisultati ottenuti non sono da considerarsi ancoraconclusivi, anche alla luce degli effetti collaterali(ipotensione e peggioramento della funzionerenale) delle dosi più elevate (23).
IVABRADINAL’Ivabradina è la “new entry” delle ultime
Linee Guida, è un farmaco che inibisce i canali Ifnel nodo del seno. È conosciuta per i suoi effettifarmacologici nel rallentare la frequenza cardiacain pazienti in ritmo sinusale (non può essere usataquindi nella Fibrillazione atriale e nel portatore diPace Maker).
Riduce il rischio di ospedalizzazione (studioSHIFT) in pazienti con FE < 35%, frequenza car-diaca > 70 bpm e persistenza dei sintomi, nono-stante il trattamento con Beta-Bloccanti, ACE-I (oARBs) e MRA (o ARBs) (Classe di raccomandazio-ne IIa, livello di evidenza B) (24).
Può essere inoltre considerata nel ridurre ilrischio di ospedalizzazione in pazienti con FE <35%, frequenza cardiaca > 70 bpm che non tolleranoi Beta-Bloccanti, ma che comunque sono in tratta-mento con ACE-I (o ARBs) e MRA (o ARBs) (Classedi raccomandazione IIa, livello di evidenza C) (6).
IDRALAZINA ED ISOSORBIDE DINITRATOIn pazienti sintomatici con una FE ≤ 40% la
combinazione di Idralazina e di IsosorbideDinitrato (H-ISDN) può essere utilizzata in alter-nativa ai ACE-I e ARBs (25), in caso di intolleran-za agli stessi. Può essere aggiunta nei casi in cui siha una persistenza dei sintomi nonostante l’otti-mizzazione della terapia con ACE-I, BetaBloccanti e ARBs o Antagonisti dell’Aldosterone(Classe di raccomandazione IIb, livello di eviden-za B). L’associazione di H-ISDN riduce l’ospeda-lizzazione per il peggioramento dello scompenso(Classe di raccomandazione IIa, livello di eviden-za B) e migliora la funzione ventricolare e la capa-cità nell’esercizio (Classe di raccomandazione IIa,livello di evidenza A) (5).
Al presente, i vasodilatatori disponibili epotenzialmente utili nell’IC avanzata sono rap-presentati dai Nitrati. L’Isosorbide Dinitrato è ilfarmaco teoricamente più indicato, ma la neces-sità di somministrazioni multiple nell’arco dellagiornata li rende poco accetti a pazienti che giàassumono molti farmaci, favorendo l’impiego diformulazioni ad azione prolungata (orali o tran-sdermiche), nonostante non sia stata dimostrata laloro efficacia in grandi trials farmacologici. INitrati sono generalmente ben tollerati se si esclu-de la possibile insorgenza di cefalea; la sospensio-ne del trattamento per qualche ora al giorno, perevitare la tolerance, sembra utile anche neipazienti con insufficienza cardiaca, analogamentea quanto osservato negli ischemici.
Gabrielli D., Savini E., Benvenuto M., et al. - Up to date nello scompenso... 189

DIGOSSINANei pazienti con scompenso cardiaco sintoma-
tico e fibrillazione atriale la Digitale può essereusata per rallentare una risposta ventricolare rapi-da. Nei pazienti con fibrillazione atriale e FE ≤40% dovrebbe essere usata per il controllo dellafrequenza cardiaca insieme o prima dei Beta-Bloccanti (Classe di raccomandazione IIb, livellodi evidenza B). Nei pazienti in ritmo sinusale conscompenso cardiaco sintomatico e FE ≤ 40%,iltrattamento con Digossina (in aggiunta a un ACE-I) migliora la funzione ventricolare e il benesseredel paziente, riduce la ospedalizzazione per peg-gioramento di scompenso, ma non ha effetti sullasopravvivenza (Classe di raccomandazione IIb,livello di evidenza B) (26,6).
La Digitale è utile in molti pazienti con scom-penso cardiaco grave. Tuttavia secondo i piùrecenti orientamenti il suo utilizzo non è manda-tario. Resta consigliabile nei pazienti fibrillantie/o tachicardici. I livelli ematici devono essereaccuratamente sorvegliati nei soggetti con com-penso labile e con latente disfunzione d’organo.Nei pazienti in trattamento digitalico, è utile ilcontrollo periodico del ritmo e della conduzioneall’ECG (27).
DIURETICII Diuretici sono raccomandati in pazienti con
scompenso cardiaco e sintomi o segni clinici dicongestione (Classe di raccomandazione I, livellodi evidenza B) (1,6).
I Diuretici sono farmaci sintomatici utili a limi-tare la congestione. La dose è dettata dalla neces-sità, tenendo presente che ridurre il diuretico alladose minima necessaria ne limita gli effetti sfavo-revoli sull’equilibrio elettrolitico, sull’assetto neu-roendocrino, sulla funzione renale e sull’uricemia,e spesso permette l’impiego di dosi più elevate diACE-Inibitori. La necessità di incremento pro-gressivo e/o stabile del diuretico è un indice dipeggioramento dell’IC, ma bisogna ricordare chea volte il paziente risponde all’aumento della dosecon un parallelo aumento dell’assunzione diliquidi e/o sale, accentuando così il circolo vizio-so dello scompenso.
Per quanto riguarda l’associazione di piùDiuretici, pur essendo spesso più maneggevolenei pazienti ambulatoriali rispetto a quelli ricove-rati, espone al rischio di iponatriemia e ipo oiperkaliemia non riconosciute per l’assenza delcontrollo frequente del quadro elettrolitico; comenoto, l’aggiunta temporanea di Metolazone alDiuretico dell’Ansa può risolvere quadri di aggra-vamento della congestione, ma richiede strettomonitoraggio dei parametri di funzionalità renaleed elettroliti (28).
Citiamo, per completezza, lo studio DOSE-AHF, pubblicato sul New England Journal il 3
marzo 2011, sui due metodi di somministrazione(bolo vs infusione continua) di Diuretico in faseacuta (Classe NYHA IV), in cui non sono statesegnalate differenze significative sui due metodi,lasciando, volta per volta, alla pratica clinica edall’esperienza diretta la scelta della modalità tera-peutica migliore (29).
ANTICOAGULANTI E ANTIAGGREGANTIIl Warfarin è raccomandato nei pazienti scom-
pensati con fibrillazione atriale parossistica, persi-stente o permanente che non abbiamo controindi-cazioni all’anticoagulazione.
Una corretta anticoagulazione riduce il rischiotrombo embolico (Classe di raccomandazione I,livello di evidenza B). I pazienti con bassa porta-ta, fibrillazione atriale, aneurisma del ventricolosinistro, trombosi endocavitaria o fenomeni dicontrasto spontaneo all’ecocardiogramma, oltreche con le comuni indicazioni, necessitano di tera-pia anticoagulante orale con Dicumarolici secon-do le comuni abitudini. Il trattamento antiaggre-gante con Acido Acetilsalicilico, Ticlopidina odaltre Tienopiridine, o Indobufene può essereimpiegato negli altri pazienti con cardiomegalia eridotta frazione d’eiezione (30). Rimane da valu-tare il ruolo di nuovi farmaci quali il Dabigatran.
STATINE E OMEGA 3Il trattamento con Statine può essere conside-
rato per ridurre l’ospedalizzazione nei pazientianziani con scompenso cardiaco cronico sintoma-tico e disfunzione sistolica causata da coronaropa-tia, come dimostrato negli studi GISSI-HF eCORONA (Classe di raccomandazione IIb, livellodi evidenza B) (31).
Dallo studio GISSI-HF emerge un effetto favo-revole moderato sugli end-point con l’utilizzo diomega-3, le Linee Guida dell’AHA li consiglianocome terapia aggiuntiva, con effetto favorevole,nel ridurre la mortalità e le ospedalizzazioni permalattie cardiovascolari nei pazienti in ClasseNYHA II-IV sintomatici (Classe di raccomanda-zione IIa, livello di evidenza B) (6,32,33).
ANTIARITMCIIn generale, nei pazienti con IC grave, gli
Antiaritmici presentano una limitata efficaciaantiaritmica e un incremento degli effetti collate-rali (depressione contrattile, proaritmia e aritmo-genicità). Nei pazienti con aritmie, va verificatal’assenza di significativa disionia.
C’è indicazione all’impiego di Antiaritmicinella terapia di fondo dei pazienti con tachicardieventricolari sostenute, fibrillazione ventricolare(non relate a disionia o ipossiemia grave), fibrilla-zione atriale rapida mal tollerata emodinamica-mente, e, in generale, aritmie anche non sostenuteche determinano aggravamento dei segni/sinto-
190 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto

Gabrielli D., Savini E., Benvenuto M., et al. - Up to date nello scompenso... 191
mi di insufficienza cardiaca, se responsive al trat-tamento antiaritmico, ovviamente la terapia far-macologica non può essere considerata sostitutivadella terapia elettrica, ove questa sia indicata,stante la maggiore efficacia dimostrata nei nume-rosi trials clinici di confronto effettuati.
Tra i farmaci Antiaritmici, fatte salve le ovvieconsiderazioni di efficacia, sono da considerare discelta nei pazienti con scompenso cardiaco, soprat-tutto se refrattario, l’Amiodarone e la Mexi letina(da sola o associate all’Amio darone) (34). L’effettocollaterale più frequente e temibile dell’Amio -darone è il distiroidismo; in particolare, l’ipertiroi-dismo può scatenare un peggioramento delloscompenso fino a renderlo intrattabile; in questicasi, va presa in considerazione la tiroidectomia.
CONCLUSIONIIn questo scritto abbiamo brevemente esami-
nato i capisaldi della terapia farmacologica delloscompenso cardiaco da disfunzione ventricolaresinistra in accordo alle Linee Guida delACCF/AHA del 2013 e della ESC del 2012 (5,6) eapplicati nella pratica clinica quotidiana.
Dalla revisione della letteratura e delle prece-denti Linee Guida non sono emerse delle sostan-ziali differenze per ciò che concerne la farmacote-rapia dello scompenso.
Infatti, i vari studi di registro e i trials che sonostati effettuati in merito hanno confermato la vali-dità dell’associazione terapeutica per la gestionedel paziente. ACE-Inibitori, Beta Bloccanti eAntagonisti degli Anti-Aldosteronici assumonoun ruolo preponderante, in associazione conl’Ivabradina, e, in assenza di specifiche controin-dicazioni, andrebbero sempre utilizzati neipazienti con disfunzione sistolica sintomatici.
Effettivamente, le classi di farmaci attualmen-te impiegate agiscono su aspetti diversi e in variomodo nella fisiopatologia dello scompenso car-diaco e, considerando la molteplicità dei meccani-
smi contemporaneamente coinvolti, la terapia diassociazione consente di intervenire a vari livellicon outcomes migliori. Infatti, esistono forti evi-denze che testimoniano come una corretta terapiaaumenti in modo significativo la sopravvivenza eriduca il tasso di ri-ospedalizzazione, miglioran-do la qualità della vita dei pazienti.
Per quanto riguarda nuove possibilità farma-cologiche rimane da verificare il ruolodell’Aliskiren e delle terapie di supplementazionemarziale, per i quali sono in corso trials, rimango-no problemi aperti nella gestione di sottogruppidi pazienti specifici e degli anziani, in relazionealla politerapia necessaria ed alla sua tollerabilitàanche alla luce delle comorbilità; inoltre si aspet-tano evidenze più probanti sulla terapia farmaco-logica dello scompenso diastolico od a funzionesistolica confermata, dove rimane fondamentale ilcontrollo ottimale della pressione arteriosa e dellecomorbilità (Classe I, livello di evidenza B) (5). Aquesto proposito le Linee Guida del ACCF/AHApubblicate nel giugno 2013, raccomandano il trat-tamento della pressione arteriosa con BetaBloccante, ACE-I e ARBs (Classe II, livello di evi-denza C), e l’uso dei diuretici nel sovraccarico divolume (Classe I, livello di evidenza C) (5).
In conclusione, al momento rimane di fonda-mentale importanza una terapia farmacologicabasata sì sulle Linee-Guida, ma soprattutto indivi-dualizzata sul singolo paziente, tenendo in asso-luta considerazione le interazioni farmacologichenella politerapia e le eventuali comorbilità, consi-derando che la terapia farmacologica della IC èsolo una degli aspetti, anche se fondamentale,della gestione terapeutica complessiva delpaziente (restrizione idro-salina, controllo dei fat-tori di rischio e del peso corporeo etc.), comeperaltro ben messo in chiaro dalle Linee-Guidaeuropee ed americane e dalla esperienza matura-ta da chi si occupa sul campo della cura di questapatologia.

192 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto
1. The Task Force on Heart Failure of the European Society of CardiologyGuidelines for the diagnosis of heart failure. Eur Heart J 1995, 741-745. 2. REMME W.J.,SWELBERG K.: Guidelines for the diagnosis and treatmentof chronic heart failure. Eur Heart J 2001; 23:1527-1560.3. Heart Failure Society of America. Executive summary: HFSA 2006; J CardFail 2006; 12: 10-387.4. MOSTERD A., HOES A.W.: Clinical epidemiology of heart failure. Heart2007; 9:1137-1146.5. CLYDE W.Y., et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management ofHeart Failure: A Report of the American College of CardiologyFoundation/American Heart Association Task Force on Practice. Guidelines.Circulation. published online June 5, 2013; 6: 1-125.6. MCMURRAY J.J.V. et al.: ESC Guidelines for the diagnosis and treatmentof acute and chronic heart failure 2012. European Heart Journal 2012; 33:1787-1847.7. HUNT S.A., ABRAHM W.T., CHIN M.H. et al. Guidelines update for thediagnosis and management of chronic heart failure in the adult. Circulation2005; 12: 154-235.8. Effect of enalapril on mortality and the development of heart failure inasymptomatic patients with reduced left ventricular ejection fractions. TheSOLVD Investigattors. N Engl J Med. 1992; 327: 685-691.9. PFEFFER M.A., BRAUNWALD E., MOYE L.A., et al. Effect of captoprilon mortality and morbidity in patients with left ventricular dysfunction aftermyocardial infarction. Results of the survival and ventricular enlargementtrial. The SAVE Investigators. N Engl J Med. 1992; 327: 669-677.10. Effects of enalapril on mortality in severe congestive heart failure. Resultsof the Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study (CONSEN-SUS). The CONSENSUS Trial Study Group. N Engl J Med. 1987; 316: 1429-1435.11. KOMAIDA M.,WIMART M.C.: The ATLAS study. Arch Mal CoeurVaiss 1994; 2: 45-50.12. HOBBS R.E.: Result of the ATLAS study: high or low dose of ACE inhibi-tors for heart failure. Cleve Clin J Med 1998; 539-542.13. POOLE-WILSON P.A., SWEDBERG K., CLELAND J.G.: Carvedilol OrMetoprolol European Trial Investigators. Comparison of carvedilol and meto-prolol on clinical outcomes in patients with chronic heart failure in theCarvedilol Or Metoprolol European Trial (COMET). Lancet 2003; 362: 7-13.14. WILLENHEIMER R.., VAN VELDHUISEN D.J., SILKE B., et al.: Effecton survival and hospitalization of initiating treatment for chronic heart failurewith bisoprolol followed by enalapril, as compared with the opposite sequence:results of the randomized Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS) III.Circulation 2005; 112: 2426-2435.15. COLUCCI W.S., PACKER M., BRISTOW M.R., et al.: Carvedilol inhibitsclinical progression in patients with mild symptoms of heart failure. USCarvedilol Heart Failure Study Group. Circulation. 1996; 94: 2800-2806.16. GATTIS W.A., O'CONNOR C.M., GALLUP D.S., et al.: Predischargeinitiation of carvedilol in patients hospitalized for decompensated heart failure:results of the Initiation Management Predischarge: Process for Assessment ofCarvedilol Therapy in Heart Failure (IMPACT-HF) trial. J Am Coll Cardiol.2004; 43: 1534-1541.17. PITT B., ZANNAD F., REMME W.J., et al.: The effect of spironolactoneon morbidity and mortality in patients with severe heart failure. RandomizedAldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med. 1999; 341: 709-717.
18. ZANNAD F., MCMURRAY J.J., KRUM H., et al.: Eplerenone in patientswith systolic heart failure and mild symptoms. N Engl J Med. 2011; 364: 11-21.19. PITT B., REMME W., ZANNAD F., et al.: Eplerenone, a selective aldoste-rone blocker, in patients with left ventricular dysfunction after myocardialinfarction. N Engl J Med 2003; 348: 1309-1321.20. MAGGIONI A.P., ANAND I., GOTTLIEB S.O., et al.: Effects of valsar-tan on morbidity and mortality in patients with heart failure not receivingangiotensin-converting enzyme inhibitors. J Am Coll Cardiol. 2002; 40: 1414-1421.21. GRANGER C.B., MCMURRAY J.J., YUSUF S., et al.: Effects of cande-sartan in patients with chronic heart failure and reduced left-ventricular systo-lic function intolerant to angiotensin-converting-enzyme inhibitors: TheCHARM-Alternative trial. Lancet. 2003; 362: 772-776.22. KONSTAM M.A., NEATON J.D., DICKSTEIN K., et al.: Effects of high-dose versus low-dose losartan on clinical outcomes in patients with heart failure(HEAAL study): a randomised, double-blind trial. Lancet. 2009; 374: 1848.23. PACKER M., POOLE-WILSON P.A., ARMSTRONG P.W., et al.:Comparative effects of low and high doses of the angiotensinconverting enzy-me inhibitor, lisinopril, on morbidity and mortality in chronic heart failure.ATLAS Study Group. Circulation. 1999; 100: 2312-2318.24. SWEDBERG K., KOMAJDA M., BOHM M., et al.: Ivabradine and out-comes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study.Lancet 2010; 376: 875-885.25. TAYLOR A.L., ZIESCHE S., YANCY C., et al.: Combination of isosorbi-de dinitrate and hydralazine in blacks with heart failure. N Engl J Med 2004;351: 2049-2057.26. The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients with heart fai-lure. The Digitalis Investigation Group. N Engl J Med 1997; 336: 525-533.27. HOOD W.B. JR, DANS A.L., GUYATT G.H., et al.: Digitalis for treat-ment of congestive heart failure in patients in sinus rhythm: a systematicreview and meta-analysis. J Card Fail 2004; 10: 155-164.28. CHANNER K.S., MCLEAN K.A., LAWSON P. et al.: Combination diu-retic treatment in severe heart failure.a randomized controlled trial. Br Heart J1994; 71: 146-150.29. FELKER G.M. et al.: Diuretic Strategies in Patients with AcuteDecompensated Heart Failure. N Engl J Med 2011; 364: 797-805.30. HOMMA S., THOMPSON J.L., PULLICINO P.M., et al.: The WARCEFInvestigators. Warfarin and aspirin in patients with heart failure and sinusrhythm. N Engl JMed 2012; 366 (20): 1859-1869.31. REINER Z., CATAPANO A.L., et al.: ESC/EAS Guidelines for the mana-gementof dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemiasof the European Society of Cardiology (ESC) and the European AtherosclerosisSociety (EAS). Eur Heart J 2011; 32: 1769-1818.32. KJEKSHUS J., APETREI E., et al.: ESC Guidelines: Rosuvastatin in olderpatients with systolic heart failure. N Engl J Med 2007; 357: 2248-2261.33. TAVAZZI L., MAGGIONI A.P., et al.: Effect of rosuvastatin in patientswith chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind,placebocontrolled trial. Lancet 2008; 372: 1231-1239.34. DOVAL H.C., NUL D.R., GRANCELLI H.O., et al.: Randomised trial oflow-dose amiodarone in severe congestive heart failure. Grupo de Estudio de laSobrevida en la Insuficiencia Cardiaca en Argentina (GESICA). Lancet. 1994;344: 493-498.
BIBLIOGRAFIA

Zocca N. - Caso clinico: Una strana cirrosi 193
INTRODUZIONELa fibrillazione atriale è la più comune aritmia;
colpisce circa il 10% dei soggetti con età superioreai 65 anni e la sua incidenza aumenta con l’età.
Il profilo di sicurezza dei farmaci antiaritmici(es. Amiodarone, Chinidina, Flecainide, Propa fe -no ne, Sotalolo) non è ottimale.
Questi, infatti, possono causare gravi effettiindesiderati, in alcuni casi minaccianti la vita.
Inoltre sono scarsamente efficaci nel manteni-mento del ritmo sinusale.
Il trattamento con Amiodarone, in particolare,è gravato da un numero considerevole di gravieffetti indesiderati, tra cui l’epatotossicità (elevatilivelli enzimatici: 15-30%; epatite e cirrosi: menodel 3% (0.6% annualmente).
CASO CLINICOD. M. M. (83 anni); affetta da cardiopatia iper-
tensiva da anni; soffre di F.A. in trattamento conamiodarone 300 mg (1 cp e mezza) da 18 anni (conaccertati depositi corneali). Dal 2009 ha segni diiniziale insufficienza renale. Dal 2010 gli esamibioumorali mostrano movimento degli enzimiepatici. La paziente nega potus; mai avuto epatitevirale (B, C, altro).
Da alcuni mesi presenta progressivo edemaagli arti inferiori associato ad aumento volumetri-co dell’addome. Fu ricoverata l’11/1/2012 nelReparto Cardiologico della Casa di Cura e succes-sivamente trasferita nel nostro Reparto Medico il25/1 per versamento addominale resistente allaterapia diuretica.
L’esame obiettivo all’ingresso evidenziava ipo-tensione arteriosa (PAO 90/60 mmHg), versa-mento ascitico addominale, pleurico bilaterale emarcati edemi declivi.
ITER CLINICOIl 25/01 abbiamo eseguito una paracentesi,
evacuando 720 cc. di liquido trasudatizio e concitologia negativa per oncocellule.
I marcatori di epatite B e C sono risultati nega-tivi ; Ac anti CMV IgM negativi, IgG positivi; nelrange di normalità sono risultati anche gli anticor-pi anti muscolo liscio, anti mitocondri LKM, ANA
ed ENA (per escludere un’epatopatia autoimmu-ne). Non significativi sono risultati anche cupre-mia, alfa1-antitripsina ed acidi biliari.
I marcatori tumorali sono nel range di norma-lità ad eccezione del CA 125 che è risultato parti-colarmente elevato sia nel plasma che nel liquidoascitico (aspecifico?).
Era presente ipocalcemia, corretta dalla terapiaed ipoalbuminemia non completamente norma-lizzata dall’apporto infusionale.
L’ammonio risultava modicamente aumentatoe la Pseudocolinesterasi ridotta.
Il BNP all’ingresso era di 400 pg/ml. Abbiamo sospeso la Doxazosina e l’Amlodi -
pina per ipotensione persistente, legata ancheall’incremento dei diuretici; attualmente la diure-si si mantiene intorno ai 3 litri e si è ottenuto unasensibile riduzione degli edemi e dell’ascite.
Non possiamo escludere che la causa dell’epa-topatia sia l’Amiodarone: la letteratura riporta un3% di epatopatia acuta e cronica ed uno 0.6% dicirrosi ad impronta colestatica con inversione delrapporto GOT/GPT (come in questo caso).
Abbiamo perciò deciso, consultato il cardiolo-go, medico curante della paziente, di interrompe-re l’assunzione dell’Amiodarone, monitorandolacon Holter (ad 1 mese di distanza).
ACCERTAMENTI ESEGUITI Il Controllo ematochimico del 13/02 segnala:
Bilirubina T= 2.95 mg/dl, D= 2,10 mg/dl GOT 76UI/L GPT= 14 UI, GGT= 411 UI,Fosf.Alcalina= 235 UI, Creatinina = 1.48mg/dl, Calcemia= 8.2 mg/dl, Albuminemia=2,3 gr, GR= 3.1 milioni, Hb= 9.8 gr/dl, Hct=29.9%, GB= 10800 (N= 8660), Sodio, potassio ecloro nel range di normalità.
ECG= Ritmo sinusale regolare. PR e QT nei limi-ti. Molto modeste atipie della ripolarizzazioneventricolare.
Colonscopia= diverticolosi iniziale del discen-dente-sigma.
EGDS= Varici esofagee F1 bleu. Gastropatiaantrale aspecifica (E.I.: non rilevante).
Ecocardiogramma= Atrio sinistro lievementedilatato. Mitrale normale con lieve insuffi-cienza. Aorta con valvola tricuspide normo-funzionante e tratto toracico nei limiti.
CASO CLINICO: UNA STRANA CIRROSI
Zocca N.
Unità Operativa di Medicina Interna, Casa di Cura Eretenia, Vicenza
Indirizzo per la corrispondenza:Dott. Nadir ZoccaVia Paolo Calvi,8536100 VicenzaCell.: 3471107010E-mail: [email protected]

194 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto
Ventricolo sx con spessori lievemente aumen-tati, deficit diastolico di I°, diametri e cinesiglobale e segmentaria nei limiti. Atrio dxmoderatamente dilatato, lieve insufficienzatricuspidale con ipertensione polmonare(PAPs 45 mmHg), ventricolo dx nei limiti. Nonversamenti pericardici. Non versamenti pleu-rici. Normali i restanti flussi transvalvolari.
Rx del torace (19/01)= Attualmente immodificatal’espansione e la diafania di fondo. Al control-lo attuale appare comparso ispessimento capil-lare della pleura interlobare dx. Meno eviden-te l’accentuazione della trama interstizio-parenchimale precedentemente descritta acarico di entrambi i campi polmonari. Ili vasa-li immodificati. Cuore immodificato permorfologia e diametri. Aorta allungata all’arcocon lamella calcifica. Liberi i seni costofrenici.
Rx del torace (2/2)= Attualmente immodificatal’espansione e la diafania di fondo. Al control-lo attuale appare comparso ispessimento capil-lare della pleura interlobare dx. Meno eviden-te l’accentuazione della trama interstizio-parenchimale precedentemente descritta acarico di entrambi i campi polmonari. Ili vasa-li immodificati. Cuore immodificato permorfologia e diametri. Aorta allungata all’arcocon lamella calcifica. Liberi i seni costofrenici.
Ecografia dell’addome completo= Non sono evi-denti alterazioni significative della morfologiae della struttura del fegato; in particolare nonevidenti lesioni focali. Non litiasi della coleci-sti né dilatazione delle vie biliari. Pervio l’assespleno-mesenterico-portale. Pancreas, milza erene sn di aspetto regolare. Cisti del diametrodi 2.7 cm al terzo medio-superiore del rene dx.Regolare il calibro dell’aorta addominale.Vescica discretamente espansa con profili con-servati. Nei limiti per l’età le strutture utero-annessiali. È presente falda ascitica di discreto grado insede peri-epatica, lungo le docce parieto-coli-che e nello scavo pelvico.
TAC addome (23/1)= si rivede il versamento liqui-do, già segnalato in ambito peritoneale, piùabbondante in sede peri-epatica, peri-splenicae nei settori declivi della regione pelvica (vediTAC del 16.01.12 eseguita senza somministra-zione di mdc endovena). Il fegato si confermaa margini bozzuti. Non sono apprezzabililesioni focali nel suo contesto. Vie biliariintraepatiche e via biliare principale con cali-bro regolare. La colecisti appare discretamentedistesa a pareti un po’ ispessite circondata daalone ipodenso, come nei casi di disprotide-
mia. Asse spleno-portale bene opacizzato.Marcate e diffuse note di atrofia della regionepancreatica. Come di norma la milza, le regio-ni surrenali ed i reni. Lesione liquida, di tipo cistico, a dx con diame-tro assiale massimo di 3 cm circa. Bacinetti nondilatati. Coesiste marcato ispessimento di granparete delle radici del ventaglio mesenterico.Ispessito anche il mesocolon trasverso.Ispessite appaiono anche le pareti del colon dxcon mammellonatura di alcuni tratti dei suoiprofili (tali aspetti necessitano di valutazioneendoscopica). Grosso lane e sfumate striedense nel tessuto grasso peri-viscerale. Lavescica è discretamente distesa a pareti regola-ri. Utero di tipo senile. Non alterazioni di rilievo a carico delle regioniannessiali. Calcificazioni estese lungo le paretidell’aorta addominale e degli assi arteriosi ilia-co-femorali.
TAC toraco-addome (9/2)= campi polmonaridiscretamente espansi; qualche sottile striadensa, di tipo distelettasico, ad entrambe lebasi. Non lesioni parenchimali a focolaio inatto. Non versamento pleurico. La trachea e lediramazioni bronchiali principali presentanoregolari decorso e calibro. In sede mediastinicanon sembrano essere riconoscibili adenopatie.Cuore ingrandito in tutti i suoi diametri.Dilatazione dell’arco aortico con lamelle calci-fiche lungo le sue pareti. Ridotta in estensione risulta la quantità diliquido già descritta in ambito peritonealeanche se risulta comunque apprezzabile intutti i distretti già segnalati. Marcata riduzioneanche dell’ispessimento di gran parte delleradici del ventaglio mesenterico già segnalatoed anche del grande omento. Appaiono quasicompletamente scomparsi inoltre gli aspetti dimammellonatura del colon trasverso e di quel-lo dx con irregolarità dei profili. Quadrosostanzialmente invariato per il resto.
LA PAZIENTE FU DIMESSACON LA SEGUENTE TERAPIA FUROSEMIDE 500mg cp 1/2cp mattinaALPRAZOLAM 0.25mg cp 1 cp seraPANTOPRAZOLO 40mg cp 1 cp mattina
a digiunoALLOPURINOLO 100mg cp 1 cp alla seraSPIRONOLATTONE 50mg cp 1 cp x 2
(8.00-20.00).
DISCUSSIONE E CONCLUSIONIL’aumento degli enzimi epatici è l’effetto
avverso più comunemente segnalato (fino al 40%)in letteratura (1) nei pazienti in trattamento far-macologico con Amiodarone. L’epatite acuta è

Zocca N. - Caso clinico: Una strana cirrosi 195
molto rara anche se potenzialmente mortale.L’epatotossicità è generalmente dose e durata-dipendente. La scheda tecnica di questo impor-tante presidio farmacologico descrive, oltre almodesto incremento delle transaminasi, general-mente isolato ed eccezionalmente associato adittero, soprattutto all’inizio del trattamento, alcu-ni casi di epatite cronica, in qualche caso ad evo-luzione irreversibile.
Per questo si raccomanda il controllo periodi-co della funzionalità epatica. Tuttavia un aumen-to (2-4 volte la norma) asintomatico delle soletransaminasi non sembra costituire una indicazio-ne alla sospensione del farmaco. Lo studio diPollak (2) dimostrò che il valore delle ALT siericheresta il parametro di scelta, per controllare glieffetti dell’amiodarone sulla funzione epatica esuggerisce il seguente programma di controlloottimale: (a) annotare il valore basale di ALT, AST,ALK e di LDH per il confronto futuro; (b) misura-re il valore delle ALT dopo 1 mese di terapia pereliminare l’eventuale sensibilità idiosincrasica ad
amiodarone; (c) controllare le ALT a 3 e 6 mesi perdeterminare la risposta massima da accumulo diamiodarone; (d) fissare dei controlli semestraliper annotare eventuali effetti ritardati, lo stato delpaziente e come procede la terapia.
Secondo questo studio, un’ulteriore indaginesulla funzionalità epatica dovrebbe essere richie-sta soltanto se il valore delle ALT supera di 3 voltei limiti o si sviluppano sintomi epatici. I meccani-smi di epatotossicità ipotizzati sono stati l’esposi-zione al diluente, polisorbato 80, nella formaparenterale (3) o cause di natura immunologica(4). Entrambi i casi mortali sono associati allasomministrazione parenterale di una alta doseiniziale (1500 mg entro 5 ore).
Tuttavia, l’epatite acuta è stata descritta siadopo somministrazione parenterale (1,5,6) che inseguito a terapia orale (400 – 800 mg/die dopo 6settimane di trattamento) (7). Abbiamo rilevatoche la tossicità epatica, da amiodarone, si manife-sta indipendentemente dalla via di somministra-zione.

196 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto
1. PYE M.: Acute hepatitis after parenteral amiodarone administration. BrHeart J. 1988 Jun; 59 (6): 690-691.2. POLLAK , YOU: Monitoring of hepatic function during amiodarone the-rapy. Am J Cardiol. 2003 Mar 1; 91 (5): 613-616.3. RHODES et al.: Early acute hepatitis with parenteral amiodarone: a toxiceffect of the vehicle? Gut. 1993 Apr; 34 (4): 565-566. 4. BREUER H.W. et al.: Amiodarone-induced severe hepatitis mediated byimmunological mechanisms. Int J Clin Pharmacol Ther. 1998 Jun; 36 (6): 350-352.
5. GREGORY S.A., et al.: Acute hepatitis induced by parenteral amiodarone.Am J Med. 2002 Aug 15; 113 (3): 254-255.6. JAMES P.R., HARDMAN S.M.: Acute hepatitis complicating parenteralamiodarone does not preclude subsequent oral therapy. Heart. 1997 Jun; 77 (6):583-584.7. JAIN D., et al.: Granular cells as a marker of early amiodarone hepatotoxi-city. J ClinGastroenterol. 2000 Oct; 31 (3): 241-243.
BIBLIOGRAFIA

FARMACI ORALI E ALIMENTAZIONEENTERALE ARTIFICIALE NELLE RSA
Negli ospedali, e da qualche tempo nelleResidenze Sanitarie Assistenziali (RSA) (oltre chenelle case di riposo per anziani) esiste un elevatonumero di pazienti sottoposti ad alimentazioneenterale artificiale (1).
La nutrizione artificiale (NA) – scrivono leLinee Guida SINPE (2) – è una procedura tera-peutica mediante la quale è possibile soddisfareintegralmente i fabbisogni nutrizionali di pazien-ti altrimenti non in grado di alimentarsi sufficien-temente per la via naturale.
Molti residenti in RSA, soprattutto se in fasecachettica o terminale, appaiono adatti a questotipo di alimentazione; più spesso provengonodall’ospedale già attrezzati per l’uso con sondevariamente posizionate; qualche volta la praticadel sondino nasogastrico si realizza come esigen-za autoctona.
Le indicazioni alla nutrizione artificiale sonodescritte dappertutto, e la discussione tra appro-priatezza ed eccessi in riferimento alle condizionicliniche del paziente le rimandiamo ad altre sedi.
Delle sonde e delle raccomandazioni sulla loromanutenzione sappiamo tutto. Ugualmente deiprodotti nutrizionali calcolati per il fabbisogno diciascuna persona.
Viceversa meno studiato è il problema dellasomministrazione dei farmaci per sonda, e menonote sono le loro interazioni con lo stato nutrizio-nale del paziente, con la sonda e con i nutrimenti.
In teoria andrebbero benissimo i farmaci informa liquida, e il ricorso alla triturazione per
quelli in forma solida. Ma il discorso è più com-plesso. Le forme liquide hanno differenti caratte-ristiche chimiche, e quelle solide, modificando laforma farmaceutica possono cambiare i processidi biotrasformazione.
Il finale è una possibile trasformazione dell’a-zione farmacologica, la comparsa di effetti secon-dari non previsti, fino a possibili reazioni tossi-che.
In un vecchio lavoro del 2001 (3) eseguito damedici ed infermieri di una Unità di terapiaintensiva si dimostrò che di 115 farmaci utilizzatiper sonda 50 non andavano triturati.
Si trattava di forme farmaceutiche che modifi-cavano, una volta triturate, le proprie caratteristi-che, le proprietà farmacocinetiche etc.
Oggi il dato è risaputo e lo si ritrova in tutte leraccomandazioni forti delle linee guida.Purtuttavia errori o comportamenti inappropriativengono continuamente segnalati nella letteratu-ra degli ultimi anni.
Un recente lavoro in lingua spagnola (4) havoluto studiare il grado di accuratezza (e di cultu-ra specialistica) del personale infermieristico diun ospedale di Madrid, per conoscere le modalitàdi somministrazione dei farmaci attraverso lesonde enterali, e identificare gli errori più comu-ni nell’esecuzione.
Le conclusioni sono state che le conoscenzedelle pratiche corrette di somministrazione deifarmaci sono deficitarie, in alcuni casi grossolana-mente carenti, da cui la necessità di corsi di for-mazione adeguati in collaborazione con il servi-zio di farmacia dell’ospedale.
Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto 197
VITA AGLI ANNI
a cura di:Sabatini D.Con la collaborazione di Emauela Iurlaro
Famacista, Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Università di Camerino
1. HIDALGO F.J., DELGADO E., GARCIA MARCO D., et al.: Guia deadministracion de farmacos por sonda nasogastrica, Farm Hosp 1995; 19 (5):251-258.2. Linee guida SINPE per la Nutrizione Artificiale Ospedaliera 2002, RivistaItaliana di Nutrizione Parenterale ed Enterale / Anno 20 S5, p. S1.
3. CATALAN E., PADILLA F., HERVAS F., et al.: Fármacos orales que no debenser triturados, Enferm Intensiva 2001; 12 (3): 146-150.4. DE AMURIZA N. C., JIMENEZ R.M.R., ZANUY M.A.V., et al.: Evaluaciónde las prácticas de administración de fármacos por sonda nasoentérica y entero-stomía en pacientes hospitalizados, Nutr Hosp. 2012; 27 (3): 879-888.
BIBLIOGRAFIA

Casa Editrice Scientifica Internazionale
per ordini spedire a c.e.S.I. - Via cremona, 19 • 00161 roma anche via fax
Volume in brossura, Edizione 2010300 pagine E 35,00
Cognome ....................................…….......... Nome ……………………… Tel. ………………………………………………
Via .........................................................……………… CAP …………… Città ………………………………………………
Firma .................................………………….... Contributo fisso spese imballo e spediz Û 3,00 TOTALE Û ..............……...........
■ Anticipato a mezzo Assegno Bancario (non trasfer.) allegato intestato a CESI ■ A mezzo vers. C/C N. 52181005 intestato a CESI ■ American Express (c/c N. ………………… Validità ……………… Firma ………………………………………………)
Per ordini telefonici 06.44.290.783 - 06.44.241.343 Fax 06.44.241.598 Via Cremona, 19 - 00161 Roma
Partita IVA ........................................................ (solo per chi desidera la fattura)
■■ Sì, desidero ricevere argomentI dI gerIatrIa di massimo marci
al prezzo di Û 35,00
BIBLIOGRAFIA

Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto 199
FIBRILLAZIONE ATRIALE E DEMENZA: ESISTE UNA CORRELAZIONE CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA?
Un’importante meta-analisi includente ben 21studi, prospettici e non, è stata condotta recente-mente al fine di valutare l’associazione tra fibrilla-zione atriale (F.A.) e rischio di demenza, il cuirisultato può così essere sintetizzato: anche consi-derata la presenza di variabili confondenti deglistudi osservazionali e la significativa eterogeneitàdegli studi inclusi, le evidenze suggeriscono chela F.A. è associata ad un rischio più elevato dideficit cognitivo e di demenza, questo con o senzauna storia clinica di ictus correlato all’aritmia (1).
Un precedente studio prospettico condotto su3045 pazienti con età pari a 65 anni o più, anzianisenza demenza né ictus, seguiti dal 1994 al 2008riportava come risultato finale che la fibrillazioneatriale era associata ad un 40-50% di rischio mag-giore di contrarre demenza (2).
In letteratura è meritevole di essere letto conattenzione un altro studio condotto da IreneMarzona, una ricercatrice italiana del Laboratoriodi Ricerca in Medicina Generale (DipartimentoCardiovascolare) del Mario Negri, che ha analiz-zato i dati prospettici risultanti dai trial ONTAR-GET e TRANSCEND. Si tratta di 31.546 pazienti,provenienti da 733 centri di 40 Paesi, tutti ad altorischio cardiovascolare ai quali, fra l’altro, è statovalutato anche lo stato cognitivo al M.M.S.E.(Mini Mental State Examination) al basale e dopodue e cinque anni. In questi soggetti è stato evi-denziato che un quarto dei pazienti senza fibrilla-zione atriale (7.269 pz su 27.864) presentava unadiminuzione di più di 3 punti nel test M.M.S.E.(Mini Mental State Examination) indice di signifi-cativo declino cognitivo, mentre nei pazienti conF.A. si registrava un aumento percentuale del
declino cognitivo pari ad un terzo (1.050 pz su3.068); inoltre nei pazienti con F.A. la comparsa didemenza, il ricovero in una struttura di lungode-genza e la perdita di autonomia nelle comuni atti-vità quotidiane risultavano statisticamente signi-ficativi (3).
Secondo i dati emersi da questo studio la fibril-lazione atriale aumenterebbe il rischio di demenzadel 21% a prescindere dalla presenza di una pato-logia ischemica cerebrale precedente al trial oppu-re riscontrata durante il periodo di follow up.
I meccanismi fisiopatologici proposti daidiversi studi per spiegare l’associazione osservatatra le patologie suddette sono essenzialmentedue: microembolismi clinicamente “silenti” cau-sati dalla fibrillazione atriale e/o la grande varia-bilità della frequenza cardiaca caratteristica dellaFA che potrebbe causare di per sé ipoperfusionecerebrale.
Da questa concisa disamina della letteraturascientifica emergono alcuni spunti di riflessione.Non sarebbe meglio avere un atteggiamento tera-peutico più aggressivo riguardo il tentativo diripristino del ritmo sinusale (cardioversione far-macologica o elettrica) di fronte a pazienti anzianicon fibrillazione atriale piuttosto che propendereper il “rate-control”?
Riguardo la terapia anticoagulante orale (qua-lora si propenda per il rate-control della FA)andrebbero preferiti i nuovi anticoagulanti orali(apixaban, dabigatran etexilato, rivaroxaban)rispetto ai “vecchi” warfarin ed acenocumarolo?
Saranno necessari nuovi studi clinici effettuatisu grandi numeri di pazienti ed una maggiore col-laborazione tra le varie figure specialistiche qualiil Geriatra, l’Internista ed il Cardiologo per offrireal paziente “older” cure appropriate e finalizzatead arginare la “piaga” demenza in quanto patolo-gia grave e con un costo sociale elevatissimo.
GERIATRIA NEL MONDO
a cura di:Zanatta A., Galanti A., Fiore V.
1. KALANTARIAN S., et al.: Cognitive impairment associated with atrialfibrillation: a meta-analysis; Ann Intern Med 2013; 158: 338-346.2. DUBLIN S., et al.: Atrial fibrillation and risk of dementia: a prospectivecohort study; J Am Geriatr Soc. 2011; 59: 1369-1375.
3. MARZONA I., et al.: Increased risk of cognitive and functional decline inpatients with atrial fibrillation: results of the Ontarget and Transcend studies;CMAJ 2012; 184: 329-336.

Web: www.congressline.net
Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto 200
Società Italiana di Cardiologia dello SportXVI CONGRESSO NAZIONALEObiettivo: riduzione del rischio cardiovascolaredurante sportPADOVA 12-14 Settembre 2013
Per informazioni:Congress Line • Via Cremona, 19 - 00161 RomaTel. 0644241343 - 0644290783 Fax 0644241598E.mail: [email protected]
Società Italiana di Geriatria Ospedale e TerritorioS.I.G.O.T. CONVEGNO INTERREGIONALE MARCHE,LAZIO, ABRUZZO E MOLISEL’Eccellenza Sanitaria nel Passato e nel Futuro...Come Cambierà L’Assistenza...FERMO 27-28 Settembre 2013
Per informazioni:Congress Line • Via Cremona, 19 - 00161 RomaTel. 0644241343 - 0644290783 Fax 0644241598E.mail: [email protected]: www.congressline.net
CONVEGNO NAZIONALEL’integrazione terapeutica con i farmaci target inoncologiaROMA 4-5 Ottobre 2013
Per informazioni:Congress Line • Via Cremona, 19 - 00161 RomaTel. 0644241343 - 0644290783 Fax 0644241598E.mail: [email protected]: www.congressline.net
Società Italiana di Geriatria Ospedale e TerritorioS.I.G.O.T.XXVI SEMINARIO NAZIONALE Luci ed ombrein diagnosi e terapia nel crepuscolo degli anniMATERA 10-12 Ottobre 2013
Per informazioni:Congress Line • Via Cremona, 19 - 00161 RomaTel. 0644241343 - 0644290783 Fax 0644241598E.mail: [email protected]: www.congressline.net
Convegno Attualità in CardiologiaAPRILIA 19 Ottobre 2013Per informazioni:Congress Line • Via Cremona, 19 - 00161 RomaTel. 0644241343 - 0644290783 Fax 0644241598E.mail: [email protected]: www.congressline.net
III CONGRESSO NAZIONALEElettrocardiografia Clinica DeduttivaCONEGLIANO 25-26 Ottobre 2013
Per informazioni:Congress Line • Via Cremona, 19 - 00161 RomaTel. 0644241343 - 0644290783 Fax 0644241598E.mail: [email protected]: www.congressline.net
114° CONGRESSO NAZIONALESocietà Italiana di Medicina InternaROMA 26-28 Ottobre 2013
Per informazioni:Aristea• Via Roma, 10 - 16121 GenovaTel. 010553591 Fax 0105535970E.mail: [email protected]
W.A.P.S. - PAN.D.O.R.A.I CONVEGNO NAZIONALELifestyle and aging: come invecchiare bene attraverso una buona condotta di vitaROMA 22-23 NOVEMBRE 2013Per informazioni:Congress Line • Via Cremona, 19 - 00161 RomaTel. 0644241343 - 0644290783 Fax 0644241598E.mail: [email protected]: www.congressline.ne
Società Italiana di Geriatria Ospedale e TerritorioS.I.G.O.T.XXVIII CONGRESSO NAZIONALE Roma 15/17 Maggio 2014Per informazioni:Congress Line • Via Cremona, 19 - 00161 RomaTel. 0644241343 - 0644290783 Fax 0644241598E.mail: [email protected]
CALENDARIO CONGRESSI

Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto 201
La rivista GERIATRIA prende in esame per la pubbli-cazione articoli contenenti argomenti di geriatria. Icontributi possono essere redatti come editoriali, arti-coli originali, review, casi clinici, lettere al direttore.I manoscritti devono essere preparati se guendo rigoro-samente le norme per gli Autori pubblicate di seguito,che sono conformi agli Uniform Re quirements forManu scripts Submitted to Bio medical Editors editi acura del l’Interna tional Committee of Medical JournalEditors (Ann Intern Med 1997; 126: 36-47).Non saranno presi in considerazione gli articoli chenon si uniformano agli standards internazionali.I lavori in lingua italiana o inglese vanno spediti in tri-plice copia (comprendente pagina di titolo, riassunto ininglese, parole chiave in inglese, testo, figure, tabelle,didascalie, bibliografia) con relativo dischetto a:
In caso di invio on-line si prega di salvare il testo inword per Macintosh.L’invio del dattiloscritto sottintende che il lavoro nonsia già stato pubblicato e che, se accettato, non verràpubblicato altrove né integralmente né in parte.Tutto il materiale iconografico deve essere originale.L’iconografia tratta da altre pubblicazioni deve es serecorredata da permesso dell’Editore.La rivista recepisce i principi presentati nella Di -chiarazione di Helsinki e ribadisce che tutte le ricercheche coinvolgano esseri umani siano condotte in confor-mità ad essi.La rivista recepisce altresì gli International Gui dingPrinciples for Biomedical Research Involving Animalsraccomandati dalla WHO e richiede che tutte le ricer-che su animali siano condotte in conformità ad essi.Il lavoro deve essere accompagnato dalla seguentedichiarazione firmata da tutti gli Autori: “I sottoscrittiAutori trasferiscono la proprietà dei diritti di autore allarivista geriatria, nella eventualità che il loro lavorosia pubblicato sulla stessa rivista.Essi dichiarano che l’articolo è originale, non è statoinviato per la pubblicazione ad altra rivista, e non èstato già pubblicato.Essi dichiarano di essere responsabili della ricerca, chehanno progettato e condotto e di aver partecipato allastesura e alla revisione del manoscritto presentato, dicui approvano i contenuti.
Dichiarano inoltre che la ricerca riportata nel loro la -voro è stata eseguita nel rispetto della Dichia ra zione diHelsinki e dei Principi Inter nazionali che regolano laricerca sugli animali”.Gli Autori accettano implicitamente che il lavorovenga sottoposto all’esame del Comitato di Lettura. Incaso di richiesta di modifiche, la nuova versione corret-ta deve essere inviata alla redazione o per posta o pervia e-mail sottolineando ed evidenziando le parti modi-ficate. La correzione delle bozze di stampa dovrà esse-re limitata alla semplice revisione tipografica; eventua-li modificazioni del testo saranno addebitate agliAutori. Le bozze corrette dovranno essere rispediteentro 10 giorni a ge riatria - c.e.S.I. - Casa EditriceScientifica Inter na zionale, Via Cremona, 19 - 00161Roma. In caso di ritardo, la Re dazione della rivistapotrà correggere d’ufficio le bozze in base all’origina-le pervenuto.I moduli per la richiesta di estratti vengono inviati in -sieme alle bozze.
Gli articoli scientifici
possono essere redatti nelle seguenti forme:
editoriale. Su invito del Direttore, deve riguardare unargomento di grande rilevanza in cui l’Auto re esprimela sua opinione personale. Sono am messe 10 pagine ditesto dattiloscritto e 50 citazioni bibliografiche.
articolo originale. Deve portare un contributo origi-nale all’argomento trattato. Sono ammesse 14 paginedi testo dattiloscritto e 80 citazioni bibliografiche.L’articolo deve essere suddiviso nelle sezioni: introdu-zione, materiali e metodi, risultati, discussione, conclu-sioni.Nell’introduzione sintetizzare chiaramente lo sco podel lo studio. Nella sezione materiali e metodi descrive-re in sequenza logica come è stato impostato e portatoavanti lo studio, come sono stati a naliz zati i dati (qualeipotesi è stata testata, tipo di indagine condotta, come èstata fatta la randomizzazione, come sono stati recluta-ti e scelti i soggetti, fornire dettagli accurati sulle carat-teristiche essenziali del trattamento, sui materiali utiliz-zati, sui dosaggi di farmaci, sulle apparecchiature noncomuni, sul metodo stilistico...). Nella sezione dei ri -sultati dare le risposte alle domande poste nel l’in tro -duzione. I risultati devono essere presentati in modocompleto, chiaro, conciso eventualmente correlati difigure, grafici e tabelle.Nella sezione discussione riassumere i risultati princi-pali, analizzare criticamente i metodi utilizzati, con-frontare i risultati ottenuti con gli altri dati della lette-ratura, discutere le implicazioni dei risultati.
review. Deve trattare un argomento di attualità ed
norme per glI autorI
geriatria - c.e.S.I. - casa editrice Scientifica
Internazionale
Via Cremona, 19 - 00161 Roma
Tel. 06 44241343-44290783 Fax. 06 44241598
www.cesiedizioni.com

interesse, presentare lo stato delle conoscenze sull’ar-gomento, analizzare le differenti opinioni sul problematrattato, essere aggiornato con gli ultimi dati della let-teratura. Sono ammesse 25 pagine di testo dattiloscrit-to e 100 citazioni bibliografiche.
caso clinico. Descrizioni di casi clinici di particolareinteresse. Sono ammesse 8 pagine di testo e 30 citazio-ni bibliografiche. L’articolo deve essere suddiviso nel -le sezioni: introduzione, caso clinico, discussione, con-clusioni.
preparazione dei lavoriI lavori inviati devono essere dattiloscritti con spaziodue, su una sola facciata (circa 28 righe per pagina) econ margini laterali di circa 3 cm. Gli Autori devonoinviare 3 copie complete del lavoro (un originale e duefotocopie) e conservare una copia dal momento che idattiloscritti non verranno restituiti. Le pagine vannonumerate progressivamente: la pagina 1 deve contene-re il titolo del lavoro; nome e cognome degli Autori;l’istituzione ove il lavoro è stato eseguito; nome, indi-rizzo completo di C.A.P. e telefono dell’Autore alquale dovrà essere inviata ogni corrispondenza.Nella pagina 2 e seguenti devono comparire un rias-sunto e le parole chiave in inglese; il riassunto deveessere al massimo di 150 parole.Nelle pagine successive il testo del manoscritto dovràessere così suddiviso:Introduzione, breve ma esauriente nel giustificare loscopo del lavoro.materiali e metodi di studio: qualora questi ultimirisultino nuovi o poco noti vanno descritti dettagliata-mente.risultati.discussione.conclusioni.Bibliografia: le voci bibliografiche vanno elencate enumerate nell’ordine in cui compaiono nel testo e com-pilate nel seguente modo: cognome e iniziali dei nomidegli Autori in maiuscolo, titolo completo del lavoro inlingua originale, nome abbreviato della Rivista comeriportato nell’Index Medicus, anno, numero del volu-
me, pagina iniziale e finale. Dei libri citati si deve indi-care cognome e iniziali del nome dell’Autore (o degliAu tori), titolo per esteso, nome e città dell’editore,anno, volume, pagina iniziale e finale.tabelle: vanno dattiloscritte su fogli separati e devonoessere contraddistinte da un numero arabo (con riferi-mento dello stesso nel testo), un titolo breve ed u nachiara e concisa didascalia.didascalie delle illustrazioni: devono essere prepara-te su fogli separati e numerate con numeri arabi corri-spondenti alle figure cui si riferiscono; devono conte-nere anche la spiegazione di eventuali simboli, frecce,numeri o lettere che identificano parti delle illustrazio-ni stesse.Illustrazioni: tutte le illustrazioni devono recar scrittosul retro, il numero arabo con cui vengono menzionatenel testo, il cognome del primo Autore ed una frecciaindicante la parte alta della figura. I disegni ed i grafici devono essere eseguiti in nero sufondo bianco o stampati su carta lucida ed avere unabase minima di 11 cm per un’altezza massima di 16cm.Le fotografie devono essere nitide e ben contrastate.Le illustrazioni non idonee alla pubblicazione sa rannorifatte a cura dell’Editore e le spese sostenute sa rannoa carico dell’Autore.I lavori accettati per la pubblicazione diventano di pro-prietà esclusiva della Casa editrice della Rivista e nonpotranno essere pubblicati altrove senza il permessoscritto dell’Editore.I lavori vengono accettati alla condizione che non sianostati precedentemente pubblicati.Gli Autori dovranno indicare sull’apposita scheda, chesarà loro inviata insieme alle bozze da correggere, ilnumero degli estratti che intendono ricevere e ciò avràvalore di contratto vincolante agli effetti di legge.Gli articoli pubblicati su gerIatrIa sono redattisotto la responsabilità degli Autori.
N.B.: I lavori possono essere inviati via e-maila [email protected] oppure perposta su cd o pen drive salvati in word.
202 Geriatria 2013 Vol. XXV; n. 4 Luglio/Agosto

ANNUNCIO
PRIMO
4° CorSo NazioNale di aGGiorNaMeNto
Cardiologia dello Sport 2014Problemi emergenti, certezze vacillanti:
la difficile ricerca della “verità”
in Cardiologia dello Sport
7-8 Marzo 20147-8 Marzo 2014
Grand Hotel Salerno
Segreteria OrganizzativaCONGRESS LINE
Via cremona, 19 – 00161 roma
tel. 06.44.29.07.83 - 06.44.241.343 Fax 06.44.24.15.98
e-mail: [email protected]

Massimo Marci Stefano Maria Zuccaro
LA TERAPIAANTICOAGULANTE
Vecchie certezze e nuove prospettive
Casa Editrice Scientifica Internazionale
per ordini spedire a c.e.S.I. - Via cremona, 19 • 00161 roma
Volume in brossura Edizione 2013 140 pagine circa E 25,00
Cognome ....................................…….......... Nome ……………………… Tel. ………………………………………………
Via .........................................................……………… CAP …………… Città ………………………………………………Firma .................................………………….... Contributo fisso spese imballo e spediz E 3,00 TOTALE E ..............……...........
■ Anticipato a mezzo Assegno Bancario (non trasfer.) allegato intestato a CESI ■ A mezzo vers. C/C N. 52181005 intestato a CESI ■ American Express (c/c N. ………………… Validità ……………… Firma ………………………………………………)
Per ordini telefonici 06.44.290.783 - 06.44.241.343 Fax 06.44.241.598 Via Cremona, 19 - 00161 Roma
Partita IVA ........................................................ (solo per chi desidera la fattura)
■■ Sì, desidero ricevere la terapIa antIcoagulante al prezzo di E 25,00