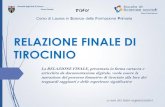Relazione finale Stage
description
Transcript of Relazione finale Stage

POR PUGLIA 2000 – 2006 – Misura 6.4 “Risorse umane e società dell’informazione” - Azione a) approvato con determinazione dirigenziale n° 1117 del 14.12.2006
pubblicata sul BUR Puglia n° 172 del 28.12.2006Cod. Progetto POR 06064aPIT0074
---------------
CORSO DI FORMAZIONE
“MARKETING TERRITORIALE E SVILUPPO LOCALE”STAGE
BOLOGNA 11.05.2008 – 16.05.2008
RELAZIONE FINALE
PROGETTO “FAST”FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO PER IL SISTEMA TARANTO

PROGETTO “FAST”FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO PER IL SISTEMA TARANTO
Il progetto “FAST – Formazione e Accompagnamento per il Sistema Taranto”, è stato finanziato nell’ambito del POR Puglia 2000-2006 – Avviso 11/2006 – Mis 6.4 “Risorse umane e società dell’informazione”.Obiettivo progettuale è stato quello di formare i dipendenti dei comuni appartenenti all’area del PIT n. 6, Taranto, Massafra, Fragagnano, Grottaglie, San Giorgio Jonico e Statte, mettendoli nelle condizione di utilizzare al meglio gli strumenti informatici e le piattaforme telematiche, contribuendo al decollo territoriale in coerenza con le finalità del PIT 6 “valorizzazione territoriale ed intercomunale dell’area”.
Territori del PIT n. 6

Progetto “Fast”Formazione E Accompagnamento Per Il Sistema Taranto
Il Progetto si è articolato in:
1. Attività formative con la realizzazione di n. 15 corsi nelle seguenti aree tematiche:
• Lo sviluppo della società dell’informazione nella pubblica amministrazioneDurata: 96 ore
• Innovazione tecnologica del governo localeDurata: 80 ore
• Contesto legislativo e normativo dell’ICTDurata: 96 ore
• Ruolo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazioneDurata: 96 ore
• Analisi della piattaforma telematica CON.TE.S.T. Durata: 96 ore
• Marketing territoriale e progetti di sviluppo localeDurata: 128 ore di cui 96 ore teoriche e 32 ore di stage
2. Attività non formative con la realizzazione dei seguenti tre laboratori:
• Laboratorio per l’utilizzo della piattaforma telematica CON.TE.S.T. nell’ambito del processo di pianificazione del PIT n. 6
• Laboratorio per la gestione dei contenuti informativi di una piattaforma info-telematica di Marketing territoriale per lo sviluppo locale
• Scambio di buone prassi con i comuni di Bologna, Modena, Carpi e Santarcangelo di Romagna

Lo STAGE
Nell’ambito dell’area tematica di “Marketing territoriale e sviluppo locale”, le due edizioni realizzate hanno visto i corsisti partecipare alle attività di stage in Emilia-Romagna, con il coinvolgimento di alcune delle più significative pubbliche amministrazioni locali che vantano prassi di eccellenza nello sviluppo del territorio. La scelta di prevedere una fase di stage per questa area tematica trova fondamento nella metodologia didattica del training on the job.L’attività di stage è stata concepita come un’opportunità formativa in situazione nel vivo dei rapporti professionali, relazionali, sociali, organizzativi, che caratterizzano il contesto lavorativo attraverso cui sperimentare e confrontare nella realtà concreta del lavoro il proprio ruolo e comprendere l'organizzazione di contesti diversi entro i quali imparare ad apprendere con modalità nuove.Lo stage è stato creato per fare in modo che il corsista si rendesse consapevole della differenza che esiste tra le realtà a confronto, in una situazione la cui finalità formativa è in un contesto lavorativo. Allo stagista sono state riproposte alcune note condizioni tipiche del lavoro durante le quali ha potuto rendersi conto delle proprie capacità e delle proprie carenze.Le fasi di realizzazione dello stage sono state essenzialmente cinque:
1. OsservativaLa fase osservativa è consista essenzialmente nel valutare i comportamenti dei corsisti durante il processo di apprendimento con particolare attenzione alla motivazione alla partecipazione ed ai contenuti.2. InformativaLa fase informativa si è basata sulla presentazione delle finalità e modalità organizzative del progetto. 3. Organizzativa La fase organizzativa è stato il momento in cui il gruppo di coordinamento ha cercato di coinvolgere l’intera aula, compresi quelli privi di motivazione, nella organizzazione pratica delle attività, accogliendo suggerimenti relativi ai contenuti ed alle pubbliche amministrazioni ospitanti da coinvolgere4. OperativaLa fase operativa è stata lo svolgimento dell'attività prevista, quindi la visita presso le amministrazioni individuate.5. Valutativa. La fase valutativa è stata la verifica dei risultati dell'esperienza con una conseguente scheda di valutazione ed una relazione finale conclusiva.

RINGRAZIAMENTI ……….
L’accoglienza degli Amministratori, Dirigenti, e Funzionari, degli Enti e Organismi e Aziende della Regione Emilia Romagna e dei Comuni ospitanti è stata un’esperienza indimenticabile, sia per l’eccellenza della competenza , sia per la capacità relazionale ed emotiva.
Un RINGRAZIAMENTO va a tutto lo staff del progetto, SMILE Puglia ed il CTA Taranto, ed in particolare a Simona NITTI Coordinatrice didattica e Simona NASOLE, tutord’aula, che hanno assunto per questo STAGE, un compito di impostazione metodologica rilevante, a verifica della correttezza del progetto e nel rispetto delle caratteristiche del percorso formativo, assicurandosi serietà e professionalità nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Infine, si ringrazia il Dott. Bruno TIMONCINI e Dott.ssa Morena SARTORI, dell’AECA Bologna (Ente Regionale per la Formazione Regione Emilia Romagna) per la dedizione e l’interessamento, affinché lo svolgimento dello stage si risolvesse con soddisfazione ed entusiasmo. Si ringrazia inoltre, per i Saluti informali il Sindaco COFFERATI e l’ex Presidente del Consiglio PRODI.
Pertanto in ricordo di questa esperienza, a verifica e nel rispetto di quanto previsto dal progetto formativo e del buon andamento dello stage, e stato opportuno redigere una relazione giornaliera per ogni contatto, per monitorare lo sviluppo del modulo stage e per formalizzare l’esperienza è stata prodotta questa fantasiosa Relazione , in modo tale che a futura memoria ciò che si è visto realizzato nella Regione Emilia Romagna possa anche nel nostro Territorio trovare applicazione.
Un arriverderci invece ad i partecipanti che hanno contribuito con le loro esperienze e la loro capacitàcritica a rendere stimolante e significativo lo scambio professionale con i colleghi emilano-romagnoli.
5
Gruppo MT 2 - Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis
Dott.ssa Pasana Maria DeSantisDirezione Gabinetto Sindaco
Dott.ssa Rosalba De VincenzoDirezioni Affari Generali
Sig. Giuseppe TorrettaDirezione Attività Produttive
Dott.ssa Angela LarucciaServizio Statistica
Sig.ra Rosanna TucciServizio Politiche del Lavoro
Dott.ssa Angela MartemucciDirezione Pubblica Istruzione

QUADRO DI INSIEME DELL’ ESPERIENZA
Regione Emilia Romagna
CONSIDERAZIONI
Il POR Puglia 2000 – 2006 – Misura 6.4 “Risorse Umane e Società dell’Informazione” Azione a) nell’ambito del Progetto “FAST Formazione e Accompagnamento per il Sistema Taranto”. ha reso possibile l’esperienza di STAGE (fase indispensabile del percorso formativo), con altre realtà locali Nazionali.
Tali scambi hanno permesso momenti di riflessione e comparazione, per valutare opportunitàdi dialogo/partenariato e cooperazioni, attraverso future tappe delle attività Istituzionali.
l’esperienza di stage vissuta ha incoraggiato le nostre realtà territoriali ad organizzare ampi confronti con differenti Regioni e Istituzioni delle P.A. Nazionali, per un proprio futuro di sviluppo territoriale.
L’idea centrale di tale percorso consiste nel “trasferire ciò che funziona” per far apprendere, “meglio toccar con mano per conoscere” capendo ciò che non funziona, il tutto finalizzato ad una partecipazione alla riflessione, e su come poter applicare un probabile e adeguato “Sviluppo Territoriale”,
Ha così preso forma un essere a contatto con le realtà della Regione Emilia Romagna, raffrontando le attività interessate (Marketing Territoriale), e accettando in merito le proposte di azioni specifiche, per un futuro di miglioramento anche per il nostro territorio.
Tra le attività di punta figurano le realizzazioni di Progetti Finanziati dai Fondi Strutturali, Piani Nazionali e dai Programmi della Commissione Europea.
Con tali Progetti le P.A., sperimentano metodi di Sviluppo Turistico/Economico innovativi, al fine di consentire a soggetti differenti Pubblico/Privati di collaborare tra loro in qualità di cittadini Europei, e di discutere sul futuro del proprio territorio nell’Unione Europea.
Su queste esperienze positive maturate in questi anni, intendono ampliare approfondire il Partenariato e le Cooperazioni, estendendo e rinnovando il loro impegno nei confronti delle azioni intraprese, strutturando una nuova serie di Progetti, della società civile, insistendo in particolare sui giovani, sulle donne, e sulla dimensione locale.
La Regione Emilia Romagna coerente con il Trattato di Lisbona ha rilevato l’importanza cruciale di una maggiore e migliore comunicazione ospitando altre realtà locali per lo scambio di “Buone Prassi”, fornendo informazioni esaustive su metodologie ed Azioni, e ritenendosi disponibili a partecipare a dialoghi permanenti, realizzando Cooperazioni e Partenariati finalizzati al miglioramento delle attività future.
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis
7

Essi, coerenti con la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea “Insieme per comunicare l’Europa”, hanno l’obiettivo globale di rafforzare la coerenza e le sinergie tra le attività portate avanti dalle varie Istituzioni Comunitarie e dagli Stati Membri, in modo da permettere ai Cittadini d’Europa di accedere più agevolmente all’informazione e di comprendere meglio quali ripercussioni abbiano le Politiche dell’Unione Europea sul Piano Europeo, Nazionale e Locale.
Pertanto la loro Strategia futura consiste in un più attento ascolto, una migliore divulgazione e un’azione mirata a livello locale, (il piano saràportato avanti per tutto il 2008 e 2009), e implica come obiettivi centrali di Comunicazione, quella di dar voce a coloro che intendono sostenere un dibattito informato sulle questioni Comunitarie.
La Regione Emilia Romagna, ha inteso puntare a tutto tondo sul “Marketing Territoriale”, sfruttando quelle che sono le caratteristiche peculiari del proprio paese, sapendo ben utilizzare i Fondi Strutturali, Piani Nazionali e Programmi Comunitari e altre provvidenze finanziarie della Commissione Europea, incrementando così l’aspetto storico/turistico/culturale, economico e occupazionale del luogo, senza trascurare un dialogobidirezionale, sia personale che virtuale, tra Attori Locali di Istituzioni Pubbliche e Privati, Pubbliche Locali Regionali e Attori Privati, Istituzioni Pubbliche e Commissione Europea, Cittadini e Istituzioni.
Tale approccio è risultato alquanto vincente e particolarmente utile sia nella fase iniziale, che per l’avvenire del loro territorio. Esso si è rilevato strumento indispensabile per consentire agli Organismi della Società Civile di sperimentare metodi innovativi di coinvolgimento, dando origine ad esperienze più disparate e ad un dibattito sempre più aperto per il futuro dell’Europa.
La pubblicizzazione Virtuale poi, dà voce ad un territorio, accomunando tutti gli aspetti peculiari e tipici del luogo, coinvolgendo Autorità Pubbliche e Pubbliche Locali e Regionali, Organismi, Associazioni, Aziende, Cittadini, Società Civile e Stati Membri. Tutto ciò, per confermare l’importanza di stabilire contatti e per dare “un volto distintivo” al proprio paese.
I Progetti ad oggi da loro realizzati, hanno dimostrato come i Fondi Comunitari, le cooperazioni e partenariati, possano utilmente integrare tutti gli aspetti rappresentativi del luogo, e hanno confermato quanto già emerso da altri tipi di programmi realizzati a favore del territorio, dove tutti gli attori caratteristici del paese, diventano indispensabili per la realizzazione d’esperienze gratificanti, anche sul piano umano e politico.
8
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis
8

DEDUZIONI DEL QUADRO D’INSIEME
I Progetti da loro avviati hanno espresso che gli obiettivi sono raggiungibili in vari modi, ricorrendo:
- alla costruzione di reti Istituzionali, Locali, Regionali, Nazionali, Comunitari;
- alla condivisione di opportunità spartite tra Istituzioni delle P.A. e Organismi Pubblico/Privato;
- alla realizzazione di siti web collegati a reti regionali e nazionali, associati a iniziative di discussione locale, nazionale ed europeo……… perché stabilire collegamenti tra molteplici realtà locali è un loro desiderio unanime, per colmare i divari esistenti tra territori locali, regionali, nazionali e quelli europei. I vari gruppi politici della Regione Emilia Romagna poi, ci credono e sostengono la volontà gestionale, partecipando dinamicamente a tutte le attività che si svolgono in favore del proprio territorio, e adottano una comunicazione bidirezionale che funge da catalizzatore per rafforzare le iniziative lanciate dalla Commissione Europea.
Inoltre hanno compreso che, i progetti di Enti Pubblici a livello Europeo gestiti in cooperazione/partenariato con gruppi eterogenei “Organizzazioni, Università, Organismi di Ricerca, Fondazioni, associazioni, ecc.” sostengono ulteriormente le azioni Comunitarie, consentendo la realizzazione di programmi/piani in tutti i territori Nazionali di qualsiasi appartenenza geografica, agevolando la partecipazione, discussione e divulgazione di tutte le scelte politiche che operano a livello europeo.
Dette cooperazioni beneficiano misure concrete dei regolamenti Comunitari, e confluiscono in attivitàche contribuiscono in maniera decisiva al coinvolgimento di una condivisione/partecipazione e di dialogo permanente schietto e informato. Tra l’altro la Commissione ha dimostrato che le Istituzioni risultano più efficaci quando uniscono le loro forze prendono parte congiuntamente al dialogo fra loro, avendo così l’opportunità di dimostrare la dimensione democratica dell’Unione in tutti i suoi aspetti, il che consente a sua volta ai territori di comprendere meglio il processo decisionale dell’UE.
Tali forme di Cooperazioni Interistituzionali sono incorporati in tutti i Programmi Comunitari.
COME CREARE SINERGIE CON ALTRE REALTÀ LOCALI
Per dare un impulso propulsivo creando sinergie in modo organico e complementare con tutti i programmi della Commissione a favore dei Territori Europei, significa dare un assetto distintivo della propria realtà locale. La dimensione di condivisione - cooperazione e partenariato interistituzionale, politiche/ private e mediatiche , incentivano le specifiche politiche d’insieme, pertanto la partecipazione agli inviti a presentare proposte di finanziamenti Europei, garantiscono ai progetti selezionati valore aggiunto.
9
Gruppo MT 2Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

CITTA’ DI BOLOGNA – MAPPASISTEMAZIONE “SAVHOTEL” BOLOGNA
CALENDARIO STAGE MT 2MARKTING TERRITORIALE E SVILUPPO LOCALE ISTITUZIONI
E COMPETITIVITA’: LO SVILUPPO TERRITORIALE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
CITTA’ DI BOLOGNA – MAPPASISTEMAZIONE “SAVHOTEL” - BOLOGNA
10
10
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

Provincia di Bologna Ass. Politiche del Lavoro12.04.2008
I CIP ( Centri per l’Impiego) e gli Sportelli Comunali del LavoroL’Ultima innovazione di Servizio al Cittadino e alle Imprese consiste nella
Cooperazione tra Enti locali: “Centri per l’Impiego e Sportelli Comunali per il Lavoro” e ufficio inserimento disabili, essi nascono da un forte impegno della Provincia di Bologna e dai Comuni, con l’obiettivo di ampliare sul territorio una rete di Servizi Pubblici, per l’impiego e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli Sportelli Comunali per il Lavoro operano in stretta collaborazione con i Centri per l’Impiego, dedicando particolare attenzione ai temi del lavoro e dell’orientamento professionale, operando per la realizzazione di politiche attive del lavoro attraverso erogazione di servizi finalizzati da un lato ad incrementare l’occupabilità delle persone in cerca di lavoro, e dall’altro a fornire alle imprese servizi adeguati e funzionali di incontro domanda-offerta di lavoro e di supporto alle procedure amministrative.
♦riorganizzazione delle struttureLe sedi dei Centri per l’Impiego, e gli Sportelli Comunali per il Lavoro, operanti
in tutto il territorio provinciale e comunale, sono state ristrutturate e riorganizzate per renderle funzionali ai nuovi compiti secondo gli standard definiti a livello nazionale e regionale.
♦integrazione con i servizi di orientamentoIl passaggio dal collocamento gestito dal Ministero del Lavoro alla Provincia
attraverso i nuovi Centri per l’impiego e gli sportelli comunali per il lavoro e gli uffici inserimento disabili, hanno allargato la base degli utenti sia per quantità che come tipologia: è stato pertanto necessario porre maggiore attenzione ad accogliere, informare e far emergere i bisogni spesso inespressi da parte dei lavoratori.
Tale Progetto si è adottato, utilizzando risorse proprie e risorse del FSE, sono stati ampliati e messi a regime i servizi di base per l’orientamento e i servizi specialistici, che svolgono due funzioni.
- orientamento informativo: produzione, elaborazione e diffusione di materiali informativi sul lavoro e la formazione su supporto cartaceo e informatizzato;
- orientamento formativo: supporto alla persona per aiutarla a definire un suo percorso professionale autonomo, consapevole e ben documentato.
La consulenza di base per i disoccupati, che viene offerta nei Centri per l’Impiego e negli sportelli comunali del lavoro è svolta da operatori interni, mentre i servizi specialistici gestiti dalla Provincia/Comuni, con finanziamenti FSE sono svolti da consulenti esterni.
11

PROVINCIA DI BOLOGNA ASSESS. ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Incontro: del 12.04.2008Dott.Caterina Benni (Dir. Att. Produttive)Dott. Francesca Polluce – dr. Antonio Barresi
ARGOMENTO: EBAN (European Business Angels Network)Per incentivare le Attività Produttive non vi era mai stata la disponibilità di capitali di finanziamento
aventi un buon equilibrio tra rischio e remunerazione, nonché un serio coinvolgimento degli investitori, figurano tra le risorse chiave che permettono ad una azienda di svilupparsi.
Fin dagli anni ottanta, in particolare in Inghilterra ed Olanda, si è potuto constatare che i BusinessAngels (altrimenti detti "investitori privati informali"), giocano un ruolo importante nel senso sopra descritto; essi infatti rivestono un ruolo catalizzatore in materia finanziaria e gestionale e possono stimolare fortemente lo sviluppo delle PMI.
E' sulla base di queste considerazioni che la Commissione Europea ha organizzato a Bruxelles, nel giugno del 1996, la prima Conferenza della rete europea dei Business Angels. Nel 1999, si è costituita EBAN (European Business Angels Network), a cui ha aderito anche l'associazione italiana, IBAN, l'indomani della sua costituzione che è avvenuta il 15 marzo 1999.
Nel maggio 2001 è stata costituita la B.A.N. Bologna, una rete fra investitori informali e imprese improntata sul rapporto fiduciario, con sede a Bologna, affiliata ad IBAN, con l'intento di: contribuire a promuovere lo sviluppo economico della provincia di Bologna e della regione Emilia-Romagna, con particolare attenzione all'introduzione di innovazione nelle PMI, contribuire a promuovere la cultura e gli strumenti del capitale di rischio, contribuire ad elevare la capacità manageriale e la disponibilità di capitali per le start-up e leearly stage.
La B.A.N. Bologna è un’iniziativa coofinanziata dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi della Misura 2.2., Azione A, del Programma Triennale per le Attività Produttive.
Considerando che, lo scenario economico cambia a sostegno di uno sviluppo sostenibile, anche nella Provincia di Bologna questi nuovi bisogni emergenti, vanno individuati e sperimentati in favore di energie rinnovabili. Pertanto le Banche hanno rinnovato il loro impegno per sostenere il tessuto produttivo Provinciale, attraverso l’istituzione di del “Tavolo delle Banche”, fortemente voluto dall’Assessorato delle “Attività Produttive”della Provincia di Bologna, dando nuovo slancio al rapporto tra gli Istituti di Credito e Istituzioni, a sottolineare l’importanza strategica di un sistema che favorisca il dialogo e la sinergia tra i diversi soggetti del Territorio.
12
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

Pianoro, 13.04.2008 Ass. per il Settore Turistico Dott. ssa Egle Teglia
Visita Guidata al ……MUSEO DI ARTI E MESTIERI
Il Museo di Arti e Mestieri studia e raccoglie le testimonianze materiali della passata civiltà contadina e artigianale del territorio delle vallate (Savena, Idice, Setta). La ricostruzione d'ambiente mira a una più immediata comprensione dell'antica realtà socio-economica locale.
La stalla/fienile Gualando, appositamente restaurata dal Comune di Pianoro con Fondi Strutturali, possiede oggetti antichi provenienti da tutta la regione.
Il percorso espositivo è strutturato secondo tre filoni tematici incentrati sulle attività lavorative della donna e dell'uomo.
Nella casa contadina la vita ruotava nella cucina, ambiente in cui si riunivano tutti membri della famiglia, mentre d'inverno ci si radunava a veglia nelle stalle tiepide di calore animale.
La lavorazione del terreno era l'attività fondamentale. In questa sezione sono esposti gli attrezzi per la coltivazione dei prodotti locali, le macchine e i mezzi di trasporto agricolo.
Le antiche botteghe artigiane rivivono all'interno del museo accanto alle attivitàlavorative della casa rurale e agli attrezzi dei mestieri ambulanti.
Il museo offre al piano superiore un'ampia sala dotata di videoproiettore e impianto audio. La sala viene utilizzata per mostre temporanee, riunioni, conferenze.
Vi è un'aula didattica, dotata di computer con collegamento ad internet è a disposizione delle scolaresche in visita. L'aula è utilizzabile anche come laboratorio per dimostrazioni d'uso degli oggetti.
13
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

Incontro: Dott. Stefano Lorenzi Resp. Sviluppo Piano Territoriale
CRONISTORIA DELLA NASCITA DEL «MUSEO DI ARTI E MESTIERI»DI PIANORO
L’idea di un museo della cultura materiale relativa al vissuto del quel Territorio Appennino prese formale avvio nel 2002 con la costituzione, dinanzi al notaio, dell’Associazione «Territorio e Civiltà dei Mestieri». Il sodalizio, promosso da un gruppo di appassionati e finalizzato alla ricerca, recupero e conservazione di strumenti di lavoro e suppellettili in uso nel nostro territorio nella passata civiltà contadina e artigianale, individuò il suo obiettivo primario nella salvaguardia e valorizzazione della straordinaria raccolta di tali oggetti tesaurizzata negli anni dal concittadino Pietro Lazzarini e da lui generosamente destinata al Comune di Pianoro.
Nell’ambito del Piano Particolareggiato del Gualando voluto dal sindaco si giungeva alla designazione del presente stabile, all’epoca stalla-fienile del podere Gualando, come sede architettonicamente ideale del museo.
I lavori di rifinitura e la realizzazione del percorso didattico-espositivo consentivano di procedere all’inaugurazione della polivalente strutturamuseale il 17 marzo del 2007.
Così, grazie alla sollecitudine dell’Amministrazione Comunale e all’impegno dell’Associazione «Territorio e Civiltà dei Mestieri», è oggi a disposizione della collettività un inedito strumento di conoscenza.
14
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

LA COMUNITÀ MONTANA
La Comunità Montana delle Cinque Valli Bolognesi è costituita dalle Valli del Savena, delSambro, del Setta, del Reno e dell'Idice sono situate in uno dei più suggestivi scenari dell'Appennino Bolognese: il territorio ha una bellezza discreta, riservata, quasi nascosta che va conquistata passo dopo passo esplorandone gli angoli più nascosti. Numerose e interessanti le tracce di antiche civiltà che tramandano la loro memoria nelle credenze popolari, nelle sagre paesane, nei mercati o nelle fiere, come nei canti e nelle danze di altri tempi.
Il territorio è un ambiente ideale per un turismo riposante e alternativo: tanti e diversi gli itinerari, ma al visitatore attento tutti risulteranno originali ed entusiasmanti. È sufficiente discostarsi di poco dalle vie di traffico per avere l'emozione di scoperte Essa offre percorsi della memoria, calore e sicurezza delle tradizioni; il paesaggio è come un libro dalle tante pagine: in tutte è possibile leggere l'impegno dell'uomo a mantenere quel disegno che la natura ha magistralmente tracciato.
A piedi, a cavallo o in mountain-bike è possibile immergersi in passeggiate lungo i torrenti o ai bordi di un lago, in un ambiente ancora integro e salutare, per giungere in un'azienda agrituristica o in una trattoria tipica a gustare spuntini biologici o piatti tradizionali. Il verde dei castagneti, delle rive dei torrenti, dei boschi, dei campi seminati dilaga e sull'orizzonte, alzando appena gli occhi, la corona delle montagne, raggiungibili a piedi lungo le antiche mulattiere. Una rete di sentieri, toccando antichi borghi, cappelle, case in sasso, mulini permette di leggere tuttora, la Storia e le storie dell'Appennino.
L'Appennino, fedele alla tradizione, ha mantenuto la semplicità e l'amore per la buona cucina di un tempo nelle piccole trattorie come nei raffinati ristoranti: una cucina di famiglia curata dalla massaia di casa. Tortellini, tagliatelle, sfoglia, sughi, ripieni, salse, brodo tutto è selezionato e cucinato con perizia e meticolosità.
Alla freschezza e genuinità dei prodotti della terra, si aggiungono le carni scelte, i prodotti biologici, gli insaccati, i formaggi, i dolci locali. Gusti e sapori dell'Appennino arricchiscono e completano la cucina bolognese. Ai cibi genuini fanno da corona i vini tipici dei Colli Bolognesi. Cosìesprime l'Appennino la propria ospitalità, accogliendo calorosamente gli ospiti ma ricordando anche modi di vita, tradizioni che affondano le radici in un tempo remoto. Il passato, curato con attenzione, si miscela con il nuovo, mettendo a disposizione tante occasioni di divertimento: canti e balli modernissimi si alternano a stagioni teatrali, rassegne musicali, mostre di grande impegno culturale, rassegne di bande e di cori, folcloristici, musica sacra e musica profana, arte antica e arte moderna.
15
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

Piano di Sviluppo Territoriale
Dott. Stefano Lorenzi Resp. Sviluppo Piano Territoriale
I Comuni che fanno parte del Sistema Turistico Valli Bolognesi sono: castiglione dei pepoli, loiano, monghidoro, monterenzio, monzuno, pianoro, s. benedetto, val di sambro, sasso marconi.
BOZZA CONVENZIONE COMUNITA’ MONTANA “CINQUE VALLI BOLOGNESI”
La convenzione è la realizzazione di progetti atti a favorire la conoscenza e la crescita delle potenzialità culturali presenti nel nostro territorio, garantendo pari opportunità di sviluppo, rispetto al resto del territorio che li circonda, nella salvaguardia e nel rispetto dell'identità culturale e di un patrimonio di tradizioni irrinunciabili.
Per le finalità di cui sopra, i Comuni di Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro,Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro e Sasso Marconi, delegano alla Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi le funzioni di programmazione e di gestione di attività culturali di competenza della pubblica amministrazione con le modalità e nei limiti disciplinati dall’atto di Convenzione.
La gestione associata ha lo scopo di valorizzare le emergenze culturali del territorio della CM, con le sue tradizioni, i suoi contenuti di grande valenza simbolica, le sue dinamiche innovative, di favorirne il suo radicamento e di promuoverne la conoscenza nel resto della Provincia ed anche oltre.
Con il coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio e non solo, hanno costruito una rete relazionale tra le realtà locali e non, allo scopo di alimentare conoscenze, scambi di esperienze, momenti di studio, progettualità comuni, tra quanti operano nel settore della cultura e del turismo.
16
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

17
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

L’ASSOCIAZIONE MONTAGNAMICA DIRETTORE - DOTT. PAOLO CANTO
Associazione MontagnAmica L’Associazione MontagnAmica nasce dalla volontà dei comuni diLoiano, Monzuno e dell’Amministrazione della Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi, nell’intraprendere un interessante ed innovativo progetto di marketing territoriale integrato, che coinvolge soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e dei servizi presenti nel territorio, incentivando le attivitàeconomiche e promuovendo un turismo di qualità ed eco-sostenibile.
Associazione MontagnAmica – ruolo ed obiettivi L’Associazione ha il compito di promuovere e valorizzare il territorio facendo conoscere le attività dei produttori e degli artigiani, definendo i disciplinari e lecertificazioni di qualità dei prodotti tipici e di fare network attraverso eventi e manifestazioni con l’obiettivo dirivitalizzare l’ambiente montano. A riprova del valore della filosofia di MontagnAmica, c’è l’ottimo risultato conseguito con la prima fase operativo/progettuale.
MontagnAmica Servizi Scarl – funzioni operative MontagnaAmica Servizi Scarl è una Societàcomposta da dieci imprenditori agricoli si occupa di produrre, promuovere e commercializzare sul mercato i prodotti tipici – il pane montanaro è il primo esperimento – del territorio. La Scarl ha il pregio di aver concentrato su interessi comuni i componenti di una realtà territoriale altrimenti molto frammentata. Prossimo Progetto sarà“Birra a Doppio Farro”
Obiettivi a breve e medio termine MontagnAmica Servizi Scarl ha operato inizialmente per far conoscere il pane tipico montanaro ed il suo itinerario turistico, attraverso una serie di azioni ed eventi promozionali rivolti sia al publico che alla stampa. L’effettiva commercializzazione del pane montanaro, viene acquistato presso punti vendita convenzionati sia nella comunità montana che a Bologna. Il prodotto in vendita èdotato di un’apposita scheda identificativa che contiene tutte le informazioni sul controllo qualitativo delle fasi di produzione: dalla coltivazione del grano, alla macinatura delle farine, alla cottura, al confezionamento.
La via del Pane "La via del Pane dell'Appennino Bolognese" nasce come progetto speciale dell'Associazione MontagnAmica. Alla base del progetto c’è stata l’idea di recuperare e valorizzare la coltivazione biologica dei cereali diffusa nell’area appenninica bolognese, attraverso la qualificazione dell’intera filiera, dal campo alla tavola.
Oggi si sa che una delle principali motivazioni di turismo è quella a carattere enogastronomico, ossia si va a conoscere un territorio perché è proprio lì che si trova un particolare prodotto alimentare di qualità altrove non reperibile.
18
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

La Sorgente e la fonte di Cà Briscandoli Il Mulino di Pietra è il Mulino Mazzone
La Filiera Cerealicola - il percorso di MONGHIDORO
LA SORGENTE:
L’Alpe di Monghidoro è una zona particolarmente ricca d’acqua, di conseguenza non mancano le fonti che forniscono al viandante punti per dissetarsi. Una di queste sorgenti ha alimentato per anni la “Botte” del mulino di Ca’ di Guglielmo di Sopra. L’acqua, sapientemente utilizzata, successivamente serviva per far funzionare altri tre mulini più in basso e tutti vicini fra di loro (Ca’ di Guglielmo di Sotto).
Sempre in zona poco più in basso, troviamo la fonte di Ca’ di Briscandoli, recentemente ristrutturata come tante altre nel Comune di Monghidoro. La fonte serviva quale punto di approvvigionamento idrico per la borgata. Lì si abbeveravano uomini e bestie. La fonte era anche un luogo di aggregazione, dove le donne si trovavano per lavare i panni e dove sono nate canzoni e storie popolari giunte fino a noi tramandate dalla tradizione orale.
IL MULINO A PIETRA:
Risale al 1785 come riportato nel Catasto Boncompagni con il toponimo pressochè identico all’attuale “Molino dè Mazzoni”, il complesso è composto da abitazione, stalla, locali distinti per ciascuna macina e un ampio portico antistante l’ingresso, costruito nel 1878, come attesta la data incisa sull’architrave. Oltre alle macine alloggiate nel complesso stesso, ne esiste una quinta posta in una minuscola costruzione, un centinaio di metri a valle, sulla sponda sinistra detta “mulinlin”, dove venivano macinate le biade. Recentemente restaurato ed ancora in grado di funzionare, questo mulino presenta tutti gli elementi caratteristici degli opifici della specie.
(l’ultimo mugnaio a tempo pieno)
19
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

20
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

IL FORNO A LEGNA DEL MULINO MAZZONEIl vecchio forno a legna si trova ben inserito
nell’edificio del Mulino. È oggi poco usato ma ancora efficiente. I materiali
utilizzati per la costruzione dei forni erano quelli di più facile reperibilità, i composti isolanti per esempio erano costituiti semplicemente da una miscela di sabbia e cenere che consentivano una cottura uniforme e conservavano il calore più a lungo. Il fondo del forno è costituito da mattoni in pietra
refrattaria che permettano di assorbire l ’umidità del pane ed evitano che la pagnottasi bruci nella parte inferiore. All’interno del forno, la caratteristica volta re èrealizzata con mattoni refrattari è in grado di cuocere circa 12 pagnotte di pane di circa 1 chilogrammo. Scaldato a puntino con “bacchetti” di quercia che
regalano al pane il gusto ed il profumo della montagna.
IL PANE MONTANAROClassico pane casareccio, è tipico delle vallate dell’Appennino Bolognese con l’epicentro produttivo
nei Comuni di Loiano, Monzuno e Monghidoro la farina utilizzata per la produzione di questo pane èprodotta in loco. Il prodotto in questione deriva dall’impasto di farina Biologica di tipo 0 prodotta con cereali ricchi di fibre e proteine, acqua di montagna, un pizzico di sale e un massimo del 2% di lievito di birra e un minimo del 20% di lievito madre o pasta acida, questi ingredienti vengono lavorati fino ad ottenere una pasta dalla consistenza omogenea e abbastanza soda. I pani in commercio hanno una forma leggermente allungata con una spaccatura centrale, la crosta croccante e fragrante. Ciò garantisce un quadro organolettico di sicura piacevolezza nonché una durevole fragranza.
21

14.05.2008 OSTERIA IL FANTORNO
Incontro con Dr. Marino Lorenzini - Sindaco di Monghidoro
Il Sindaco di Monghidoro, persona amabile e ottimista mi ha parlato del suo Programma Politico e così si è espresso: ……. il mio intento è quello di valorizzare Monghidoro, la sua gente, il suo territorio.
Ho sempre lavorato in questa direzione. I molti progetti sviluppati, in cui si caratterizza l’attuale Amministrazione di cui molti andati in porto, ne sono la conferma. Siamo riusciti a portare anche molti finanziamenti dall’esterno (Europei) a conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta. Abbiamo sviluppato molto sul turismo sostenibile legato all’ambiente con la ricostruenda Antica Osteria del Fantorno immersa nel verde del MonteOggioli; il recupero di un vecchio mulino, acquisito dal Comune e restaurato con cura con le macine funzionanti ad acqua dove macinare il grano di montagna per riproporre il Pane di Montagna; il rilancio del Parco e del Camping “La Martina” immerso nel verde del Parco La Martina; la nascita di B&B, Agriturismi e Fattorie Didattiche; il Museo della Civiltà Contadina; la realizzazione della prima Area Artigianale e industriale di Monghidoro; il miglioramento della viabilità tutta; stimolare l’Associazionismo e fornire loro risorse per la loro progettualità; Attraverso la “Tutto Servizi spa” di cui siamo azionisti di maggioranza con cui abbiamo garantitoinnovazione e risparmio e promozione turistica, abbiamo realizzato un centro IAT; la sentieristica, le fontane, il centro storico, l’ampliamento del plesso scolastico, il centro Handicap, il recupero dei monumenti e le nuove iniziative legate alla storia locale, la nuova Caserma dei Carabinieri, la realizzazione di molte strutture per giovani ed anziani; ma soprattutto essere a disposizione dei cittadini per ascoltare i problemi di tutti e promuovere le azioni di cui il territorio ha bisogno.
Queste sono alcune delle principali realizzazioni in cui ci caratterizziamo e a cui abbiamo lavorato e continueremo a lavorare.
22
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

COMUNE DI
MONGHIDORO
23
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

L’AGRITURISMO LA CARTIERA DEI BENENDANTII titolari de “La cartiera dei Benandanti” sono agricoltori da generazioni, vivono
infatti su queste terre da oltre 100 anni.Oggi, grazie al lavoro dei nonni e dei genitori che si sono via via succeduti nelle
attivita' di allevamento e coltivazione, nonche' di custodia del territorio, un'anticofabbricato facente parte di quei poderi e' stato ristrutturato ed adibito ad agriturismo funziona l’ospitalità per tutti coloro che desiderano conoscere queste valli, queste montagne, le genti, il lavoro e le tradizioni.
L'intero complesso aziendale si estende sull'Appennino Tosco-Emiliano nella Valle del fiume Idice. L'azienda agricola, convertita interamente a produzione biologica ( certificata da Suolo salute ), di cui bosco di querce e coltivazioni di orzo, grano, favino ed erba medica.
A 400 metri dall'azienda agricola e sulla riva dal fiume Idice, ristrutturando le parti laterali di un vecchio casale distrutto durante la II° guerra mondiale, è stato ricavato l'agriturismo La Cartiera dei Benandanti. Il nome e' dovuto alla sua antica origine ed utilizzazione; l'edificio fu infatti costruito alla fine del 1500 ed era utilizzato come cartiera, si trasformavano paglia e stracci in carta utilizzando l'acqua e la forza del fiumeIdice; i Benandanti facevano parte dei culti agrari dell'epoca, erano una sorta di stregoni buoni, che girovagavano per le campagne propiziando i raccolti e combattevano ogni sorta di maleficio e stregoneria. Riadattata a casa colonica e' ora agriturismo, in cui vengono offerti alloggio e ristoro.
La principale attività è l'allevamento di bovini da latte per alimentare i quali si utilizzano i foraggi ed i cereali di produzione propria. Vengono allevati anche bovini da carne, che sono venduti direttamente a privati o a macellerie specializzate; durante l'inverno, il taglio del legname di quercia da ardere completa le attività. In azienda ci sono anche altri animali come galline, conigli, cani, gatti e cavalli e il neo arrivato asinello “Ernestino”.
24

LA FILIERA CORTADAL PRODUTTORE AL
CONSUMATORE
25
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

L’AGRITURISMO LA CARTIERA DEI BENENDANTI
26
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

IL CIOFS/FP – IMOLAL’ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTE ZENNARO”IMOLA
Il CIOFS/FP con Sede ad Imola ha maturato in questi anni una consolidata esperienza di tradizione nella realizzazione delle attività formative/orientative rivolti a giovani, e giovani in situazioni di disagio.
Presso questo Istituto immerso nel verde, l’istruzione e la formazione, o meglio ancora la possibilità di apprendere per tutto il corso della vita, sono priorità ineludibili dei nostri tempi, esso rappresenta un nuovo diritto sociale e individuale, che risponde a bisogni che nel tempo sono cambiati, insieme alla società e alla economia.
Tra l’altro l’Emilia Romagna ha ben appreso le politiche dell’Unione Europea, sull’Istruzione e sulla Formazione permanente, che ha rinnovato e rilanciato a LISBONA, attraverso il programma di lavoro “Educazione e Formazione 2010”, dove riconosce nel capitale umano la risorsa più importante per lo Sviluppo dell’Europa.
Dovremmo tutti farne tesoro e capire che è sempre più centrale promuovere una pratica a sostegno di Politiche di Valorizzazione delle risorse umane attraverso la costruzione di interventi formativi mirati, aziendali o settoriali, coinvolgendo tutta la platea dei lavoratori. Un compito primario è quello di rendere esigibile la formazione continua, in orario di lavoro, come diritto di tutti i lavoratori, prevedendo le ricadute dei processi formativi incidenti sull’inquadramento e sul salario professionale, nei percorsi di carriera e come consolidamento del rapporto di lavoro. Garantendo sempre di più l’accesso alla formazione di soggetti a rischio di esclusione, disabili, stranieri, lavoratori svantaggiati.
E necessario mettere a fuoco una Piattaforma Territoriale specifica per formare e sperimentare interventi formativi innovativi, peculiari per quel territorio, in grado di mettere in sinergia la Programmazione Pubblica delle risorse e le altre forme di intervento, in primo luogo quelli legati ai Fondi Comunitari per la Formazione continua.
27
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

Il 14.05.2008 - UNA GIORNATA NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTE ZENNARO” IMOLA
Tema. Politiche per l’Istruzione e la Formazione Centro CIOFS di Imola - Dott.ssa Vita SCARANO
28
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

In un pomeriggio bello e soleggiato i 6 dipendenti fuori dal Comune sono andati alla scoperta di Imola, attraverso la storia, la cultura, i personaggi e luoghi, con il Tutoraggio del sapiente Dott. BrunoTimoncini che con dovizia di particolari sfiziosi, ha raccontato aneddoti della storia della città, del territorio, dei sapori e delle tradizioni.
IMOLA, l’antica colonia romana, sorgeva in un area già intensamente popolata in etàpreistorica, come testimoniano l’insediamento dell’età del bronzo e la grande necropoli del VI-V secolo a.C. Dopo la decadenza seguita alla fine dell’impero romano e alle invasioni longobarde, la ripresa economica e la riorganizzazione della vita cittadina del secolo X sono preludio ai turbolenti anni medievali scanditi dalle sanguinose lotte per il predominio sul territorio che vedranno Imola opposta a Bologna, Faenza e Ravenna.Nel 1473 la città è in mano a Galeazzo Maria Sforza che la dona in dote alla figlia naturale Caterina, sposa
giovanissima di Girolamo Riario, nipote di Papa Sisto IV.E’ questo periodo particolarmente felice per la città, che conosce una breve ma intensa stagione
rinascimentale; rilevanti interventi ne modificano l’assetto urbanistico e numerosi ed importanti palazzi signorili sorgono ad abbellirla. Nel 1502, Leonardo da Vinci, – giunto a Imola al seguito delle vittoriose truppe di CesareBorgia, – riceve l’incarico di disegnare una pianta di Imola per studiarne le strutture difensive, che rimarràsplendido e unico esempio di lavoro topografico del grande artista.Dal 1504 fino all’unità di Italia, tranne che nel periodo napoleonico, Imola fa parte dello Stato Pontificio: terminano le lotte tra le diverse fazioni e , sotto il governo della chiesa, la città modifica il suo volto grazie ai grandi lavori settecenteschi: viene costruito l’Ospedale civile. Bisognerà aspettare il periodo successivo all’Unitàdi Italia per avere nuovamente interventi così grandi in campo edilizio.
Infatti, sulla scia dei forti fermenti sociali e politici che interessano la Romagna, a Imola si afferma una forte presenza socialista. dovizia
Lo sviluppo dell’associazionismo mutualistico e cooperativo porta allo sviluppo dell’edilizia popolare e alla fondazione della Cooperativa Ceramica, tra le più antiche d’Italia, imprimendo al tessuto sociale ed economico della città un’impronta indelebile e vitale. In un mutato scenario politico, negli anni ’30, è degna di nota la costruzione dei grandi sanatori sulle colline circostanti la città, che insieme ai grandi ospedali psichiatrici cittadini confermano una tradizione ospedaliera antica di quasi mille anni.
Durante il secondo conflitto mondiale, Imola, –– partecipa intensamente alla lotta per la liberazione e viene insignita di medaglia d’oro al valore militare. A partire dagli anni ’50, dotatasi tempestivamente di un piano di ricostruzione, la città inizia ad espandersi con la costruzione dei grandi quartieri periferici e della zona industriale, a testimonianza di un progressivo cambiamento dell’economia cittadina da prevalentemente agricola, ad industriale e terziaria.
29
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

LA FILIERA LUNGA COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA
PRODUZIONE DI PIASTRELLE
30
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

COOP. CERAMICA IMOLA PRODUZIONE ARTISTICA
Il fiore all’occhiello della Cooperativa Ceramica d’Imola è la sezione artistica.Funzionalità degli oggetti e godibilità estetica sono caratteristiche presenti fin dalla prima produzione se è vero che già agli inizi degli anni Ottanta del XIX secolo la Cooperativa Ceramica d’Imola otteneva premi e riconoscimenti in numerosi concorsi e fiere, che furono veicolo per destare l’interesse del mercato nazionale e internazionale.
Anche quando nel 1913 prese avvio la produzione di piastrelle da rivestimento la Sezione Artistica continuò ad operare e a custodire la preziosa eredità artistica della società.
Lungo il corso dei decenni la produzione industriale ha preso il sopravvento, ma èindubbio che il suo successo è dovuto ad una così ricca di storia può vantare un felice connubio di ricerca tecnologica e di cultura, che solo un’azienda così ricca di storia può vantare.
Tra i Direttori Artistici che si sono avvicendati lungo i decenni merita ricordare almeno il primo
…Gaetano LODI, e Domenico MINGANTI, che ebbe tra l’altro il merito, nell’immediato dopoguerra, di portare nella Cooperativa Ceramica d’ Imola Giò Ponti e di offrire all’Architetto milanese, l’esperienza dei ceramisti della Imola per sperimentare il connubio tra Arte e Design che da sempre lo aveva interessato.
Bai, Pomodoro, Hsiao, Chin, Tadini, Tison, sono solo alcuni degli artisti che in questi ultimi tempi hanno collaborato con la Sezione Artistica della Cooperativa Ceramica d’Imola, dando nuovi impulsi, nuove energie, capaci di giungere a settori sempre più vasti di pubblico.
31
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

MUSEO COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA
Il Museo nasce nel 1979, e raccoglie materiale documentale dal 1874 al 1970.
Esso è diviso in tre sale:
Sala degli Autori; La sala degli autori testimonia nei documenti fotografici e d’archivio la nascita e lo sviluppo dell’azienda dal 1874 agli anni ’70. Una serie di tavole con le marche aiutano il visitatore ad individuare, dal punto di vista cronologico, la produzione sia artistica che industriale dell’azienda. Sono in questa sala rappresentati, con le loro opere, i ceramisti più significativi operanti presso l'azienda.
Sala delle Decorazioni; La sala delle decorazioni raccoglie 44 diplomi dalla fine dell’ottocento agli anni ’70. Nelle vetrine la produzione seriale delle decorazioni prodotte dalla sezione artistica dalla fondazione ad oggi. Divise per tipologie, queste maioliche di origine principale settecentesca, testimoniano come la tradizione si sia tramandata inalterata nel tempo. Anche la produzione di carattere popolare èdocumentata con un’ampia raccolta di oggetti bianchi e con un’interessante serie di boccali dalle diverse forme.
Sala degli Artisti Contemporanei. Nella sala degli artisti contemporanei sono esposte opere realizzate da grandi artisti dei nostri tempi presso la sezione artistica di cooperativa ceramica d’imola a partire dal 1981. Questa esperienza di collaborazioni, iniziata in particolare con gli artisti hsiao-chin e remo brindisi a inizio anni ’80, ebbe un felicissimo incremento con l’operazione “artecotta” in collaborazione con lo studio marconi di milano a metà degli anni ’80.
32
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

AECA -BOLOGNA Dr. Bruno TIMONCINI
Con l‘AECA, da trent'anni, nella regione Emilia-Romagna si formano giovani, adulti, donne, stranieri, disabili, persone che intendono crescere sul piano umano e professionale per potenziare e spendere le proprie doti e competenze, con soddisfazione, in un ambiente professionale.
l‘AECA nasce nel 1973 per volontà di enti di formazione professionale accomunati dall'impegno per la promozione di iniziative formative di sviluppo integrale della persona secondo principi di ispirazione cristiana. si tratta di istituzioni che credono nella validità e attualità di una formazione orientata secondo i valori espressi dalla dottrina sociale della chiesa. l'associazione riunisce oggi 24 centri di formazione professionale, molti dei quali hanno un'origine antica.
Essi hanno dimostrato di saper mantenere vivi il pensiero e le idee guida dei fondatori coniugandoli con un continuo lavoro di aggiornamento e rinnovamento. ciò ha consentito loro di essere pronti a rispondere al mutare delle necessità espresse dalle persone e dal contesto nel quale sono attivi. i centri inoltre sono in un collegamento attivo con il mondo produttivo e collaborano con una rete composta da più di mille imprese. I centri dell‘AECA costruiscono insieme ai giovani, alle famiglie, alle persone adulte il percorso formativo più adatto per entrare, restare e crescere nel mondo del lavoro. essi si rivolgono particolarmente a quanti appartengono a fasce deboli che rischiano un'emarginazione sociale oltre
che professionale.
I centri associati condividono la stessa Mission: ciò significa che da sempre, e da trent'anni insieme, credono nell'importanza di lavorare con un progetto educativo integrale per la persona, un progetto capace cioè di considerare accanto alla crescita delle abilità professionali, lo sviluppo dell'insieme delle potenzialità della persona, intrecciando così dimensione etica, culturale e sociale.
33
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

Bologna, 15.05.2008
Le Consigliere Regionali di parità dell’Emilia Romagna hanno inteso fare ricerca sulle discriminazioni di genere nel lavoro con riferimento temporale all’anno 2006-2008 con l’obiettivo di creare un banca dati on line che sia fruibile per tutti coloro - addetti ai lavori e non - che sono interessati alla conoscenza delle varie tipologie di discriminazioni che sono state rilevate nella nostra regione dalle consigliere di parità.
L’intento del progetto è di colmare un gap di conoscenza di dati specifici sulle discriminazioni individuali e collettive subite che debbono essere fonte privilegiata di studio per l’attivazione di politiche di pari opportunità e di progetti di azioni positive mirate.
Inoltre la ricerca consente di approfondire la variegata attività delle consigliere che svolgono anche un prezioso lavoro di consulenza, di informazione in materia di avviamento al lavoro, di trasmissione di conoscenze dei diritti delle donne unitamente ad un’attività di supporto psicologico com’è noto la legge 125/91 ed il d.Lgs 196/2000 e il Dlgs. 11 aprile 2006, n. 198, attribuiscono alle consigliere di parità funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini E donne nel lavoro EE del loro staff al cui front-office può rivolgersi chiunque ritenga di “la vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione fra uomini e donne nel lavoro pubblico E privato e la rilevazione di violazioni della normativa in materia di parità E pari opportunità” (art.1 d.Lgs N.196). I dati quantitativi E qualitativi oggetto della ricercaprovengono da fonti certe e “dirette” ovvero dai dati raccolti grazie alla collaborazione della rete regionale delle consigliere provinciali di parità avere subito discriminazione a vario titolo sui luoghi di lavoro.
REGIONE EMILIA ROMAGNAINCONTRO CON LA CONSIGLIERA DI PARITA’
Dott. Ssa Rosa Maria AMOREVOLE
34
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

La bella esperienza Emiliana ha avuto fine nostro malgrado, e da ciò si èdedotto che: La Regione Emilia Romagna, si trova in una posizione privilegiata perché il suo Sistema Politico ha puntato fortemente alle Provvidenze Finanziarie dei Programmi/ Iniziative Comunitarie , con la partecipazione di tutti gli Organismi Privati del territorio (indispensabile è il sostegno degli sponsor, e delle Banche).
Le reti di Cooperazioni, Partenariati Interistituzionali, Associative e Private, sono diventati per la Regione parte integrante del loro dibattito Politico /Sociale, pertanto una volta realizzati i vari Progetti Pilota intrapresi, la loro sfida consiste, nel garantire una continuità di espansione che assicuri fasi sempre più avanzate di Sviluppo Territoriale.
Essi affermano risultati sempre più virtuosi, alimentando un proseguo di processo progettuale inclusivo, ampliando e trasferendo le loro esperienze attraverso la comunicazione e le buone prassi, innescando un processo di Democrazia Partecipativa, CHE AUTOMATICAMENTE DIVENTA UTILMENTE UNA DEMOCRAZIA
RAPPRESENTATIVA.Bologna, 16.05.2008
35
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis

l’essere umano crede più suoi occhi che alle sue orecchie, quindi insegnare norme e regole è un
lento processo, mentre insegnare con l’esempio èveloce ed efficace.
SENECA
36
Gruppo MT 2 Elaborazione Dott.ssa Pasana Maria Desantis