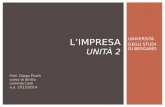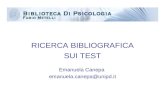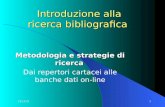Rassegna bibliografica - italia-resistenza.it · A più di un secolo e mezzo dalla sua fonda ... li...
-
Upload
truonghuong -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Rassegna bibliografica - italia-resistenza.it · A più di un secolo e mezzo dalla sua fonda ... li...
Rassegna bibliografica
Scienze mediche nell’Ottocento veneto
Luciana Garibbo
A più di un secolo e mezzo dalla sua fondazione (il centocinquantesimo anniversario è stato infatti celebrato nell’ottobre del 1988) l’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti continua a svolgere con costante presenza il suo antico ruolo di centro di aggregazione culturale che vuole agire in due direzioni: nella dimensione storica indirizzata a fondare una conoscenza critica del proprio passato e a rielaborarne la memoria; nella sollecitazione a continuare quel cammino di presenza nella elaborazione culturale della propria contemporaneità che da quel passato emerge. Questi due aspetti dell’organizzazione della vita culturale acquistano uno specifico significato oggi per l’area veneziana: la loro intersezione infatti centralizza il confronto tra un passato di originalità culturale e potenza politica e un presente fatto di difficile identità culturale e incerta definizione di ruolo economico nel complesso dello sviluppo nazionale.
È vero che la tendenza attuale dell’organizzazione politica o economica è quella di privilegiare l’attenzione sul ruolo che i territori regionali possono assumere all’interno di una dimensione europea piuttosto che nazionale: è un momento quindi di ridefinizione dei ruoli economici e politici, e di recupero delle identità culturali regionali, anche se (e sia detto per inciso) la ricerca di definitivi profili delle identità regionali si sta rivelando sempre più difficile e molto spesso artificiosa e contestabile. Tuttavia in questo con
testo di trasformazione dei ruoli regionali la conoscenza storica del proprio passato può fornire indicazioni fondamentali, e diventa centrale proprio il momento di costituzione dello stato nazionale e l’analisi del modo in cui è stato elaborato l’inserimento delle preesistenti realtà politiche e culturali nella organizzazione territoriale del nuovo Stato: il tipo di relazioni che si sono allora stabilite e il livello di integrazione culturale ed economica successivamente raggiunto contribuiscono a determinare le scelte politiche regionali in questo difficile momento dello stato nazionale.
Da questo insieme di considerazioni è nata l’attenzione che da vari anni non solo i diversi centri di storia locale, ma anche iniziative programmate a livello nazionale, come i volumi pubblicati da Einaudi sulle regioni italiane dopo l’Unità, hanno rivolto alla ri- costruzione del percorso storico che si è sviluppato all’interno delle loro aree culturali dagli ultimi decenni del Settecento a tutto l’Ottocento, superando l’antico pregiudizio metodologico che limitava l’interesse storico locale alla vita degli stati preunitari e ai momenti del loro maggiore splendore, senza argomentare le forme di continuità storica che si ponevano tra quel passato e il loro presente, e i diversi caratteri della nuova identità culturale che si era andata formando. Tanto più che questo lungo corso di anni vive diversi momenti di ‘crisi’ che investono non solo i sistemi di organizzazione politica, so-
Italia contemporanea”, marzo 1992, n. 186
156 Rassegna bibliografica
dale, economica, ma prima di tutto i modelli di conoscenza e i criteri di verità, con quelle due rotture epistemologiche che sono rappresentate daH’illuminismo e dal positivismo, e incidono pertanto sul livello profondo degli orientamenti culturali.
Lungo questo diverso indirizzo degli studi di storia locale — che comunque vuole superare i limiti del localismo nel momento in cui problematizza il rapporto locale-nazionale — si è mosso l’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti avviando un’indagine sui processi di trasformazione che si sono sviluppati nella ‘marca’ veneta successivamente alla fine della repubblica aristocratica, soprattutto per quanto concerne le forme di organizzazione della vita, la sua qualità, le strutture sociali, la capacità delle élite dirigenti di mettersi in contatto con i circuiti della cultura internazionale e di utilizzarli a livello locale.
L’indagine è stata avviata attraverso la ri- costruzione della storia di discipline scientifiche e tecniche di particolare impatto sociale (come medicina, ingegneria, agraria, economia), che permettono di indagare su eventuali mutamenti di mentalità e di atteggiamenti culturali a livello di élite dirigenti con quella maggiore concretezza e possibilità di verifica che gli itinerari del sapere tecnico e scientifico indubbiamente offrono nei confronti delle scelte ideologiche e politiche, nonostante i profondi legami e condizionamenti che sempre si sviluppano tra i due universi di discorso, ma che sono particolarmente forti in quegli anni in cui il significato e l’uso ideologico della scienza molto spesso complica la stessa valutazione della capacità di conoscenza dei nuovi paradigmi scientifici.
La scelta metodologica dell’Istituto veneto nasce dunque da una serie di considerazioni: la presenza di una ormai consolidata tradizione culturale che ha sottolineato l’importanza della dimensione storica della scienza; la centralità che il sapere scientifico
ha assunto nella costituzione della cultura ottocentesca; di conseguenza la maggiore capacità di conoscenza dei meccanismi di organizzazione delle culture locali che questo ampliamento dello spettro di indicatori, su cui verificare persistenze e mutamenti dei percorsi culturali, può offrire, sottolineandone l’andamento non lineare e i modi in cui i nuovi modelli di conoscenza scientifica lentamente concorrono a una modifica della mentalità e a una verifica degli stereotipi presenti anche in altri campi del sapere.
L’istituto Veneto ha avviato questo nuovo percorso di conoscenza della realtà locale con un convegno organizzato a Venezia il 2 dicembre 1989 e di cui è stato pubblicato con molta tempestività il volume degli atti (Aa.Vv., Scienze mediche nel Veneto dell’Ottocento, Atti del primo seminario di storia delle scienze e delle tecniche nell’Ottocento veneto, Venezia, Istituto Veneto di scienze, lettere e arti, 1990, pp. 241, lire 28.000).
Come sottolinea la scheda di presentazione pubblicata nel catalogo delle Novità editoriali dell’istituto nel gennaio 1991, il convengo si è mosso appunto in questa duplice direttiva, di illustrare “da un lato i legami europei degli studi compiuti nel Veneto in quel secolo, e dall’altro una qualche specificità del mondo scientifico e tecnico delle nostre regioni, soprattutto in quei settori che più condizionavano la realtà sociale o che più ne risentivano”.
In relazione a questi scopi della pubblicazione, il modello di analisi scelto dalla maggioranza dei relatori non poteva essere quello di una storia della medicina intradiscipli- nare, ossia tutta interna alla disciplina stessa, ma naturalmente un modello interdisciplinare, attento a rinsaldare “i legami con il portato della riflessione epistemologica e storico-sociale”, come proponeva nel 1984 l’editoriale della rivista “Sanità, Scienza e Storia” . Un modello sostenuto e utilizzato anche da Giorgio Cosmacini nei suoi due
Rassegna bibliografica 157
volumi sulla Storia della medicina in Italia (cfr. il primo volume, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. IX-XVI). Anche se il volume veneziano nel suo complesso denota forse un’enfasi sugli aspetti storico-sociali che va oltre i limiti di attenzione proposti da quel modello.
Attraverso questo schema di analisi, le relazioni presentate al convegno — ovviamente nei limiti imposti da una ricerca ai suoi esordi, ma che comincia ad affrontare un aspetto della vita regionale non indagato nel volume einaudiano su II Veneto (a cura di Silvio Lanaro, in Storia d ’Italia. Le Regioni dall’Unità a oggi, Torino, 1984) — riescono a ricostruire un articolato panorama delle diverse caratteristiche che, a livello scientifico e di intervento sociale, le scienze mediche assumono a contatto con le diverse identità collettive che si sono formate alPinterno del territorio veneto: Passe Venezia-Padova; il territorio che ha il suo centro in Verona; il Trentino; la zona di Trieste, con l’indicazione dei circuiti culturali e delle vie di sviluppo economico da ognuna di esse privilegiati.
Per necessità limiteremo la nostra attenzione alle due aree più interessanti per la storia delle scienze mediche: Passe Venezia- Padova e l’ambiente veronese.
L’asse Venezia-Padova, sede del potere politico e centro culturale della regione non solo per la presenza delle due università, è anche l’area di maggiore interesse per una definizione del rapporto tra scienze mediche e politica, e per una ricostruzione della diffusione dei nuovi statuti scientifici e del dibattito che attorno a essi si sviluppa.
Carlo Maccagni attraverso la figura di Francesco Aglietti, medico, divulgatore scientifico, editore, consigliere e protomedico del governo di Venezia, che opera nella città lagunare tra il 1780 e il 1830, ricostruisce il convulso periodo storico che la repubblica vive in questo corso di anni e i riflessi che le vicende politiche hanno sulla organizzazione degli studi medici nell’università di
Padova. Sull’ordinamento degli studi nella sede padovana il governo veneziano era già in precedenza intervenuto per “portarla al passo con i tempi e soprattutto per renderne gli insegnamenti più rispondenti alle esigenze dello Stato stesso” (p. 156). Vi si riflettono successivamente le diverse politiche mediche e sanitarie diffuse dai francesi e dagli austriaci, ma senza che “a Padova e a Venezia [...] si riscontrino quelle ventate innovatrici che hanno luogo a Pavia e a Milano” (p. 158).
Oltre alle sedi universitarie, importanti centri di aggregazione della cultura medica a Venezia sono il “Giornale per servire alla storia ragionata della medicina di questo secolo”, di cui Aglietti inizia le pubblicazioni nel 1783, e ancora la Società di medicina, fondata nel 1783, ma successivamente guardata con sospetto dalla polizia austriaca proprio per la presenza, tra i suoi membri, di Aglietti, che durante il governo provvisorio aveva manifestato il proprio entusiasmo per le idee di Francia (e su cui cfr. anche Umberto Corsini, Pro e contro le idee di Francia, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1990, p. 35).
Tutte queste istituzioni, a cui naturalmente si affianca lo stesso Istituto veneto, aprono circuiti di scambio internazionale e diventano sede per la diffusione di nuovi indirizzi metodologici e per una riflessione critica su di essi e più in generale sui compiti della medicina, sulla definizione del ruolo professionale del medico, sull’importanza che una storia della medicina può assumere come retroterra su cui verificare le scelte del presente. Si evidenzia dunque un assetto organizzativo che favorisce il coagularsi di una tradizione culturale locale.
Al dibattito che si apre nel Veneto sul “sistema di Brown” è dedicata la relazione di Giancarlo Zanier {La medicina browniana nel Veneto, pp. 31-60): la teoria di Brown si diffonde in Italia con l’arrivo dei francesi soprattutto nel triennio 1796-1799 e diventa
158 Rassegna bibliografica
un momento centrale per la definizione del rapporto tra paradigmi scientifici e ideologie politiche che in quegli anni si va stabilendo, ma anche del modo in cui si procede alla verifica della logica epistemologica interna ai nuovi paradigmi.
Secondo Cosmacini l’idea di medicina di Brown è quella che “rompe col passato” e le sue opere “costituiscono una nuova dottrina sistematica che prospetta [...] tesi riformatrici altrettanto radicali quanto le istanze giacobine di rivoluzione politica” (Storia della medicina, cit., vol. I, pp. 257 sgg.). La nuova dottrina dunque entra in Italia con precisi referenti politici, indicati non solo dal collegamento esterno con le élite giacobine, ma dalla struttura profonda del suo modo di pensare in medicina. Esso si riallaccia alla struttura del pensiero illuminista e ha i caratteri di quel giacobinismo scientifico che Cosmacini individua nelle sue “istanze di onnicomprensione sistematica, di rinnovamento ab imis fundamentis, di razionalità deificata, di salute pubblica garantita”, oltre che nel suo impianto empirista (cfr. G. Cosmacini, Teorie e prassi mediche tra Rivoluzione e Restaurazione: dall’ideologia giacobina all’ideologia del primato, in Storia d ’Italia, Annali, 7, Malattia e medicina, Torino, Einaudi, 1984, p. 159).
Il brownianismo è accolto con entusiasmo all’università di Pavia: l’adesione al giacobinismo culturale e politico di molti docenti e studenti predispone a una accettazione incondizionata della nuova dottrina, assumendola come “un modello per pensare e per agire in ogni campo” (ivi, p. 158), senza una verifica di scientificità dei suoi canoni epistemologici.
Diversi sono i termini del dibattito che si sviluppa nell’ambiente veneto e che vengono pubblicizzati da una lunga serie di interventi che appaiono sul “Giornale per servire alla storia ragionata della medicina di questo secolo”: le prime memorie dedicate al brownianismo sono infatti di condanna al sistema
per la connotazione di “smascherato materialista” del medico scozzese (G. Zanier, La medicina browniana nel Veneto, cit. p. 36). È dunque una condanna che nasce dalle im- plicanze politiche, filosofiche, religiose del sistema. Ma lentamente l’atteggiamento del giornale cambia, e l’attenzione si sposta su una riflessione critica sulla scientificità della teoria e sulla sua applicabilità pratica. Il carattere di novità della teoria consisteva nel suo configurarsi “a tutta prima come tentativo di riportare i fenomeni vitali a un unico principio, equivalente nel mondo organico all’attrazione newtoniana [...]. Tale principio è l’eccitabilità” : la vita consiste nella “reazione della sostanza midollare dei nervi e del solido muscolare” a forze eccitanti esterne (ivi, pp. 31-32). Il principio di eccitabilità diventa per Brown “una legge universale di fatto” evidente, che pertanto non necessita di verifica e di dimostrazione: proprio in questo consiste il suo carattere di scienza mal fondata, di ideologia scientifica (cfr. G. Cosmacini, Teorie e prassi mediche tra Rivoluzione e Restaurazione, cit., p. 156).
Il dibattito che si svolge sul giornale veneziano non arriva a evidenziare questo limite epistemologico del brownianismo: ma avvia una riflessione molto attenta ed equilibrata, che se da un lato sottolinea “l’abuso di proposizioni astratte e generali” presente nel ragionamento del medico scozzese, dall’altro sottolinea la necessità di sottoporlo a verifica, di ripensarlo, di vedere che cosa sia utilizzabile per far fronte all’esigenza imperativa di rinnovare la medicina: questo insieme di polemiche, di ricerche empiriche, di rielaborazioni che accompagnano la lunga disamina del brownianismo diventa una documentazione importante del modo in cui, sul piano epistemologico e culturale, lentamente si cerca di gettare un ponte tra rivoluzione e tradizione.
La relazione con cui Maria Laura Soppel- sa illustra la “originale operazione di stori-
Rassegna bibliografica 159
cizzazione linguistico-antropologica” condotta da Paolo Marzolo (Paolo Marzolo e le “parole-medaglie” della medicina) introduce un altro carattere specifico della cultura scientifica veneta, cioè la sua attenzione per la storia della scienza. Afferma infatti Marzolo nel 1857 (in clima di positivismo già affermato), presentando all’Istituto veneto la sua memoria Parole-medaglia della medicina: “la storia delle scienze, costituendo quella del rapporto oggettivo dell’umana soggettività è indispensabile per le scienze stesse: la cognizione del modo in cui si ottiene il sapere ne fa già una parte integrante” (ivi, p. 129).
L’attenzione per la storia della medicina è però soprattutto presente a Verona, dove peraltro la diffusione di un indirizzo storico-critico (seppure in campo economico) è sostenuta anche dalla scuola di Angelo Messedaglia. Sottolinea infatti Luciano Bo- nuzzi (Figure ed itinerari della medicina veronese): “Scrive l’economista Angelo Messedaglia: ‘Siamo in un’età che può ben dirsi, fra tutte, ed eminentemente, un’età scientifica’. E più oltre nota come la ricerca
scientifica moderna, sintetizzando il sapere di tutti i tempi, esiga rispetto al passato ‘un istinto di più: il senso e l’istinto storico’” (P -71).
È sostenitore a Verona dell’importanza della storia della medicina, anche con “compiti di verifica metodologica e riflessione critica sugli aspetti civili che condizionano la salute” (p. 67), Giuseppe Cervetto, per il quale, riassume Bonuzzi, “Tutto il sapere dell’uomo è riducibile in una dimensione storica che appare quanto mai utile nell’ambito delle scienze mediche per individuare le direttive di sviluppo del sapere, per mettere a disposizione degli studiosi la bibliografia, per illuminare gli errori, per mettere ordine nella monteplicità degli approcci e delle osservazioni, per confrontare il progresso della medicina con quello delle altre scienze, in modo da poter lavorare, con le strategie più evidenti, alla costruzione del benessere sociale” (p. 68).
Un’indicazione semplice, forse, ma efficace per definire il rapporto tra scienza e storia.
Luciana Garibbo
Donne intellettuab fra Otto e Novecento Le figlie di Cesare Lombroso
Simonetta Soldani
A essere scrutata in queste pagine scritte in punta di penna (Delfina Dolza, Essere figlie di Lombroso. Due donne intellettuali tra ’800 e ’900, Milano, Angeli, 1990, pp. 263, lire 30.000) è la storia di due vite gemelle, o meglio della contraddizione che costituì la trama dell’una e dell’altra, e che nasceva dall’intenso esercizio dell’attività intellettuale come professione da parte di donne attivamente partecipi di una cultura per la quale
l’inferiorità biologica della mente femminile era da considerarsi un dato scientifico inconfutabile, e ogni deviazione dal comportamento medio statisticamente accertato da condannare in quanto fonte inevitabile di disordine individuale e sociale. Costruire, su queste basi, un’immagine di sé come donne intellettuali che non costringesse a mettere in discussione o ad avvertire come conflittuali i due termini in cui si articolava la propria
160 Rassegna bibliografica
personalità non era certo agevole: e il problema acquista una rilevanza del tutto particolare ove si consideri che in Italia gli anni del consolidamento del positivismo a livello di opinione pubblica media furono anche quelli dell’ingresso relativamente massiccio— e comunque molto più intenso e diversificato che in qualunque altro periodo della storia — di donne nelle professioni intellettuali e nella sfera pubblica.
Delfina Dolza è attenta a non imboccare la strada sin troppo facile del crucifige femminista alla cultura positivista. Il suo invito a guardare al di là del florilegio antifemminile in cui resta per lo più pietrificato ogni riferimento al binomio donna/positivismo è sacrosanto, così come il richiamo a considerare con maggior attenzione le “circostanze concrete” in cui prese forma quel “progetto culturale complessivo” , gli ambiti disciplina- ri, i temi e i centri in cui si articolò, gli intellettuali grandi e medi che in esso si riconobbero e che ne trasmisero valori e miti a intere generazioni di “operatori culturali” (p. 15), vale a dire al tessuto di professionisti che, nei diversi settori, costituì uno dei frutti più significativi dell’Italia umbertina e gio- littiana e che ne modellò il volto. In tal modo, l’autrice mostra di aver fatto tesoro di rivisitazioni recenti, sia generali che mirate— si pensi ai saggi compresi in II positivismo e la cultura italiana (a cura di Emilio Papa, Milano, Angeli, 1985) o alla mostra torinese su La scienza e la colpa: crimini, criminali, criminologi, un volto dell’Ottocento (a cura di Umberto Levra, Milano, Electa, 1985) — e di saper mettere a frutto il loro apporto. Di qui l’attenzione prestata alle prospettive nuove che il positivismo aprì grazie alla sua insistenza sul peso dei condizionamenti sociali, sulla necessità che ogni essere umano potesse esprimere il meglio di sé. Di qui, anche, i rapidi ma fermi richiami alle benefiche ricadute, dirette e indirette, che la sua dichiarata volontà “di rompere con una tradizione di conformismo conser
vatore” e di legare l’impegno culturale “ad un’autentica apertura democratica” (p. 21) ebbe anche sul versante della condizione femminile.
Talvolta, peraltro, si ha l’impressione che l’autrice finisca col cadere nell’eccesso opposto. Così, se è vero che l’idea dell’attività intellettuale come esplicitazione di un “impegno” a operare per il bene collettivo propugnata dal positivismo permetteva di considerarla una modalità nuova e privilegiata di intervento nel sociale, e dunque di spostarla verso una dimensione che le più diverse culture accreditavano come passibile di una forte presenza femminile, non si può dimenticare che quell’idea si legava alla convinta sottolineatura del diritto-dovere dell’intellettuale a un ruolo pubblico forte, dotato di precise responsabilità e valenze politiche che anche il positivismo contribuì a confermare come estraneo, prima che vietato, alle donne. Più in generale, è difficile non avvertire una sostanziale sottovalutazione dell’incidenza negativa che ebbe sul processo di emancipazione femminile in corso il coacervo di ideologismi elaborati dal positivismo o indotti dalle sue affermazioni in tema di natura e ruolo della donna: una donna che proprio allora vide ribadite e aggravate, in base ad argomentazioni ‘scientifiche’, preclusioni ed esclusioni tradizionali, e gerarchie tanto consolidate da apparire ed essere proclamate naturali, e per ciò stesso immodificabili, come — sia pure con qualche rigidità di troppo — ha ricordato Giovanni Landucci in un contributo su I positivisti e la “servitù” della donna (in L ’educazione delle donne, a cura di Simonetta Sol- dani, Milano, Angeli, 1989, recensito in “Italia contemporanea”, 1991, pp. 531-532). Di qui, anche, un giudizio che tende ad attribuire la difficoltà delle sorelle Lombroso di pensarsi come donne intellettuali, e la loro tendenziale riduzione della donna alla funzione materna, più al peso che poterono avere condizionamenti familiari e d’ambien
Rassegna bibliografica 161
te su persone dotate di “un’identità femminile ancora in larga parte debitrice di valori tradizionali” (p. 237) che non alla cultura positivista: la stessa, appunto, che forniva il quadro di riferimento e l’intelaiatura di sostegno alla loro militanza intellettuale, ora fiera e orgogliosa, ora incerta e travagliata, ma comunque molto importante nei loro equilibri e nelle loro prospettive di vita: senza dubbio più di quanto esse fossero disposte ad ammettere e a riconoscere.
Del resto, l’autrice preferisce non indugiare su tematiche così generali, e se vi fa riferimento è solo in un’ottica strettamente funzionale al filo rosso della sua ricerca, nel timore — si direbbe — di incappare nei rischi opposti e simmetrici della riduzione della biografia a pretesto per uno studio d’ambiente e di contesto, o per una esaltazione della centralità del biografato nel processo storico: un timore tanto più comprensibile se si tiene conto della natura duale del soggetto e dei tratti delle figure di cui esso si compone, lontane dall’eccezionaiità ma anche dall’anonimato, e quindi tale da richiedere un registro capace di cogliere i difficili e precari equilibri che di volta in volta si istituiscono fra condizionamenti e scelte, fra caratteri individuali e contesti familiari, culturali, sociali. Ma la biografia è un genere tanto seducente quanto insidioso, come non mancava di ricordare alcuni anni or sono Lawrence Stone in un saggio molto discusso e subito tradotto che pure ne rilanciava l’importanza e il valore (Riflessioni sulla storia: il ritorno alla narrazione, “Comunità” , 1981, n. 183). In qualche modo, infatti, la biografia reca iscritto nel proprio codice genetico il modello delle vite illustri ed esemplari della grande tradizione classica e cristiana, dove il protagonismo onnivoro e irripetibile dei ‘grandi della storia’ trascolora senza soluzione di continuità in galleria di vizi e di virtù, di situazioni e di comportamenti proposti come tipici, e dunque ‘ri- producibili’. Su questioni cruciali come
quelle del “rapporto tra biografia e storia generale, tra biografia come studio dell’individualità o del ‘tipo’” non pare davvero agevole trovare un denominatore comune di qualche solidità, come hanno dimostrato anche riflessioni recenti (cfr. ad esempio Bibliografia e storiografia, a cura di Alceo Riosa, Milano, Angeli, 1985: la citazione è da p. 7). Ed è del tutto evidente che, quando dalle vette supreme si scende ai livelli intermedi, rifiutare il piano della “capacità di rappresentanza” significa precludersi una legittimità e una ragione di interesse già pronte all’uso, e prepararsi a costruirne altre ex novo.
Nel caso specifico all’autrice preme precisare di non avere nessuna intenzione di proporre la biografia delle protagoniste in quanto “esemplare di quelle innumerevoli sorti individuali” che potevano per molti aspetti apparentarsi a quelle prese in esame, secondo la chiave proposta da Ippolito Nie- vo per giustificare “l’esposizione de’ casi suoi” e ripresa da Tommaso Detti per dar conto della Vita di un medico socialista come Fabrizio Maffi, allo stesso tempo eccezionale e significativa delle esperienze e degli ideali di una intera generazione. La ricerca, anzi, rifugge dal presentare come tipica di un clima e di un’epoca la vicenda trattata, per concentrarsi piuttosto sul caso specifico a cui il titolo allude, e cioè sulla tormentata e incerta conquista di un’identità di intellettuali di professione da parte delle due figlie di Cesare Lombroso, Paola e Gina, profondamente segnate dalla forte personalità di un padre entusiasta e pervasi- vo, e dalle idee di quell’ala cruciale e militante del positivismo italiano che ebbe nel fondatore dell’antropologia criminale un protagonista e un portavoce di straordinaria fortuna ed efficacia: segnate a tal punto da non riuscire, di fatto, a concepire sé e la propria esistenza al di fuori di quello specifico quadro di riferimento, e da cercare in ogni modo di ritagliarsi spazi e ruoli di atti
162 Rassegna bibliografica
vità come donne intellettuali a partire da una concezione (pienamente condivisa, anche se con accenti diversi, dall’una e dall’altra) strutturalmente limitativa delle possibilità teoriche e pratiche di farlo da parte di individui di sesso femminile. Il fatto stesso che tutte e due sposassero non solo degli intellettuali di grande prestigio, ma degli studiosi che il padre aveva eletto a propri allievi e collaboratori — Mario Carrara la prima, Guglielmo Ferrerò la seconda — ribadisce la centralità del problema e dell’impronta paterna, al di là del modo diverso di vivere un evento che costituì, se non una cesura, certo una scansione fondamentale nell’esistenza delle due sorelle.
Fedele a un’impostazione che privilegia nettamente la dimensione privata e psicologica delle dinamiche di vita prese in esame, Dolza sembra infatti suggerire che la matrice delle divaricazioni crescenti che sono riscontrabili nelle problematiche e nelle direttrici di lavoro delle sorelle Lombroso a partire dal matrimonio sia da cercare nel modo diverso in cui esso fu vissuto — anche in rapporto al diverso rapporto col padre —, e nelle reazioni che innescò. Alla gioiosa corsa di Paola fuori dalla casa e dall’ingombrante tutela paterna, all’“intimo profondo senso di affinità interiore” (p. 96) che essa affermava di provare nei confronti del marito (la cui figura e la cui vita sono qui ri- percorse con partecipata finezza) corrispose infatti il lungo, angoscioso rifiuto dell’altra di distaccarsi dal nido paterno, di accettare la prospettiva del matrimonio, e per di più con un uomo che sembrava ignorare la sua dimensione femminile e che le appariva tanto “grave, ponderato, riservato” (p. 141) da rendere impossibile ogni abbandono.
Essere figlie di Lombroso costituì dunque un privilegio, ma anche un bagaglio oneroso. Per un verso, infatti, quella condizione permise a Paola e Gina di seguire dall’interno il farsi del clima culturale dell’Italia umbertina e le portò a confrontarsi con i gran
di problemi del tempo e con persone abituate a considerarli il centro e il sale della vita. Ma d’altra parte essa propose loro anche inquietanti problemi di autonomia personale e culturale: una autonomia rimasta sempre più precaria — a mio parere — di quanto l’autrice sia disposta ad ammettere. Pesantemente condizionate dalla mancanza di prestigio e di consenso sociale che circondava la figura della femme savante, esse si trovarono per tutta la vita alle prese con una immagine di sé in cui convinzioni e comportamenti faticavano a muoversi su registri compatibili. Ne è un segno l’esigenza (avvertita con diversa intensità dall’una e dall’altra, ma sempre presente) di giustificare e ridefinire a più riprese una scelta di vita non immediatamente riferibile all’“ordine naturale delle cose”, nel tentativo di attenuare l’evidente disarmonia che essa comportava rispetto alla convinta affermazione dell’organica inferiorità intellettuale della donna, e dell’esigenza di uniformarsi, per ridurre il tasso di infelicità, a una “norma” che identificava “nel matrimonio e nella maternità il naturale ambito di realizzazione della donna” (p. 195). Senza dimenticare, d’altronde, che una simile concezione era parte integrante di una vulgata che ottenne grande successo anche presso i settori più progressisti dell’opinione pubblica, di qua e di là dell’Oceano, dall’Inghilterra vittoriana analizzata da Carol Dyhouse e Flavia Ayala agli States della Progressive Era di cui ha parlato di recente Mark Pittenger (“Woman’s Nature” and American Feminist Socialism, 1900-1915, “Radical History Review”, 1989, n. 36). Ciò che differenziava le due sorelle era il modo di spiegare l’origine di quella norma, più legata a tradizioni e convenzioni per Paola, decisamente biologica per Gina, ma accettata da tutte e due e posta a fondamento dell’idea di donna propagata dai loro scritti: intelligenza e cultura hanno senso, in ambito femminile, solo se vengono usate per il benessere e la felicità
Rassegna bibliografica 163
della famiglia, nucleo per eccellenza della società; fuori da quell’ambito, l’unica legittimazione dell’attività intellettuale delle “donne che hanno menti e cuori superiori” può venire — concederà Gina — dalla necessità di “formare i modelli e le tradizioni su cui si fonderanno le altre donne per vivere” (p. 220). Del resto le donne, diligenti e zelanti, sono del tutto incapaci di passione intellettuale e di lavoro teorico; e se studiano “per amor proprio, per “essere notate”, per “primeggiare”, la loro “esclusione sistematica” da studi e professioni maschili è da considerarsi un provvedimento saggio.
Mobile e discreto, l’obiettivo mette a fuoco esperienze, convinzioni, ideologie di cui le scelte delle sorelle Lombroso risultano più o meno consapevolmente intrise: e lo fa incrociando e avvicinando sguardi diversi e lontani, producendo intersezioni, sovrapposizioni e corti circuiti, attraverso un uso accurato e mirato sia degli studi che di un folto materiale documentario, arricchito da fortunate esplorazioni negli archivi familiari. Al centro dell’attenzione sono comunque le fonti più funzionali a una indagine attenta a valorizzare la dimensione privata e psicologica dei percorsi di vita presi in esame, vale a dire le memorie scritte da Paola e Gina per dar conto all’esterno di personaggi ed eventi connessi al “sistema Lombroso” , o più semplicemente per mettere ordine nelle testimonianze opache e sfuggenti di vite intensamente vissute anche sul piano interiore; le corrispondenze, le autobiografie e le biografie dei protagonisti di questa duplice storia di vita; le lettere e le notazioni di amici, di corrispondenti, di persone più o meno illustri che conobbero le sorelle Lombroso e si soffermarono a giudicarne atteggiamenti e comportamenti. Assai poco spazio e rilievo viene invece dato ai contenuti dei loro scritti, così come al retroterra di idee, di ricerche, di polemiche che in essi si riflettevano, perfino quando essi riguardano il tema su cui è imperniata l’intera ricer
ca, e che concerne non solo la condizione, ma la natura femminile.
È il caso, ad esempio, dei molti interventi di Gina sulle caratteristiche della criminalità femminile, sul versante morboso e delittuoso di fantasie e passioni considerate proprie della donna, sui nessi tra psicologia “normale” e deviata, nei quali è facile riconoscere l’onda lunga del suo coinvolgimento giovanile nella elaborazione e nella stesura de La donna delinquente, in qualità di “segretaria mediatrice” fra il padre e il futuro marito: una circostanza che segnala 1’esistenza di un nodo spinoso e irrisolto aperto da quel testo e dalla partecipazione a quella esperienza, fonte di un rovello durato tutta la vita, e a cui invece si allude solo fuggevolmente. E lo spazio dedicato a ricostruire contesti e contributi o a fornire informazioni si riduce ulteriormente quando si esce da quell’ambito. Come accade anche per il grande tema del- l’antindustrialismo e della critica all’idea di progresso a cui pure si dedica particolare attenzione, vista l’importanza che esso riveste non solo per ciascuno dei coniugi Ferrerò, ma per il loro complesso rapporto intellettuale: presente in Gina già sul finir del secolo e da lei riproposto con molta forza in seguito alle esperienze americane del 1907- 1910, quel tema traspariva già, ma solo in modo implicito, nelle riflessioni di Guglielmo Ferrerò su Grandezza e decadenza di Roma e rimase a lungo sommerso nelle sue riflessioni, per esplodere poi negli anni venti e trenta come uno dei fili rossi delle elaborazioni, separate e convergenti, sia dell’uno che dell’altra.
Ancora meno si dice — vista la crescente marginalità del suo interesse per la questione femminile — della produzione di Paola, sempre più immersa, a partire dalla fondazione del “Corriere dei Piccoli” (di cui Dol- za aveva già parlato nel saggio Paola Lombroso e la nascita del “Corriere dei piccoli”, “Storia in Lombardia” , 1990, 2), in iniziative e scritture incentrate sul mondo infantile:
164 Rassegna bibliografica
un mondo amato fin dai primi saggi di scrittura dell’adolescenza — si pensi alle novelle per “Cenerentola”, composte a quindici anni appena — e col quale il colloquio sarebbe continuato intenso per tutta la vita, come stanno a testimoniare le decine di migliaia di copie vendute dalle varie raccolte di storie della “zia Mariù”, che avrebbero continuato a influenzare in modo tutt’altro che trascurabile la sensibilità e la formazione dei bambini italiani anche negli anni in cui chi le aveva scritte era divenuta una “indesiderabile” del regime fascista.
D’altronde, si parli di iniziative e di realizzazioni, di cultura o di politica, di reti familiari o amicali, ogni discorso di contesto e di merito viene ridotto ai minimi termini, col rischio di far perdere spessore e concretezza storica ai temi che vengono via via toccati. Decisa a mantenere ferma la centralità e responsabilità del concreto soggetto storico e del suo agire, l’autrice finisce col delimitare tanto rigidamente territori, temi e orizzonti da far perdere respiro alla ricerca e da attenuarne sensibilmente le potenzialità conoscitive.
Ma la scelta non risulta né del tutto convincente sul piano dell’impostazione, né — soprattutto — pagante sul piano dei risultati. Più volte, leggendo queste pagine sobrie, accade di scoprirsi curiosi proprio delle cose taciute o appena accennate, di notizie relegate in nota e di temi suggeriti dalle bibliografie sommarie degli scritti delle due sorelle e lasciati cadere, di volti ed eventi nascosti nelle pieghe della narrazione.
Penso ai mille accenni, mai sviluppati, sull’ambiente in cui esse crebbero, alle atmosfere e alle cadenze della vita quotidiana di casa Lombroso, tanto simili, nonostante i quarant’anni e passa che separano le due esperienze, a quelle di cui si alimentò il “lessico” ricostruito in pagine memorabili per misura e distaccata passione da Natalia Ginzburg, e maturato sullo stesso terreno: Torino, la comunità ebraica, l’università, la
passione scientifica, il disprezzo per le convenzioni... Tutte realtà di cui la recente ripresa di studi sulla città subalpina ha cominciato a restituirci il volto (penso agli studi di Claudio Pogliano, di Renzo Villa, di Giancarlo Bergami, per esempio, ma anche a un volume come quello dedicato agli Ebrei a Torino, Ricerche per il centenario della sinagoga 1884-1984, Torino, Allemandi, edito nel 1984 in occasione del centenario della sinagoga), e che una diversa tematizzazione avrebbe potuto far emergere con ben altra forza.
Considerazioni analoghe si potrebbero fare in rapporto al modo di presentare la formazione di Paola e di Gina Lombroso. Di essa Dolza tende a sottolineare allo stesso tempo l’eccezionaiità e l’ambiguità: due tratti che sarebbero apparsi assai meno spiccati se, invece di prendere come parametro una fascia di generica media borghesia, si fosse fatto riferimento a quel suo segmento particolare che è l’ambiente accademico e 1’“aristocrazia intellettuale” (p. 43) di cui esso costituiva un polo che proprio in quegli anni veniva notevolmente aumentando il proprio peso specifico. Ragazze piu a loro agio con bozze di stampa e novità librarie che non con serate mondane e figurini di moda erano più numerose di quanto si creda fra le élite colte, laiche e progressiste di quegli anni, tanto convinte dell’importanza di un profondo cambiamento nell’educazione delle donne per promuovere la costruzione di “una società nuova, più libera e giusta” (p. 29) quanto prive di modelli congrui rispetto alla loro sensibilità e poco interessate a soffermarsi sul problema. Una conferma collaterale ma significativa viene dal curricolo di studi seguito dalle due sorelle: familiare e informale nel caso di Paola, collegato alle istituzioni scolastiche quello di Gina, prima ragazza a essere iscritta al liceo classico statale e due volte laureata all’università di Torino, secondo un’alternanza molto frequente in ambienti aperti al nuovo ma so
Rassegna bibliografica 165
stanzialmente alieni dall’attribuire valore programmatico a scelte riguardanti la vita privata.
Semmai, è da osservare che, nel caso specifico, la scelta della scuola pubblica era sollecitata dall’appartenenza alla comunità ebraica, che non disponeva di alternative valide a quel livello sul versante privato: ma l’autrice, pronta a interrogarsi sulle ragioni e sulle ripercussioni individuali del diverso percorso formativo delle due sorelle, non si sofferma su questi retroterra culturali e sociali, limitandosi a notare en passant che anche le cugine Debenedetti furono in quegli anni regolarmente iscritte all’università torinese, che d’altronde fra il 1877 e il 1900, laureò ben 69 delle 257 donne che nell’Italia di quegli anni raggiunsero tale obiettivo.
Anche il tema delle reti di relazione ebraiche — del loro peso, del loro significato — affiora solo indirettamente, al di là di alcune interessanti notazioni sui genitori e sulle loro rispettive famiglie d’origine. Eppure, cognomi che rinviano a un’origine ebraica appaiono singolarmente numerosi, com’è naturale, sia tra i frequentatori di casa Lombroso (lasciando intravedere una presenza singolarmente incisiva dell’intellettualità ebraica nella costruzione di una cultura positivista come base di riferimento comune dell’Italia unita), sia nella rete amicale femminile a cui Paola e Gina appoggiarono le loro iniziative, utilizzando legami parentali non ancora dissolti dalla spinta all’integrazione e all’assimilazione, ma soprattutto facendo leva sulla diffusa disponibilità delle donne della borghesia ebraica colta a un forte impegno culturale e sociale: una dinamica che non fu soltanto italiana, ma che in Italia, dove la debolezza dei ceti medi si riverberò accresciuta in ambito femminile, risultò particolarmente visibile, come hanno confermato i primi sondaggi compiuti in questa direzione (si veda per esempio Monica Miniati, Tra emancipazione ebraica ed emancipazione femminile: il dibattito sulla stampa ebraica
dall’Unità alla grande guerra, “Storia contemporanea”, 1989, n. 1). E ancor più nell’ombra restano tutti quei nuclei di mute comparse che qua e là si affacciano dalle note, del resto puntuali e informate. Penso, ad esempio, ai gruppi promotori delle “biblio- techine rurali” lanciate da Paola per dotare anche le scuole più sperdute di un sia pur minimo nucleo di libri per l’infanzia, occasione e tramite di uno straordinario “movimento di solidarietà tra ambiente rurale e urbano e tra ragazzi di diverse condizioni sociali” (p. 130), che già alla vigilia della guerra aveva raggiunto dimensioni ‘di massa’; alle solidarietà che sostennero l’apertura e la gestione della prima “Casa del sole” per “bambini del popolo” durante “l’immane conflitto” e all’indomani di esso; o, ancora, al centinaio di sottoscrittori dell’Addi (Associazione divulgatrice donne italiane), organizzata da Gina con l’aiuto di un pugno di amiche del Lyceum fiorentino (a partire da Amelia Rosselli e Olga Monsani) per “promuovere la circolazione di idee nuove” e di “pubblicazioni ostacolate nella loro diffusione dalla ‘rete degli interessi costituiti’” (p. 178) nel bel mezzo della grande guerra.
Una guerra che — proprio in quanto sconvolse l’intero assetto mondiale, spazzando via stati e culture, sovvertendo parametri e gerarchie di valore, ruoli e prospettive di vita, decidendo ciò che era vivo e ciò che era morto — finisce col presentarsi alla mente del lettore come una data molto più periodizzante, anche per le idee e i destini di queste “donne intellettuali” a forte tasso di presenza pubblica, di quanto non fosse stato il matrimonio, la nascita dei figli, e perfino la morte del padre, che pure avrebbe inferto un colpo mortale alla “scienza” da lui costruita, e di fatto accettata dalle sue figlie come un dato fondante della loro identità personale e come una chiave indispensabile per la lettura della realtà.
Simonetta Soldani
166 Rassegna bibliografica
Ceti urbani e agrari nell’Italia liberale
Aldino Monti
Il volume Municipalità e borghesie padane tra Otto e Novecento. Alcuni casi di studio, a cura di Salvatore Adorno e di Carlotta Sorba, Milano, Angeli, 1991 (Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia - Istituto storico della resistenza in provincia di Parma), raccoglie gli atti del convegno “Amministrazioni, borghesie, gruppi di interesse locali nell’Italia liberale: l’ambito padano”, tenuto a Parma nel maggio 1989 presso l’Istituto storico della resistenza di Parma. Milano, Parma e Piacenza, Bologna, Forlì e Mantova sono i casi studiati. Tre sono i settori d’indagine dei relatori; i soggetti istituzionali, cioè le autorità municipali, le borghesie e le loro organizzazioni di interesse. Nei vari interventi la considerazione della componente urbana della dinamica della modernizzazione si affianca — ed è interessante sottolinearlo — a quella della componente agraria; l’appello al ruolo dell’ente locale nel coinvolgere i gruppi dirigenti locali nel processo di mobilitazione e investimento delle risorse consente di leggere in termini meno tradizionali, e quindi meno ‘agraristici’, il profilo evolutivo di tale dinamica. In altri termini, l’attenzione al luogo e al momento ‘municipale’, non solo consente il recupero del ruolo dei ceti dirigenti locali rispetto al centro — secondo un ormai abusato ideologema storiografico chiamato centro-periferia — ma soprattutto consente un sostanziale riequilibrio del discorso storico, troppo sbilanciato fino a ora sul ruolo degli “agrari” e delle loro organizzazioni d’interesse — che per altro hanno cominciato a incidere in misura significativa solo a metà dell’età giolittiana, verso il 1906-1908 — scarsamente correlate all’indagine della stratificazione e della cultura dei ceti della città. L’osservazione è tanto più pertinente, mi sembra, nel caso delle città al
lineate lungo l’arteria emiliana, accumunate da indubbie analogie strutturali.
Innanzi tutto, le città emiliane hanno una caratteristica comune, di natura socio-urbanistica: sono centri storici, capisaldi politici, alcune ex capitali e sedi di corti, uscite dal mercato internazionale tra Sette e Ottocento con la rovina delle loro strutture produttive determinata dalla concorrenza internazionale e dall’invasione napoleonica; lungo tutto l’Ottocento, fino agli anni ottanta, esse accentuano il loro tradizionale profilo di città di servizi, nell’ambito di un terziario ancora largamente preindustriale, bene rappresentato da esempi come Piacenza, “città militare per eccellenza”, come Parma e Mantova, città-corti, come Bologna, città dalle funzioni urbane eminentemente transattive, quale scalo del commercio di transito, centro universitario, e, nei primi decenni post-unitari, piazzaforte militare. Una volta entrate nella nuova compagine nazionale unitaria, il loro retaggio sociale d’ancien régime, costituito dal corredo di ceti urbani dal ruolo socialmente improduttivo, condizionò in diversa misura l’acquisizione di una nuova identità economica e civile tra l’Unità e la prima guerra mondiale. Se si accoglie il suggerimento di Roberto Balzani, per il caso di Forlì, di connettere più strettamente physical morphology e social morphology della città, si può affermare che, dopo l’unificazione, si attua il passaggio da una città il cui epicentro è costituito dalla rete dei poli monumentali nei cui contenitori architettonici sono erogati i servizi di un terziario direzionale preindustriale (la corte, la chiesa, l’apparato politico-burocratico e caritativo-assi- stenziale), a una città in cui la rete dei moderni servizi urbani — la rete idrica, del gas, dell’illuminazione, dell’elettricità, delle tramvie e degli allacciamenti viari col terri-
Rassegna bibliografica 167
torio, dei nuovi terminali dei mercati e degli scali ferroviari, eccetera), diventa il supporto materiale dell’emergere di nuovi interessi sociali e di rinnovati ceti dirigenti.
Il sistema vascolare della città — per usare un utile concetto marxiano relativo alla storia dell’urbanizzazione antica e moderna — riprese peso e significato di funzioni a ridosso del sistema muscolare della seconda rivoluzione industriale, sotto forma di sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia, luogo di un’interazione storicamente inedita tra industrializzazione e urbanizzazione. Le condutture dell’acqua, del gas e dell’elettricità possono costituire “il fedele calco sotterraneo della ‘mappa’ del potere all’interno delle mura”; per la quantità delle risorse investite, per la molteplicità degli interessi sollecitati, per la complessità della gestione e delle interazioni tecnico-economiche, il rinnovato network di manufatti e ingredienti sociali urbani portò alla selezione di un nuovo personale politico, dalle competenze politiche più professionalizzate, in sostituzione del vecchio ceto dei notabili liberali. Le relazioni tra forma fisica e forma sociale della città, scrive Balzani, possono dunque “essere descritte e comprese, affiancando al profilo della città pre-moderna, assunto come dato, le trasformazioni culturali, economiche ed urbanistiche avviate dalle élite succedutesi alla guida di un’amministrazione”. Trasformazioni che “muovendosi nel duplice ambito dello spazio fisico e del progetto sociale, appaiono più facilmente percepibili e riconducibili ad un’interpretazione unitaria” ( “Protagonismo” municipale e modernizzazione. Note in margine al caso forlivese 1880-1915, pp. 36-37). Questa prospettiva socio-urbanistica permette di leggere con più immediatezza, credo, il ruolo che l’intreccio di vecchia e nuova borghesia urbana ha esercitato nei processi di ammodernamento delle città emiliane tra Otto e Novecento, in rapporto e in concorrenza con il ceto degli agrari. I casi presentati dai
relatori presentano significative varianti entro il medesimo processo di riconversione dalla città antica a quella moderna.
A Piacenza la vecchia borghesia urbana— come documenta Severina Fontana (Am ministrazione locale e borghesia agraria a Piacenza nella seconda metà dell’Ottocento)— si mostra totalmente incapace “di liberarsi dalla dipendenza economica dei proventi militari” , riproponendo “alla comunità il modello di una ‘città militare per eccellenza’, imperniato sulla sua chiusura e sulla impossibilità di una espansione edilizia urbana, per il vincolo delle servirtù militari che
•gravava sulla cinta muraria cinquecentesca e sulle fortificazioni esterne” (pp. 133-134), tagliando fuori la città dal processo di commercializzazione dei prodotti. L’impulso al rinnovamento delle funzioni urbane parte da una nuova borghesia agraria, produttiva e dinamica, che ha il suo simbolo nella figura di Giovanni Raineri e che sostituisce nel governo della città la “vecchia élite cittadina degli avvocati, commercianti ed artigiani [...] espressione di un tessuto sociale ed economico che entro il perimetro disegnato dalla vecchia cinta muraria non aveva conosciuto ancora forme di rinnovamento ed era fermo al periodo preindustriale” (p. 145). Il caso di Parma rappresenta, al contrario, una variante opposta; il ceto dei “commercianti ed esercenti”, dedito ad attività commerciali e artigianali ben radicate nella tradizione ducale della città (produzione di beni di lusso, industria tipografica), costituisce “il gruppo più compatto e facilmente identificabile nella trama sociale cittadina” , il sostegno più forte per la coalizione democratica, la quale emerge dalle elezioni del 1889 “come la più credibile forza modernizzatrice della città” , in polemica affermazione con gli interessi agrari. La gestione del sindaco Mariotti promuove una certa idea della “modernità” , che consiste nell’idea “di dotare il nucleo urbano ottocentesco [...] delle infrastrutture collettive e dei servizi tecnici
168 Rassegna bibliografica
urbani di cui è privo”, con un richiamo municipalistico alla tradizione ducale dei “lavori d’inverno” di Maria Luigia, facendo “convergere sull’obbiettivo della modernizzazione della città [...] gli interessi dei ceti medi urbani, commerciali, professionali, della piccola produzione, e quelli degli operai disoccupati assoldati per i grandi lavori di demolizione e ricostruzione” (Carlotta Sorba, Comune, stato e interessi locali. Parma 1882-1914, p. 56 e p. 70).
Nella fase successiva della storia cittadina, che inizia nel 1906, il ceto agrario conquista l’amministrazione della città. L’Agraria di Lino Carrara persegue un progetto egemonico di controllo sulla città, basato sull’alleanza coi ceti medi industriali e commerciali, alleanza agevolata dalla forte presenza degli agrari parmensi nelle industrie di trasformazione (bietola e pomodoro). Il tentativo si avvale anche di un’elaborazione ideologico-politica che sfocia nella proposta del “partito agrario” . Come scrive Salvatore Adorno, “l’idea cardine è quella di costruire una società rurale fortemente gerarchizzata, aconflittuale e produttivista in cui il capitale agrario e agroindustriale svolgesse una funzione di direzione e tutela nei confronti del proletariato e dei ceti medi, controllandone i meccanismi di crescita e di cooptazione. Una volta pacificata, grazie alla capacità di produrre ricchezza, la società agraria sarebbe riuscita a imporre i propri interessi come interessi generali dello sviluppo” (Gli agrari di Parma nell’età giolittiana tra politica, amministrazione e interessi, p. 156). Nell’ideologia di questa posizione sono forse rintracciabili gli elementi di una possibile risposta al problema posto da Alberto Banti (Gli agrari padani. Problemi di analisi e ipotesi di interpretazione) sul carattere borghese o meno degli agrari padani.
Banti afferma la natura borghese degli agrari padani e quindi la loro assimilabilità e comparabilità coi loro colleghi europei, in base ai loro caratteri spiccatamente impren
ditoriali e al carattere produttivistico e progressivo della loro ideologia corporativa; ne spiega la “deviazione” verso posizioni illiberali e reazionarie sulla base della eccezionale conflittualità politica scatenata nelle campagne dalle leghe contadine. Banti sottovaluta forse il carattere arcaico, “civico-industria- lista” del corporativismo di questo blocco agrario-industriale che, sotto il profilo socioprofessionale, aveva sicuramente i caratteri moderni delle borghesie europee; tale cultura era largamente presente in vasti strati di ceti medi, sia economici che intellettuali (cfr. le pagine dedicate da Gioacchino Volpe in Storia del movimento fascista, Milano, 1939, al contributo emiliano e romagnolo alla cultura del nazionalismo e del fascismo) delle città padane, in coerenza, d’altra parte, con l’orientamento organicistico di gran parte del pensiero liberale e conservatore otto-novecentesco, pregiudizialmente ostile alla conflittualità politicosociale. La loro particolare idea “civica” e “nazionale” dell’armonia economico-sociale non era in grado di attrezzare adeguatamente i ceti medi padani ad affrontare i moderni problemi di una società industriale; essa pertanto fornì un filtro puramente ideologico alla percezione di scioperi e conflitti, di cui misurava preliminarmente lo scarto dalle proprie idealità e velleità egemoniche, piuttosto che l’impatto effettivo e il perimetro reale nella società e nell’economia (cfr. anche Gian Carlo Jocteau, L ’Armonia perturbata. Classi dirigenti e percezione degli scioperi nell’Italia liberale, Roma-Bari, La- terza, 1988). La dilatazione simbolica dell’evento conflittuale, la paura e lo smarrimento furono tanto piu gravi, in quanto gli agrari furono e si sentirono sempre un gruppo sociale socialmente frantumato e politicamente diviso, dotato di scarse connotazioni elitarie. E qui mi si permetta un’osservazione critica circa l’uso scontato, eccessivo e disinvolto, del termine di “élite agrarie” .
Rassegna bibliografica 169
Nelle mille Italie agricole e municipali del nostro paese, dalla complessa articolazione sociale, non vi fu spazio per una funzione egemonica unificante del conflitto sociale da parte degli agrari — posto che la produzione di un’egemonia sia il carattere distintivo del ruolo dell’élite — ma vi fu, da parte di ceti agrari composti di figure in gran parte economicamente e socialmente miste (proprietari, imprenditori, professionisti, eccetera, coesistenti nella medesima persona), una marcata delega alla politica, alle sue élite parlamentari prima, a quelle extraparlamentari, col fascismo, poi. Una sorta di capitalismo “agrario-esercentesco” — per usare la terminologia di Giovanni Zibordi nel 1921 — con solide peculiari radici nella tradizione delle città emiliane, dopo aver
fatto la sua prova generale politica nel laboratorio parmense di Lino Carrara, portò il nazionalismo e il fascismo al potere nel “quadrivio” di Bologna, “perché ivi — scrive il deputato socialista reggiano — parevano essersi dati convegno tutti i coefficienti economici e psicologici atti a farlo nascere, ed a concentrare intorno a lui la somma più complessa e più varia delle adesioni: coefficiente agrario, esercentesco, studentesco, militare, letterario, universitario, eccetera” . Oppurtunamente, i relatori del seminario parmense hanno spostato l’attenzione sul versante e sul contesto urbano-rurale del processo di modernizzazione nelle città padane e della matrice strutturale del fascismo.
Aldino Monti
L’idea antiborghese e la sindrome del moderatismo
Mario G. Rossi
“Intento originario” dell’ultimo volume di Domenico Settembrini (Storia dell’idea antiborghese in Italia 1860-1989. Società del benessere-liberalismo-totalitarismo, Roma-Ba- ri, Laterza, 1991, pp. XII-522, lire 60.000) è, secondo lo stesso autore, quello di contribuire a spiegare la cosiddetta “anomalia italiana” , ossia le difficoltà di consolidamento della democrazia nel nostro paese, le cui radici affonderebbero in una peculiare mentalità “antiborghese” , che ha ostacolato e distorto il cammino della democrazia liberale, traducendosi prima nel fascismo e poi nel suo “continuatore” ed “erede” , il comuniSmo (pp. VII-VIII). Il risultato è una sorta di requisitoria, che, a partire dal Risorgimento, ma soprattutto dall’età giolittiana in poi, prende di petto la borghesia intellettuale italiana, accusata di aver alimentato un
orientamento critico e distruttivo, frutto di utopie astratte o di inguaribile elitarismo, che era destinato ad aprire la strada al totalitarismo, cioè allo sviluppo più organico e conseguente di quelle premesse. Di destra o di sinistra, infatti, il totalitarismo è riconducibile a un unico ceppo: “la comune derivazione del comuniSmo e del fascismo italiani dallo stesso clima intellettuale e da uno stesso maestro — Mussolini —” sta a dimostrare che, al di sopra delle differenze su tanti aspetti particolari, prevale la “comunanza dell’obiettivo: la distruzione appunto della società aperta” (p. 82).
In realtà, se alla base di questo storico fallimento della democrazia italiana c’è lo “spirito antiborghese e anticapitalista” , la vera imputata nel processo intentato dall’autore è la sinistra, che ne è la principale portatrice
170 Rassegna bibliografica
e di conseguenza è responsabile dell’ascesa al potere del fascismo e delle successive tare della democrazia repubblicana. In questa ottica ogni corrente di pensiero e ogni singolo intellettuale, che, in nome della democrazia e della giustizia sociale, abbia messo sotto accusa la politica della classe dirigente postunitaria (la “borghesia”, per l’appunto) e abbia criticato la conduzione dell’economia e l’organizzazione della società (il “capitalismo”, non in generale, ma nella sua specifica versione nazionale), incappa in una condanna senza appello, di fronte alla quale poco valgono le attenuanti per singoli meriti contratti in taluni passaggi della storia del paese. Così Salvemini e Gobetti, Turati e Treves, che non hanno risparmiato le critiche alla democrazia parlamentare e alla classe dirigente liberale, spinti dalla loro “ottica anticapitalistica” e da quella che Settembrini definisce “l’insuperabile tentazione rivoluzionaria dei riformisti” (p. 187), diventano tutti ugualmente corresponsabili del disastro della democrazia italiana nel primo dopoguerra.
Quello della grande guerra e delle tensioni rivoluzionarie che investono il paese nel biennio successivo alla fine del conflitto è infatti uno dei passaggi fondamentali dell’analisi dell’autore. Fu allora che il processo di integrazione delle masse nello Stato, preparato dalla politica giolittiana, avrebbe potuto avvalersi di condizioni particolarmente favorevoli alla sua realizzazione (a cominciare dalla disponibilità del ceto imprenditoriale e degli stessi nazionalisti per una politica di riforme), se non fosse stato travolto dall’“ondata anarcoide” dilagante nelle piazze e nei luoghi di lavoro e dall’incapacità dei riformisti di svolgere la necessaria “opera di educazione” , sottraendosi alle suggestioni disfattiste e rivoluzionarie.
Inutile chiedere a Settembrini di prendere in qualche considerazione la tragedia di quattro anni di guerra, con tutto il loro carico di lutti e di sofferenze: si tratta evidente
mente di un particolare irrilevante, che non vale a spiegare né il radicalizzarsi dell’anti- bellicismo del Partito socialista italiano (“il fattore fondamentale cui si deve se il cammino della democrazia italiana venne bruscamente interrotto”, p. 206) né il nesso tra l’esasperazione popolare e il rivoluzionarismo diffuso del biennio rosso. Anzi, sembra che la guerra sia stata poco più che un pretesto per dare sfogo agli “elementari istinti” delle masse e la rabbia postbellica “una sorta di compensazione collettiva per la frustrazione subita” (p. 208), che ha originato una violenza certo meno organizzata ed efficace rispetto a quella fascista, ma “anche — forse proprio per questo suo carattere anarcoide — socialmente più distruttiva, più endemica e in alcuni pochi casi piu barbarica e micidiale” (p. 211). Tanto che perfino uno studioso, non proprio tenero verso le tendenze rivoluzionarie, come Roberto Vivarelli, si prende le sue bacchettate sulle dita per aver richiamato, in sintonia con le proprie simpatie salveminiane, la responsabilità della classe dirigente nel fallimento del liberalismo: una tesi “che senza essere a rigore marxista” troppo concede alle motivazioni di carattere economico. Macché responsabilità della classe dirigente liberale! La colpa fu solo dei socialisti, incapaci di liberarsi dei miti rivoluzionari e di cogliere 1’“occasione storica” delle riforme, rese possibili proprio per merito della classe imprenditoriale e di quella politica (pp. 239-241).
È facile comprendere a questo punto come l’antifascismo e la resistenza siano l’altro snodo fondamentale del libro e l’obiettivo polemico principale dell’autore. Dal momento che nella battaglia per la riconquista della democrazia la lotta al fascismo si accompagna e si intreccia con quella per l’abbattimento (o almeno per una radicale trasformazione) del capitalismo, il vizio di fondo di cui la sinistra è portatrice si manifesta in tutta la sua gravità. Anche qui poco contano venti anni di dittatura, consentiti dalle
Rassegna bibliografica 171
complicità di tutta la vecchia classe dirigente politica ed economica; l’avventura della guerra, che corona una politica imperialista non certo estranea agli interessi del grande capitale; la stessa crisi del 1929, con i suoi effetti devastanti sull’intera economia capitalistica: tutti nodi ineliminabili per capire la spinta a un profondo rinnovamento, anche economico e sociale, che muove le varie componenti dell’antifascismo. Ma estendere la portata della lotta antifascista dal ripristino della democrazia parlamentare alla messa in discussione delle basi economico-socia- li della dittatura costituisce per Settembrini una colpa storica imperdonabile. “In questo modo [...] — scrive — anche tutti quegli antifascisti che pure erano pienamente acquisiti ai valori della democrazia liberale, da Turati a Rosselli, da Saragat a La Malfa, restarono ideologicamente del tutto succubi del comuniSmo” (p. 357) e “diedero un contributo di prim’ordine all’operazione di radicamento dello stalinismo nella cultura e nella società italiana, condotta con successo da Togliatti nel dopoguerra” (p. 358).
Con tali premesse, è soprattutto Pazioni- smo a fare da bersaglio alle bordate polemiche dell’autore. Trattandosi di un movimento impegnato in prima linea sia sul fronte politico che nella battaglia culturale, simbolo per di più di una concezione della resistenza intesa come rinnovamento radicale del paese, esso diventa l’autentica bestia nera di tutta l’ultima parte del volume. Viene anzi il dubbio che l’intera opera sia stata concepita in funzione di questa polemica finale, visti l’asprezza e lo schematismo dei giudizi con cui vengono liquidati Carlo Rosselli e Guido Calogero, il primo La Malfa e Ferruccio Parri, Giustizia e Libertà e il Partito d’Azione, fino al Bobbio di ieri e di oggi. Tutti quanti indelebilmente macchiati da una duplice colpa: da un lato, la subalternità al comuniSmo, riassunta nel termine di “liberalcomunismo”, che per l’autore vuol dire il “puro e semplice innesto delle libertà
occidentali sul tronco del collettivismo e della pianificazione economica di tipo sovietico” (p. 380); dall’altro, una forma mentis, “comune col fascismo di sinistra” e ancor più incompatibile con la democrazia dello stesso capitalismo, che sarebbe “l’ambizione di cambiare intus et in cute tutti gli italiani” (p. 383), ossia qualcosa di simile alla “riforma intellettuale e morale” indicata da Gramsci.
Per giunta, è in primo luogo dall’azioni- smo e dai suoi esponenti che è derivata (naturalmente sotto la regia occulta del Pei di Togliatti) quell’idea della resistenza come “un non meglio specificato rinnovamento morale e sociale radicale” (p. 434), che rappresenta il massimo equivoco aleggiante sulla democrazia del postfascismo. Da qui ha origine “il mito della resistenza tradita” , “l’idea che la resistenza abbia costituito un’occasione mancata per attuare un profondo rinnovamento democratico del nostro paese” , porta aperta dalla quale hanno continuato a irrompere le ventate della contestazione anticapitalistica e antimoderna e le utopie della “terza via” e della “democrazia economica”, in una parola quello “spirito antiborghese”, che è la continuità negativa della storia d’Italia. E l’autore, prodigo di riconoscimenti per i “migliori esponenti della cultura d’ispirazione socialista” (p. 430), che hanno dato un grosso contributo a seppellire il mito, rivolge i suoi pesanti rimbrotti a quanti altri, come Simona Colarizi, mostrano di restarvi ostinatamente attaccati, vaneggiando di una possibile “trasformazione democratica dell’economia”, che non si è mai vista e che è incompatibile col capitalismo reale: del resto, dice, “la studiosa proviene politicamente dalla sinistra socialista di Riccardo Lombardi, il quale a sua volta proveniva dal Partito d’Azione” (p. 438), e dunque che altro ci si può aspettare da costei?
Il vero succo dell’opera è tutto in questo processo a ogni idea (o forza) di sinistra che
172 Rassegna bibliografica
implichi la critica della società esistente e la spinta al cambiamento, non tanto nell’Italia liberale, quanto soprattutto nell’Italia repubblicana, recuperata da De Gasperi ai parametri occidentali e capitalistici dopo la parentesi del fascismo. L’“anomalia italiana”, in ultima analisi, non è la democrazia bloccata, ma la sinistra nelle sue radici ideali, nei suoi sviluppi storici e nei suoi programmi politici.
Se si considera la rivalutazione che l’autore fa del riformismo liberale di Giolitti e della politica di De Gasperi, si potrebbe essere indotti a pensare a una sorta di riproposizione, ideologizzata e radicalizzata, dell’antire- visionismo crociano (compreso il recupero dell’interpretazione del fascismo come parentesi), aggiornato fino all’Italia repubblicana, in difesa dei valori e dell’operato dei ceti dirigenti succedutisi al potere prima e dopo il regime. Ma la totale assenza di un confronto con le vicende storiche reali (non con i rapporti di produzione e con le lotte sociali, per carità, soltanto con gli événements) e la rigida unilateralità dei giudizi, più che dare all’opera un taglio “provocatorio” (come dice la stessa presentazione del volume), ne fanno un condensato quasi caricaturale di luoghi comuni da maggioranza silenziosa,
dove alla difesa dell’ordine costituito viene sacrificata anche la spregiudicatezza laica esibita in passato.
È quanto mai significativo che dal quadro dello schieramento antiborghese e anticapitalistico l’autore cancelli ogni riferimento ai cattolici (al punto che sbaglia perfino la data della Rerum novarum: 1893!, p. 77). Per chi ha scritto alcuni decenni or sono La Chiesa nella politica italiana 1944-1963 (Pisa, Nistri- Lischi, 1964), denunciando l’invadenza clericale e il suo contrasto con la modernizzazione del paese, non è un’omissione di poco conto. Si spiega tuttavia alla luce del ruolo di pilastro del sistema politico ed economico nazionale, che il partito cattolico ha ormai consolidato e di fronte al quale l’anticlericalismo di facciata di certo laicismo va in liquidazione. Così le velleità anticapitalistiche del vecchio intransigentismo non valgono più neppure una citazione di cortesia e le falangi clericali, riscattate dal centrismo degaspe- riano, sono arruolate a pieno titolo fra i paladini della democrazia. Per le magnifiche sorti e progressive della borghesia e del capitalismo, in saecula saeculorum.
Mario G. Rossi
Autoritratto di Hitler
Gustavo Corni
Scrivere una biografia di un personaggio così intricato come Hitler, che nel corso di una breve parabola esistenziale racchiuse in sé un enorme potere, non è facile. La letteratura su questo tema è ampia e ha dato vita a interpretazioni molto divergenti l’una dall’altra. Coloro che si sono cimentati nell’impresa hanno dovuto fare i conti — con esiti
molto diversi — con svariate questioni di fondo. In primo luogo, il netto divario fra la povertà della biografia personale di Hitler e il peso che le sue idee e le sue scelte politiche hanno avuto nel determinare la storia del mondo in questo secolo; in secondo luogo, la difficoltà di individuare con precisione quali fossero le idee forza del programma
Rassegna bibliografica 173
politico hitleriano e di stabilire prioritariamente se egli avesse un programma al quale si sarebbe sentito legato. Le stesse fonti disponibili rendono difficile dirimere questi problemi di fondo, a causa della difficoltà di penetrare al di là della cortina di decisioni prese in modo orale, informale, sfuggente dal Führer. Per scrivere una biografia di Hitler occorre, in altre parole, decidere prioritariamente se le idee, il programma e le sottostanti motivazioni di ordine esistenziale e psicologico di Hitler abbiano un rilievo storico determinante, o se invece sia più opportuno scrivere libri di storia del nazionalsocialismo e del Terzo Reich, in cui a Hitler come persona, come statista o come stratega, sia dedicato uno spazio adeguato, ma non preponderante.
Alcuni studiosi, come Alan Bullock nei primi anni cinquanta (Hitler. Studio sulla tirannide, Milano, Mondadori, 1955, ed. orig. London, 1952) e più recentemente Joachim C. Fest {Hitler, Milano, Rizzoli, 1974, ed. orig. Frankfurt a.M.-Berlin-Wien, 1973), hanno scelto la strada di esaminare nel dettaglio i collegamenti fra la vita di Hitler, le sue pulsioni programmatiche e le sue decisioni concrete, interpretando alla luce della biografia del dittatore la storia del nazionalsocialismo. Altri — come Werner Maser {Hitler segreto, Milano, Garzanti, 1974, ed. orig. Düsseldorf-Wien, 1973) — hanno dedicato tutte le loro energie a ricostruire i frammenti più minuti della vita di Hitler, soprattutto nella sua parte iniziale, con l’obiettivo di cogliere le motivazioni psicologiche degli atti e dei crimini di cui Hitler si sarebbe reso protagonista in seguito. L’approfondimento psicologico del personaggio non ha dato certo i risultati sperati, anche a causa dello scarso spessore di colui che è stato correttamente definito un “non personaggio” . Le indagini anche più minuziose non hanno contribuito granché a spiegare meglio le ragioni per cui Hitler fece ciò che fece, né tantomeno ci sono state d’aiuto per capire
perché milioni di tedeschi, di ogni ceto e di ogni età, abbiano aderito al nazionalsocialismo, militato nelle sue file e collaborato (a vario titolo) alle sue imprese. Non va, poi, dimenticato che concentrare l’attenzione della ricerca sulla figura di Hitler ha — almeno oggettivamente — significato in talune congiunture storiche mettere in secondo piano le colpe e le responsabilità altrui, giocando su un capro espiatorio così ‘facile’.
Rainer Zitelmann, un giovane ricercatore che si è messo in luce con uno straordinario attivismo editoriale nell’ultimo quinquennio, ha affrontato queste spinose questioni con grande equilibrio e abilità, scrivendo una “biografia politica” — così recita il sottotitolo dell’edizione originale tedesca, omesso dal traduttore italiano — di Hitler (Roma-Bari, Laterza, 1991, ed. orig. Gòt- tingen-Zürich, 1989, pp. 232, lire 35.000) che soddisfa i criteri della più limpida scientificità, ma che nello stesso tempo si fa leggere agevolmente, anche per le contenute dimensioni. Zitelmann ha scritto una biografia breve, ma non per questo meno ricca di spunti analitici e di riflessioni degne di attenzione. Una biografia in cui il personaggio Hitler e le sue idee programmatiche vengono valorizzate in contrapposizione con le tesi cosiddette “funzionaliste” , che negano a Hitler un ruolo preponderante nel contesto del sistema politico nazionalsocialista. Si deve far rilevare, poi, che la biografia qui recensita segue una linea interpretativa precisa e molto netta, che Zitelmann aveva proposto qualche anno fa in una ponderosa monografia intitolata: Hitler. Selbstverstandnis eines Revolutionàrs (Stuttgart, Klett-Cotta, 1987); un libro che al suo apparire aveva suscitato giudizi molto positivi dalla critica. In estrema sintesi, questa linea interpretativa si fonda sul presupposto di esaminare con la massima attenzione tutte le prese di posizione di Hitler: discorsi, articoli di giornale, dichiarazioni alla stampa, e non solo le opere cosiddette teoriche scritte alla metà degli anni
174 Rassegna bibliografica
venti. Nella succitata monografia, e poi nella biografia qui recensita, Zitelmann ha fondato la sua analisi sulla minuziosa ricostruzione del pensiero di Hitler, nelle sue molteplici sfaccettature. Sembra quasi paradossale — ma corrisponde allo stato dei fatti — che prima di Zitelmann nessuno studioso si sia assunto il compito (certo non agevole) di passare a pettine fitto l’enorme produzione oratoria e giornalistica di un personaggio storico così importante come Hitler! Il secondo elemento portante della sua interpretazione, evidente fin nel titolo della monografia, consiste nel dare credibilità alle molteplici dichiarazioni di stampo rivoluzionario di Hitler, cui la storiografia, soprattutto quella di parte marxista, aveva finora attribuito piuttosto la funzione di trarre in inganno la classe operaia per conquistarne il consenso. Gli storici liberali, invece, avevano dedicato un’attenzione maggiore alle tematiche razziali e antisémite, considerandole il fulcro del programma e della Weltanschauung hitleriani.
A parere di Zitelmann, invece, nel suo intimo Hitler avrebbe desiderato un rivoluzionamento delle gerarchie sociali e un ridimensionamento del ruolo egemonico della borghesia, per favorire l’ascesa di una nuova classe dirigente, reclutata fra i migliori elementi del proletariato. Egli avrebbe considerato la borghesia come destinata alla decadenza e si sarebbe alleato a essa solo per ragioni strumentali, perché consapevole di non poter conquistare il potere senza il suo sostegno. Inoltre, Zitelmann ci presenta l’immagine di un Hitler attento alle grandi questioni sociali e con una mentalità nien- t ’affatto retrograda o legata a cliché rurali- stici e preindustriali. Zitelmann non dimentica certo di considerare la fissazione antisemita e razzista, ma critica quegli studiosi che si sono soffermati unilateralmente su di essa. In contrasto con questa visione dominante, il giovane storico berlinese — cui non manca il gusto del ‘revisionismo’ esacerbato
— sottolinea le finalità rivoluzionarie di Hitler e rileva come queste non siano rimaste confinate esclusivamente nella sfera degli auspici, ma abbiano trovato un’attuazione perlomeno parziale. Va ricordato, peraltro, che Hitler ebbe un numero ridotto di anni a disposizione per avviare l’attuazione del suo programma sociale, che cionondimeno Zitelmann considera una parte importante della sua visione del mondo.
Entrando nel merito di un’altra questione cruciale — su cui la storiografia si è divisa: se Hitler debba essere considerato un opportunista, pronto ad adattarsi alle specifiche circostanze, o se invece egli si sia mosso sempre con la finalità di realizzare le proprie idee fisse — Zitelmann assume una posizione mediana, affermando che “Hitler aveva stilato un programma d’azione sin dai primissimi tempi e aveva cercato di metterlo in pratica. Tuttavia, egli non seguiva una ‘tabella di marcia’ rigida, ma cercò piuttosto di sfruttare le occasioni favorevoli [...] Non si preoccupò mai tanto dei passaggi intermedi compresi fra la realizzazione dei suoi disegni visionari e le azioni politiche quotidiane” (p. 127). Grazie a questa tattica Hitler si sarebbe dimostrato maestro nel dominare le innumerevoli situazioni di crisi in cui finì per trovarsi.
Questa biografia di Hitler si presenta perciò con un taglio molto innovativo, proponendo interpretazioni originali su di una figura che ogni volta che viene studiata da una prospettiva diversa presenta tratti nuovi e sconosciuti. Viene evidenziato il carattere “rivoluzionario” del programma politico hitleriano e nello stesso tempo viene sottolineata l’attenzione di Hitler per i temi economici e tecnici, ribaltando in entrambi i casi dei consolidati luoghi comuni. Zitelmann suffraga la sua interpretazione con frequenti riferimenti a una nuova fonte, messa a disposizione degli studiosi grazie a un paziente lavoro di ricostruzione filologica: i diari di Goebbels. Stretto collaboratore
Rassegna bibliografica 175
di Hitler (almeno in alcune fasi) e dotato di una notevole intelligenza politica, Goebbels ha affidato ai suoi diari una messe di notizie e di osservazioni, sulle quali gli storici avranno modo di sbizzarrirsi anche in futuro.
Sottolineate le caratteristiche salienti della biografia scritta da Zitelmann, rimane comunque da far presente come l’interpretazione revisionistica che lo sottende non sia — a mio parere — sempre adeguatamente dimostrata. Non sempre Zitelmann riesce a collegare le prese di posizione di Hitler con le specifiche vicende a cui queste di volta in volta si richiamano; perciò, la sua costruzione di un’immagine “nuova” di Hitler rischia di essere troppo astratta. Inoltre, è da osservare come la credibilità assoluta che Zitelmann attribuisce alle prese di posizione di Hitler non favorisca un adeguato distacco interpretativo e induca talora a immedesimarsi troppo — certo non dal punto di vista politico — con la persona oggetto di studio.
Si tratta di una critica frequentemente sollevata in Italia nei confronti della biografia mussoliniana scritta da Renzo De Felice.
Tuttavia, la proposta interpretativa di Zitelmann offre sicuramente nuovi spunti per riconsiderare la questione del consenso al regime, questione che non può essere liquidata unilateralmente richiamandosi alla forza della repressione, ovvero della propaganda. Il nazionalsocialismo significò sterminio, repressione, discriminazione — sottolinea Zitelmann —, ma “anche maggiori possibilità di ascesa sociale per i gruppi socialmente svantaggiati, progressi assistenziali e previdenziali per ampi strati della popolazione, successi sorprendenti in politica economica ed estera” (p. 204).
Su queste basi Hitler conquistò e consolidò la sua popolarità, che resse fino alle ultime settimane di guerra, nonostante l’evidenza della prossima sconfitta.
Gustavo Corni
Storia militare
Enrico A cerbi, Le truppe da montagna dell’esercito austro- ungarico nella Grande Guerra 1914-1918, Valdagno, Gino Rossato, 1991, pp. 238, lire28.000.
Le province dell’arco alpino orientale hanno visto in questi ultimi decenni un grosso sviluppo della ricerca storica che in buona parte possiamo definire “alpina”. Una ricerca che nasce al di fuori (o con un concorso marginale) delle strutture universitarie, per iniziativa di singoli e gruppi locali, come ricupero e documentazione di un passato regionale in cui la grande guerra ha il primo posto, ma
che può estendersi ai secoli passati (come nel caso di “Passato- Presente”, rivista del gruppo “Il Chiese” di Storo, appunto in Val di Chiese) o giungere alla seconda guerra mondiale e alla guerra partigiana, con un grosso apporto degli Istituti per la storia della resistenza. Pur nella varietà di risultati e orientamenti (si passa dalla straordinaria attività del gruppo di “Materiali di lavoro” di Rovereto a pubblicazioni di valore puramente locale, condizionate da interessi turistici), questo insieme di ricerche ha una grande vitalità e novità, che trova supporto nella dinamica attività di piccole case editrici radicate nel territorio, ma pure capaci di proporre studi di assoluto rilie
vo nazionale, come Alessandro Massignani, Alpini e tedeschi sul Don, dell’editore Rossato (Valdagno, 1991), Marco di Giovanni, I paracadutisti, della Editrice goriziana (Gorizia, 1991), Mimmo Franzinelli, Il riarmo dello spirito sui cappellani militari 1940-1945 (recensito in queste pagine di “Italia contemporanea”).
La maggioranza di questa produzione è però concentrata sulla grande guerra (da qui la nostra definizione di storiografia “alpina”, che non intende essere riduttiva, bensì segnalare un fecondo radicamento territoriale e una originalità e ricchezza a livello nazionale), studiata sulle carte e sul terreno, spesso con la collaborazione