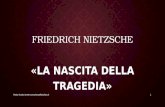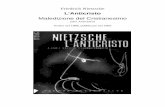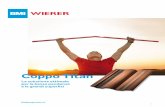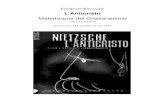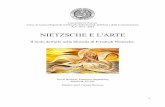Pietro Coppo, Sulla Nascita Della Tragedia Di Nietzsche
-
Upload
giovanni-maria-campari -
Category
Documents
-
view
222 -
download
0
Transcript of Pietro Coppo, Sulla Nascita Della Tragedia Di Nietzsche

8/12/2019 Pietro Coppo, Sulla Nascita Della Tragedia Di Nietzsche
http://slidepdf.com/reader/full/pietro-coppo-sulla-nascita-della-tragedia-di-nietzsche 1/11
1
PIERO COPPONote a proposito de “La nascita della tragedia dallo spirito della musica” di FriedrichNietsche, Adelphi, 1976, Vol III delle Opere.
Dalle “Notizie e note” di G. Colli e M. Montanari (pp 461-466) si evincono alcune informazioni circa
questo testo che, dopo più di un secolo, “rimane sempre oltremodo misterioso”. Gli studiosi dellaGrecia antica lo hanno considerato come non scientifico, e in particolare hanno ritenuta arbitraria laconcezione di N. sulla stretta connessione tra la tragedia antica e il culto di Dioniso. “Ma La nascita dellatragedia non è un’interpretazione storica. Proprio mentre sembra svilupparsi come tale, si trasforma inun’interpretazione di tutta la grecità, e … addirittura in una visione filosofica totale. … E’ l’opera più‘mistica’ di N., nel senso cioè che richiede una iniziazione.”Da un lato il testo si occupa del “ … mondo della Grecia arcaica, scandagliato e percorso conl’erudizione, ma ancor più sognato, integrato dalla fantasia, ricostruito come una vita senza volto, sullabase delle parole folli, dello sconnesso balbettare di Pindaro e dei cori tragici. E’ un’esperienza estatica,dove l’approccio dell’iniziato si realizza attraverso la lettura degli autori antichi.” Da un altro lato allabase del testo stanno gli scritti di Arthur Schopenhauer; e, dietro di lui, l’orizzonte indiano, la visione
del mondo di una intera civiltà. Infine, la terza matrice dello scritto è l’esposizione alla musica wagneriana, e in particolare al terzo atto del Tristano e Isotta: “La dissonanza 1 nel cuore del mondo, vissuta, ascoltata come uno scotimento, un brivido radicale, un’ebbrezza esaltante: questa è l’esperienza‘sua’”. L’intensità dell’esperienza che sta alla base de La nascita della tragedia – e che la fa diventare ilracconto dell’epifania vissuta di un Dio, Dioniso – nasce da un “misticismo” 2 autentico, vissuto, che“spezza la costrizione del discorso storico”. Nella seconda “Considerazione inattuale”, che seguequesto testo ( Sull’utilità e il danno della storia per la vita ), N. chiarisce meglio ciò che cerca nell’esperienzadel vivente e, insieme, il suo rapporto con la storia, ponendo l’accento più sul danno di questa chesull’utilità. La giustificazione teorica di questo “sta nel fatto che la vita si oppone intimamente al saperestorico: la prima fiorisce nell’oblio, in una immersione totale nel presente, mentre il secondo si fondasulla memoria, sulla persistenza del ricordo. La vita storicizzata languisce, decade, si impoverisce, soffre,
si spegne: ‘è sempre una cosa sola quella per cui la felicità diventa felicità: il poter dimenticare o, conespressione più dotta, la capacità di sentire, mentre essa dura, in modo non storico.’ Questafondamentale prospettiva teoretica appartiene in modo originale a N., e la sua portata si estende assai aldi là della tematica della seconda Inattuale . Non è infatti soltanto il sapere storico a essere coinvolto daquesta condanna: tutta la scienza, la filosofia, forse anche l’arte, se si può dire che l’arte sia conoscenza,si fondano sulla memoria del passato, si differenziano dalla immediatezza della vita.” La presa didistanza di N. da ciò che la cultura dominante della sua epoca aveva come progetto non può essere piùradicale: “Chi pensa … che una innovazione politica basti a rendere gli uomini una volta per sempre
1“Nel linguaggio ordinario con il termine consonanza (dal latino consonare , "suonare insieme") si indica in genere un insieme
di suoni eseguiti simultaneamente e tali che l'effetto complessivo risulti morbido e gradevole, mentre con il terminedissonanza , all'opposto, si indica un agglomerato di suoni dall'effetto aspro e stridente. In realtà si definisce consonante unintervallo caratterizzato da "stasi armonica"(non ha bisogno di risolvere su un ulteriore intervallo), dissonante quell'intervalloche, all'orecchio, dà l'impressione di "movimento armonico", di dovere cioè risolvere su un intervallo consonante.…L'armonia wagneriana, che fu di capitale importanza per la storia della musica, portò la densità sonora media della tramaaccordale a un livello nettamente più alto rispetto alle generazioni precedenti. Mentre l'armonia precedente era cioè fondatasulla triade, l'armonia tardoromantica si fonda essenzialmente sulla quadriade. Ciò contiene già intrinsecamente unarivisitazione del concetto di dissonanza, in quanto non esiste una quadriade consonante formata da suoni temperati.”(Wikipedia) Ma si veda anche in Rouget la questione dello stile frigio e quello dorico, e la loro connessione con il vissutodella trance. L’opposizione del modo dorico, “armonia dell’Ellade europea” (di cui lo strumento principe è la cetra) a quellofrigio, musica degli auleti (i flautisti, NdR) della Frigia sta, tecnicamente, nel fatto che in un caso il modo è pentatonico senzamezzi toni, nell’altro diatonico a semitoni. Per Aristotele, il modo principe per determinare il “trasporto dionisiaco” è quellofrigio (Rouget G., 1986, Musica e transe. I rapporti tra musica e i fenomeni di possessione , Einaudi, Torino). C’è anche da ricordareche l’ortossia ecclesiastica medioevale, in Italia, proibiva il modo diatonico e canonizzava quello pentatonico; il primoessendo sospettato di collusione con Satana.2 Qui “misticismo” non ha niente a che vedere con l’abitare sfere trascendentali, metafisiche; ma, piuttosto, col frequentaregli ambiti profondi, misteriosi, del mondo vissuto.

8/12/2019 Pietro Coppo, Sulla Nascita Della Tragedia Di Nietzsche
http://slidepdf.com/reader/full/pietro-coppo-sulla-nascita-della-tragedia-di-nietzsche 2/11
2
soddisfatti abitatori della terra, merita davvero di essere professore di filosofia in un’università tedesca.”(466)
La parte per me essenziale del testo di N. è proprio quella che allude all’esperienza “mistica” vissuta,cerca di concettualizzarla e di trarne delle lezioni e conseguenze che indichino la via per praticarla. C’è
poi tutta una parte legata alla speranza del risorgere del dionisismo, dello spirito tedesco, illusione inparticolare sostenuta e animata dalla sua alleanza con Richard Wagner e con altri che, in quel passaggiocritico della Kultur mitteleuropea, dovevano pure, per continuare ad operare, immaginare una via diuscita. Questa manifestazione della (anche contingente) miseria umana, fa sempre da pendant alloslancio visionario; quando questo non sappia fermarsi ai suoi limiti. Condanna però allora chi ne èportato all’isolamento, a una afasia che si esaurisce in una esperienza intima, personale, inumana, perchénon condivisibile.
Quanto alla storia, appunto: il testo nasce da due conferenze tenute a Basilea nel 1870; riordinate earricchite con altro materiale, vengono pubblicate nel 1870 in una prima edizione, nel 1872 in unaseconda. Per un accenno al contesto, la Comune di Parigi, che segue la disfatta francese nella guerra
franco-prussiana, è del 1871; del 1899 è la pubblicazione de L’interpretazione dei sogni di S. Freud. Inquegli anni N. è professore a Basilea; il suo rapporto con i Wagner (Richard e Cosima) è stretto, con luiprefigura un progetto comune che riguarda, appunto, la rinascita dello “spirito tedesco”: preparanoinsieme “l’epoca dell’adempimento, l’epoca della civiltà di Bayreuth” (482). Wagner è entusiasta del suoscritto, che il maestro di N., Ritshl, giudica piuttosto una “stravaganza geniale”. Ma la salute di N. non èbuona, ha problemi agli occhi, e alcuni dei suoi amici temono anche per il suo equilibrio psichico per
via di sue manifestazioni ipocondriache e megalomaniache. Il rapporto con Wagner si deteriora, ancheperché N. non riesce a stare “normalmente” nella società che, a quell’epoca, contava e che invece iconiugi Wagner praticavano con successo. Per il Natale del 1874, Wagner scrive a N., preoccupato perla sua salute. A testimoniare la distanza che ormai c’è tra i due, non ha da proporgli di meglio cometerapia di un matrimonio, di evitare la solitudine e la frequentazione di altri uomini “ipocondriaci”. E
quindi: sposi una donna ricca, anche se brutta! (498)La fine della storia, almeno quella di N, è nota. Ciò a cui la semplice constatazione della pazzia chechiuse la sua esistenza fa torto, è il senso delle particolari espressioni che assunse: lui che danza nellasua casa, solo, nudo e col fallo eretto; lui che abbraccia piangendo, per le vie di Torino, il cavallo cadutosotto i colpi del vetturino che vorrebbe costringerlo a portare oltre il suo carico; lui che, nella cella delmanicomio, beve le proprie urine dal suo stivale.
Traccio qui un percorso attraverso il testo seguendo un mio personale interesse, tralasciando partimagari importanti, libero dalla preoccupazione di restare fedele al movimento e alla intenzionedell’Autore.
Dioniso e Apollo
N. pone a base del suo discorso l’opposizione, ma anche la necessaria complementarietà, del dionisiacoe dell’apollineo. Il primo è la musica e l’ebbrezza; il secondo il sogno, l’immagine, l’arte figurativa.Questa partitura iniziale può costituire quasi l’inizio di una psicologia.
Apollo è la magnifica, divina immagine del principium individuationis dai cui gesti e sguardi ci parla tutta lagioia e la saggezza della parvenza, insieme alla sua bellezza. Cita da Schopenhauer ( Mondo come volontà erappresentazione , I, 416): “ ‘Come un mare in furia che, sconfinato da ogni parte, solleva e sprofondamontagne d’onde, un navigante siede su un battello, confidando nella debole imbarcazione; cosìl’individuo sta placidamente in mezzo a un mondo di affanni, appoggiandosi e confidando nel
principium individuationis ….’ Nello stesso luogo Schopenhauer ci ha descritto l’immenso orrore che afferral’uomo, quando improvvisamente perde la fiducia nelle forme di conoscenza dell’apparenza, in quanto
il principio di ragione sembra soffrire un’eccezione in qualcuna delle sue configurazioni. Se a questoorrore aggiungiamo l’estatico rapimento che, per la stessa violazione del principium individuationis , saledall’intima profondità dell’uomo, anzi della natura, riusciamo allora a gettare uno sguardo nell’essenza

8/12/2019 Pietro Coppo, Sulla Nascita Della Tragedia Di Nietzsche
http://slidepdf.com/reader/full/pietro-coppo-sulla-nascita-della-tragedia-di-nietzsche 3/11
3
del dionisiaco, a cui ci accostiamo di più ancora attraverso l’analogia con l’ ebbrezza .” (24) Apollo quindicome difesa dal rischio dissolutivo portato dal dionisiaco. “Sotto l’incantesimo del dionisiaco non solosi restringe il legame tra uomo e uomo, ma anche la natura estraniata, ostile e soggiogata celebra dinuovo la sua festa di riconciliazione col suo figlio perduto, l’uomo. La terra offre spontaneamente i suoidoni, e gli animali feroci delle terre rocciose e desertiche si avvicinano pacificamente. Il carro di
Dioniso è tutto coperto di fiori e ghirlande: sotto il suo giogo si avanzano la pantera e la tigre.”(25) …“Ora, nel vangelo dell’armonia universale, ognuno si sente non solo riunito, riconciliato, fuso col suoprossimo, ma addirittura uno con esso, come se il velo di Maia fosse stato strappato e sventolasse ormaiin brandelli davanti alla misteriosa unità originaria.” (26)La “misteriosa unità originaria” è qui il ritorno indietro, al prima della differenziazione. Ma tra i Grecidionisiaci e i barbari dionisiaci3, c’è una diversità che indirizza il movimento in Grecia verso ilsuperamento della ripetizione. I barbari si davano a “…feste di sfrenatezza sessuale, le cui ondespazzavano via ogni senso della famiglia e dei suoi venerandi canoni; venivano qui liberate proprio lebestie più selvagge della natura, fino a quell’orribile miscuglio di voluttà e crudeltà”. Rispetto a questetendenze che provenivano dall’Oriente, Apollo e l’arte dorica costituiscono un baluardo. Ma poi,quando istinti simili emersero nella grecità, “Apollo tolse al pericoloso avversario, con una
riconciliazione conclusa al momento giusto, le armi annientatrici.” (28) Avvenne forse allora qualcosa di analogo a ciò che ha portato, tra ‘800 e ‘900, nel mezzo della crisi dellaMitteleuropa, mentre emergevano tendenze irrazionali e regressive (Schorske), la psicoanalisi a fare unpatto operativo con ciò che identificò come Inconscio. Sembrerebbe quasi che ogni volta che una culturasi sbilancia verso l’Apollineo (come nel ‘700 e con i Lumi) il Dionisiaco riemerga a volte in formeprogressive, a volte in forme conservatrici e regressive e obblighi a un nuovo patto destinato aculturalizzare in nuove forme il selvaggio, animando la cultura con forme più attuali, o comunque, nelleforme nuove che l’organizzazione di quella inedita, specifica esistenza umana permette. Da questaprospettiva gli “operatori culturali” (S. Freud, per esempio, ma anche il Socrate di cui parla più avantiN.) sarebbero mossi da una “immane ruota” che, attraverso i suoi attori, può essere contemplata “comeun’ombra” (92).
“Ma se consideriamo il manifestarsi della forza dionisiaca sotto l’influsso del trattato di pace, nell’orgiadionisiaca dei Greci ravvisiamo ora, paragonandola alle anzidette Sacee babilonesi e al regredire in essedell’uomo a tigre e a scimmia, il significato di feste di redenzione del mondo e di giorni ditrasfigurazione. Solo in essa la natura raggiunge il suo giubilo artistico, solo in essa la lacerazione del
principium individuationis diventa un fenomeno artistico. Quell’orribile filtro di streghe fatto di voluttà e dicrudeltà fu qui impotente: solo la meravigliosa mescolanza e duplicità delle passioni degli invasatidionisiaci ricorda – come i rimedi ricordano i veleni mortali – quel fenomeno in cui i dolori generanopiacere, in cui il giubilo strappa al petto voci angosciate. Dal sommo della gioia risuono il grido delterrore o lo struggente lamento per una perdita irreparabile. In quelle feste greche si manifesta come uncarattere sentimentale della natura, quasi che essa debba sospirare per il suo frammentarsi in individui.Il canto e la mimica di tali invasati dai duplici sentimenti furono per il mondo omerico dei Greci
qualcosa di nuovo e inaudito. In particolare suscitò in essi spavento e orrore la musica dionisiaca. … Lamusica di Apollo era architettura dorica in suoni, ma in suoni solo accennati, quali appartengono allacetra. E’ tenuto cautamente lontano, come non apollineo, proprio l’elemento che costituisce il caratteredella musica dionisiaca, e pertanto della musica in genre, la violenza sconvolgente del suono, la correnteunitaria della melodia, e il mondo assolutamente incomparabile dell’armonia. Nel ditirambo dionisiacol’uomo viene stimolato al massimo potenziamento di tutte le sue facoltà simboliche; qualcosa di maisentito preme per manifestarsi, l’annientamento del velo di Maia, l’unificazione come genio della specie,anzi della natura. Ora l’essenza della natura deve esprimersi simbolicamente; è necessario un nuovomondo di simboli…” (29-30)Per affermarsi in questo confronto, la cultura apollinea “dovrà anzitutto avere abbattuto tutto un regnodi Titani e ucciso mostri ed essere risultata vittoriosa, per mezzo di forti immagini chimeriche e di liete
illusioni, su una terribile profondità di contemplazione del mondo e una eccitabilissima capacità di3 Il dionisismo, inteso come culto di possessione selvatico e di trance, sarebbe penetrato in Grecia attraverso la Tracia
provenendo da culture sciamaniche siberiane (Rohde 1983, Doods 1995).

8/12/2019 Pietro Coppo, Sulla Nascita Della Tragedia Di Nietzsche
http://slidepdf.com/reader/full/pietro-coppo-sulla-nascita-della-tragedia-di-nietzsche 4/11
4
soffrire.” (34) “L’enorme diffidenza verso le forze titaniche della natura …. fu dai Greci ogni voltasuperata, o comunque nascosta e sottratta alla vista, mediante quel mondo artistico intermedio degli dèiolimpici. Fu per vivere che i Greci dovettero, per profondissima necessità, creare questi dèi…” (32) N.accenna qui al compito fondamentale della cultura: proteggere dal disperdimento nel caos, saperlotrasformare in materia, motore di un trascendimento che lo renda convocabile nelle esistenze umane
per il suo potere generativo e fecondante, e non per quello distruttivo, dissolvente. Conservandoneperò la potenza in forme culturali che sappiano non contenerla in toto (ciò che è impossibile), macontenerne in piccolo la qualità, di modo che possano costituire dei legami, dei nessi praticabili versoquella totalità indomabile. Si veda, anche in altre culture, l’instaurazione di un “mondo intermedio” traquello umano e quello delle “forze titaniche della natura”, abitato da forze e entità culturalizzabili einterpellabili.S. Freud, nella sua negoziazione con questa dimensione sub- e sovraumana, individuò per la cultura uncompito un po’ diverso. La relazione tra Io e Inconscio, e tra l’Io e l’Es richiederebbe una bonifica; ilcompito della cultura 4 sarebbe portare la luce là dove c’è ombra, o tenebre; la parola deve prendereposto là dove c’è caos primigenio, indicibile. Qui Freud dà prova di quell’ottimismo di cui parlerà poiN. più avanti, l’ottimismo della scienza; anche se permane in lui una ambiguità che lo porterà, tra l’altro,
a postulare poi l’istinto di morte.5
N. vede, come un possibile esito dell’interazione tra apollineo e dionisiaco, la “consolazione metafisica”lasciata alla fine in noi da ogni vera tragedia dionisiaca: la consapevolezza che “…in fondo alle cose la
vita è, a dispetto di ogni mutare della apparenze, indistruttibilmente potente e gioiosa; questaconsolazione appare in corposa chiarezza come coro di Satiri, come coro di esseri naturali che per cosìdire vivono incorruttibili dietro ogni civiltà e, nonostante ogni mutamento delle generazioni e dellastoria dei popoli, rimangono eternamente se stessi. 6” Questa “consolazione metafisica” ricorda laposizione di chi, avendo assunto la caducità delle forme esistenti, e avendo riconosciuto dietro a esse ilsenso del divenire e delle trasformazioni, si distacca dall’attaccamento alle apparenze: posizione propriaa tutta una tradizione, da Eraclito in poi, fino ad alcuni rappresentanti della “filosofia” orientale 7.
Da ciò che scrive, è evidente che N. conosceva per esperienza diretta lo “stato dionisiaco” e ciò chesignifica passare da questo a quello governato dalla “realtà quotidiana”: “L’estasi dello stato dionisiacocon il suo annientamento delle barriere e dei limiti abituali dell’esistenza contiene infatti, mentre dura,un elemento letargico, in cui si immerge tutto ciò che è stato vissuto personalmente nel passato. Così,per questo abisso di oblio, il mondo della realtà quotidiana e quello della realtà dionisiaca si separano.Ma non appena quella realtà quotidiana rientra nella coscienza, viene sentita con nausea come tale; unadisposizione ascetica, negatrice della volontà, è il frutto di quegli stati. In questo senso l’uomodionisiaco assomiglia ad Amleto: entrambi hanno gettato una volta uno sguardo vero nell’esistenza dellecose, hanno conosciuto, e provano nausea di fronte all’agire; giacché la loro azione non può mutare
4 Si veda, a proposito della ritualizzazione del disordine come funzione generale della cultura, in Coppo 2003 pp 162 e segg.
5 A proposito della relazione tra Io e Inconscio nel sistema freudiano, si veda la questione del senso della famosa frase Wo Es War, soll Ich Werden che rimanda alla strategia freudiana e può essere tradotta in due modi: a) Dove Esso (Es) era, là Iodevo voler subentrare; b) Dove Esso ( Es ) era, là Io devo voler addivenire. Werden infatti in tedesco può avere questo doppiosignificato: quello di divenire, al posto di ciò che c’era; e quello di andare ad abitare nella dimora dell’altro. A seconda dicome si intenda, cambia la strategia dell’intervento. Nel primo caso si tratta di una “riconversione adattiva”: come per unterreno che da agricolo si voglia trasformare in industriale. Nel secondo, di una “conversione messianica”. In uno Iosubentra al posto dell’ Es ; nella seconda, Io entra nel suo spazio per abitarlo (attraverso una negoziazione). In un caso l’Ioimpoverisce Es colonizzandolo; nel secondo la soggettività diviene in contiguità negoziale con l’ Es (da una lezione di SergioBenvenuto, Firenze, 19.9.10).6 Si veda, come esempio di un modello antropologico diverso da quello adottato dalla psicologia, l’idea del Sé come nonstorico in S. Kakar: “Le tecniche di meditazione delle scuole psicofilosofiche indiane di “autorealizzazione” a cui si potrebbeforse paragonare l’attività introspettiva sono di natura differente e hanno scopi radicalmente diversi. La massima indiana“conosci te stesso” ( atmanvidhi ) si riferisce a un Sé diverso da quello cui si riferisce Socrate. Si tratta di un Sé incontamninatodal tempo e dallo spazio e, pertanto, senza la dimensione storica della vita individuale che è al centro della psicoanalisi e dellaletteratura romantica occidentale.” (Kakar S. 1982 [1997] : 15)7 N. entra in contatto con il pensiero orientale anche attraverso Schopenahuer che, su suggerimento dell’orientalista Fr.
Majer, aveva letto le Upanisad indiane.

8/12/2019 Pietro Coppo, Sulla Nascita Della Tragedia Di Nietzsche
http://slidepdf.com/reader/full/pietro-coppo-sulla-nascita-della-tragedia-di-nietzsche 5/11
5
nulla nell’essenza eterna delle cose, ed essi sentono come ridicolo o infame che si pretenda da loro cherimettano in sesto il mondo che è fuori dai suoi cardini.” (55) E ancora, la rinascita del dionisiaco glipare necessaria visti gli effetti dell’individuazione lasciata a sé stessa: “…… una dottrina misterica dellatragedia: la conoscenza fondamentale dell’unità di tutto ciò che esiste, la concezione dell’individuazionecome causa prima del male, l’arte come lieta speranza che il dominio dell’individuazione possa essere
spezzato, come presentimento di una ripristinata unità.” (72) Ciò che qui N. chiama “arte” è una formadi conoscenza, esperienza, attività che ha come dimora gli “stati non ordinari di coscienza”, la “trance”,l’ “estasi” o come altro ancora si voglia chiamare quella esplorazione e pratica di un modo di esistenzafuori dallo stato ordinario, che non sia solo subito passivamente. Torna utile, qui, quella distinzione chetutti i culti di trance e possessione ancora attivi fanno tra estasi liturgiche e estasi selvagge. Le primeritualizzate, pratica sapiente di un andare altrove; le seconde scomposte e informi, sintomi di unamancanza, di un bisogno, di una eccedenza che cerca una via verso espressioni che consentano albisogno e alla ricerca di integrarsi nella dimensione individuale e collettiva. Qui, di nuovo, ilsuperamento del principium individuationis non avverrebbe per sua semplice negazione, ma per il suotrascendere a una esistenza dove possa animarsi per la potenza del simbolo e del mito assunti, si, in una“ripristinata unità”, ma di un tipo, a un livello del tutto inediti. 8
Allora, però, fu la commedia attica nuova a imporsi su quel dispositivo sapiente, capace di conservare laprofondità del mito, che per N. era la tragedia antica. Scalzando il mito presentificato nella tragedia,essa porta in scena gli spettatori: “…lo specchio, in cui prima venivano riflessi solo i tratti grandi earditi, mostrò ora quella meticolosa fedeltà che riproduce coscienziosamente anche le linee non riuscitedella natura.” (76). “Prendeva ora a parlare la mediocrità cittadina … la vita e la pratica comune, nota,quotidiana, di cui ognuno era capace di giudicare.” (77) La commedia attica nuova diventa un mezzoper costruire una massa filosofante, che con accortezza possa amministrare terre e beni, e saggiamentegiudicare e prendere decisioni. Euripide è, per N., l’autore che segna il passaggio.“… Euripide si era seduto in teatro e si era sforzato di riconoscere daccapo nei capolavori dei suoigrandi predecessori tratto su tratto, linea su linea, come in dipinti oscuratisi. E al riguardo gli era
accaduto quello che a chiunque sia iniziato ai più profondi misteri della tragedia eschilea non puòriuscire inaspettato: egli scorse in ogni tratto e in ogni linea qualcosa di incommensurabile, una certaingannevole determinatezza e insieme una enigmatica profondità, anzi un’infinità dello sfondo. Lafigura più chiara aveva ancor sempre dietro di sé una coda di cometa, che sembrava accennare aqualcosa di incerto e non rischiarabile. La stessa luce crepuscolare avvolgeva la struttura del dramma,specialmente il significato del coro. E quanto incerta rimase per lui la soluzione dei problemi etici!Quanto problematica la trattazione dei miti! Quanto sproporzionata la ripartizione della felicità edell’infelicità! Perfino nella lingua della tragedia antica c’era per lui molto di urtante, o almeno dienigmatico; in particolare egli trovava troppa pompa in situazioni semplici, troppe metafore e forzaturerispetto alla semplicità dei caratteri. Così egli sedette in teatro, stillandosi inquietamente il cervello, e daspettatore confessò a se stesso di non capire i suoi grandi predecessori. Ma poiché l’intelletto era da lui
considerato la vera e propria radice di ogni godimento e creazione, dovette guardarsi intorno e chiederese dunque nessuno pensasse come lui ed ammettesse ugualmente quell’incommensurabilità. …E inquesto stato tormentoso egli trovò l’ altro spettatore , che non capiva la tragedia e perciò non l’apprezzava.In lega con costui, egli poté osare di uscire dal suo isolamento e iniziare l’immane lotta contro le opered’arte di Eschilo e Sofocle – non con scritti polemici, bensì come poeta drammatico che contrappone lasua concezione della tragedia a quella tramandata.” (81-82) Euripide lavorò così per scacciare dallatragedia quell’elemento dionisiaco originario e potente. Al posto del dramma che nasceva nellamisteriosa luce crepuscolare del dionisiaco, divenne il poeta dell’ epos drammatizzato, che non puòfondersi appieno con le sue immagini, che è sempre in contemplazione calma e immota, e vede leimmagini davanti a sé. “In questo epos drammatizzato l’attore rimane nella più profonda essenza ancora
8 Torna forse utile, qui, un modello del divenire storico non come retta ascendente, che supera in ogni punto,definitivamente, i punti precedenti; né come circolo dell’eterno ritorno, dove a ogni punto si ritorna; ma come spirale, in cui,a ogni spira, si torna in prossimità del punto precedente, ma con uno slivellamento significativo, che è quello del tempo e delprocesso trascorsi.

8/12/2019 Pietro Coppo, Sulla Nascita Della Tragedia Di Nietzsche
http://slidepdf.com/reader/full/pietro-coppo-sulla-nascita-della-tragedia-di-nietzsche 6/11
6
rapsodo; tutte le azioni sono consacrate da un sognare interiore, sicché egli non è mai completamenteattore.” (84) “Così il dramma euripideo è una cosa insieme triste e focosa, ugualmente capace diagghiacciare e infiammare; per esso è impossibile raggiungere l’effetto apollineo dell’ epos , mentre d’altraparte si è liberato il più possibile degli elementi dionisiaci e ora ha bisogno, per esercitare comunque uneffetto, di nuovi mezzi di eccitamento, che però non possono più trovarsi nella sfera dei due soli
impulsi artistici, l’apollineo e il dionisiaco. Questi mezzi di eccitamento sono pensieri freddi e paradossali – e passioni roventi - in luogo delle intuizioni apollinee – più precisamente, pensieri e passioni imitati inmodo estremamente realistico, niente affatto immersi nell’etere dell’arte.”
Socrate
L’alleato che Euripide trovò in questo suo lavoro e che parlava per la sua bocca fu una divinità che nonera né Dioniso né Apollo, “bensì un demone di recentissima nascita, chiamato Socrate .” (83) “Finchél’unico ordinatore e reggitore del tutto, il nus 9, era ancora escluso dal creare artistico, tutto rimanevasempre in un caos originario; così dovette giudicare Euripide, così lui, primo poeta ‘sobrio’, dovette
condannare i poeti ‘ebbri’. Euripide si accinse a mostrare al mondo, come anche fece Platone, l’oppostodel poeta ‘irragionevole’; il suo principio estetico ‘tutto deve essere cosciente per essere bello’ è … laproposizione parallela al precetto socratico ‘tutto deve essere cosciente per essere buono’. 10 …riconosciamo in Socrate l’avversario di Dioniso, il nuovo Orfeo che si leva contro Dioniso e, benchédestinato a essere dilaniato dalle Menadi del tribunale ateniese, costringe alla fuga il potentissimo dio.Quest’ultimo, come nel tempo in cui era fuggito di fronte al re degli Edoni Licurgo, si salva nelleprofondità del mare, cioè nei flutti mistici di un culto segreto, che a poco a poco invaderà il mondointero.” (89)
Ora la mèta superiore, sapere in quanto si “è coscienti”, è quella dei “sapienti”, quelli che sanno perluce chiara. “… La parola più acuta per quella nuova e inaudita stima del sapere e dell’intelligenza la
pronunciò Socrate, quando trovò di essere l’unico che ammettesse di non saper niente ; mentre, nelle sueperegrinazioni critiche per Atene, egli incontrava dappertutto, parlando con i maggiori statisti, oratori,poeti, e artisti, la presunzione del sapere. Vide con stupore che tutte quelle celebrità non avevanoun’idea giusta e sicura neanche della loro professione, e che la esercitavano solo per istinto. ‘Solo peristinto’: con questa espressione tocchiamo il cuore e il centro della tendenza socratica.” Dovunque ilsocratismo si volga, “… vede la mancanza di intelligenza e la potenza dell’illusione, e da questamancanza deduce l’intima assurdità e riprovevolezza di quanto esiste nel presente. Partendo da questopunto, Socrate credette di dover correggere l’esistenza: egli, come individuo isolato, entra con aria disprezzo e di superiorità, quale precursore di una cultura, di un’arte e di una morale di tutt’altra specie, inun mondo dove ascriveremmo a nostra massima fortuna il riuscire a coglierne con venerazione unframmento…. Chi è costui, che osa da solo negare la natura greca …? Quale forza demoniaca è questa,
che può ardire di rovesciare nella polvere un tale filtro incantato? Quale semidio è questo… ?” (90-91)“Una chiave per spiegare la natura di Socrate ci viene offerta da quel miracoloso fenomeno che vieneindicato come ‘demone di Socrate’. In situazioni particolari, in cui il suo prodigioso intelletto vacillava,egli trovava un saldo sostegno grazie a una voce divina che in tali momenti si faceva udire. Questa voce,quando viene, dissuade sempre. La saggezza istintiva si mostra in questa natura assolutamente abnormesoltanto per contrastare qua e là, ostacolandolo, il conoscere cosciente. Mentre in tutti gli uominiproduttivi l’istinto è proprio la forza creativa e affermativa, e la coscienza si comporta in maniera criticae dissuadente, in Socrate l’istinto si trasforma in un critico, la coscienza in una creatrice – una veramostruosità per defectum ! Più precisamente noi scorgiamo qui un mostruoso defectus di ogni disposizionemistica, sicché Socrate sarebbe da definire come l’individuo specificamente non mistico, in cui la naturalogica, per una superfetazione, è sviluppata in modo tanto eccessivo quanto lo è quella sapienza istintiva
del mistico.” (91) L’“istinto logico” che si manifesta in Socrate mostra, nel suo “sfrenato sgorgare”, la9 Nòos : mente, intelletto, pensiero, intenzione [NdR].
10 Qui torna, nuovamente, l’analogia con il Es War, soll Ich Werdenfreudiano (si veda in nota 4).

8/12/2019 Pietro Coppo, Sulla Nascita Della Tragedia Di Nietzsche
http://slidepdf.com/reader/full/pietro-coppo-sulla-nascita-della-tragedia-di-nietzsche 7/11

8/12/2019 Pietro Coppo, Sulla Nascita Della Tragedia Di Nietzsche
http://slidepdf.com/reader/full/pietro-coppo-sulla-nascita-della-tragedia-di-nietzsche 8/11
8
piramide sorprendentemente alta del sapere presente, non può trattenersi dal vedere in Socrate il puntodecisivo e il vertice della cosiddetta storia universale.” (102-103)“ …Socrate è il prototipo dell’ottimista teorico che, con la menzionata fede nell’attingibilità della naturadelle cose, concede al sapere e alla conoscenza la forza di una medicina universale e vede nell’errore ilmale in sé. Penetrare in quelle profondità e sceverare la vera conoscenza dall’illusione e dall’errore
sembrò all’uomo socratico la missione più nobile, anzi l’unica missione veramente umana; allo stessomodo quel meccanismo di idee, giudizi e sillogismi fu stimato da Socrate in poi al di sopra di tutte lealtre facoltà, come suprema attività e ammirevolissimo dono di natura. Perfino i fatti morali più sublimi,i moti della compassione, dell’abnegazione, dell’eroismo e quella tranquillità dell’anima così difficile daraggiungere e che il Greco apollineo chiamava sophrosyne , derivano secondo Socrate e i suoi seguaci esimpatizzanti sino ad oggi, dalla dialettica del sapere, e sono considerati in conformità comeapprendibili. Chi ha sperimentato in sé il piacere di una conoscenza socratica e sente come essa cerchidi abbracciare, in anelli sempre più vasti, l’intero mondo dei fenomeni, non avvertirà da allora in poinessun pungolo che possa spingere alla vita più fortemente della brama di perfezionare quella conquistae di intessere la rete in modo impenetrabilmente saldo. A uno così disposto il Socrate di Platone appareallora come il maestro di una forma tutta nuova di ‘serenità greca’ e di beatitudine di esistere, che cerca
di effondersi in azioni e indirizza queste effusioni per lo più in influenze maieutiche ed educative sunobili giovani, allo scopo della produzione finale del genio.Peraltro la scienza, spronata dalla sua robusta illusione, corre senza freno fino ai suoi limiti, dovel’ottimismo insito nell’essenza della logica naufraga. Infatti la circonferenza che chiude il cerchio dellascienza ha infiniti punti, e mentre non si può ancora prevedere come sarà mai possibile misurareinteramente il cerchio, l’uomo nobile e dotato giunge a toccare inevitabilmente, ancor prima di giungerea metà della sua esistenza, tali punti di confine della circonferenza, dove guarda fissamentel’inesplicabile. Quando egli vede qui con terrore come la logica in questi limiti si torca intorno a sestessa e si morda infine la coda, - ecco che irrompe la nuova forma di conoscenza, la conoscenza tragica ,la quale, per poter essere sopportata, ha bisogno dell’arte come protezione e rimedio.” (102-103).“Qui ci preme il problema di stabilire se la potenza, per la cui azione contraria la tragedia si infranse,
avrà in ogni tempo abbastanza forza da impedire il risveglio artistico della tragedia e della concezionetragica del mondo. Se la tragedia antica fu spinta fuori dal suo binario dall’impulso dialettico verso ilsapere e l’ottimismo della scienza, da questo fatto si potrebbe dedurre un’eterna lotta tra la concezionedel mondo teoretica e quella tragica; e solo dopo che lo spirito della scienza fosse stato condotto ai suoilimiti estremi, e la sua pretesa di validità universale fosse stata distrutta dalla dimostrazione di queilimiti, si potrebbe sperare in una rinascita della tragedia: a simbolo di questa forma di culturadovremmo porre Socrate musicista, nel senso in precedenza discusso. In questa contrapposizioneintendo per spirito della scienza la fede, venuta in luce per la prima volta con la persona di Socrate,nella possibilità di attingere la conoscenza della natura e nell’efficacia risanatrice universale del sapere.Chi ricorda le conseguenze immediate di codesto spirito della scienza che si spinge instancabilmente inavanti, immaginerà subito come il mito fu da esso distrutto e come attraverso questa distruzione la
poesia fu scacciata dal suo naturale terreno ideale, risultando ormai senza patria.” (113) Per N., daSofocle in poi lo spettatore non partecipa più al mito, ma sente la potente verità naturalistica e la forzadi imitazione dell’artista; e nel modo più chiaro il nuovo spirito antidionisiaco si rivela nella conclusionedei nuovi drammi, dove alla “consolazione metafisica” subentra il deus ex machina che ricompensa e fagiustizia, pedagogo rassicurante e moralizzante.La tendenza più nobile, meno demagoga, di quell’altra forma di “serenità greca” è invece l’uomoteoretico, la cultura alessandrina. “Tutto il mondo moderno è preso nella rete della cultura alessandrinae trova il suo ideale nell’uomo teoretico, che è dotato di grandissime forze conoscitive e lavora alservizio della scienza, e di cui Socrate è il prototipo e il capostipite. Tutti i nostri mezzi educativitengono originariamente davanti agli occhi questo ideale : ogni altra esistenza deve lottare faticosamenteper sollevarsi accanto a quella, come esistenza permessa, non come esistenza voluta. In un senso quasi
spaventoso, per lungo tempo si è trovato a questo riguardo l’uomo di cultura solo nella formadell’erudito… A un vero Greco come dovrebbe apprire incomprensibile Faust, l’uomo di culturamoderno in sé comprensibile, il Faust che si precipita insoddisfatto attraverso tutte le discipline, dedito

8/12/2019 Pietro Coppo, Sulla Nascita Della Tragedia Di Nietzsche
http://slidepdf.com/reader/full/pietro-coppo-sulla-nascita-della-tragedia-di-nietzsche 9/11
9
alla magia e al diavolo per brama di sapere, che ci basta mettere a confronto con Socrate per vederecome l’uomo moderno cominci ad avere sentore dei limiti di quel piacere socratico per la conoscenza, ecome dal vasto e deserto mare del sapere aneli a una costa!...” (119)Nel grembo della cultura socratica lievita un ottimismo senza limiti, la fede nella felicità terrena pertutti. Questa cultura, la cultura alessandrina, ha però bisogno di un classe di schiavi; tuttavia “ … essa,
nella sua concezione ottimistica dell’esistenza, nega la necessità di una tale classe e va perciògradualmente incontro, quando sia esaurito l’effetto delle sue belle parole di seduzione e dirassicurazione della ‘dignità dell’uomo’ e della ‘dignità del lavoro’, a un’orrenda distruzione. Non c’èniente di più terribile di una classe barbarica di schiavi che abbia imparato a considerare la sua esistenzacome un’ingiustizia e che si accinga a far vendetta non solo per sé, ma per tutte le generazioni. …Mentre la sventura sonnecchiante in grembo alla cultura teoretica comincia gradualmente ad angustiarel’uomo moderno, …. ecco che grandi nature con doti universali hanno saputo utilizzare con incredibileavvedutezza l’apparato della stessa scienza, per mostrare in genere i limiti e la natura condizionata dellaconoscenza e per negare in tal modo decisivamente la pretesa della scienza a una validità universale e ascopi universali; mediante questa dimostrazione è stata riconosciuta per la prima volta come talequell’illusione che si arroga di poter scrutare , sulla base della causalità, l’intima essenza delle cose.” 11
(121) Essi hanno elevato “a meta suprema, in luogo della scienza la sapienza, la quale, senza farsiingannare dalle seducenti deviazioni delle scienze, si volge con immobile sguardo all’immagine totale delmondo, cercando di cogliere in essa, con simpatetico sentimento di amore, l’eterna sofferenza comesofferenza propria.” (122)“Ma dopo che la cultura socratica è stata scossa da due lati e può sostenere ormai lo scettrodell’infallibilità solo con mani tremanti, da un lato cioè dalla paura delle sue stesse conseguenze, checomincia finalmente a presentire, e dall’altro perché essa stessa non è più convinta dell’eterna validitàdel suo fondamento con l’ingenua fiducia di prima, è ora un triste spettacolo vedere come la danza delsuo pensiero si precipiti con desiderio ardente verso forme sempre nuove, per abbracciarle, e comeinorridendo le lasci di nuovo improvvisamente andare, come Mefistofele fa con le Lamie tentatrici. …Il segno caratteristico di quella “rottura”, di cui tutti sogliono parlare come del male primo della cultura
moderna, sta appunto in questo, che l’uomo teoretico si spaventa delle conseguenze da lui prodotte e,insoddisfatto, non osa più affidarsi al terribile fiume ghiacciato dell’esistenza: angosciosamente eglicorre su e giù per la riva. Non vuole più avere niente interamente, interamente anche con tutta lanaturale crudeltà delle cose. La concezione ottimistica l’ha rammollito fino a questo punto. Inoltre essosente come una cultura che si sia costruita sul principio della scienza debba perire quando comincia adiventare illogica , vale a dire a rifuggire dalle proprie conseguenze. … egli rimane l’eterno affamato, il“critico” senza piacere e senza forza, l’uomo alessandrino, che è in fondo un bibliotecario o unemendatore, e si acceca miseramente sulla polvere dei libri e sugli errori di stampa.” (123) “E oral’uomo senza miti sta, eternamente affamato, in mezzo a tutti i passati, e scavando e frugando cercaradici, a costo di scavare per questo nelle antichità più remote.” (152) Al vertice del presente “la stessaeccessiva brama di sapere, la stessa insaziata felicità di scoprire, la stessa mostruosa mondanizzazione, e
accanto a ciò un vagare senza patria, un avido accalcarsi a tavole straniere, una frivola divinizzazione delpresente oppure un ottuso e intontito distacco”, sintomi di una “deficienza nel cuore” di questa cultura. A partire da qui inizia per N. la prospettiva della speranza. Che la potenza del simbolo e del mito sia dinuovo iniettabile in quel mondo e che lo spirito tedesco sia riconvocabile nella società disanimata cheosservava; che Richard Wagner e la sua musica potessero avere in questo un ruolo di primo piano, tuttoquesto era una speranza, una illusione, una visione; e per di più fallace e pericolosa come poi la storia, eanche l’evoluzione della relazione tra N. e Wagner, hanno dimostrato.
Qualche suggerimento
Il pensiero di N. e ciò di cui in questo testo si occupa, la tragedia greca, il suo divenire e l’affermarsi
dell’ “uomo teoretico” attraverso la figura di Socrate, possono essere di qualche interesse per il lavoroin cui alcuni di noi sono impegnati. Siamo anche noi, a partire dalle nostre particolari posizioni
11 Qui N. si riferisce a Kant e Schopenauer

8/12/2019 Pietro Coppo, Sulla Nascita Della Tragedia Di Nietzsche
http://slidepdf.com/reader/full/pietro-coppo-sulla-nascita-della-tragedia-di-nietzsche 10/11
10
disciplinari, mossi dalla “immane ruota” che animò, per N., anche il genio e il lavoro di Socrate? Nellecondizioni del presente precipita la crisi dell’egemonia della cultura occidentale, a concludere quella che,alla fine dell’800, segnò la fine dell’egemonia dellaKultur mitteleuropea. N. ci dà qualche suggerimento,elevandosi al di sopra della particolarità delle singole crisi, per leggere ciò che motiva il lavoro dellacultura e per pensare i fondamenti di una psicologia capace di non restare chiusa nelle forme che le ha
dato lo specifico ambiente in cui è stata istituita.Il motore, l’immane ruota, è quello del divenire. Lo sforzo umano dovrebbe essere quello di essereaderente ad esso: di essere il più possibile in sintonia con esso, non di staccarsene, né tanto meno dicercare di dominarlo. L’intenzione civilizzatrice deve in questa ottica lasciare l’ottimismo scientifico,l’intenzione di un impossibile controllo e dominio, e cercare piuttosto il modo di abitare, umanizzare,ciò che immediatamente circonda l’esistenza umana, rendendola il più possibile spessa, sicura,soddisfacente, godibile. E’ ciò che fanno, in tutto il mondo, gruppi umani non ancora assoggettati daciò che l’ottimismo scientifico, e le sue declinazioni tecniche, hanno generato.La psicologia che abbiamo ereditato dal ‘900 è tutta intrisa dall’ideologia e dall’intenzione scaturite dallaparticolare storia dalla quale veniamo. Non ci serve più, e anzi la respingiamo come pericolosa. Si trattadi provare a pensare – a pensarci – altrimenti.
N. offre per questo degli spunti. Descrive il divenire, il suo manifestarsi nella sfera propria alla Specieumana, la cultura, come incluso in una coppia di opposti: il dionisiaco e l’apollineo. Apollineo è il movimento dell’individuazione, grazie al quale si può raggiungere la liberazionenell’illusione delle forme; mentre il “mistico grido di giubilo di Dioniso” spezza la catenadell’individuazione “e apre la via verso le Madri dell’essere, verso l’essenza intima delle cose”, verso la
vita eterna che sta dietro la caducità delle forme, dietro le apparenze e la loro dissoluzione. Qui “…l’eroe, la più alta apparenza della volontà, viene con nostra gioia negato, perché è comunque soloapparenza, e la vita eterna della volontà non viene toccata dalla sua distruzione. … dobbiamo cercare[l’eterna gioia dell’esistenza] … non nelle apparenze, ma dietro le apparenze, … le innumerevoli formedi esistenza … Malgrado il dolore e la compassione, noi viviamo in modo felice, non come individui, inquanto siamo quell’unico vivente, con la cui gioia generativa siamo fusi.” (105) N. qui dà prova di una
chiara competenza “mistica”, o addirittura sciamanica: l’esperienza diretta della dissoluzione delle formee del loro trasmutarsi incessante che sta loro dietro, “strabocchevole fecondità della volontà delmondo.” Questa esperienza, come quella del mito, “non trova affatto nella parola la sua oggettivazioneadeguata.”La dialettica che motiva la storia culturale e che suggerisce, in un suo possibile equilibrio, uncompimento umano (una via per la salute) è dunque, per N., questa. Da un lato la frequentazione,attraverso forme culturali ritualizzate (come lo fu la tragedia greca) del mondo caotico, primigenio, incui tutto è immerso. In prossimità con quel mondo le apparenze conservano, e si tirano dietro comecode di comete, le loro ombre. Questa esperienza spessa, in buona parte ineffabile, penetrata da simbolie miti, è “mistica” nel senso che è in contiguità con il mistero; ed è essa ad animare una componenteessenziale degli umani. Qui non c’è distinzione tra corpo e spirito, tra uomo e uomo, tra vivente e
vivente: vi si accede, per esempio, con la danza, con la musica e più in generale attraverso le svariate“tecnologie del sacro”. Si tratta di esperienze estatiche, di transe (transiti attraverso le soglie) chescardinano i contenitori rigidi nei quali l’individuo rischia di trovarsi rinserrato, se esposto a unaindividuazione troppo sbilanciata sul registro del giorno, dell’ordine, della rassicurazione, della difesa daciò che è mobile, inafferrabile, incontrollabile.Dall’altro, il lavoro apollineo della messa in forma, in primis nella forma della parola, o in quelladell’immagine scolpita o dipinta, o in una delle infinite espressioni della cultura. Questo mirabile lavorosquisitamente umano, per N. è il lavoro dell’arte. Solo se questi due dimensioni (l’esperienza bruta e lasua integrazione) si nutrono immediatamente l’una dell’altra, permane la solidarietà, la vicinanza con ilfenomeno della vita, espressione del perenne divenire.Il principium individuationis in opera, senza un suo continuo ri-circolare nella dimensione della
dissoluzione delle forme, e quindi senza esporsi perennemente alla prospettiva della morte dell’Io, siorganizza come difesa, che impedisce l’esperienza del vivente. E’ quello che sanno tutti gli sciamani o

8/12/2019 Pietro Coppo, Sulla Nascita Della Tragedia Di Nietzsche
http://slidepdf.com/reader/full/pietro-coppo-sulla-nascita-della-tragedia-di-nietzsche 11/11
11
gli iniziati che vivono per sé, e propongono ad altri in forme ritualizzate, il passaggio nella notte, nellatranse, nella morte.
Venti anni dopo La nascita della tragedia , nel pieno della crisi del liberalismo mitteleuropeo, e un annoprima della morte di N., S. Freud pubblicherà L’interpretazione del sogni . Incontrerà e instaurerà così il suo
“Inconscio” a partire dal rimosso della società borghese dell’epoca. Ma quale differenza tra questo e ciòche N. voleva convocare! L’Altro che Freud incontra e pratica sta in un orizzonte borghese, scientista(in perenne ricerca, cioè, di autenticazione da parte della Scienza) e giudeo-cristiano. E’ perciò tuttaun’altra cosa da ciò che N. aveva incontrato, e praticato. E, infatti, le caratteristiche e le intenzioni di ciò
verso cui l’uno e l’altro erano andati incontro 12 erano talmente diverse da portare i due uomini a destiniopposti. Uno alla solitudine, la marginalità e la follia; l’altro al successo mondano, agli onoridell’Accademia e alla fondazione di una Scuola.Intanto, l’ “immane ruota” continua il suo giro.
12 Facendo un “salto lontano dalla terraferma delle nostre evidenze, verso qualcosa di cui abbiamo fiducia che ci verrà
incontro, che potrebbe venirci incontro” (W. James, cit. in Stengers 2009: 31-32)