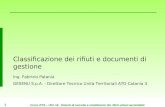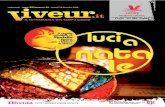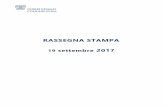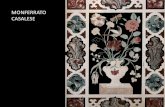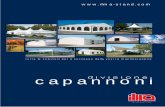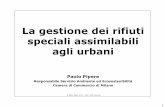pag.89-100 INTRODUZIONE ALLE ANTENNE · PDF filegrowth of the digital ... Per un ambiente di...
-
Upload
nguyendiep -
Category
Documents
-
view
216 -
download
3
Transcript of pag.89-100 INTRODUZIONE ALLE ANTENNE · PDF filegrowth of the digital ... Per un ambiente di...

89
S ommario: la richiesta di banda larga nelle
reti di telecomunicazioni ha avuto, in questi
ultimi anni, un’impennata prevedibile dopo lo svi-
luppo delle moderne tecniche di trasmissione digi-
tale che ha consentito l’offerta di contenuti multi-
mediali molto attraenti. Nelle applicazioni che
richiedono la mobilità, il mezzo radio è insostitui-
bile ma le disponibilità dello spettro sono limitate.
E’ d’obbligo quindi sfruttare al meglio questa risor-
sa scarsa e preziosa. La tecnica delle antenne adat-
tative fornisce uno strumento per rendere otti-
mizzabile e dinamica la capacità delle antenne nel
discriminare spazialmente le sorgenti utili o per
illuminare solo le zone interessate al collegamen-
to. Il principio di base, che viene brevemente
richiamato, è quello delle schiere di antenne con
parametri di alimentazione controllabili.
L’applicazione sembra immediata ma la sfida tec-
nologica è ancora aperta.
Abstract: the demand for bandwidth in tele-
communication networks has increased in
recent years in a predictable way, considering the
growth of the digital transmission techniques that
allowed the provision of very attractive multime-
dia content. Radio is irreplaceable for every mobi-
le application but spectrum is limited. So it is an
obligation to exploit carefully this scarce and most
valuable resource. Adaptive antennas provide a
tool for optimizing in a dynamic way antennas abi-
lity to select spatially only the wanted transmitters
or to light only the wanted receivers. The basic
principle is that of antenna arrays with control of
feeding parameters. Despite the apparent easy
application to adaptive systems, technological
challenge is still open.
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA
EElliioo RReessttuucccciiaa
(Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - ISCTI)
IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE AALLLLEE AANNTTEENNNNEE AADDAATTTTAATTIIVVEEUna tecnica innovativa in ausilio all’uso ottimale dello spettro radio
per l’accesso alla rete tlc a banda larga
AADDAAPPTTIIVVEE AANNTTEENNNNAASS:: AANN IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN
An innovative technique to improve the radio spectrum
optimal use for broadband wireless access
11 IInnttrroodduuzziioonnee
Le tecniche di comunicazione via radio si sono
evolute in questo ultimo mezzo secolo in modo
rapido e sostanziale.
Queste hanno vissuto il contemporaneo svilup-
po della tecnologia dei dispositivi ottici e delle
fibre ottiche che ha consentito l’offerta di banda
larghissima di trasmissione e la conseguente offer-
ta di grande capacità, in termini di quantità di infor-
mazione trasmessa nell’unità di tempo, stimolando
la proliferazione di servizi di comunicazione sem-
pre più ricchi di prestazioni innovative ambiziose.
Le comunicazioni via radio, che tradizionalmen-
te coprivano le necessità delle medie e grandi
distanze e marginalmente le necessità delle brevi
distanze, si sono viste gradatamente sottrarre
importanza dall’agguerrita concorrenza dei sistemi
su supporto fisico.
Neanche la rivoluzione dirompente delle tecni-
che digitali, nei sistemi di modulazione e demodu-
lazione radio come anche nei sistemi di processa-
mento dei segnali, è riuscita a vincere la battaglia
della concorrenza con il supporto fisico, essendo la
limitazione della risorsa spettrale un fattore deter-
minante ed inevitabile.
Le grandi infrastrutture di connessione in fibra
ottica a lunga distanza sia nazionali che internazio-
nali hanno relegato i collegamenti in ponte radio a
microonde a sistemi di supporto e di riserva, i col-
NNOO
TTEE

legamenti radio intercontinentali in onda corta
sono stati gradatamente dismessi e sostituiti dai
sistemi via satellite e dai numerosi collegamenti via
cavo transoceanici sottomarini.
I centri di radiodiffusione sonora a grande
distanza in onda corta, come anche quelli in onda
media per la copertura di aree regionali, sono sem-
pre meno numerosi a causa dei timori sollevati di
recente in merito ai possibili effetti dell’esposizio-
ne a forti campi elettromagnetici delle zone abita-
te in prossimità dei centri di trasmissione e dell’al-
to costo che rappresentano per gli enti gestori.
A ciò si aggiunge l’interesse via via decrescente
che tali trasmissioni riscuotono in un pubblico che
trova più facile reperire gli stessi contenuti, con
qualità migliore, navigando in internet.
Il mezzo radio però continua oggi ad essere uti-
lizzato intensamente nei contesti nei quali non è
ancora economicamente utile sostituirlo, come ad
esempio nel caso di quei collegamenti, per lo più di
limitata lunghezza, all’interno della rete pubblica e
privata di telecomunicazione, in ambito urbano e
semi-urbano, per i quali è difficile e costosa la posa
di cavi.
Un altro esempio è quello della radiodiffusione
televisiva per cui è indispensabile la pervasività del
segnale destinato ad una pluralità di utenti il più
variamente distribuiti sul territorio e non ancora
servita da una rete in cavi sufficientemente capilla-
re.
Ma vi è un caso in cui il mezzo radio è insosti-
tuibile e che gli è fondamentalmente naturale : il
servizio mobile, nell’ambito del quale viene oggi
massicciamente utilizzato.
Si è visto quindi ribaltare la situazione prece-
dente riguardo le comunicazioni via radio, che pur
essendo ancora utilizzate per coprire le medie e
grandi distanze hanno assunto maggiore popolari-
tà per coprire le necessità delle brevi distanze ed
in particolare per permettere libertà di movimen-
to all’utente.
Ciò è testimoniato dall’enorme successo otte-
nuto dalla telefonia radiomobile cellulare che con-
sente a chiunque, dotato di un apparecchio porta-
tile di piccole dimensioni, di mantenersi connesso
alla rete pubblica quasi dappertutto ed in movi-
mento sul territorio nazionale ed anche all’estero,
grazie a collegamenti a breve distanza che si per-
dono e si ricostituiscono tra una cella e l’altra in
modo trasparente per l’utente.
Un altro caso ancora in pieno sviluppo è quello
dei cosiddetti sistemi “wireless” che permettono
l’accesso alla rete anche a larga banda (BWA,
Broadband Wireless Access) che significa l’accesso
a servizi come la connessione internet, la telefonia,
la trasmissione multimediale audio-video ecc.
E’ in questo contesto che l’evoluzione delle tec-
niche ha determinato una nuova forma del sistema
complessivo di telecomunicazione via radio rispet-
to alle forme tradizionali dei decenni scorsi.
22 LL’’aacccceessssoo aallllaa rreettee aa llaarrggaa bbaannddaa
La diffusione di apparati WAS/RLAN (Wireless
Access Systems / Radio Local Area Networks) a
basso costo per la connessione di personal com-
puter fra loro ed alla rete pubblica di tlc, con dis-
ponibilità tra l’altro di connessione internet e di
posta elettronica, ha avuto uno sviluppo rapidissi-
mo e di conseguenza le bande di frequenze previ-
ste per tale uso si sono, in alcuni casi, rivelate insuf-
ficienti a smaltire il traffico richiesto con le presta-
zioni attese.
E’ questo il caso delle bande 2400-2483.5 MHz,
5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz in cui, nel
rispetto dei requisiti tecnici e d’impiego imposti, si
opera in regime di libero uso.
Il piano nazionale di ripartizione delle frequen-
ze prevede che i servizi operanti in queste bande
“devono accettare i disturbi pregiudizievoli che
possono verificarsi a causa delle citate applicazio-
ni. Ogni misura praticamente possibile deve esse-
re adottata per assicurare che le irradiazioni delle
apparecchiature usate per tali applicazioni siano
minime....” ed inoltre che “tali utilizzazioni non
debbono causare interferenze ai collegamenti dei
servizi presenti in tabella, né possono pretendere
protezione da tali utilizzazioni.”
Le apparecchiature radio devono quindi funzio-
nare con tali limitazioni per un’utenza che diviene
sempre più esigente e sempre meno tollerante
verso i fuori servizio, le interruzioni o i rallenta-
menti nella trasmissione dei dati.
Benché di piccola potenza e apparentemente di
prestazioni ridotte, molte delle loro funzioni sono
gestite in modo automatico da microcontrollori il
cui software risponde alle esigenze dei protocolli
di comunicazione previsti da standard concordati a
livello internazionale.
Tutto ciò porta ad escogitare strategie proget-
tuali ardite per strappare qualche decibel di miglio-
90
NNOO
TTEE Elio Restuccia
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA

91
ramento sulle prestazioni complessive dei sistemi
di ricetrasmissione nella continua lotta tra veloci-
tà di trasmissione e impegno di banda compatibil-
mente con la robustezza nei confronti del rumore
e con la sensibilità disponibile del ricevitore e gio-
cando il miglior compromesso tra inquinamento
dello spettro radio e potenza trasmessa.
Una velocità di trasmissione più elevata richie-
de, a parità di banda disponibile e di ambiente in
cui avviene la propagazione, uno schema di modu-
lazione più complesso e di conseguenza un miglio-
re rapporto segnale rumore, dove qui per rumore
si intende quello complessivo costituito dalla
somma del rumore del ricevitore più quello pro-
veniente dall’esterno compreso il contributo di
eventuali segnali interferenti.
Questo può richiedere a sua volta una potenza
irradiata maggiore lato trasmissione oppure un
ricevitore con livello del segnale di soglia più basso
lato ricezione o ambedue le cose.
Il livello di potenza irradiata lato trasmissione,
inteso come prodotto della potenza fornita dal
trasmettitore per il guadagno d’antenna, è limitato
dalla normativa per cui gli studi sul miglioramento
delle prestazioni di sistema si concentrano sulle
caratteristiche del ricevitore e sulle tecniche di
codifica, in particolare quelle di canale, che com-
portano anche algoritmi di correzione degli errori
sempre più potenti.
Moltissimi studi sono stati fatti in questi campi
ed hanno permesso, in tempi moderni, grandi passi
avanti.
Ma la lotta non è terminata e si svolge anche su
altri fronti.
Un fronte su cui si rivolge l’attenzione è quello
della prima interfaccia con cui il ricevitore o il tra-
smettitore è connesso al resto del canale trasmis-
sivo e cioè l’antenna.
Per i sistemi radio il canale trasmissivo è costi-
tuito in modo preponderante dallo spazio, tra l’an-
tenna trasmittente e l’antenna ricevente, in cui si
propaga il segnale elettromagnetico interagendo
con tutto ciò che vi si trova dentro.
La casistica è estremamente varia ed articolata.
Per un ambiente di tipo outdoor, volendo sem-
plificare, vi è il caso rurale, semiurbano ed urbano,
mentre per un ambiente di tipo indoor vi sono
categorie assimilabili a capannoni industriali, grandi
ambienti affollati come stazioni ferroviarie e aero-
stazioni, ambienti d’ufficio, ambienti domestici,
locali interrati ecc.
In tali ambienti si possono trovare altri utenti
che utilizzano la stessa banda per lo stesso servi-
zio, sorgenti di rumore a spettro limitato, a spettro
allargato ed altre sorgenti d’interferenza disposti
in modo fisso o mobile rispetto all’antenna rice-
vente e che sono viste da questa lungo direzioni in
genere differenti.
A tutto ciò si aggiunge l’effetto dei cammini
multipli percorsi dal segnale utile verso il ricevito-
re seguendo strade diverse.
I cammini multipli sono provocati da fenomeni
di riflessione, rifrazione o diffrazione da parte del
mezzo trasmissivo o da parte degli oggetti incon-
trati nel corso della propagazione e che, una volta
giunti a destinazione, combinandosi fra loro e con
il segnale diretto, possono essere causa di degrado
della qualità di trasmissione.
Anche i segnali da cammini multipli sono visti
dall’antenna ricevente provenire da direzioni diver-
se.
Ecco quindi nascere l’idea di proteggere il siste-
ma ricevente mediante l’uso di un’antenna, o
meglio di un ssiisstteemmaa dd’’aanntteennnnaa ddiinnaammiiccoo, che adat-
ti le proprie caratteristiche di direttività alla parti-
colare situazione, al fine di ottimizzare la qualità
del segnale ricevuto.
Tutto ciò seguendo in tempo reale l’eventuale
evoluzione nel tempo della configurazione d’insie-
me dei segnali ricevuti utili e di quelli indesiderati.
Lo stesso criterio di adattabilità può essere
esteso al sistema d’antenna di trasmissione in base
a previsioni effettuate a priori, o meglio in base ad
informazioni scambiate con il corrispondente rice-
vitore, per la migliore sagomatura del diagramma
di radiazione sempre al fine di massimizzare la qua-
lità del collegamento.
Su queste considerazioni si basa il concetto
delle cosiddette aanntteennnnee aaddaattttaattiivvee.
33 LLee sscchhiieerree ddii aanntteennnnee
Il principio che viene sfruttato per la sagomatu-
ra dinamica del diagramma di radiazione dei siste-
mi d’antenna è quello, già consolidato e approfon-
ditamente studiato in passato [1] [2] [3] [4] [5],
delle schiere o cortine di antenne semplici di cui di
seguito si riporta molto brevemente qualche
cenno.
INTRODUZIONE ALLE ANTENNE ADATTATIVE
(ADAPTIVE ANTENNAS: AN INTRODUCTION)
NNOO
TTEE
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA

92
NNOO
TTEE
33..11 SScchhiieerraa ddii dduuee aanntteennnnee iissoottrrooppee
Si parte dal caso più semplice di due antenne
isotrope, che irradiano quindi ciascuna in modo
eguale in tutte le direzioni, disposte in spazio libe-
ro, ad una distanza d fra loro, lungo un asse X, ali-
mentate da correnti alla stessa frequenza.
Si esamina la distribuzione del campo elettro-
magnetico complessivo nei punti dello spazio
attorno, individuati dalla distanza D dal centro del
sistema d’antenna e dall’angolo Φ che la direzione
di D forma con l’asse X.
Ci si accorge che tale distribuzione non è come
quella di un’antenna isolata ma dipende, oltre che
dal punto P in cui si esegue la misura, anche dalla
distanza d tra le sorgenti e dalla differenza di
ampiezza e di fase delle correnti di alimentazione.
Il campo complessivo, grazie alla linearità delle
equazioni di Maxwell e della conseguente proprie-
tà di sovrapposizione degli effetti, è infatti dato
dalla somma vettoriale dei due campi contributo:
I due campi contributo giungono nel punto P
con una differenza di fase ψ nel tempo che è data
dalla differenza di fase γγ = fase(I2)-fase(I1)
delle correnti I a cui si somma algebricamente
la differenza di fase causata dalla differenza Δ dei
tragitti percorsi.
Se il punto P è sufficientemente lontano dal
sistema radiante (D>>d) è possibile assumere
parallele le direzioni con cui le due sorgenti vedo-
no il punto P.
In queste ipotesi la differenza di fase ψ sarà:
La stessa condizione D>>d permette di assu-
mere uguali le attenuazioni di propagazione dei
due contributi di campo prodotti da ciascuna sor-
gente isotropa nel punto P e, nell’ulteriore ipotesi
di correnti di alimentazione di pari ampiezza, que-
sti contributi saranno di ampiezza E uguale.
Il campo elettrico totale Et sarà:
che si dimostra con le considerazioni geometri-
che di somma vettoriale che si desumono dalla
figura 2:
Come esempio si riporta in Figura 3 il diagram-
ma di radiazione, in uno qualunque dei piani pas-
santi per l’asse X, quando la distanza d tra le sor-
genti è mezz’onda e le correnti di alimentazione
oltre che equiampiezza sono anche equifase, γ = 0°
(Fig. 3).
Come altro esempio si riporta in Figura 4 il dia-
gramma di radiazione nelle stesse condizioni di
prima ma con sfasamento delle correnti di alimen-
tazione γ = 180° (Fig. 4).
Osservando i diagrammi precedenti risulta evi-
dente come le caratteristiche radiative di un siste-
Elio Restuccia
E
E
ψ
ψ/2
Et
γϑλ
πγλ
πψ +=+Δ
= cos2 2d
)2
coscos(2 )2
cos(2γ
ϑλπψ
+==d
EEEt
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA
Figura 2Figura 1

93
NNOO
TTEE
ma anche semplice, come può essere una schiera
di due sole antenne isotrope, possa essere cam-
biato, anche in modo sostanziale, controllando
opportunamente solo la relazione di fase delle
correnti isofrequenza di alimentazione delle
antenne.
33..22 SScchhiieerraa lliinneeaarree uunniiffoorrmmee ddii nn aanntteennnnee iissoo--
ttrrooppee
Nel caso la schiera sia formata da più di due
antenne isotrope allineate, separate tutte della
stessa distanza ed alimentate con correnti aventi
lo stesso sfasamento progressivo, si viene a for-
mare una schiera lineare uniforme.
I lobi di radiazione massima diventano più
stretti con conseguente maggiore direttività del
sistema.
Di seguito si riportano gli esempi relativi a 3, 4
e 6 antenne:
INTRODUZIONE ALLE ANTENNE ADATTATIVE
(ADAPTIVE ANTENNAS: AN INTRODUCTION)
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA
Figura 3
(n=2 , d/λ= 0.5 , γ= 0°)
Figura 4
(n=2 , d/λ=0.5 , γ= 180°)
Figura 5
(n=3 , d/λ=0.5 , γ= 0°)
Figura 6
(n=4 , d/λ=0.5 , γ=0°)
Figura 7
(n=6 , d/λ=0.5 , γ= 0°)

Il solido di radiazione può essere ottenuto in
questo caso, grazie alle proprietà di simmetria
della disposizione nello spazio delle sorgenti, ruo-
tando i relativi diagrammi attorno all’asse X.
Se l’asse X è verticale la radiazione risulta omni-
direzionale e, nel caso di sfasamento nullo delle
correnti di alimentazione (γ = 0), le direzioni di
massimo giacciono nel piano orizzontale.
Ma nel caso di sfasamento non nullo, le direzioni
di massimo si spostano verso l’alto o verso il
basso a seconda del segno di γ.
94
NNOO
TTEE Elio Restuccia
33..33 SScchhiieerraa lliinneeaarree uunniiffoorrmmee ddii nn aanntteennnnee ggeennee
rriicchhee
Quando la schiera lineare uniforme è costituita,
nel caso più generale, da antenne diverse da quelle
isotrope ma tutte uguali fra loro, il problema di
determinare la distribuzione dell’ampiezza del
campo e.m. può essere risolto facilmente ricorren-
do al principio della moltiplicazione dei diagrammi.
Tale principio afferma che il diagramma di radia-
zione è dato dal prodotto del diagramma di radia-
zione della singola antenna (elemento di schiera)
per il diagramma della stessa schiera nella quale og
antenna è stata sostituita da un’antenna isotropa.
Quest’ultimo diagramma è chiamato Fattore dischiera.
Se il Fattore di schiera viene diviso per il valore
che esso assume nella direzione di irradiazione mas-sima, si ottiene il Fattore di schiera normalizzato.
Con ciò è possibile sfruttare i risultati ottenuti in
precedenza.
Infatti immaginando, per esempio, che la schiera
sia costituita da dipoli mezz’onda per ottenerne il
diagramma di radiazione è sufficiente moltiplicare
l’espressione che descrive il diagramma del dipolo
mezz’onda per l’espressione che descrive il dia-
gramma della corrispondente schiera di antenne
isotrope (Fattore di schiera).
Come esempio si riporta il risultato ottenibile
con un allineamento di quattro dipoli mezz’onda
verticali (collineare).
Raffrontandolo con il diagramma di un singolo
dipolo risulta evidente l’aumento della direttività:
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA
Figura 8
(n=6 , d/λ=0.5 , γ= 60°)
Figura 9(n=6 , d/λ=0.5 , γ= -60°)
Figura 10
(dipolo mezz’onda verticale)

95
Anche in questo caso modificando il valore
dello sfasamento γ è possibile modificare corri-
spondentemente la direzione di puntamento del
lobo principale di irradiazione.
33..44 SScchhiieerraa ppllaannaarree uunniiffoorrmmee ddii aalllliinneeaammeennttii ddii
aanntteennnnee
Accostando ad un schiera lineare uniforme
altre schiere lineari uniformi parallele, costituite
sempre dallo stesso tipo di antenna e disposte in
modo da creare una rete ordinata di righe e
colonne in cui la fase delle correnti di alimentazio-
ne degli elementi, sia per le righe che per le colon-
ne, rispetti una progressione uniforme, si viene a
formare una schiera planare uniforme. Lo studio
della distribuzione del campo e.m. è più complica-
to ma è possibile, sfruttando una estensione del
concetto di Fattore di schiera ed il principio della
moltiplicazione dei diagrammi, ottenere in modo
semplice gli stessi risultati. Il Fattore di schiera è
dato in questo caso dal diagramma di radiazione di
schiere lineari, disposte come sopra descritto, e
formate da antenne isotrope. Definendo un siste-
ma di riferimento cartesiano ortogonale XYZ e
disponendo le sorgenti isotrope nel piano XY cen-
trate nell’origine del riferimento:
e avendo indicato con:
P(θ,ϕ) = il punto d’osservazione nella direzione
θ,ϕ;
n = il numero delle sorgenti che costituscono
il lato X;
m = il numero delle sorgenti che costituiscono
il lato Y;
dx = la distanza fra le sorgenti disposte nelle
direzioni parallele all’asse X;
dy = la distanza fra le sorgenti disposte nelle
direzioni parallele all’asse Y;
θ = l’angolo che il piano passante per Z, con
tenente la direzione d’osservazione,forma
con l’asse X;
ϕ = l’angolo che la direzione d’osservazione
NNOO
TTEE
θ dy
P(θ,φ)
ϕ
Z
X
Y dx
INTRODUZIONE ALLE ANTENNE ADATTATIVE
(ADAPTIVE ANTENNAS: AN INTRODUCTION)
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA
Figura 11
(collineare di 4 dipoli verticali)
Figura 14
θ
X
Im
Im-1
θ
X
Im
Im-1
θ X
Im
Im-1
Figura 12
(collineare di 4 dipoli verticali , d/λ=0.6 , γ= 90°
Figura 13
(collineare di 4 dipoli verticali, d/λ=0.6 , γ= -90°)

forma con l’asse Z;
γx = lo sfasamento progressivo tra le sorgenti
lungo X;
γy = lo sfasamento progressivo tra le sorgenti
lungo Y;
l’estensione del principio della moltiplicazione dei
diagrammi afferma, in questo caso, che il diagram-
ma complessivo della schiera planare è dato dalla
moltiplicazione del diagramma relativo alla schiera
lineare che costituisce una delle righe per il dia-
gramma relativo alla schiera lineare costituita
da una colonna di singole sorgenti isotrope
posizionate nel centro di fase di ciascuna riga e che
sostituiscono le righe stesse.
La medesima definizione può essere ripetuta
scambiando le righe con le colonne ed è applicabi-
le anche ai solidi di radiazione.
Con la geometria descritta in fig. 14 si ottiene:
Il risultato rappresenta la superficie del solido
di radiazione normalizzata per una schiera planare
di sorgenti isotrope.
Nel caso in cui le antenne, elementi della schie-
ra, non siano isotrope, occorre moltiplicare ulte-
riormente per il diagramma specifico dell’antenna,
elemento di schiera, ponendo attenzione alla con-
cordanza del sistema di riferimento.
Applicando ancora il principio di moltiplicazio-
ne dei diagrammi è possibile così ottenere il risul-
tato Fsp per schiere planari in cui le sorgenti iso-
trope sono sostituite da altro tipo di antenna il cui
solido di radiazione è descritto dalla funzione
Fa(θ,) :
Seguono alcuni esempi di raffigurazione di
solidi di radiazione in cui, per una schiera 4x4 di
antenne isotrope, viene fatta variare la distanza
relativa fra sorgenti dx/λ , dy/λ e lo sfasa-
mento progressivo γx , γy :
96
NNOO
TTEE Elio Restuccia
( ) ( )
( ) ( )⋅
⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ −
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎥⎦⎤
⎢⎣⎡ −
⋅⋅
=
=
2cossinsin
2cossinsin
1
),(
xx
xx
d
dn
mn
F
γϑϕ
λπ
γϑϕ
λπ
ϕθ
( ) ( )
( ) ( ) ⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡−
⋅
2sinsinsin
2sinsinsin
yy
yy
d
dm
γϑϕ
λπ
γϑϕ
λπ
(3)
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA
Figura 15
4x4 iso, dx/λ=0.5, dy/λ=0.5, γx=0°, γy=0°
Figura 16
4x4 iso, dx/λ=0.7, dy/λ=0.7, γx=0°, γy=0°
(3)
),(),(),( ϕθϕθϕθ asp FFF ⋅= (4)
Figura 17
4x4 iso, dx/λ=0.5, dy/λ=0.5, γx=60°, γy=0°
X
Z
Y

97
33..55 SScchhiieerraa ccoonn sscchheerrmmoo rriifflleetttteennttee
Se la schiera è provvista di schermo elettroma-
gnetico piano, disposto parallelo all’allineamento, o
alla schiera planare, e a distanza opportuna, in
modo da massimizzare l’irradiazione nella direzio-
ne normale al piano riflettente, si ottiene il massi-
mo solo in un verso di tale direzione.
E’ così possibile realizzare un ulteriore miglio-
ramento della direttività privilegiando una direzio-
ne o un semispazio.
NNOO
TTEE
INTRODUZIONE ALLE ANTENNE ADATTATIVE
(ADAPTIVE ANTENNAS: AN INTRODUCTION)
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA
Figura 21
4x4 iso, dx/λ=0.5, dy/λ=0.5,γx=100°, γy=0°
Figura 22
4x4 iso, dx/λ=0.5,dy/λ=0.5, γx=0°,γy=100°
Figura 19
4x4 iso, dx/λ=0.5, dy/λ=0.5, γx=60°, γy=60°
Figura 20
4x4iso, dx/λ=0.5,dy/λ=0.5,γx=-60°,γy=- 60°
Figura 18
4x4 iso, dx/λ=0.5 dy/λ=0.5, γx=0° γy=60°

Tale principio viene sfruttato nella realizzazione
dei pannelli irradianti utilizzati per esempio nei
sistemi di trasmissione di radiodiffusione o nei
centri radiobase dei sistemi radiomobili.
Negli esempi che seguono vengono raffigurati
qualitativamente i solidi di radiazione che si otten-
gono:
44 AApppplliiccaazziioonnee aallllee aanntteennnnee aaddaattttaattiivvee
Se il sistema d’antenne, costituito dalle schiere
come prima descritte, consente la possibilità di
controllare lo sfasamento progressivo che deter-
mina la direzione di irradiazione massima, si com-
prende immediatamente come si abbia in mano
uno strumento per migliorare le condizioni di tra-
smissione verso un utente o un gruppo di utenti e
contemporaneamente minimizzare l’effetto inter-
ferente verso le zone dove lo stesso segnale risul-
ta indesiderato [6] [7] [8] [9].
Minimizzare l’irradiazione verso determinate
direzioni segue dalla possibilità di potere orienta-
re, oltre che la direzione di massimo, anche le dire-
zioni di minimo sfruttando le tecniche di sintesi dei
diagrammi di radiazione.
A ciò si può aggiungere che regolando oppor-
tunamente l’ampiezza delle correnti di alimenta-
zione degli elementi della schiera è possibile otte-
nere l’eliminazione dei lobi secondari o la loro
riduzione.
Dal lato ricevente si può, nella medesima
maniera, migliorare le condizioni di ricezione verso
il sito trasmittente desiderato e contemporanea-
mente minimizzare l’interferenza proveniente da
siti diversi il cui segnale è indesiderato.
L’effetto migliorativo risulta quindi doppio sia
dal punto di vista del sito di trasmissione sia da
quello del sito di ricezione.
Considerando, inoltre, che per i moderni siste-
mi radio in tecnica numerica sono sufficienti pochi
decibel di miglioramento del rapporto segnale/
(rumore + interferente) per fare la differenza tra
l’instaurazione di un collegamento di buona qualità
oppure la sua interruzione, si comprende quanto
importante in molti casi possa essere la disponibi-
lità di antenne adattative.
Il controllo dello sfasamento progressivo viene
effettuato da una logica, governata da micropro-
cessori, che analizza una serie di dati in ingresso,
esegue degli algoritmi di ottimizzazione e decide
quali comandi inviare al sistema d’antenna per
ottenere il desiderato solido di radiazione.
Le parti principali, costituenti un sistema radio che
utilizza le antenne adattative, possono essere quin-
di riassunte in:
- schiera di antenne elementari, con relativa rete di
alimentazione, dotata di sfasatori controllabili
direttamente in modo numerico o comunque
dotati di interfaccia per la logica di controllo;
- gruppo di controllo a microprocessore che ela-
bora le informazioni scambiate con il ricetrasmet-
titore e che pilota opportunamente la rete di sfa-
satori della schiera;
- software che gestisce tutte le operazioni seguen-
do la strategia scelta in base alle specifiche condi-
zioni operative ed all’ambiente elettromagnetico
previsto.
98
NNOO
TTEE Elio Restuccia
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA
Figura 24
4x4 iso, dx/λ=0.5, dy/λ=0.5,γx=100°,γy=0° con
schermo posteriore
Figura 23
4x4 iso, dx/λ=0.5, dy/λ=0.5, γx=0°, γy=0°con
schermo posteriore

99
55 CCoonncclluussiioonni
Le difficoltà incontrate nello sviluppo di un
sistema, come sommariamente descritto sopra,
pongono delle sfide che riguardano vari aspetti ma
in particolare la ricerca di soluzioni pratiche nella
tecnologia di realizzazione degli sfasatori integrati
nell’antenna.
Tale tecnologia deve rispondere a criteri di
accuratezza, efficienza, robustezza, capacità di ope-
rare alle frequenze richieste e con la larghezza di
banda richiesta e non ultimo deve anche risponde-
re a criteri di economicità per sperare in un suc-
cesso di mercato.
Un altro fronte di studio consiste nello svilup-
pare strategie operative, da tradurre in software
che gestisca il gruppo di controllo della schiera, e
che possono presentarsi anche notevolmente
diverse tra loro e dipendenti dalle svariatissime
esigenze che il sistema radio si può trovare a
dover fronteggiare.
La tecnica delle antenne adattative infatti può
trovare applicazione utile, per fare solo degli esem-
pi, con apparati radio di tipo fisso o mobile, idonei
alla sola trasmissione, alla sola ricezione o alla rice-
trasmissione, operanti in ambiente outdoor o
indoor, che svolgano servizio broadcasting, servizio
radiomobile in configurazione a celle oppure impe-
gnati in reti costitute da due o più unità.
Dagli inizi della tecnica radio ad oggi le esigen-
ze sono molto cambiate, i sistemi si trovano a
dover operare in ambienti, dal punto di vista elet-
tromagnetico, sempre più affollati e trattare volu-
mi di dati sempre maggiori.
La rincorsa a potenze di emissione sempre
maggiori ha lasciato il posto allo studio di metodi
alternativi per migliorare la qualità e le prestazioni
nelle comunicazioni radio.
Ci si è convinti ad un uso parsimonioso della
potenza ed allo sfruttamento di quanto, nel siste-
ma radiante, può aiutare in questo senso.
La strada da percorrere è già tracciata e la sfida
è appena iniziata.
INTRODUZIONE ALLE ANTENNE ADATTATIVE
(ADAPTIVE ANTENNAS: AN INTRODUCTION)
NNOO
TTEE
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA
CONTROLLO SFASAMENTO
RICETRASMETTITORE
schiera di antenne
ingresso/uscita
dati
Figura 25

100 La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA
NNOO
TTEE Elio Restuccia
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA
[1] G. Bronzi,“Linee di trasmissione ed antenne”, parte II, Colombo Cursi – Pisa, 1968;
[2] D. J. Kraus,“Antennas”, Mc Graw-Hill Book Company, Inc., 1950;
[3] R. Collin,“Antenna theory”, Mc Graw-Hill Book Company, Inc., 1969;
[4] R. J. Mailloux,“Phased array antenna handbook”,Artech House, 1994;
[5] C.A. Balanis,“Modern Antenna Handbook”,Wiley-Interscience, 2008;
[6] B. Allen, M. Ghavami, “Adaptive array sensors fundamentals and applications”, John Wiley & Sons
Ltd., 2005;
[7] R.A. Monzingo,T.W. Miller,“Introduction to adaptive arrays”, SciTech Publishing, 2004;
[8] T. K. Sarkar, M. C.Wicks,“Smart antennas”,Technology & Engineering, 2003;
[9] J. Li, P. Stoica,“Robust adaptive beamforming”,Wiley-Interscience, 2006