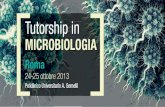Microbiologia - Virologia 19 Aprile
-
Upload
noemi-di-fuccia -
Category
Documents
-
view
31 -
download
6
description
Transcript of Microbiologia - Virologia 19 Aprile

Microbiologia, 19 aprile – Virologia
Retroviridae
Sono noti maggiormente per il virus dell’HIV e, sebbene alla famiglia appartengano diversi virus, soprattutto animali, ne esiste anche un’altra variante patogena per l’uomo.
Classificazione
Il nome, “retroviridae”, deriva dal fatto che questi virus si replicano grazie ad un meccanismo di retrotrascrizione. La modalità di replicazione del genoma virale, che è un RNA, è del tutto atipica: si passa attraverso un intermedio replicativo a DNA e non a RNA; questo significa che il virus non utilizza una RNA polimerasi-DNA dipendenti ma una DNA polimerasi-RNA dipendenti. Quindi retroviridae perché di fatto si attua un meccanismo opposto a tutte le trascrizioni cellulari: la retrotrascrittasi trascrive da RNA a DNA. Tra i retroviridae esistono 3 famiglie che sono:
• Orthovirinae: i primi ad essere individuati
• Lentivirus: di recente individuazione
• Spumavirus: sono poco patogeni e non hanno a che fare con l’uomo, infettano la scimmia e sono utilizzati nelle colture cellulari a scopo sperimentale
Orthovirinae: sono caratterizzati da 5 generi che si dividono per la morfologia della particella virale e la posizione del nucleocapside all’interno della particella virale. L’envelop è caratterizzato da due glicoproteine virali all’esterno. In tutti gli orthovirinae il nucleocapside è icosaedrico, nei lentivirus il nucleocapside ha una struttura particolare. Tra gli orthoviridae distinguiamo 5 sottogruppi:
• Alfa-retrovirus: virus del sarcoma di Rous
• Beta-retrovirus: tumore mammario nel topo
• Gamma-retrovirus: leucemia murina
• Delta-retrovirus: leucemia bovina
• Epsilon-retrovirus: sarcoma dermico
Gli orthovirinae sono tutti virus oncogeni, in grado, dunque, di indurre il cancro. Tra questi, il patogeno per l’uomo è l’HTLV-I: fa parte dei delta-retrovirus ed è un agente di leucemia; non è particolarmente né fortemente oncogeno ma è possibile che dopo diversi anni dall’infezione (circa 1 su 100 casi) si sviluppi il tumore. È stato uno dei primi ad essere scoperti poiché causava tumori alle cellule del sangue. Il fatto che la sua struttura sia altamente conservata in tutta la famiglia, ci suggerisce che questa deve avere un ruolo importante quantomeno nell’infezione. Esistono tuttavia delle differenze tra le glicoproteine del capside, eccezion fatta per due di queste che hanno funzioni diverse: una recettoriale, l’altra facilita l’ingresso del genoma virale nella cellula ospite. L’ingresso può avvenire o tramite endocitosi mediata da recettore o tramite fusione (HIV penetra per fusione). Nel nucleocapside sono contenute due molecole di RNA identiche, cioè con la stessa polarità, in questo caso positiva. Apparentemente il genoma potrebbe

sembrare diploide: due copie identiche del materiale genetico; in realtà, questa diploidia apparente è utilizzata per altri scopi. Nel nucleocapside, le due molecole di RNA sono appaiate tra loro e tenute insieme da legami idrogeno, sono poi associate ad altre proteine. Tuttavia, nonostante il virus possegga un genoma a polarità positiva, questo non incide sulla modalità di replicazione. Nel materiale genetico si possono riconoscere tre ORF – Open Reading Frame: gag, pol ed env. Gag codifica per proteine strutturali del nucleocapside, l'acronimo gag sta per group-specific antigen, questo perchè nel capside sono contenuti gli antigeni specifici del gruppo retroviridae. Env (envelop) codifica per le proteine dell'envelop, quindi le glicoproteine della superficie, insieme ad altre proteine accessorie. Pol sta per DNA polimerasi RNA-dipendente o retrotrascrittasi insieme ad un altro enzima necessario per la replicazione che è l'integrasi.
L'estremità 5' e 3' del materiale genomico dei retroviridae presenta sequenze particolari che servono per la replicazione dell'RNA in DNA. Queste sono U5 e U3: unica 3' e unica 5' . Esistono anche regioni note come repeat, o R, cioè ripetizioni. Una particella di retroviridae che entra nella cellulla, attraversa dapprima la membrana plasmatica poi si insinua nel citoplasma e avviene così la retrotrascrizione; a gtrandi linee, da tutte le molecole di RNA vengono formate molecole di DNA complementare, questo DNA non è totalmente uguale all'RNA ma avrà delle regioni diverse sia all'etremità 5' che a quella 3'. Il DNA, definito provirale, viene quindi inglobato nel nucleo: questo è il passaggio fondamentale e non casuale, deve infatti avvenire integrazione tra il materiale genetico della cellula ospite e quello del virus. L'integrazione, mediata dalla integrasi, avviene in punti casuali sebbene ci siano delle regioni preferenziali. Il cromosoma virale può così essere trascritto come parte integrante del cromosoma ospite. La RNA pol II della cellula ospite trascrive, dunque, anche i messaggeri virali. Tra i messaggeri virali ce ne saranno alcuni che codificheranno per proteine del capside; potrebbe capitare, infatti, che alcuni RNA messaggeri vengano circondati da proteine e che siano poi incapsulati. E' lecito chiedersi: perchè questo ciclo replicativo è differente da quello degli altri virus ad RNA? In questo caso abbiamo un passaggio obbligato: il genoma virale viene infatti incorporato nel nucleo per essere integrato col DNA ospite e poi trascritto.
Affincè la retrotrascrizione si verifichi è necessario l'enzima virale retrotrascrittasi. Questa, contenuta nel virione, inizia a trascrivere da una regione ben conservata in tutti i retroviridae e nota come PBS - primer binding site. Per poter iniziare la trascrizione, la DNA pol RNA-dipendente ha bisogno di un innesco che è fornito da un t-RNA che il virus ha preso dal ciclo replicativo precedente e ha impacchettato nel virione. Viene dapprima trascritta la PBS e poi la regione U5 ed R; dopodichè la retrotrascrittasi si avvale di un'altra sua caratteristica funzione: RNAasi H, ovvero, la retrotrascrittasi è in grado di degradare lo stamp utilizzato per produrre la molecola di DNA. Un'altra caratteristica dell'enzima è il fatto di poter saltare da un filamento all'altro della molecola virale. Questo spiega perchè nel virione siano presenti due copie del materiale genetico: la retrotrascrittasi ha bisogno della regione R per iniziare la sintesi e questa può trovarla o sullo stesso filamento o sull'altra molecola. Il DNA virale è tuttavia diverso dal DNA di partenza per la presenza delle estremità LTR. La particolarità della retrotrascrittasi di spostarsi da un filamento all'altro può essere spiegata in vivo quando, ad esempio, ci troviamo in presenza di due genomi di HIV diversi: l'enzima si sposta da un filamento all'altro producendo delle forme ricombinanti estremamente pericolose; questa proprietà è dunque una fonte di variabilità genetica.
C'è bisogno, poi, di integrare il genoma in quello della cellula ospite. Per questo passaggio intervengono gli efficaci promotori del genoma virali che hanno alta affinità per la polimerasi della cellula ospite. Alla fine del ciclo replicativo viene creato un RNA genomico identico a quello di partenza che può essere incapsidato, quindi non conterrà le LTR che contengono numerosi siti di legame per altrettanti fattori di

trascrizione che assicurano una certa accuratezza della trascrizione.
Virus oncogeni: grazie allo studio della oncogenesi virale è stato possibile scoprire e capire molto della tumorinogenesi generale. In effetti molti oncogeni trovati nei virus sono omologhi degli oncogeni cellulari che hanno il compito di far progredire la cellula attraverso il ciclo cellulare. E' possibile che questi virus abbiano incapsidato questi geni dalla cellula ospite, reinserendoli in altre cellule. L'onco-virus è tale poichè possiede un oncogene ma a volte il tumore può svilupparsi anche senza che l'oncogene sia presente "completo": è il caso della oncogenesi inserzionale, il cDNA infatti si inserisce in siti altamente trascritti del genoma dove appunto la trascrizione è vivacemente attiva. La regione U3 contiene siti dove la trascrizione è attiva, se questa regione si inserisce accanto a geni altrettanto attivi, può potenzialmente attivare la trascrizione. Un altro meccanismo (vedi HTLV) è la oncogenesi per trans-attivazione: esistono proteine regolatrici virali che hanno la funzione di attivare la proliferazione cellulare, queste "svegliano" la cellula e infatti fan sì che cellule quiescente possano progredire attraverso il ciclo; nel caso di HTLV le cellule che proliferano sono i linfociti T che infettati possono indurre leucemia.
HIV
Ha una morfologia della particella differente, il capside non è icosaedrico ma a tronco di cono; possiede due glicoproteine che sono bersaglio di farmaci e sono utili per la diagnosi. Importanti sono gp120 e gp41; derivano dallo stesso precursore che è prodotto dal gene env ma per maturare subiscono dei tagli da parte di una proteasi. gp41 consente l'ingresso del virus nella cellula bersaglio ed è dunque una proteina fusogena. Al di sotto dell'envelop abbiamo le proteine di matrice. La più abbondante è p24 che consente la formazione di una struttura a tronco di cono; abbiamo poi RNA, trascrittasi inversa e piccole proteine accessorie. Il gene gag codifica per p17. Il ciclo replicativo di HIV è identico a quello dei retroviridae, tuttavia, il virus stesso differisce dagli altri non tanto per il ciclo replicativo quanto per le proteine accessorie: HIV ne ha ben 6 e la loro presenza pare sia indispensabile affinchè possa essere replicato correttamente.
Tat, transattivatore della trascrizione, è un'altra proteina importante poichè attiva le successive trascrizioni e potenzia la possibilità di trascrivere e tradurre geni che codificano per cofattori che servono per la replicazione del virus. Tat non è sempre attiva ma viene regolata durante il ciclo replicativo da Rev che serve anche per la produzione di messaggeri più lunghi ch non subiscono splicing, tali messaggeri codificano per le proteine strutturali. Esistono altre proteine tra cui Nef: questa serve alla duplicazione del virus, downregola ovvero diminuisce il riconoscimento della cellula infettata da parte dei linfociti. Il sistema immunitario riconoscono le cellule grazie agli antigeni che espongono, il virus nasconde i recettori che i linfociti possono riconoscere come estranei e in questo modo le cellule si "autoproteggono" resistendo a lungo nel torrente circolatorio. Tuttavia, le proteine "principali e indispensabili" restano Tat e Rev.
Recettori vs Co-recettori
HIV ha bisogno di co-recettori che sono proteine di membrana deputate al riconoscimento di chemochine, piccole molecole diffuse per lanciare segnali. I recettori vengono sfruttati per pernetrare nei vari tipi di cellule.
Esistono 3 ceppi di virus:
-linfotropico: ha un'alta capacità replicativa e distruttiva delle cellule T, si osserva negli stadi terminali.

-macrofagrotropico: si osservano nelle prime fasi delle infezioni, questo ceppo si osserva nelle infezioni che si sviluppano nelle mucose.
-duotropo: ceppo che può infettare sia macrofagi che linfociti.
La distinzione è importante dal punto di vista clinico in quando a seconda del ceppo virale si possono attuare specifiche terapie.
Noi esseri umani abbiamo una sensibilità del 99% alla infezione: abbiamo 99 probabilità su 100 di infettarci qualora entrassimo a contatto col virus. Esiste tuttavia un genotipo che dà fenotipo mutante, rappresenta 1 caso su 100. La mutazione rende la persona resistente all'attacco del virus e impedisce il contagio (quindi l'ingresso del virus nella cellula) sia da parte dei macrofagi che dei linfociti. Questo genotipo non è presente in Africa, ragion per cui l'intera popolazione risulta sovraesposta alla infezione. Tuttavia, se la mutazione si presenta in eterozigosi (17% circa della popolazione caucasica), l'individuo è in grado di resistere meglio al contagio (verrà comunque infettato ma in misura minore): questa eterozigosi ha consentito un certo rallentamento nella malattia.
I meccanismi di trasmissione della malattia sono principalmente due:
-rapporti sessuali
-scambi di sangue
Esistono altri due modi di trasmissione:
-perinatale: scambi di sangue al momento della nascita; il contagio può essere evitato grazie alla somministrazione di farmaci retrovirali.
-transplacentare: è meno efficace ma può diventare significativa se la carica virale è elevata. Ad esempio, in Africa, è possibile che la madre infetta da HIV con una viremia non specificata ma potenzialmente elevata possa trasmettere il virus al figlio attraverso la barriera placentare.
Eppure tra l'infezione e l'insorgenza della malattia passano anni. Come mai? Supponiamo ci sia una infezione da monitorare. I parametri da investigare sono due: viremia, quantità di virus nel sangue; conto dei linfociti cd4 dal prelievo di sangue.
• infezione primaria: a partire da poche settimane dopo l'infezione, la viremia cresce rapidamente. Questo corrisponde ad un abbassamento della quantità di linfociti T cd4 soprattutto se il virus che entra è L-tropico; l'abbassamento avviene più rapidamente se è M-tropico.
• ripresa dei parametri: non a livelli base o fisiologici. Dopo l'infezione c'è una risposta immunitaria che si accompagna a sintomi che il paziente riferirebbe in caso di infezione (febbre, astenia); i sinomti restano però aspecifici, resta quindi difficile una diagnosi "precoce".
• la viremia si abbassa ed inizia la fase di latenza clinica: si tratta di una condizione che si verifica nel caso di infezioni croniche. Il virus non viene completamente eradicato sia perchè l'infezione è a carico delle cellule deputate alla difesa sia perchè questo si insinua, ad esempio, nelle regioni linfonodali che sono inaccessibili alla risposta immunitaria proprio perchè loro stessi sono sistema immunitario. Anche se non si produce virione c'è la archiviazione di cellule che contengono DNA provirale integrato nel cromosoma; questo signfica che se la cellula

intraprendesse il ciclo ripordurrebbe insieme ai suoi cromosomi parte del genoma virale. C'è poi da tenere in considerazione la variabilità data dal genoma diploide e dalla retrotrascrittasi che compie "salti tra i filamenti": questa variabilità che esiste tra i vari virus causa un vero e proprio sfinimento del sistema immunitario nonchè difficoltà di comunicazione tra le cellule immunitarie stesse. Seppure infatti si verifica una sorta di risposta immunitaria, quando il virus cambia ed entra in circolo, i linfociti non sono più in grado di riconoscerlo e l'abbattimento delle particelle virali diventa ancora più difficoltoso. Durante la fase di latenza può verificarsi anche una sindrome neurologica: il virus pur non replicandosi direttamente nei neuroni riesce a dare una demenza-AIDS associata. Nelle cellule bianche dell'encefalo, l'infezione da HIV produce cellule che possono avere un effetto patogeno sui neuroni; inoltre la Tat sopracitata induce apoptosi e dunque morte cellulare, per cui gli effetti della infezione si verificano non tanto a causa della replicazione del virus quanto ai danni a questa subordinati. Perciò, nella fase di latenza avremo dei picchi/oscillazioni di viremi e conto dei linfociti cd4. Il tempo necessario a superare la fase di latenza è variabile da paziente a paziente e soprattutto dipende dal tipo di virus ecc.
La fase finale dell'AIDS prevede un deficit immunitario irrecuperabile, si abbassa il livello di cd4, aumenta la viremia e compaiono i sintomi che sono i prodromi della malattia stessa; si sviluppano infezioni e tumori a causa della proliferazione cellulare incontrollata. Dal punto di vista della terapia si interviene con farmaci antiretrovirali e che bloccano l'ingresso del virus nelle cellule.