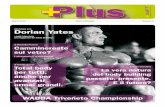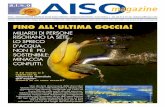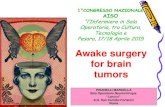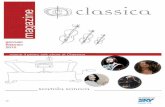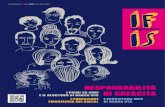Magazine AISO
description
Transcript of Magazine AISO

AISO - ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDI SULLE ORIGINI - CINISELLO BALSAMO - Viale Molise, 1 - Tel. 02 612 77 40 - [email protected]
Newsletter trimestrale on line • Febbraio 2013 • N.ro 1 • Direttore AISO: Stefano Bertolini • Redazione: Renato Colmano, Fabrizio Fratus, Giusy Pistillo • Fax 02 612 47 896 • www.origini.info
Foto di Noel Quidu da SETTE, n.ro 31/2012
SUL MONTE ARARAT DOVE SI ARENÒ NOÈ?
QUI NELLA ZONA DEL MONTE ARARAT, TRA LA TURCHIA E L'ARMENIA, SECONDO GENESI, SI CONCLUSE IL «VIAGGIO DELL'ARCA»«Montagna del dolore» per i turchi, «Opera di Dio» per gli armeni!(pagine 3-4)
Tipico paesaggio vulcanico checirconda l'Ararat, anche se leultime eruzioni risalgonoall'età del bronzo.
La cima innevata del Monte. Secondo il mito, ha una valenza divina non
solo per l'Arca. È infatti la fonte di due fiumi leggendari: il Tigri e l'Eufrate, che
forniscono la fertilepianura della
Mesopotamia.

2
Tempo fa un giornalista ebbe l'idea di scrvere un articolo sulla felicità.E così uscì dal suo ufficio per cercare persone alle quali rivolgere alcune domande sul tema della felicità.E incontrò un uomo d'affari, molto ricco che gli rispose: «Io sono molto felice perché ho tutto quello che posso avere», mostrandogli dalla vetrata dell'ufficio tutto lo stabilimento che lo circondava.Poi il giornalista si recò da una coppia di mezza età, che viveva in un bel paesino di collina ricco di alberi, piante e fiori. Disteso in un paesaggio idilliaco. E fece loro la solita domanda. «Noi siamo felici perché le persone vicine ci vogliono bene e abbiamo una bambina che ci dà tanta felicità».Poi il giornalista si recò da una signora, povera, che viveva in un alloggio di un seminterrato di una casa popolare e gli pose la domanda sulla felicità.«Io sono felice, perché ho ricevuto molte cose, e per questo posso dire di esserlo: ho la vita, ho un tetto sopra la testa e ho la gioia di avere tre
FELICITÀ NON È SOLOquestione di fortuna
bambini». Detto questo mostrò al giornalista il cortile del caseggiato dove giocavano i suoi bambini e gli disse: «Sono loro che mi danno felicità».«Essere felici è come un abito su misura!» diceva il notissimo direttore d'orchestra Karl Böhm.«Le persone infelici sono coloro che vogliono indossare un abito su misura di un altro».Ormai siamo nel mese di febbraio ed è passato il tempo e l'«atmosfera» in cui fare gli auguri, ma una domanda possiamo ancora porcela tutti noi: cosa realmente ci può rendere felici nel 2013?Lo scorso anno 2012 in una provincia del Nord Italia la popolazione ivi residente ha speso, pro capite, 1.300 Euro per tentare la fortuna con i vari «gratta e vinci», nella speranza di afferrare la felicità. Ma la cosa più importante che possa esserci, nessuno più l'afferra: ciò che Gesù Cristo ha fatto per noi in questo mondo! Nonostante tutto la «sua» offerta è ancora la migliore risposta alle nostre domande.
Renato Colmano
Foto ERF Gute Nachrichten
IN QUESTO NUMEROLA FELICITÀ NON È SOLOQUESTIONE DI FORTUNApag. 2SUL MONTE ARARAT DOVESI ARENÒ NOÈ?pag. 3LA DISTROFINA E LA COM-PLESSITÀ DELLA CONTRA-ZIONE MUSCOLAREpag. 5I PRINCIPALI TERMINI DELCONTRADDITORIO!pag. 6ALLA RICERCA DELLAFELICITÀpag. 7LE DUE LEZIONI DI RITA:LA SCIENZA E LA LIBERTÀpag. 9 CRESSY MORRISON, UNO SCIENZIATO CHE CREDEVA IN DIO. PERCHÈ?pag. 10E DIO CREÒ LA BELLEZZApag. 12E VENNE... IL DILUVIOpag. 15C'È UN LIBRO PER TUTTIMA COSA CENTRA DARWIN?pag. 17LA FAMIGLIA MULTICOLOREpag. 18MISTERIOSA STRAGEDI ANIMALI NEL BORNEOpag. 19I LETTORI CI SCRIVONOpag. 20DI TUTTO UN PO'pag. 21
DI TUTTO UN PÒ!pag. 16

3
L E T E R R E D E L M I T O
SUL MONTE ARARATDOVE SI ARENÒ NOÈ?
Dall'epoca di Eusebio di Cesarea fino ai giorni nostri, la ricerca dei resti materiali dell'arca di Noè ha costituito una vera ossessione per numerosi cristia-ni - e non per gli ebrei o i musulmani, che sembrano essere meno interessati a ritrovare il relitto.
Si deve a un cronista armeno del V secolo, Fausto di Bisanzio, aver utilizza-to per la prima volta il nome di «Ararat» per indicare una montagna ben precisa, piuttosto che una regione. L'autore af-fermava che l'arca era ancora visibile al vertice di questo rilievo montuoso, e ri-ferisce che un angelo portò una reliquia tratta dalla nave ad un vescovo, che fu in seguito incapace di compiere la scala-ta per raggiungere i resti! La tradizione vuole che l'imperatore bizantino Eraclio abbia tentato il viaggio nel VII secolo. Quanto ai pellegrini meno fortunati, do-vevano affrontare le zone desertiche, i terreni accidentati, le distese innevate, i ghiacciai e le tempeste, senza contare i briganti, le guerre e, più tardi, la sfiducia delle autorità ottomane.
La regione, sistemata e resa un po' più ospitale soltanto nel XIX secolo, permise ad alcuni occidentali di partire alla ricer-ca dell'arca. Nel 1829, il medico Frie-drich Parrott, dopo una scalata al monte Ararat, scriveva nel suo diario che «ad Ararat tutti gli Armeni sono fermamen-te convinti che l'arca di Noè resti tuttora sulla cima del monte e che, allo scopo di preservarla, nessun essere umano è auto-rizzato ad avvicinarsi alla città».
Nel 1876, James Bryce, esploratore e professore di diritto civile alla università di Oxford, scalò oltre l'altitudine fino alla quale si possono trovare gli alberi e tro-vò una trave di legno lavorata a mano, di una lunghezza di 130 cm e di uno spesso-re di 12 cm. Lo identificò come un pezzo dell'arca.
Nel 1883 il «British Prophetic Mes-senger» e altri giornali segnalarono che una spedizione turca aveva potuto scor-gere i resti dell'arca.
Il problema dell'arca si fece più di-screto nel XX secolo. Nel corso della guerra fredda, il monte Ararat si trovò in-fatti sulla frontiera molto sensibile tra la
Turchia ed l'Unione sovietica, così come pure nel bel mezzo della zona d'attivi-tà dei separatisti curdi, di modo che gli esploratori si esponevano a rischi parti-colarmente elevati.
L'ex astronauta James Irwin condus-
se due spedizioni sull'Ararat negli anni 1980, ma non scoprì alcuna prova tan-gibile dell'esistenza dell'arca: «Ho fatto tutto ciò che mi era possibile, ma l'arca continua a sfuggirci».
All'inizio del XXI secolo esistono
Fotografia della
anomalia dell'Ararat
presa nel 1949

4
Sopra: Il lago di Vian è il lago più grande della Turchia: è salato, riceve acqua da numerosi piccoli fiumi e la sua origine è vulcanica.In ato: le due immagini si riferiscono al Palazzo di Ishak Pasha, patrimonio mondiale dell'Unesco, a 6 km da Dogubeyazit: meraviglia architettonica del XVII secolo, domina i monti dell'Anatolia orientale. È costituito da tre sezioni, più un cortile esterno, uno interno e un harem.Raggiungere la zona non è difficile, ora che la Turchia è più «aperta» al turismo europeo. Risulta però difficile poter salire sulla montagna, anche perché è tuttora ghiacciata e, quindi, è raccomandabile per chi pratica sports invernali. Info presso l'Ambasciata di
Turchia, Ufficio Cultura e Informazioni,tel. 06448 71190.
due principali percorsi di esplorazione: fotografie aeree o via satellite che han-no messo in evidenza un certa anomalia sull'Ararat, che mostra non lontano dalla cima della montagna una macchia nera e sfocata sulla neve ed il ghiaccio (vedi foto pagina precedetnte).
Ma occorre soprattutto citare il sito Durupinar (ufficiale turco scopritore del sito), vicino a Doğubeyazıt e a 25 chilo-metri a sud dal monte Ararat, consistente in una grande formazione rocciosa con l'aspetto di una barca che esce dalla terra. La località senza essere una grande attra-zione turistica, riceve un flusso continuo di visitatori, ma sull'Arca di Durupinar non c'è unanimità tra gli studiosi.
Nel 2004, un certo Daniel McGivern, annunciò che intendeva finanziare una spedizione sulla cima del monte Ararat nel mese di luglio, ma, le autorità turche gli rifiutarono l'accesso alla cima, perché situata in una zona militare. La spedizio-ne fu in seguito accusata dalla «National Geographic Society» di essersi fatta un colpo mediatico. La CIA, in seguito, ha esaminato le immagini satellitari di Mc-Givern, ritenendo che l'anomalia fosse costituita da «strati lineari di ghiaccio co-perti da ghiaccio e dalla neve accumulati di recente».
Un nuovo annuncio di un presunto ri-trovamento fu dato il 27 aprile 2010 da una spedizione congiunta turca e di Hong Kong, a cui hanno partecipato membri della «Noah's Ark Ministries Internatio-nal». La spedizione aveva annunciato di avere scoperto sull'Ararat una insolita ca-verna con pareti in legno a un'altitudine alla quale si ritiene non siano mai esistiti insediamenti umani, e di aver datato il le-gno (test del carbonio 14), a 4.800 anni fa. Però il suo portavoce, Yeung Wing-Cheung, ebbe a dichiarare che non vi era certezza al 100%, ma solo al 99,9%! Poi uno dei membri della spedizione, in se-guito dissociatosi dal gruppo, disse che il legno ritrovato sull'Ararat era stato por-tato lì appositamente da alcuni manovali curdi...
Il mistero continua! Da parte nostra facciamo notare che E.G.White scrive molto semplicemente che «quando l’ac-qua cominciò ad abbassarsi, il Signore fece in modo che l’arca si fermasse in una regione protetta da un gruppo di montagne che non erano state distrut-te dal diluvio. Appena la nave entrò in quella piccola rada il rollio cessò, con grande sollievo dei viaggiatori, stanchi per essere stati così a lungo sbattuti dal-le onde».
Non abbiamo trovato riscontri alla voce «Ararat»!

5
In questo modello possiamo ammirare la com-plessità delle microstrutture che fanno parte della fibra muscolare. Non possiamo non esi-merci dallo stupore e dalla meraviglia di come avviene una semplice sua contrazione.La conoscenza dei meccanismi della vita ci avvi-ciano sempre di più a Dio!
Esistono delle patologie geneti-che gravi chiamate distrofie muscola-ri progressive; iniziano in una età mol-to giovane provocando un progressivo indebolimento muscolare sino all’atro-fia dei muscoli e alla fibrosi; sono col-piti quasi tutti i muscoli e la morte av-viene in genere per una paralisi dei mu-scoli respiratori.
La più comune è la «distrofia mu-scolare di Duchenne» dal nome dello studioso che per primo la osservò.
Questa malattia è dovuta alla man-canza nel DNA del gene che codifica una proteina chiamata distrofina: il ge-ne più lungo che esiste in natura e codi-fica una grossa proteina di 3.648 ami-noacidi. Questa proteina ha innanzitut-to la funzione, insieme ad altre proteine, di stabilizzare la membrana muscolare ed evitare che lo stress della contrazio-ne muscolare, meccanicamente violen-to, provochi un deterioramento rapi-do della membrana muscolare con sua successiva rottura e morte della cellula muscolare stessa.
Recentemente è stato scoperto che la distrofina ha una funzione più sofi-sticata e… intelligente: essa attiva al-cuni geni che codificano dei micro RNA i quali a sua volta inibiscono l’attiva-zione dei geni dello stress ossidativo e della fibrosi. In assenza della distrofina vengono attivati questi ultimi geni e vie-ne provocata la fibrosi muscolare che sostituisce quindi il muscolo deteriora-to. Anche le mutazioni del gene della di-strofina danno luogo a distrofine difet-tose che determinano altri tipi e varietà di distrofie muscolari.
La distrofina sembra apparentemen-te una proteina che non fa parte diretta-mente della contrazione muscolare, ma non è così perché senza di essa i musco-li si deteriorano irrimediabilmente.
La contrazione muscolare è un feno-meno straordinarimente sofisticato per-ché in essa entrano tantissime proteine. Una di queste è, per es., la titina, una grossissima proteina formata da ben 30.000 aminoacidi! Essa ha una funzio-
LA DISTROFINA E LA COMPLESSITÀ DELLA CONTRAZIONE MUSCOLARE
ne elastica: mettendosi in senso longi-tudinale per tutta la lunghezza della fi-bra muscolare permette a quest’ultima di ritornare facilmente nella posizione di partenza dopo l’accorciamento do-vuto alla contrazione muscolare.
Descrivo in breve la contrazione muscolare: l’acetilcolina, un neurotra-smettitore, fuoriesce dalle vescicole si-tuate nel terminale sinaptico della fi-bra nervosa motrice; due molecole di acetilcolina si uniscono al recettore co-linergico posto sulla superficie della membrana della fibra muscolare che si chiama sarcolemma.
Dopo la fusione acetilcolina-recet-tore scatta un meccanismo di apertu-ra di un canale ionico sodio-potassio; il sodio entra nella cellula e il potassio ne esce e si forma, quindi, una differenza di potenziale elettrico che innesta una corrente elettrica che viaggia nella fi-bra muscolare ed induce l’apertura di un altro tipo di canali, i canali ionici del calcio; il calcio fuoriesce dalle cisterne endoplasmatiche dove era rinchiuso e fuoriesce libero nel citoplasma.
Il calcio libero nel citoplasma si combina con una proteina chiamata
troponina che cambia conformazione e si stacca da un’altra proteina chiamata tropomiosina che è avvolta a spirale at-torno alla fibra di actina e che si sposta scoprendo i siti in cui è collegato l’ATP e la testa della miosina.
La tropomiosina, nel muscolo a ri-poso, copre i siti che sono collega-ti all’ATP e alla testa della miosina, la proteina essenziale della contrazio-ne muscolare. Una volta scoperti i siti la testa della miosina che è una ATPa-si scinde l’ATP in ADP+acido fosforico liberando energia che viene usata dal-la testa della miosina (flessibile), che fa un movimento di 90 gradi spostando la fibra di actina con un movimento ener-gico chiamato «colpo di frusta». Crea così un accorciamento della fibra mu-scolare giacchè i filamenti sottili di ac-tina e i filamenti spessi di miosina sono posti e allineati in modo opposto.
Interviene infine una calcio atpasi che stacca il calcio dalla troponina e il calcio rientra, attraverso i canali spe-cializzati del calcio, nelle cisterne en-doplasmatiche e, pertanto, la fibra mu-scolare ritorna a rilasciarsi.
Questa breve sintesi della contra-zione muscolare dimostra una cosa inequivocabile, la irriducibile com-plessità della contrazione muscolare.
Se manca una sola delle innume-revoli componenti proteiche la con-trazione muscolare non può avvenire e quindi tutto il meccanismo deve es-sersi formato tutto insieme ed improv-visamente.
Tutte queste strutture funziona-li integrate dicono a noi una sola co-sa: progetto! L’argomento del proget-to non è un argomento ad ignoranza ; infatti più sappiamo dei meccanismi della vita e più ci rendiamo conto che dietro di essi c’è una intelligenza pro-gettuale.
Non c’è più il Dio tappabuchi che copre la nostra ignoranza, ma al con-trario è la nostra conoscenza dei mec-canismi della vita che scopre sempre di più Dio.
Questa breve sintesi della contrazione muscolare, concessaci gentilmente dal Dr. Nunzio Nobile, dimostra una cosa inequivocabile: la irriducibile complessità della contrazione muscolare. Se manca una sola delle innumerevoli compo-nenti proteiche la contrazione muscolare non può avvenire...

6
DARWIN CONTRO REDIFrancesco Redi (1626-98) è l’iniziatore del-
la biologia scientifica. L’esperimento che segna la svolta è quello col quale dimostra che la car-ne in putrefazione non produce vermi, se si im-pedisce alle mosche di depositarci le uova (co-prendo la carne con una garza).
Redi volle con questo affermare che gli esse-ri viventi derivavano solo da altri esseri viventi, dando l’avvio a una lotta contro la generazione spontanea che durerà due secoli.
L’Inquisizione non lo aveva in simpatia, an-che se (o forse proprio perché) prendeva la Ge-nesi «troppo» alla lettera.
Egli ha infatti scritto: «Per molte osservazio-ni molte volte da me fatte mi sento inclinato a cre-dere che la terra, da quelle prime piante e da quei primi animali che ella nei primi giorni del mondo produsse per comandamento del sovrano e onni-potente fattore, non abbia mai più prodotto per se medesima né erba, né albero, né animale alcuno perfetto o imperfetto ch’ei fosse; e tutto quello che ora nascere da lei o in lei veggiamo, venga tutto dalla semenza reale e vera delle piante e degli ani-mali stessi» (F. Redi, Opere, Venezia 1762, vol. 1, p. 117; citato da P. Omodeo, Creazionismo ed evoluzionismo, Laterza, Bari 1984 , p. 9).
C’è un tipo di fede che acceca o funziona da oppio e questo i creazionisti lo devono ricono-scere, ma c’è anche una fede che illumina e dà coraggio, come nel caso di Redi, e questo certi evoluzionisti fanno fatica ad ammetterlo.
Darwin c’entra perché, ben due secoli dopo, si ostinava ancora a credere e a difendere la ge-nerazione spontanea, cercando così di disfare anche l’opera cominciata con Redi, come si può vedere meglio nelle schede riguardanti Spallan-zani e Pasteur.
DARWIN CONTROSPALLANZANI
È stato Redi a iniziare la scienza biologica, ma egli era anche un letterato e si interessò di mol-te cose.
Così chi ha poi dato un metodo rigoroso alla biologia è stato Lazzaro Spallanzani (1729-99).
Il noto evoluzionista Montalenti si stupisce
che Spallanzani abbia potuto far questo nono-stante fosse religioso (era un abate): non è pos-sibile che quel rigore metodologico gli derivas-se proprio perché era religioso?
D’altronde è più logico pensare che due ele-menti associati siano in sinergia, piuttosto che in opposizione, tanto più che altri casi simili non sono certo mancati, e Albert Einstein, parlando di Newton e di Keplero, arrivò a dire che «la for-za di restare fedeli al loro obiettivo nonostan-te gli insuccessi» era derivata loro dalla «religio-sità cosmica che prodiga simili forze» (A. Ein-stein, Come io vedo il mondo, Newton Com-pton, Roma 1975, pp. 29s).
Per non dilungarci e restare nel nostro cam-po, basterà ricordare che anche l’iniziatore della genetica, Mendel, era un abate.
Come Redi, anche Spallanzani lottò contro il trasformismo e la generazione spontanea, gua-dagnandosi una incondizionata stima anche da parte dall’illuminista Voltaire.
Un secolo dopo, Darwin tenterà di disfare anche l’asse portante dell’opera di Spallanza-ni, prendendo apertamente le difese della ge-nerazione spontanea (si veda anche la scheda su Pasteur).
DARWIN E GALILEISpesso gli evoluzionisti fanno un parallelo
fra Darwin e Galilei, perché ambedue hanno af-frontato temi scientifici di grande rilievo anche in altri campi (culturale, etico, teologico, politi-co e altro).
In questo c’è un’evidente similitudine e Dar-win ha indubbiamente segnato il mondo a lui posteriore. Fra i due ci sono però anche impor-tanti differenze, che vengono taciute dagli evo-luzionisti (e così implicitamente negate).
1) Galilei fu perseguitato, mentre Darwin ebbe grandi onori.
2) Contro Galilei si scatenò l’Inquisizione, mentre gli oppositori religiosi di Darwin ebbe-ro con lui pubblici e civili confronti.
3) L’opera di Galilei delegittimava la classe dirigente del suo tempo, quella di Darwin era in sintonia con i valori praticati dalla borghesia inglese di quel tempo, alla quale apparteneva e
che era ansiosa di liberarsi dai vincoli di un pu-ritanesimo pervasivo, per lanciarsi in una con-correnza («lotta per l’esistenza») senza remore verso i perdenti (la «prevalenza del più adatto» era spiacevole per alcuni, ma faceva comunque avanzare il progresso).
4) Galilei proseguiva l’opera scientifica di chi l’aveva preceduto e preparò l’opera di chi l’avrebbe poi seguito, invece Darwin riesumava e riprendeva il vecchio trasformismo pre-scien-tifico, in contrasto con tutti i grandi biologi che l’avevano preceduto (Spallanzani, Linneo) e contro l’emergente genialità di Pasteur e Men-del: tutti seguaci del fissismo.
5) Dove c’è stata libertà, gli avversari di Ga-lilei tacquero presto e presto si cessò di scrivere libri contro l’eliocentrismo da lui difeso, mentre oggi, solo in lingua italiana, ci sono una ventina di libri in commercio che sono dichiaratamen-te antidarwinisti.
6) L’obiettivo di Galilei fu di trovare le leggi che sottostanno all’apparente confusione, an-dando da ciò che potrebbe essere possibile a ciò che è certo.
Darwin fece appello continuamente a ciò che potrebbe essere possibile, valutando poi il possibile come probabile, anzi certo.
Galilei mostrò esperimenti e prove concre-te, Darwin fece spesso appello alla sua persona-le autorità («Io credo…»; Darwin e le razze sul p. numero) e si appellò a possibili scoperte fu-ture, per far dimenticare il fatto che non poteva mostrare prove.
7) Ciò che sostenne Galilei era contrario al senso comune (che percepisce la Terra ferma con il Sole che gli gira intorno), mentre ciò che propose Darwin (trasformazione delle specie e Generazione spontanea) è ciò che intuitivamen-te pensano i bambini e le persone senza cultu-ra, che amano fantasticare sulle magie che pos-sono succedere nel bosco; ciò è in sintonia con i racconti mitologici, più che con la scienza spe-rimentale.
Anche per questo qualcuno è arrivato a defi-nire il darwinismo come «una favola per adulti».
8) Darwin era inglese ed il creazionismo at-tuale è emerso negli Stati Uniti: è un confron-to interno al mondo anglofono, dove negli ul-timi quattro secoli non si sono mai bruciati o proibiti libri.
La discussione verte sulla legittimità o meno di insegnare l’evoluzionismo o il creazionismo in uno spazio come quello scolastico, che è di tutti e che si chiede tenga conto di tutti.
D I Z I O N A R I E T T O
I PRINCIPALI TERMINI DELCONTRADDITORIO!
Continua l'elenco sulle principali voci del mondo evoluzionista e creazionista.Ringraziamo il Prof. Ferdinando De Angelis che ci ha autorizzato il riporto di alcuni termini.
A sinistra Galileo Galilei (1564-1642) ritratto da Ottavio Leoni nel 1624, quando lo scienziato, a Roma, cercava di far accettare al papa la teoria copernicana. A destra Charles Robert Darwin (1809-1882).

7
Nella società, invece, c’è libertà assoluta, sia per gli evoluzionisti che per i creazionisti.
Raccontare il contrasto che c’è negli Stati Uniti con categorie italiane (Galilei contro Inqui-sizione), significa essere disinformati, o si è scel-to di ingannare il pubblico con argomenti di fa-cile presa.
DARWINISMOÈ un tentativo di spiegare come si è realiz-
zata l’evoluzione.Oggi i darwinisti pongono al centro le
mutazioni casuali e la selezione naturale: le mutazioni sono viste come la fonte di varia-bilità, mentre la selezione naturale sceglie le mutazioni più adatte all’ambiente.
Alla base del darwinismo c’è la convinzio-ne che, avendo a disposizione tempi lunghi (come minimo milioni di anni), la microevo-luzione possa produrre la macroevoluzione. Non contempla forze esterne alla natura, per-ciò è una forma implicita di naturalismo e di panteismo.
Si contrappone in generale al creazioni-smo e, recentemente, al Disegno Intelligen-te. La macroevoluzione non è stata mai os-servata direttamente in nessun laboratorio e tanto meno in natura, perciò il darwinismo è un’ipotesi e non scienza.
Continua sul prossimo numero con l'interessante voce suDARWIN E LE RAZZE
«Ciò che sostenne Galilei era contrario al senso comune (che percepisce la Terra ferma con il Sole che gli gira intorno),
mentre ciò che propose Darwin (trasformazione delle specie e
Generazione spontanea)è ciò che intuitivamente pensano
i bambini e le persone senza cultura, che amano fantasticare
sulle magie che possono succedere nel bosco;
ciò è in sintonia con i racconti mitologici, più che con
la scienza sperimentale»
P E N S I E R I
ALLA RICERCADELLA FELICITÀ
Esiste un desiderio che proviamo nel nostro profondo. È come una dipendenza dalla vita, dalla soddisfazione, dalla
felicità. In fondo è l’insaziabile desiderio del paradiso.Poiché siamo stati creati per essere felici!
«Chi comprende l’amore di Dio, ha trovato la chiave della
felicità della sua vita» Hermann H. Grafe (1818-1869)
Poeta tedesco per bambini
Quello che su questa terra non ci dà pace e ci costringe continuamente alla ricerca della felicità, è comunque questo desiderio del paradiso per il quale siamo stati creati, che abbiamo perso e nel quale vorremmo ritornare.C. S. Lewis lo esprime in questo pensiero: «Portiamo in noi il desiderio che non può essere soddisfatto attraverso alcuna felicità naturale. Su questo mondo rimane sempre un residuo di delusione».La sete per la vitaNella Bibbia incontriamo continuamente persone, che erano alla ricerca della felicità. Una donna ad un pozzo rivolge a Gesù una proposta quasi incredibile:«Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice: «Dammi da bere", tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere, e il pozzo è profondo; da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne bevve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo;
ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna» (Giovanni 4:10-14).Come dimostra la storia della sua vita, questa donna era piena di nostalgia dalla felicità. Volevano vivere! Essere felici! Ma poi la vita le venne incontro in tutta la sua durezza e i sogni si trasformarono in fallimenti.Per alcuni di noi questa suona come la loro propria storia.Tanti non sanno, che è Dio che ci parla nei nostri desideri e nei nostri sogni delusi! Conosce la nostra sete per la vita e ci guarda pieno di compassione quando ci impegnamo per la nostra felicità e forse non riconosciamo che abbiamo bisogno del Signore, perché solo lui può soddisfare questo nostro desiderio in noi. «Il mio popolo infatti ha commesso due mali: ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne, delle cisterne screpolate,che non tengono l'acqua» (Geremia 2:13). Dio si lamenta del suo popolo d’Israele già nell’Antico Testamento.Questa è la più grande tragedia
«Se Cristo fosse nato mille volte a Betlemme, ma non in te, saresti perduto per l'eternità»
Angelus Silesius (1624-1677)poeta tedesco

8
della nostra vita, il fatto che visitiamo sempre i pozzi costruiti da noi stessi, ma nonostante ciò abbiamo sempre nuova sete di felicità e vita.Dai pozzi che noi stessi scaviamo, ci aspettiamo che soddisfino la nostra sete di vita, di amore, di relazioni, di sesso, di soldi, di reputazione nella società, di bellezza...La Bibbia però ci dice, che i nostri pozzi sono crepati: non possono contenere l’acqua.Per questo la sete rimane nei nostri cuori, finché Dio non la può placare.Se troviamo la felicitànel Signore, sarà per sempre «Non ne ho mai abbastanza!» è il ritornello di una famosa canzone pop.
Ma non abbiamo mai riflettuto che potrebbe essere Dio quello che ci aspetta dietro questa sete di felicità, questo desiderio di vera vita?È il Padre di Gesù Cristo che non vuole assolutamente che ci accontentiamo della felicità terrestre, perché siamo stati creati per molto di più.È Dio che desidera che iniziamo finalmente a trovare il più grande tra i desideri: vale a dire incontrarlo, Lui che è la vita stessa (Giovanni 17:3).Se tu appartiene a quelle persone, che non hanno mai abbastanza dalla vita, allora c’è una buona notizia: Gesù come duemila anni fa parlò alla donna del pozzo, così che ci parla anche oggi!E la sua offerta è sempre uguale.
Vuole darci l’acqua della vita eterna, per placare la nostra sete di vita.Gesù dice ai suoi discepoli «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza»(Giovanni 10:10).Gesù Cristo non vuole i nostri soldi, ma la nostra felicità: «Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita» (Apocalisse 22:17).Perciò chi vuole che il suo desiderio di felicità sia esaurito, deve andare da Gesù Cristo. Allora Gli placherà la sua sete. Poiché «la felicità non è da trovare né al di fuori di noi, né dentro di noi», come dice Blaise Pascal, ma «la felicità è in Dio. E se la abbiamo trovata in lui, sarà ovunque».
La felicità non è da trovare né al di fuori di noi, né dentro di noi;la felicità è in Dio. E se la abbiamo trovatain Lui, sarà ovunque.Blaise Pascal

9
LE DUE LEZIONI DI RITALA SCIENZA E LA LIBERTÀ
Un grande premio Nobel tra cultura, slanci, ironia ecapacità di indignazione. Il suo motto: «Abbi coraggio di conoscere»
A T T U A L I T À
Rita Levi Montalcini è sta-ta la perfetta incarnazione del motto «omnia munda mundis, tutto è puro per i puri».L'immensa sua popolarità de-gli ultimi anni non l'ha mai scalfita.In genuina congenita mode-stia si scherniva dall'ammira-zione e dai complimenti, qua-si riparandosi fisicamente sol-levando appena il palmo del-le mani, dicendo: «Ma no, ma no, vi prego, non dite questo, ci mancherebbe».,L'ammirazione per la sua perso-na veniva da lei recepita come un tributo alla dignità della don-ne nella scienza in genere.E per questo Levi-Montalcini ha sempre affermato di sentirsi una donna libera. Cresciuta in «un mondo vitto-riano, nel quale dominava la fi-gura maschile e la donna aveva poche possibilità», ha dichia-rato d'averne «risentito, poiché sapevo che le nostre capacità mentali, uomo e donna, sono le stesse: abbiamo uguali possibi-lità e differente approccio». Ha rinunciato per scelta a un
marito e a una famiglia per de-dicarsi interamente alla scienza. Riguardo alla propria esperien-za di donna nell'ambito scienti-fico, ha descritto i rapporti coi collaboratori e studiosi sem-pre amichevoli e paritari, soste-nendo che le donne costituisco-no al pari degli uomini un im-menso serbatoio di potenzialità, sebbene ancora lontane dal rag-giungimento di una piena pari-tà sociale. Diceva: «L'umanità è fatta di uomini e donne e de-ve essere rappresentata da en-trambi i sessi».Pur indefettibile nella sua di-fesa del ruolo delle donne nel-la scienza, non era femminista.
Detestava ogni pretesto fem-minile sfruttato per difendere la mediocrità e i lavori eseguiti senza passione ed interesse.Come ebrea ebbe anche lei da soffrire, se non nel turbamento dei lager, ma con l'ansia di do-ver scappare ogni qualvolta le «leggi razziali» si presentavano alla porta. «L'unica libertà che ci resta è quella di indignarci!». Infatti, tante cose non le parevano «pu-re» e perciò non le tollerava.Così raccogliendo l'esortazio-ne dei genitori al sapere, utiliz-zò con coraggio e determinazio-ne le proprie facoltà intellettua-li facendo del motto di Orazio «Abbiate coraggio» un vessillo della propria esistenza: «Deve essere considerato come obbli-go morale di tutti gli individui il compito di affrontare le pro-blematiche che affliggono l'inte-ro genere umano usando al mas-simo grado le capacità razioci-nanti in loro possesso». Le ri-mane con tutto il rispetto della figura l'aver esclamato nel libro di Odifreddi «Incontri con men-ti straordinarie»: «Sono atea. Non so cosa si intenda per cre-dere in Dio».
Rita Levi-Montalcini, scompara il 30 dicembre 2012, all'età di 103 anni era nata a Torino da famiglia ebrea sefardita. Il suo massimo con-tributo, se possiamo così dire, è stata la sco-perta e l'identificazione del fattore di accresci-mento della fibra nervosa o NGF, per la qua-le è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la medicina.Insignita anche di altri premi, è stata la prima donna a essere ammessa alla Pontificia Acca-demia delle Scienze.L'1 agosto 2001 è stata nominata senatrice a vita «per aver illustrato la Patria con altissimi me-riti nel campo scientifico e sociale».Socia nazionale dell'Accademia dei Lincei per la classe delle scienze fisiche e socia fondatrice del-la «Fondazione Idis-Città della Scienza».
EntusiasmoSi entusiasmava per i buoni lavori, soprattutto (non solo) quelli delle scienziate donne, e bollava quelli senza sostanza
CandoreIl candore non le impediva di essere aspra nel condannare comportamenti inverecondi e magagne accademiche

10
S C U O L A D E L S A B A T O
Copertina della «Scuola del Sabato del primo se-mestre 2013» familiare a molti di voi, nella qua-le il primo trimestre è dedicato al tema della Cre-azione con annessi e connessi.In tutta sincerità ci ha sorpresi per l'inattesa pub-blicazione che ci rende molto felici per la disami-na del tema che al quale, purtroppo, si dedica in generale poca attenzione anche nelle comunità avventiste per ovvie e non ovvi motivi.Tuttavia vogliamo dare anche noi un piccolo con-tributo con tre «inserti»:il primo è una testimonianza di Abraham Cres-sy Morrison, cristiano credente in Dio come Cre-atore, tradotta da Sanzio Garau, Anziano della Chiesa avventista italiana e attento conoscitore della problematica teologica sul creazionismo;il secondo è un articolo della prof.sa Simona Ma-gistà, insegnante di lettere a Firenze, sulla bellez-za intrinseca del Creato apparso sul «Messagge-ro Avventista» del 4/2012;il terzo è il capitolo tratto dal libro Patriarchi e pro-feti di E.G. White, Ediz. ADV, relativo al Diluvio.A tutti una buona lettura!
Abraham Cressy Morrison, credente in Dio, negli anni immediatamente dopo la Seconda Guerra mondiale espose la sua convinzione di un «Dio artefice» della Creazione attraverso queste sette ragioni.
Del suo «manifesto» sintetizziamo le note più importanti.
1. La Terra, un mondo «unico»Più conosciamo il nostro universo, più
saremo convinti che la Terra è veramente un mondo unico, che si presenta come una dimora per l’umanità.
Morrison ricorda che nel XVIII sec., il Secolo dell'età della ragione, William Paley, scrittore, chiese ai suoi lettori, di immaginare un uomo che trovava un orologio in un luogo deserto.
Anche la persona più scettica nel rac-coglierlo, non poteva negare che qualcuno fosse stato lì in precedenza smarrendolo, e che l’orologio non fosse il prodotto di un progetto e non il risultato del caso.
Le evidenze di un progetto così gran-dioso come il concepimento del pianeta Terra sono così evidenti che diventa im-possibile attribuirlo al caso, anche perché in questi ultimi anni sono state fatte enormi scoperte scientifiche ed attualmente siamo sulla soglia di altre ancora più importanti.
Tutto questo evidenzia sempre più chia-ramente la continua opera del Creatore.
Sul nostro pianeta ci sono così tante condizioni che non potrebbero esistere semplicemente per caso, infatti per la legge della «probabilità composta», possiamo affermare che questo è vero.
Morrison ricorda, come esempio, che
CRESSY MORRISON,UNO SCIENZIATO CHE CREDEVA
IN DIO. PERCHÈ?
se dovessimo numerare dieci tondini da 1 a 10, metterli in un sacchetto, mescolarli bene ed estrarli uno alla volta in ordine progressivo sempre da 1 a 10, ci occorre-rebbero miliardi e miliardi di estrazioni! Matematicamente l’inimmaginabile di una estrazione «giusta» su dieci miliardi.
Morrison ci ricorda ancora come, ad esempio, la terra gira sul suo asse alla velocità di circa 1.656 km all’ora (esatta-mente sull'equatore si ruota o si percorrono in un giorno 39.744 km). Se girasse più lentamente, il giorno e la notte sarebbero molto più lunghe provocando così durante
il giorno la bruciatura della Terra perché sarebbe più a lungo esposta ai raggi del sole, mentre di notte gelerebbe tutto.
Ancora. La temperatura sulla superficie del Sole si aggira sui 16 milioni di gradi, ma per la sua lontananza, trasmette alla terra solo la temperatura ideale. Se la temperatura media della Terra dovesse essere aumentata di soli 50 gradi C° per un solo anno, tutta la vegetazione e l’uomo verrebbero distrutti.
Alcune delle altre stelle emettono solo metà delle radiazioni del nostro Sole; alcune di essi il doppio. Se il nostro Sole emanasse solo la metà delle radiazioni attuali, tutto sarebbe ghiacciato da una refrigerazione universale. Se invece fos-sero il doppio delle attuali, tutto, incluso l’uomo, sarebbe cenere da tanto tempo.
Pensiamo ancora ai 23 gradi di inclina-zione della Terra (attualmente di 23°27') che causa le stagioni; se l’asse non fosse così inclinato, entrambe le regioni polari sarebbero nella penombra costante, ed il ghiaccio accumulato formerebbe grandiosi continenti, formando senza dubbio un deserto fra di essi.
Pensiamo all’influsso della Luna. Attualmente le maree esercitano i loro flussi sulla Terra due volte al giorno che in alcuni luoghi raggiungono anche i 18 m di altezza. Questo avviene con la Luna distante dalla Terra circa 384.403 km. Se la Luna fosse molto più vicina il suo influsso sarebbe così grande che due volte al giorno tutti i luoghi piani della Terra sarebbero oggetto di burrascose inondazioni, che eroderebbero anche le montagne. La terra sarebbe scossa da potenti terremoti e tem-peste quotidiane. La vita umana sarebbe impossibile; il globo sarebbe avvolta da un oceano senza pari!
Morrison ci ricorda ancora che l’aria contiene la giusta quantità di ossigeno per i nostri bisogni. Se la crosta terrestre fosse un po’ più spessa o l’Oceano un po’ più profondo, tutto l’ossigeno che rende possibile la vita dell’uomo e degli animali, verrebbe assorbito.
L’atmosfera che ci circonda è del giusto spessore tanto da lasciar passare i raggi attinici necessari per vivere, per la vege-tazione, per uccidere i batteri e produrre vitamine. Eppure essi non danneggiano
Abraham Cressy Morrison (1884 -1951), chimico americano divenuto noto soprattutto per il suo libretto poetico L'uomo non è solo pubblicato nel 1944 (condensato poi da Reader's Digest Book) durante gli anni bui della Seconda guerra mon-
diale e per il manifesto Sette ragioni di uno scienziato per credere in Dio. Presidente della «New York Academy of Sciences e del-la American Institute» della città di New York, ed anche membro del «Comitato Ese-cutivo del Consiglio Nazio-nale delle Ricerche», mem-bro del «Museo Americano di Storia Naturale» e mem-bro a vita del «Royal Insti-tution di Gran Bretagna».

11
S C U O L A D E L S A B A T O
essere contenuti in un cm cubo.Non c’è quindi da meravigliarsi quando
Davide, parlando di Dio, scrive: «Io ti celebrerò, perchè sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l’anima mia lo sa molto bene» (Salmo 139:14).
6. Il processo della NaturaRicordiamo ancora l’equilibrio eco-
logico esistente nell’ambito della Natura, dove ogni «cosa» (animali, piante, inset-ti...) ha la propria funzione come quella delle ghiandole endocrine che mantengono il corpo dell’uomo in equilibrio chimico e ne regolano il suo funzionamento.
Tutto questo rivela con certezza l’in-finita saggezza della pianificazione del Creatore.
7. Il concetto di Dio Per ultimo ricordiamo il concetto di
Dio, presente non solo nella civiltà avan-zata, ma anche nelle culture primitive: una fede quasi universale in un Essere di Suprema potenza. Certamente non nato da un semplice concorso di molecole.
L’Essere Supremo stesso lo ha inserito nella mente dell’uomo.
In effetti nel «fare» le creature viventi che sono sulla terra disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza e abbia dominio… su ogni animale che striscia sulla terra. Dio li benedisse e disse loro: crescete e moltiplicate e riempite la terra» (Gen 1:26,28).
«L’immagine di Dio» non è mai stata cancellata del tutto dalla razza umana. Quantunque offuscata dal peccato è an-cora in essa, e si protende verso il cielo per qualcosa di più elevato e migliore di se stessa. Per creazione tutti gli uomini di ogni razza sono «figli di Dio».
La nostra più grande benedizione consiste nel diventare suoi figli attraverso una nuova nascita, il miracolo divino della conversione per fede in Gesù Cristo Figlio di Dio e Creatore con Lui della terra e di tutte le creature viventi.
aperto, ritorna nel fiume dov’era nato. Le anguille dell’Europa e dell’America
si accoppiano in mezzo all’Oceano Atlanti-co, nel Mar dei Sargassi, per poi morire: le giovani anguille americane trovano la via per rientrare allo stagno dei loro genitori in un anno, mentre quelle europee in due anni! Come fanno?
4. La mente dell'uomoPensiamo alla mente dell’uomo, al
grande divario dell’istinto animale e l’in-telligenza e ragione dell’uomo.
Con il loro istinto gli animali fanno cose sorprendenti come nel caso della vespa che, una volta catturato un altro insetto, lo depone in una buca del terreno, paralizzandolo; in questo modo lo con-serva per essere cibo per le future vespe che nasceranno proprio sopra l'insetto. Le vespe devono aver fatto correttamente questa procedura sin dall’inizio della loro esistenza, altrimenti sarebbero scomparse.
La scienza non ha dato ancora una spiegazione sufficiente a chiarire questo comportamento. Certamente non può essere attribuito al «caso».
Tutto questo non può essere rapportato al processo del ragionamento con il quale l’uomo ha scoperto e fatto uso del fuoco, della puleggia, della leva, della ruota... arrivando anche ad estremi e complessi ragionamenti che gli hanno permesso di muoversi velocemente sulla terra, di elevarsi aldisopra delle nuvole, di arrivare sul Marte e oltre...
5. La meraviglia dei geniA questo punto menzioneremo solo le
meraviglie dei geni coi loro cromosomi, i quali determinano tutte le caratteristiche di ogni essere umano: la razza, il colore, la forma, la mente...
Eppure sono così infinitesimali, che tutti quelli della razza umana possono
l’uomo. Se lo spessore dell’atmosfera si riducesse di tanto, le radiazioni e le mete-oriti sarebbero fatali per la vita dell’uomo sulla Terra.
«Poi Dio disse: Vi sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa "cielo". Fu sera, poi fu mattina: secondo giorno» (Gen 1:6-8).
2. Le infinite risorse della vitaMorrison parla inoltre dell’«intrapren-
denza» della vita che agendo, ad es., su una cellula la porta ad essere o pianta, o animale, o uomo.
L’uomo non ha ancora scoperto cos'è la vita; deve ancora affrontare il divario fra essa e la morte.
È ancora davanti al meraviglioso equi-librio tra mondo vegetale e animale. Se la vita fosse stata«animale», l’ossigeno si sarebbe esaurito in breve tempo, così come se fosse stata «vegetale», il biossido di carbonio sarebbe scomparso. In entrambe i casi, la vita si sarebbe estinta.
È credibile che tutte queste meraviglie provengano da un semplice fortuito con-corso di atomi? No, di certo. 3. La saggezza degli animali
Pensiamo alla saggezza degli animali. Il pettirosso che in inverno vola via verso sud, chi può dire dove va? Il prossimo anno, se nessuno lo uccide, ritornerà allo stesso nido.
Il piccione viaggiatore portato lontano anche a mille chilometri, ritorna imman-cabilmente a casa.
L’ape vola e fa migliaia di giri in di-verse direzioni, ma essa trova sempre la via per rientrare all'alveare grazie ai loro occhi microscopici.
La grande aquila, l’avvoltoio e il con-dor hanno invece occhi telescopici.
Il gufo può vedere il topo nell’erba con l’ausilio dei raggi infrarossi. Il cane da guardia ode rumori a noi impossibile udire.
Il giovane salmone, dopo anni nel mare

12
S C U O L A D E L S A B A T O
E DIO CREÒ LA BELLEZZA
La Gioconda, il David di Mi-chelangelo, i paesaggi impressioni-sti, cos’hanno a che fare con Dio? Co-sa c’entra la fede, il Supremo, l’Essenza dell’amore, della giustizia e della perfe-zione, con l’arte?
Il filo rosso che collega l’arte a Dio passa in modo del tutto particolare pro-prio dall’ultimo degli elementi soprac-citati: la perfezione e la ricerca del bel-lo. «E Dio vide ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono». Il mondo cre-ato da Dio era perfetto e squisitamente armonioso.
Dio si compiace della bellezza: la ri-cerca, la pone come un sigillo, una fir-ma; è la sua impronta nella creazione, non solo nella natura, ma anche nell’uo-mo; Adamo ed Eva erano bellissimi.
Dopo millenni, nonostante i maltrat-tamenti, lo sfruttamento e la devastazio-ne, il creato è ancora così splendido che stupisce l’uomo, il quale non resiste al-la tentazione di riprodurlo: ecco l’arte.
L’artista tenta di riprodurre la bellez-za di Dio in modo del tutto personale; arriva a reinterpretarla, azzardando una ri-creazione: creare nuovamente, co-me Dio. In questo modo, l’artista cer-ca di elevare la sua condizione da sem-plice e umile artigiano a «creatore». Per dimostrare la nobiltà del suo lavoro, di-pinge e scolpisce usando le stesse rego-le di Dio.
Ma Dio quali regole ha usato per creare? Tante e varie. Leggi estetiche, cromatiche, armoniche, regole matema-tiche, di proporzione.
Non tutte note, infatti, molte sono ri-maste misteriose alla nostra mente limi-tata, ma qualcuna, diciamo una, la co-nosciamo e come una chiave magica ci apre la porta su mondi affascinanti, deci-fra in modo curioso il creato, lasciando-ci inevitabilmente colmi di stupore. Una semplice proporzione che, pare, renda più bello e piacevole tutto ciò a cui essa viene applicata: la sezione aurea. Divina proporzione
Ora, per capire di cosa stiamo par-
lando, dobbiamo spiegare brevemente in cosa consista geometricamente que-sta sezione aurea, o «divina proporzio-ne»; essa è un modo particolare di di-videre un segmento in due parti non uguali: AC: AB = AB: BC
Da questo segmento si origina un rettangolo detto rettangolo aureo. Que-sti è a sua volta divisibile all’infinito in un quadrato e un ulteriore rettango-lo aureo, dando così origine a una spi-rale: la spirale aurea, che è anche spira-le logaritmica.
Anche la costruzione del pentago-no e della stella inscritta in esso si basa-
no sulla proporzione aurea. Ecco, que-sta misura, questa proporzione, dà ori-gine a forme che risultano esteticamen-te piacevoli all’occhio umano. Infatti, nel 1875, Gustav Fechner, uno psicolo-go tedesco, sottopose al giudizio di un campione di persone alcuni rettangoli diversi per rapporto tra i lati. A conclu-sione dell’esperimento osservò che il maggior numero di preferenze si orien-tava verso il rettangolo aureo.
Ciò rende questa proporzione più at-traente e soprattutto interessante da un punto di vista estetico e artistico.
La sezione aurea è quindi una pro-porzione che genera bellezza, armonia; e per armonia s’intende una combina-zione di elementi diversi che danno ori-gine, nell’accezione originaria del temi-ne greco, a un «buon rapporto».
Questo rapporto armonico si trova in molte parti del creato, in quanto se-guono schemi pentagonali, stellari e a spirale. Qualche esempio?
Nel centro di molti fiori, come la verbena e il lino, troviamo la stella pen-tagonale. Oppure, provate a seziona-re orizzontalmente una mela, o una pe-ra: troverete al centro il pericarpo car-tilagineo che disegna una perfetta stel-la; nell’arancia o nel limone, invece, la stella è evidente nell’attacco del piccio-lo, e viene confermata nella distribuzio-ne a 10 spicchi.
Ci sorprende ancora constatare co-me la spirale aurea rappresenti le leggi di accrescimento organico di molti es-seri viventi. Per esempio, si trova nel-lo sviluppo di molte conchiglie come il nicchio di Natulius. Non solo: vediamo la spirale aurea anche nel girasole e nel cavolfiore.
Gli esempi sono numerosi anche nel regno animale: il cranio della volpe ha la larghezza e l’altezza in rapporto au-reo tra loro.
Anche nel cavallo (animale mol-to studiato dagli artisti…) troviamo la stessa legge: la testa, il collo, la lun-ghezza del corpo, la distanza del garre-se da terra: ovunque si formano rettan-
Dio è il vero artista che ha creato il mondo e la vita dell'uomo.L'artista uomo è il collaboratore che partecipa alla sua Creazione.

13
La pittura non è quin-di meccanica imitazione, ma «intima e spirituale elaborazione del model-lo naturale» (Schlosser, La letteratura artistica, p. 179).
Essa assume caratte-ri divini anche attraver-so l’imitazione della natu-ra, la quale in tanti modi e forme esprime la divina proporzione.
L’artista utilizza la stessa struttura generativa usata da Dio per creare il
mondo, per questo egli si sente vicino a Dio: «Noi per arte possiamo essere det-ti nipoti a Dio» (Leonardo, Trattato del-la pittura, p. 11).
Lo scultore e il pittore quindi, at-traverso la sezione aurea, si voglio-no emancipare da semplici artigiani, com’erano considerati nel Medioevo, a scienziati e creatori: microcosmo e ma-crocosmo.
Contemporaneamente, l’artista dà origine a un ordine parallelo, un mon-do che si erge sulle stesse leggi su cui si regge il mondo di Dio incastrando così la sua creatura tra le creature del Som-mo Artista.
Questo anelito, questa utopia esteti-ca, che trovando le sue origini nel de-siderio di emancipazione dell’artista va ben oltre le rivendicazioni sociali, dà voce ai desideri più nascosti dell’artista, il quale, calcando un po’ la mano, pas-sa dall’immagine dell’umile artigiano a quella di Dio.
Quest’ambizione non muore col chiudersi dell’esperienza rinascimenta-le, ma cavalcando i secoli giunge sino all’epoca contemporanea, dove il feno-meno dell’astrattismo fondato sull’idea di creare un’opera che si regga su leg-gi proprie e che non faccia uso del lessi-co della natura, alimenta questa chime-ra estetica, fino a ritrovarla tra gli artisti della Section d’or.
Proprio come l’uomo del Rinasci-mento, essi considerano la loro arte «non solo rappresentazione dell’ordi-ne cosmico, ma creatrice essa stessa di un ordine identico a esso, operando se-condo le stesse leggi matematiche che
ve dell’Umanesimo fiorentino: La na-scita di Venere di Botticelli.
Essa è, nelle misure dei lati della te-la, un rettangolo aureo (così come La Primavera dello stesso pittore). La «di-vina proportio», inoltre, definisce molte parti della celebre tela: la linea di oriz-zonte è sezione aurea del lato minore del quadro, così pure l’ombelico di Ve-nere, l’occhio, il mento, la mano destra della figura femminile che si accinge a coprire Venere.
Anche La vergine delle rocce di Le-onardo è costruita all’interno di un ret-tangolo aureo, e i suoi sottomultipli or-ganizzano la posizione degli elementi del quadro.
Vi invito a cimentarvi a tentare di scovare tali rapporti aurei.
Per gli artisti del Rinascimento in modo particolare, l’imitazione della na-tura era fondamentale. Non si può imi-tare la natura senza avere fondamenti teorici, scientifici e matematici. Chi lo fa è un vero «imbrattatele».
goli aurei.Ma il fatto più incre-
dibile è che la sezione au-rea regola un importante organismo vivente: il cor-po umano. L’ombelico, per esempio, è un punto foca-le importante e in un corpo ben sviluppato divide l’al-tezza totale secondo la se-zione aurea ed è punto di ri-ferimento di base della co-struzione (vedi l’uomo vi-truviano di Leonardo o l’uomo-Modulor di Le Cor-busier). E non solo!
Il corpo umano contiene in molti punti il rapporto aureo: la lunghezza e la larghezza del volto, la distanza degli oc-chi, la posizione delle sopracciglia, del naso e delle labbra, le spalle e la lun-ghezza delle braccia aperte sono tutte misure che, in un corpo ben sviluppato, rispettano la divina proporzione.
Con la Sectio divina un universo af-fascinante si apre agli occhi degli arti-sti i quali sono sedotti da questa propor-zione in maniera costante nelle diverse epoche. A partire dal mondo greco fino al '900 molti artisti non hanno resisti-to alla tentazione di servirsi della divi-na proporzione nell’elaborazione delle loro opere. Nella sua ricerca della per-fezione, l’arte classica greca guardò al-la forma ideale della natura e pose co-me unico oggetto del suo interesse la fi-gura umana.
Policleto, artista greco del V sec a.C. costruisce il suo Doriforo, scultura che rappresenta il corpo di un atleta nelle sue perfette proporzioni.
Il Partenone, una delle più impor-tanti e famose opere greche, è regolato in molte sue parti dalla sezione aurea, e come lui anche altri templi greci meno famosi, come il Tempio della Concor-dia e quello di Cerere.
Anche molti pittori e architetti del Rinascimento (epoca che prende co-me punto di riferimento l’arte classica) utilizzano lo stesso metodo; tra questi, Botticelli, Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Raffaello, Leonardo, Tiziano.
Non possiamo prenderli tutti in esa-me, ma consideriamo una delle opere più famose e maggiormente significati-
S C U O L A D E L S A B A T O

14
lo costituiscono e inserendosi nella ca-tena della creazione divina» (Nigro Co-vre, Per una iconologia dell’ astratti-smo (1910-1913). Temi e simboli geo-metrici, p. 53).Un dono di Dio
L’uso della divina proporzione, so-prattutto nel Rinascimento, non espri-me solo significati filosofici, ma an-che profondi bisogni interiori dell’ani-mo umano.
In un interessante studio di Giorgio di Genova, viene evidenziato come alla base dell’uso della sezione aurea ci sia non solo il bisogno di bellezza e armo-nia, ma anche il complesso rapporto tra uomo e natura, la volontà dell’uomo di dominare la natura fino alle sue manife-stazioni più sfuggenti, misteriose e osti-li. Dopo avere finalmente dominato la natura, «l’uomo si esalta a tal punto da inseguire un mito di perfezione in cui proietta la sua aspirazione al divino, che non a caso riconosce nei principi della matematica e della geometria.
È così che il desiderio di perfezio-ne dell’inconscio, attraverso la coscien-za si fa utopia razionale, utopia così per-sistente da avere portato, oltre che a di-pingere opere e costruire architettura secondo i rapporti proporzionali aurei, addirittura a scovare nella natura la stes-sa sezione aurea come un valore indi-scusso di perfezione» (Di Genova, «La sezione aurea come desiderio dell’in-conscio e utopia della ragione» in Raf-faello e la sezione aurea, p. 82).
Tuttavia, l’arte non è solo sezione aurea, regola matematica; è innanzitut-to comunicazione, ma anche presa di coscienza, divertimento, dolore, prote-sta, scandalo.
Ogni pittore e scultore ha usato il linguaggio artistico per dire qualcosa, per dirlo in una forma diversa dalle pa-role, in modo alternativo, in una forma che aggira gli ostacoli, le nostre barriere di protezione, i nostri stereotipi.
L’arte è anche anelito dell’anima verso Dio. Perché non pensare a ope-re come La fiducia in Dio dello sculto-re Bartolini, il quale rappresenta la fede paragonandola a una ragazza inginoc-chiata, nuda, con lo sguardo rivolto ver-so l’alto, completamente abbandonata a
Dio; oppure, alle opere del pittore ingle-se Turner, o di David Friedrich, piene di impeto e di energia, nelle quali la natu-ra diviene soggetto con cui l’uomo dia-loga e interroga e la pennellata si fa por-tatrice dei moti inquieti dell’animo, del suo senso di angoscia verso l’enigma e il mistero?
Il linguaggio artistico è uno dei più affascinanti doni che Dio ha fatto all’uomo per imparare a uscire fuori da-gli schemi, per guardare il mondo con occhi diversi e per alzare le braccia e lo sguardo verso l’Immenso.Simona Magistà
S C U O L A D E L S A B A T O
LA PRIMAVERASandro Botticelli, 1478Firenze, Galleria degli UffiziLa Primavera, opera di soggetto mitologico, è innanzitutto un inno alla perenne rinascita della natura nell'amore, anche se contiene altri significati più nascosti e sottili con riferimenti alla filosofia neoplatonica e al Poliziano.Ma al di là di ciò Raffaello si avvale sapientemente nella composizione del quadro dei parametri della sezione aurea per cui la visione d'insieme ci appaga per i gradevoli rapporti tra i lati che nasce da quella sensazione intima che soddisfa l'anima.La composizione in questo caso dev'essere letta da destra verso sinistra in quanto l'azione descritta inizia con Zefiro, il vento vivificatore della natura, che insegue Flora; dalla loro unione nasce la Primavera che avanza spargendo fiori.Al centro è Venere, la dea dell'amore e della fecondità, sulla cui testa svolazza Eros.Naturalmente l'arte di stendere i colori, le trasparenze, le intensità... completano la visione.
La grande costellazione di Orione

15
umana si misurava ancora in secoli. Se quegli uomini così longevi, dotati di un’eccezionale capacità di proget-tare e realizzare, si fossero dedicati al servizio di Dio, avrebbero suscitato le lodi del loro Creatore. Si sarebbe adempiuto lo scopo per cui erano sta-ti creati. Ma ciò non avvenne.
In quel tempo esistevano molti gi-ganti, uomini forti e alti, famosi per la loro saggezza, abili nella realizza-zione di opere ingegnose e sorpren-denti.
La loro responsabilità, nella dif-fusione della corruzione fu purtrop-po corrispondente all’eccezionalità delle loro doti. Dio aveva concesso a questi esseri grandi capacità, ma es-si se ne servirono per appagare il loro orgoglio personale.
Le loro straordinarie qualità si tra-sformarono in una maledizione, per-ché furono utilizzate per scopi egoi-stici, anziché in favore di Dio, che le aveva donate. I giganti utilizzarono oro, argento, pietre preziose e legno pregiato per costruire delle abitazio-ni e fecero a gara per possedere la di-mora più sontuosa e raffinata. La loro principale aspirazione era soddisfa-re l’orgoglio personale e si divertiva-no nel contemplare scene di piacere e di malvagità. Evitavano di pensa-re a Dio e presto giunsero a negarne l’esistenza. Adorarono la natura inve-
ce del Creatore; resero onore al genio umano, ne adorarono le opere e inse-gnarono ai loro figli a inchinarsi da-vanti a immagini scolpite.
Posero gli altari dei loro idoli nei prati, all’ombra degli alberi; boschi interi vennero consacrati all’adora-zione di falsi dèi. I luoghi in cui si svolgevano questi culti erano magni-fici giardini, con ampi e lunghi viali fiancheggiati da alberi ricchi di frutti di ogni tipo, ornati da sculture e col-mi di tutto ciò che poteva deliziare i sensi o soddisfare i desideri. Si trat-tava di un ambiente molto seducente.
Gli uomini non credevano più in Dio, ma adoravano immagini create dalla loro fantasia e quindi la corru-zione dilagava. Il salmista descrive in questo modo le conseguenze a cui vanno incontro coloro che venerano gli idoli: «Come loro sian quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confi-dano» (Salmo 115:8). Infatti, noi sia-mo trasformati da ciò che vediamo.
La statura morale di un uomo cor-risponde al suo concetto di verità, pu-rezza e santità. Se la sua mente non si eleva, se non è guidata dalla fede a contemplare l’amore e la saggezza divini, egli sprofonderà sempre più in basso. Coloro che adorano false divi-nità, attribuendo loro passioni e ca-ratteristiche umane, abbassano il lo-ro ideale di carattere sino al livello di
S C U O L A D E L S A B A T O
E VENNE... IL DILUVIO
Al tempo di Noè le conseguen-ze della trasgressione di Adamo e dell’assassinio commesso da Cai-no costituivano una minaccia per il mondo; tuttavia, ciò non aveva avu-to conseguenze visibili sulla natura.
Pur manifestando tracce eviden-ti del male, il mondo era ancora ric-co deimagnifici doni di Dio. Le colli-ne erano ricoperte di alberi maestosi, dai rami carichi di frutta; vaste pianu-re, simili a giardini, erano rigogliose di vegetazione e di fiori profumati. I frutti della terra si trovavano in gran-de varietà ed erano molto abbondanti. Gli alberi superavano per dimensio-ni, bellezza e armonia le specie ora esistenti, il loro legno aveva bellissi-me venature ed era così duro da es-sere simile alla pietra. A quell’epo-ca era possibile trovare oro, argento e pietre preziose in grande quantità.
L’uomo conservava ancora la maggior parte delle energie e delle facoltà di cui era stato dotato alla cre-azione. Erano trascorse solo poche generazioni dall’epoca in cui Adamo aveva avuto libero accesso all’albe-ro della vita e la durata dell’esistenza
Da Patriarchi e Profeti (Edizioni ADV) di E.G.Whitevi proponiamo il capitolo 7«IL DILUVIO»
Illustrazione di Francesca CapelliniCorrere della Sera, 23.12.2012

16
S C U O L A D E L S A B A T O
un’umanità imperfetta e perdono la loro dignità.
«E l’Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e che tutti i disegni dei pensieri del lo-ro cuore non erano altro che male in ogni tempo... Or la terra era corrotta davanti a Dio; la terra era ripiena di violenza» (Genesi 6:5,11).
Dio aveva dato agli uomini i co-mandamenti come regola di vita: quando furono infranti, la corruzione divenne dilagante.
La malvagità degli uomini era inaudita, la giustizia era calpesta-ta nella polvere e i lamenti degli op-pressi raggiungevano il cielo.
Nonostante il divieto divino, la poligamia era stata introdotta già da tempo. Il Signore aveva dato ad Ada-mo una sola moglie, manifestando così la sua volontà. Dopo il peccato, gli uomini preferirono seguire i loro desideri e, come conseguenza, i de-litti e la miseria aumentarono. Non si rispettavano né il matrimonio né i diritti di proprietà; tutti desiderava-no ardentemente le mogli e i posse-dimenti del prossimo e se ne appro-priavano con la forza, orgogliosi del-le proprie azioni violente.
Gli esseri umani provavano pia-cere nel distruggere gli animali e nu-trendosi di carne diventarono sempre più crudeli, finché giunsero a consi-derare perfino la vita dei loro simili con sorprendente indifferenza.
Nonostante la storia del mondo fosse ancora agli inizi, la corruzio-ne era diventata così profonda e dif-fusa che Dio non poté più sopportar-la e disse: «... Io sterminerò di sulla faccia della terra l’uomo che ho cre-ato...» (v. 7).
Dichiarò che il suo Spirito non avrebbe sostenuto sempre l’umani-tà colpevole. Se gli uomini non aves-sero cessato di deturpare con le loro azioni malvage il mondo e i suoi ric-chi tesori, egli li avrebbe cancella-ti dal creato, distruggendo tutti i do-ni che aveva elargito. Avrebbe fatto scomparire gli animali e la vegeta-zione, che forniva una quantità così abbondante di cibo: quel bel pianeta si sarebbe trasformato in un luogo di rovina.
In mezzo alla corruzione dilagan-te, Methushelah, Noè e molti altri agirono con l’obiettivo di risvegliare la conoscenza del vero Dio e di frena-re l’ondata di malvagità.
Centoventi anni prima del diluvio, il Signore dichiarò a Noè il suo obiet-tivo, ordinandogli di costruire un’ar-ca. Mentre la costruiva, egli avrebbe annunciato il decreto di Dio circa la distruzione della terra e dei malvagi attraverso il diluvio. Chiunque aves-se creduto a questo messaggio, pre-parandosi all’evento ispirato dal pen-timento e dal sincero desiderio di ri-formare la propria esistenza, sarebbe stato perdonato e salvato.
Enoc aveva ripetuto molte vol-te l’avvertimento di Dio ai suoi fi-gli; Methushelah e i suoi discendenti, vissero abbastanza a lungo per udire la predicazione di Noè e assistere al-la costruzione dell’arca.
Dio aveva dato a Noè indicazio-ni precise sulle dimensioni dell’im-barcazione, fornendogli dati partico-lareggiati sul progetto. Nessun uomo aveva mai costruito in precedenza qualcosa di così gigantesco e resi-stente.
Dio stesso era l’ispiratore dell’o-pera e Noè il capocantiere. L’arca as-somigliava allo scafo di una nave, perché doveva galleggiare, ma in al-cune parti era una casa: era distribui-ta su tre piani e sulla fiancata si apri-va una porta.
La luce proveniva dall’alto e i vari locali erano disposti in modo da esse-re tutti illuminati. Il materiale impie-gato per la costruzione era il cipresso, detto anche legno di gofer, che pote-va resistere inalterato per secoli.
La realizzazione di questa immen-sa struttura rese necessario un lavoro attento e continuo. Nonostante la for-za eccezionale degli uomini del tem-po, la preparazione del legname rica-vato da alberi di genere e dimensioni eccezionali richiedeva una quantità di lavoro maggiore rispetto a quella oggi necessaria. Noè e i suoi compagni fe-cero tutto il possibile per compiere un lavoro perfetto, ma nonostante tutte le precauzioni e gli accorgimenti l’ar-ca non avrebbe resistito alla tempesta del diluvio, se Dio non l’avesse pro-tetta dalle acque impetuose.
Continua sul prossimo numero.
«Centovent'anni prima del Diluvio, il Signore dichiarò a Noè il suo obiettivo, ordinandoglidi costruire un'arca»
Arca di Noè,illustrazione tratta dalla «Bibbia di Norimberga»del 1483.Lo scafo dell'Arca è stato oggetto nel corso dei se-coli di numerose discus-sioni sia per le dimensioni (300 x 50 cubiti) sia per la forma. E.G.White ci ragguaglia con poche pa-role: « L’arca assomigliava allo scafo di una nave, perché doveva galleggia-re, ma in alcune parti era una casa: era distribuita su tre piani e sulla fian-cata si apriva una porta». Null'altro.

17
L I B R I
Autori: Robert C. Newmann & John L. WiesterEditrice: Alfa&Omega con A.I.S.O.Pagine: 160Prezzo: € 12,50
Gli autoriRobert C. Newmannè professore di Nuovo Testamento alla «Biblical Theological Seminary» di Hatfield, Pennsylvania. Coautore di Genesis and the Origin of the Earth.
John L. Wiesterè docente di biologia al «Westmont College», Santa Barbara, California. Autore di The Genesis Connection.Johnathan Moneymakerè insegnante e progettista di program-mi scolastici nonchè scrittore.Janet Moneymakerè vignettista e illustratrice. Insieme i Moneymaker dirigono «Readable Ink.», un'azienda che fornisce servizi di scrittura a Seattle, e sono membri del «Discovery Institute Center for the Renewal of Science and Culture».
C'è un libro per tutti! Un dialogo amichevole sull'evoluzione Meglio di questa stringata definizi-one non ci poteva essere!In effetti il libro inventa un dia-logo-dibattito tra due professori sull'evoluzione e su quanto la scien-za riesca a spiegare sulla vita.Scoprite cosa c'entra la logica.Verificate se le variazioni nelle dimensioni del becco dei fringuelli delle Galapagos provano il darwi-nismo.Scoprite le avventure entusiasmanti dei super eroi, Mutaman e Selecta.C'è più di quanto pensaste dietro a tutto ciò.Venite con noi e considerate le risposte offerte alle domande dei super eroi, sostenitori ideali di due storie «diverse».Nelle pagine del libro incontrerete il professore Tuttodire, sostenitore del darwinismo e la professoressa Facciodomande, che proporrà delle prove a favore della progetta-zione intelligente della natura.Con franchezza, ma in maniera amichevole e rispettosa, spieghe-ranno chiaramente molti aspetti- chiave di questo importante dibat-tito. Sarà un viaggio divertente e interessante.Ideale per studenti. E se non hai figli studenti fatti ugualmente un bel regalo!
Questa brillante critica è estremamente precisa e molto divertente!
Per ordinazioni:[email protected].

18
E V E N T I
LA FAMIGLIA MULTICOLORE
È tutto regolare: nessuno adotta-to, nessuno figlio di un altro padre. È mai possibile? Certo. Inusuale ma possibile. Il caso ha appassio-nato la stampa inglese che ha ribat-tezzato i Giddings come la famiglia «arcobaleno». Il colore della pelle, accompagnato dalla forma del ca-pello, e da alcuni tratti somatici ca-ratteristici è controllato da sei-set-te geni, ciascuno con le sue carat-teristiche.Mescolandosi fra di loro e incon-trando condizioni ambientali un po' variegate, possono produrre anche questo fenomeno, che salta chiara-mente all'occhio.Ma se pensate quanti tipi di neri ave-
1) Chris, 33 anni, genitori kenioti 2) Tess, 24 anni 3) Jacob, 6 anni, pelle olivastra, occhi azzurri 4) Savannah, 4 anni, alla nascita molto simile al fratello, sta crescendo on pelle e capelli più chiari 5) Amiah, 3 anni, la più simile alla mamma 6) Zion, un anno, il solo con gli occhi scuri (CdSera, 27.01.2013 - London Media).
Lui nero, lei bionda e 4 figli «arcobaleno»Sui Giddings si è aperto il dibattito.
Nessun inganno: responsabili sono gli stessi elementi che garantiscono la nostra originalità. Sette sequenze hanno fatto il tutto!
te incontrato e quanti tipi di bian-chi, non vi dovreste meravigliare.È uno scherzo della natura, ma uno scherzo innocente e che non con-travviene a nessuna legge genetica.È un po' come in una ricetta di cuci-na. Un po' più di sale, un po' più di pepe, un po' più di farina o di uovo si possono confezionare i piatti più diversi, magari chiamati tutti con lo stesso nome.In realtà è un po' più di cosi, per-ché si possono avere diversi tipi di sale, diversi tipi di pepe, diversi ti-pi di farina e così via. Differen-ze quantitative quindi, ma anche qualitative, perché un dato gene può avere diverse forme - che noi chiamiamo alleli - oltre che far
sentire la sua voce più forte o più piano.«Bianco» quindi non vuol dire nulla di preciso e così «nero» non vuol dire nulla di preciso. Basta pensare nel primo caso a un fin-landese e a uno spagnolo e nel se-condo a un ugandese e a un cin-galese.Anche se su questo tema sonostati scritti volumi e volumi, di-ciamo onestamente che sul colo-re della pelle c'è poco più da dire. Ma consideriamo altri caratteri genetici, meno appariscenti ma di maggiore sostanza, come la per-severanza, la tendenza all'ordi-ne, la puntualità, la resistenza allo stress o i gusti alimentari, anche

19
senza tirare in ballo l'intelligenza che nessuno sa bene che cosa sia.Ecco che allora la scatola di cioc-colatini non sarebbe più una me-tafora inquietante.Sappiamo da sempre che i nostri figli sono tutti diversi fra di loro, e più lo sapevano i nostri bisnonni quando di figli ne avevano anche una decina.I geni si mescolano, si mescolano le sostanze che ne con-trollano l'attività, si mescolano le condizioni in cui gli individui si trovano a crescere e si mescolano i tempi nei quali i diversi geni si attivano o si disattivavano duran-te lo sviluppo.Ho già detto tante volte che a for-giare ciascuno di noi concorro-no tre fonti di variabilità: i geni, la vita vissuta da ciascuno, cioè la sua biografia, e last but not least, il caso.L'effetto di quest'ultimo è il più difficile da comprendere e anche da credere. Anche perché la paro-la «caso» non ci piace.Ma chi, come me, ha visto nasce-re e crescere una gran numero di cuccioli delle specie più diverse con lo stesso identico patrimonio genetico e che sono andati incon-tro più o meno alle stesse vicende, sa benissimo che cosa questo può significare.Basta che invece di 20 molecole in un caso se ne facciano 22, oppu-re che una determinata connessio-ne nervosa vada più a destra inve-ce che più a sinistra o che un trat-to di dna sia più occupato o più li-bero e tutto cambia.Naturalmente entro certi limiti, sennò addio! So bene che è diffi-cile accettare tutto questo, ma poi quando si presentano casi come quelli di cui stiamo parlando op-pure persone con un occhio di un colore e uno di un altro, il fenome-no che ho sommariamente descrit-to si può toccare con mano. E non c'è nulla da obiettare.Teniamoci stretta la nostra origi-nalità e meditiamoci sopra.
E V E N T I
MISTERIOSA STRAGE DI ANIMALI NEL
BORNEODieci rarissimi elefanti pigmei sono stati trovati morti, perché avvelenati, nel settore indonesiano del Borneo.Un cucciolo, che non si rassegnava alla morte della madre, ha provato a risvegliarla accarezzandole
la fronte con la proboscide.I pachidermi compiono una sorte di rito funebre nei
confronti dei loro defunti. Ma, in questo caso, l'elefantino è stato colto impreparato e così ha dovuto acquisire, attraverso una dolorosa trafila, la nozione di cos'è un
essere dopo la morte.
Gli elefanti sono animali intelligenti e sensìbili. Imparano a cogliere la differenza tra un animale vivo e uno morto, e protrag-gono l'attaccamento affettivo per un fami-liare al di là della sua stessa esistenza.
Così almeno sembra, considerando quel-la sorta di rito funebre che questi pachider-mi compiono nei confronti dei loro defunti.
Famiglie intere vi partecipano ed è così che normalmente i giovani apprendono i comportamenti rituali di ispezione di ciò che resta dei loro morti.
Del tutto diverso è però il caso di que-sto elefantino, perché l'imprevedibile morte della madre l'ha di fatto colto impreparato.
Eccolo dunque acquisire per personale esperienza, attraverso una dolorosa trafila, la nozione di cos'è un essere dopo la mor-te. Lo scopre immoto, che non risponde ai segnali, che diventa freddo, sempre più freddo. E allora che, pur non conoscendo il
concetto, impara che la morte è per sempre. Finché non restano che ossa. E sono pro-prio queste che tornano a visitare, a ispe-zionare i gruppi di parenti. E chissà quali pensieri elabora la loro mente straordinaria.
Il caso dell'elefantino è dunque per vari motivi diverso, ed è anche più triste, per-ché sperimenta sconcerto e un dolore vivis-simo, senz'altro pari a quello di una madre che perde il proprio figlio.
Joyce Poole dell'Amboseli Elefant Pro-ject commenta: «Osservando la sua veglia funebre per la prima volta ebbi fortissima l'impressione che gli elefanti conoscano il lutto. Non potrò mai dimenticare l'espres-sione degli occhi, della bocca, del porta-mento delle orecchie, della testa, del corpo. Ogni parte esprimeva dolore».

20
R U B R I C A
I lettori ci scrivonoNell'esaminare gli insegnamenti dello
Spirito di Profezia per rispondere a do-mande riguardanti l’Arca dell'alleanza nascosta e le Tavole della Legge di Dio in essa contenute, è essenziale che si ten-ga conto del fatto che ci sono «due» Ar-che dell'alleanza: una è quella che era in-serita nel Santuario terreno, attualmente nascosta in una grotta la cui locazione è tuttora ignota:
«Fra coloro che abitavano ancora a Gerusalemme, ai quali era stato rivela-to il piano di Dio, alcuni decisero di sot-trarre alle mani sacrileghe l’Arca sacra che conteneva le tavole di pietra sulle quali erano stati scritti i precetti del De-calogo. Essi riuscirono a realizzare il lo-ro progetto.
Con estrema sofferenza e tristezza occultarono l’arca in una caverna dove sarebbe rimasta nascosta al popolo d’Israele e di Giuda a causa dei suoi peccati e non sarebbe stata mai più re-stituita. Quell’arca sacra è tuttora na-scosta e non è mai stata riesumata».(Da Profeti e Re, Edizioni ADV, pag. 230, capitolo «La deportazione a Babilonia»).
L'altra Arca è nel cielo locata nel San-tuario celeste essendo quella «origina-le» in quanto il Tabernacolo (o Santuario terrestre) è «una copia di quello celeste».
È qui che sono depositate le due tavo-le della legge.
«La legge di Dio nel santuario in cielo è il vero originale, i cui precetti scritti sul-le tavole di pietra e registrati da Mosè nel Pentateuco furono una perfetta trascri-zione» (Da Il gran conflitto, E.G.White, Edizioni ADV, pag. 434) (Delle cinque dichiarazioni contenute nello studio di Odom abbiamo estratto la più concisa).
Entrambe queste arche ed entrambi questi insiemi della legge divina sono logicamente o ovviamente nascosti agli sguardi degli uomini.
Avendo scritto E.G.White che avvici-nandosi il tempo in cui le tavole di pietra su cui sono scritti i Dieci Comandamenti saranno mostrate agli abitanti della Ter-ra, sorge naturale chiedersi quale delle due Tavole saranno esposte!
Nel documento anzidetto sono ripor-tate tutte le citazioni di E.G.White in proposito e sinceramente si fa fatica a comprendere quale delle due Tavole sa-ranno esposte! Non è un problema di ca-rattere teologico ma, potremmo dire, una semplice e, forse, grande curiosità!
Stando a questa dichiarazione sareb-bero le due Tavole scritte al Sinai ad es-sere «pubblicate» al mondo intero:
«C'è un santuario, e in questo santua-rio vi è l'arca, e nell'arca ci sono le ta-vole di pietra, sulle quali è scritta la leg-ge espressa al Sinai in mezzo a scene di grandezza terribile.
Queste tavole di pietra sono nei cie-li, e saranno mostrate nel giorno in cui il giudizio sarà presentato ed i libri verran-no aperti, e gli uomini saranno giudicati in base alle cose scritte nei libri.
Essi saranno giudicati con la legge scritta con il dito di Dio e data a Mosè per essere depositata presso l'arca.
È tenuta una registrazione degli atti di tutti gli uomini, e secondo le sue opere ogni uomo riceverà la sua sentenza, siano esse buone o siano esse cattive» (Ms 20, 1906 - 20MR68).
Probabilmente (nostra ipotesi), le due Tavole ora nascoste, saranno (o sono già state) portate nel Santuario in cielo per-ché «da nessuna parte si dica che le ta-vole saranno mostrate da uomini che di-ranno di averle trovate nascoste in una grotta» (R.L.Odom).
E.G.White non specifica quale del-le due serie di tavole della legge verrà visualizzata, e pertanto è possibile per ognuno interpretare entrambe le ipo-tesi! L'importante è «essere pronti per quell'evento»!
Quale «Arca dell'alleanza» sarà mostrata all'umanità alla fine dei tempi?Alcuni lettori ci hanno sollevato la questione di quale Arca (considerato l'articolo dello scorso numero sull'Etiopia) sarà mostrata al ritorno di Cristo. L'ADV di Firenze ci ha messo gentilmente a disposizione questo documento dal quale riportiamo i passi che interessano.Coloro i quali volessero copia del documento sono pregati di richiederlo alla Direzione dell'ADV citando il presente articolo.
Il documento in questione è una dichiarazione preparata nel 1962 da R.L. Odom, relatore degli indici del SDBible Commentary ed aggiornata nel 1989 dall'«Ellen G. White Estate», l'Istituto che cura e conserva i manoscritti originali di E.G.White.

21
DA TUTTO IL MONDO!
Citazioni citabili«Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nel bicchiere... »Salomone (X secolo a.C.), Proverbi 23:31«L'acqua che tocchi de' fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene. Così il tempo presente»Leonardo da Vinci (1452-1519) (Scritti letterari)«Voi sonerete le vostre trombe, e noi soneremo le nostre campane»Pier Capponi (1447-1496). Gonfaloniere di Firenze, a Carlo VIII, attribuita in questa forma dal Guicciardini nella Storia d'Italia«La pace è più importante di ogni giustizia; e la pace non fu fatta per amore della giustizia, ma la giustizia per amor della pace»Martin Lutero (1483-1546, iniziatore della Riforma protestante) da Il matrimono
LA RICETTA PER UNA VERA PULIZIAAll'Università dell'Ohio, Stati Uniti, si cerca di realizzare nuovi materiali autopulenti e che riducano a massimo l'attrito.Così hanno scoperto, analizzando al microsco-pio, che le ali della farfalla Morpho Didius e la foglie dell'Oriza Sativa, un comune tipo di riso, si sono resi conto che la loro repellenza allo sporco e all'acqua è data da alla complessità della struttura.Scanalature dirandanti per la farfalla africana le consentono di liberarsi dell'85% della sporcizia on un solo battito d'ali e di restare costantemente asciutta.La foglia di riso, invece, presenta righe e dossi microscopici sotto uno strato ceroso che ga-rantisce il 26% in meno di attrito e i 95% di rimozione dello sporco.Tutte queste caratteristiche permetterebbero di ridurre i tempi di trasferimento e i costi di gestione di tubature in special modo degli oleodotti.
Foresta Nera!86 CAMMELLI VI PERDONO LA VITA
La notizia non è delle più belle e dispiace per tutti gli amanti degli animali. Un catastrofico incendio di un allevamento di cammelli nella Foresta Nera, Germania, oltre a distruggere la struttura in legno che ospitava gli animali, pur-troppo, ha anche toccato la sorte dei cammelli.86 di loro sono morti nell'incendio e solo 4 si sono potuti salvare. Il complesso dal nome esotico di «Fata Morga-na» serviva anche come centro terapeutico per bambini che in 30.000 all'anno lo visitavano.La locale polizia sospetta che l'incendio sia di natura dolosa.
Ali di farfalle
Vista, udito, olfatto, gusto e tatto: presto gli smartphone saranno in grado di interagire con tutti e cinque i nostri sensi.I dispositivi oggi a disposizione possono già sentire e vedere, tramite microfono e fotoca-mere, e sentire e interpretare il nostro tatto.Ora una piccola start up di San Francisco dice di essere riuscita a realizzare un chip da integr-re nei futuri telefoni, capace di identificare odori e sapori. Un po' come avviene con i dispositivi antincendio, che rilevano in automatico fumo, gas e sostanze chimiche.Questo sistema riconosce circa duemila «odo-ri» (il naso umano ne riesce a riconoscere «ap-pena» 400), anche mescolati tra loro e verrà
applicato ai te-lefonini, sopra tutto per colo-ro che guida-no. I «bevitori» sono avvisati enon avranno più scuse nei controlli della polizia strada-le!
SentenzeSE LACIRCONCISIONE È REATOL'ha deciso il Tribunale di Colonia. La comunità ebraica chiede l'intervento del Parlamento. Anche se praticato per motivi religiosi la circoncisione, che in Germnia riguarda prevalentemente la comunità ebraica e quella musulmana equivale ad una mutilazione.Così si sono espressi i giudici del Tribunale di Colonia, aggiungendo che con questo intervento «il corpo del bambino subisce una modicazione stabile e irreversibile, contraria all'interesse del bambino stesso che dovrà decidere più tardi e da solo la sua appartenenza religiosa».
Mentre la comunità musulmana tace, i Consiglio centrale degli Ebrei di Germania ha vivamente reagito a questa snetenza, giudicandola un'intro-missione grave nelle prerogative della comunità, e ha coinvolto il Parlamento per dirimere la questione sulla libertà religiosa. La notizia è del luglio 2012. Sinora non abbiamo avuto riscontri sull'appello al Parlamento tedesco.
Problema alcolBEVUTO TROPPO?L'ALCOL TEST SI FARÀCON IL TELEFONINO
ScritturaCHI SCRIVE A MANOUSA IL CERVELLOPIÙ DI CHI DIGITAUna ricerca rivaluta penna e fogli per lo sviluppo di abilità visive, motorie e costruttive.In effetti questa ricerca cecoslovacca ef-
fettuata su bambini nati dopo il 2000, più avvezzi alla realtà virtuale che alla vita reale, ha messo in risalto il loro rischio di dimenti-care abilità utili nella realtà quotidiana, quali allacciarsi le scarpe o andare in bicicletta. Le scuole si chiedano se sia opportuno intro-durre il pc in classe al posto dei libri: la risposta non è univoca, ma di certo se il cmpouter è una risorsa non trascurabile, non dimentichino ceh il vecchio mododi scrivere velocizza la capacità di apprendere e migliora anche quella di ricordare.