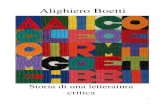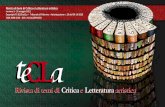Lezioni di teoria della letteratura Critica francese a.a.2010-2011
description
Transcript of Lezioni di teoria della letteratura Critica francese a.a.2010-2011

Lezioni di teoria della letteratura
Critica francesea.a.2010-2011I lezione
Raccolta dati

II lezione11.10.2010
• Diacronia di una definizione:
• “fiction” secondo Pierre Daniel Huet, La Lettre à M. de Segrais sur l’origine des romans (1670)
• e secondo Denis Diderot, Eloge de Richardson, (1761)

Lezione 3 (13.1010)
• T.Todorov, Théorie de la littérature,• Seuil, “Essais”, 2001• -meriti e limiti del formalismo• -l’oggetto della “scienza letteraria”• -il concetto di funzione• -il rapporto linguistica-letteratura (=letterarietà)• -la percettibilità della forma• -la nozione di “procedimento” nella composizione dell’intreccio• -il concetto di “evoluzione”• -il rapporto “evoluzione” “storia letteraria”• “evoluzione” e “influenza”• “l’evoluzione letteraria come “dialettico succedersi delle forme”
• -

Segue (B. Ejchembaum,La teoria del metodo formale)approfondimenti su
• .la nozione di “funzione”
• .il ruolo della percezione edello “straniamento”
• .la “letterarietà”
• .il procedimento
• .l’evoluzione delle forme e la loro “dinamica”

B.TOMACHEVSKI, THEMATIQUE(FABULA E INTRECCIO)
• .la scelta del tema e sue caratteristiche:
• -interesse, attuale, e tale da destare l’attenzione del lettore• .l’importanza del ruolo del “lettore”• .attualità e tradizione• .la fabula e l’intreccio (fable et sujet)• .i “motivi” e la loro distribuzione• .motivi legati e liberi• .motivi dinamici e statici• .i vari tipi di “narratore”• .la “struttura dell’intreccio” e la sua dimensione spazio-temporale

collegamenti
• 1. Su motivi legati e liberi cf.
• R. Barthes, Introduction à l’analyse structurale du récit in “Communications”, 8, 1966
• 2. Sulle “categorie” del racconto letterario, cf. Tv. Todorov, Le récit littéraire, ibidem.

segue
• .su la “fabula” cf. Propp, Morphologie du conte,
• .su vari tipi di intreccio, cf. Todorov,
Poétique de la prose

segue
• Le riformulazioni dello schema proppiano: il “processus” di C. Brémond , Logique de récit, poi riprese anche da Greimas in Sémantique structurale , Sémiotique et sciences sociales. Cf. anche di Greimas, Dictionnairede la théorie du langage, 1979.

Segue lezioni fino al 17- 10- 2010
• Per una critica allo Strutturalismo, cf. G.Genette, Figures I, da pp. 142-sgg.(ediz. Italiana)• Le proposte di Genette: utilizzare lo strutturalismo per indagare le letterature minori ecc., ibidem, p.
146; far convivere lo strutturalismo e l’ermeneutica in modo complementare; riprendere la retorica classica e il rinnovamento della critica letteraria.
• I limiti di tali strumenti: mancanza di una dimensione temporale, ossia la consapevolezza che ogni “sistema” formale è sottoposto ad evoluzione (ibidem).
• I meriti del Formalismo: aver messo in luce il concetto di mutamento e di funzione (p. 154).• Il cambiamento di valore delle forme da un’epoca all’altra (cf. il “grottesco).• La “letterarietà” si coniuga necessariamente ai processi di cambiamento culturale che
sottintendono al cambiamento delle “forme”.• Le oscillazioni di Genette tra Figures 1 e Figures III, cf. pp. 74- sgg., allorché tenta di modificare la
rigidità del termine “récit” inserendolo nell’atto della narrazione.• La tripartizione che Genette propone a questo fine: storia, racconto, narrazione.• Il compito del Discorso narrativo” quale studio dei rapporti tra racconto/storia, racconto/narrazione;
storia/narrazione.• In particolare, là dove Genette affronta i “Modes du récit” (Figures III, p. 209)introduce i ruolo del
lettore, quale arbitro della ricezione del racconto, a seconda della distanza e della prospettiva della narrazione.
• Il ruolo del narratore come “personaggio dell’azione” o come “assente dall’azione”. Il punto di vista della narrazione.

segue
• Da T. Todorov, Les genres du discours, pp. 13-sgg.• La nozione di letteratura e l’esistenza della letteratura• Le caratteristiche della letteratura e della finzione• La letteratura come sistema • La possibilità di ritrovare “sistemi” in altri linguaggi, diversi dal “letterario”• La sconfitta di una definizione di letteratura che si basi unicamente sulla funzionalità e sul
suo essere sistema• La necessità di introdurre un’altra nozione che corregge il termine e il concetto di “testo” ,
ossia il termine “discorso”• La molteplicità dei discorsi possibili e la loro codificazione• Discorsi e generi• Quali sono le proprietà del testo (o discorso, qualunque esso sia): l’aspetto pragmatico• Il recupero della prospettiva diacronica allorché si affronta il “discorso” e la questione
relativa ai “generi de discorso”• L’origine dei discorsi• I generi dei discorsi: il caso del “racconto fantastico” (pp. 57-59).

segue
• 1. Da R. Barthes, Essais critiques, “De l’oeuvre au texte”
• Dalla nozione di “discorso” a quella di “testo plurale”(p. 75).
• Il testo come “plaisir et jouissance” (cf. su questo punto anche Le plaisir du texte, vedi dopo.
• Il testo è uno spazio “sociale” (vedi su questo p.to S/Z)).
• 2, Da R. Barthes, Le plaisir du texte, 1973
• (cf. da p. 10 a p. 30)
• Plaisir et jouissance du texte
• Il ruolo del testo
• Come valutare un testo
• Come deve essere uno scrittore
• La scrittura ad lta voce (p. 105)