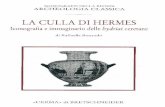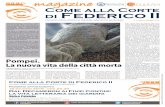Lezioni Archeologia Classica
description
Transcript of Lezioni Archeologia Classica

13 NOVEMBRE 2013
TEMPIO DI APOLLO PALATINO
Deve il suo nome all’essere stato dedicato al dio Apollo e collocato sul colle Palatino. Sappiamo che la sua costruzione, cominciata nel 36 a.C., era già conclusa nel 28 a.C.. Il tempio, che come abbiamo detto si trova sul colle Palatino, è sito in prossimità della casa di Augusto e di quella di Livia. Augusto, infatti, da abile politico evitò di farsi costruire un palazzo e decise di andare a vivere in una semplice casa, di dimensioni appena maggiori rispetto a quelle degli altri dignitari. Lì vicino, tuttavia, si pose appunto il Tempio di Apollo Palatino tanto che, a conti fatti, si finiva per associare la casa di Augusto al tempio in questione.
Scavi abbastanza recenti hanno portato alla luce alcune lastre, dette lastre campana, realizzate in terracotta e con una decorazione a rilievo, utilizzate per coprire determinate parti di alcuni edifici. Elemento piuttosto arcaico, rimarranno comunque in uso almeno sino all’età repubblicana. Nell’età augustea, che vuole un ritorno alla romanità, notiamo perciò una ripresa di questi elementi, presto reimpiegati come riempitivo nei terrazzamenti su cui posava il tempio. Il fatto che su alcune di esse permangano ancora evidenti tracce di colore ha fatto ipotizzare che rimasero esposte per breve tempo. Si pensa che la loro originaria struttura portante fosse un porticato ligneo adiacente al tempio di Apollo, porticato del quale abbiamo memoria come portico delle Danaidi.
Tra le varie decorazioni, notiamo Eracle, con in mano il tripode, e Apollo. Eracle, infatti, si era recato dall’oracolo della Pizia per ottenere indicazioni circa il come purificarsi. Al rifiuto dell’oracolo, Eracle rispose impossessandosi del tripode e minacciando di portarlo via. Intervengono, allora, sia Apollo che Zeus, qui non rappresentato, al fine di fermarlo.
Evidente l’intento politico della costruzione. Augusto, infatti, amava identificarsi con
Apollo mentre la famiglia di Marcantonio si considerava discendente di Eracle. Nella scena è quindi possibile leggere anche l’opposizione tra Augusto e Marcantonio.
La raffigurazione delle chiome di alcune fanciulle riporta all’età severa e all’età classica, a testimonianza del diffondersi del cosiddetto neoatticismo. Il termine, coniato dal Brunn, indica un ritorno allo stile che Atene elaborò quando ancora possedeva un enorme potere sull’area del Mediterraneo, enorme potere ora nelle mani di Augusto.
In un’altra lastra notiamo Atena e Perseo con al centro la testa di Medusa. Poi Iside affiancata da due sfingi. Evidenti sono, anche qui, gli intenti politici. Ottaviano, che non poteva esaltare la guerra civile condotta contro Marcantonio, tentò di esaltare la vittoria romana come una vittoria condotta sul nemico egizio. Per i contemporanei, tuttavia, le immediate associazioni dovevano comunque rendere evidente la propaganda politica.

È da ricordare che Augusto cercò in ogni modo di “mitigare” la percezione della propria figura, mantenendo, ad esempio, istituzioni ormai di facciata come il senato.
IL TRIONFO Nel mondo romano esisteva il Trionfo, una cerimonia destinata a celebrare il trionfo
militare di un personaggio in seguito ad un’importante vittoria. Il Trionfo, tuttavia, poteva essere riconosciuto solo a magistrati con imperium, solo a vittorie su stranieri, solo a vittorie con un gran numero di nemici uccisi e poche perdite nelle proprie schiere, solo a vittorie che avessero permesso l’espansione dei confini dell’impero. Tutte queste erano le condizioni necessarie al Trionfo, che prevedeva l’ingresso in armi dell’esercito nella città. Proprio per questo motivo, tutte le fasi della cerimonia erano controllare con cura e la concessione stessa dell’onore si limitò ad un esiguo numero di personaggi: l’ingresso in armi dell’esercito nella città, infatti, avrebbe potuto determinare un facile colpo di Stato. Fu così che, col passare del tempo, il Trionfo divenne, di fatto, appannaggio della sola famiglia reale.
Spesso, nel corso della processione, venivano fatti sfilare dei prigionieri e si aveva l’esposizione di cartelli con cartine geografiche e dipinti narranti i più importanti momenti della guerra, in modo da rendere il tutto noto anche a chi non ne avesse avuto notizia.