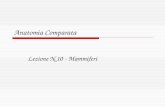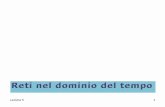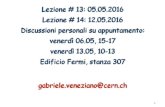Lezione Sul'Italiano Standart
-
Upload
elionanaqo -
Category
Documents
-
view
6 -
download
2
description
Transcript of Lezione Sul'Italiano Standart

Lezione 3L'italiano d'oggi: le varietà funzionali, situazionali e strutturali
Mentre l’italiano standard – quello sancito dalle grammatiche ed insegnato nelle scuole – si manifesta soprattutto nelle scritture di alto livello, nella realtà dell’uso quotidiano, scritto e orale, la lingua si manifesta, in forme che variano a seconda della cultura dei parlanti, della situazione in cui essi si trovano ad interloquire e del mezzo che impiegano per comunicare, negli atti linguistici dei parlanti. L’infinita varietà degli enunciati prodotti, però, non è priva di una struttura interna e, in realtà, essi sono raggruppabili in un certo numero di varietà che, insieme, costituiscono il repertorio della lingua. Solo tenendo presenti le differenze fra le varietà dell’italiano potremo scegliere correttamente quale di esse usare volta per volta, per ottenere il risultato migliore.
La lezione in breve
Il sistema linguistico dell’italiano contemporaneo comprende numerose varietà di tipo diverso. Vi sono innanzitutto due varietà strutturali principali, ovvero quella scritta e quella parlata, che si differenziano per persistenza, contestualità, risoluzione, portata e ricchezza. I sottocodici, o linguaggi settoriali, sono invece delle varietà funzionali, legate a specifiche attività. Esistono poi varietà geografiche, come i vari italiani regionali, e varietà sociali, come l’italiano popolare (di cui non ci occuperemo in maniera specifica). Varietà situazionali, infine, sono i registri (veri e propri livelli di lingua), scelti a seconda della formalità della situazione in cui ci troviamo. La varietà più formale, con cui tutte le altre si confrontano, è l’italiano standard, registrato e descritto nelle grammatiche, il quale sarà ovviamente la scelta privilegiata per i testi di scritti più formali, come quelli di carattere scientifico, letterario e amministrativo. Nel parlato e anche nello scritto informale si fa invece strada l’italiano neostandard, caratterizzato da processi di semplificazione della norma e da un colorito regionale, aperto a forme provenienti dalle altre varietà, e perciò in grado di soddisfare tutte le esigenze comunicative quotidiane: le peculiarità morfologiche e sintattiche tipiche di questa varietà, che tutti usiamo spontaneamente, andranno evitate nello scritto formale.
Sommario
Le varietà della lingua 2Le varietà situazionali, funzionali e strutturali dell'italiano, cenni introduttivi 2Le varietà strutturali: italiano scritto e parlato 3Le varietà funzionali: registri e sottocodici 6
I registri, in dettaglio 6I sottocodici, in dettaglio 7
L'italiano d'oggi: le varietà sociali e geografiche 7L'italiano standard: una definizione ed alcuni caratteri 9

L’italiano neo-standard 10L'uso dell'italiano neo-standard nei documenti professionali 12
Le varietà della lingua
Quali sono esattamente le varietà in cui si sarebbe "disgregata" la lingua italiana? 1. è una varietà situazionale l'italiano che si usa conversando con gli amici o parlando con un
professore ad un'interrogazione; 2. è una varietà funzionale quella usata dagli astrofisici per trattare degli argomenti connessi
con la disciplina di cui si occupano;3. è una varietà geografica quella parlata in Lombardia;4. sono varietà sociali l'italiano popolare ed i gerghi.
Alle varietà che abbiamo appena citato vanno aggiunte anche quelle che sono collegate alla modalità in cui ha luogo la comunicazione, quella scritta o quella parlata, che possiamo chiamare strutturali.
Le varietà situazionali, funzionali e strutturali dell'italiano: cenni introduttivi
Le varietà situazionali sono quelle collegate al contesto comunicativo e sono caratterizzate da parametri quali la formalità, l'accuratezza, l'adesione agli standard grammaticali; i registri sono tipiche varietà situazionali.
Le varietà funzionali sono quelle collegate all'espletamento di determinati compiti o all'esercizio di specifiche professioni; riguardano, in generale, gruppi piuttosto ristretti di parlanti e scriventi e sono caratterizzate da parametri quali la specificità del lessico ed una testualità più o meno articolata; i sottocodici sono tipiche varietà funzionali.
Le varietà situazionali e funzionali sono dette anche diafasiche.
Le varietà strutturali, infine, sono quelle che dipendono dall'uso di un particolare mezzo per la veicolazione delle informazioni: si distinguono, in particolare, varietà orali e varietà scritte.
Le varietà strutturali sono dette anche diamesiche.
Le varietà strutturali: italiano scritto e parlato
Uno scambio comunicativo avviene sempre tra un emittente ed un destinatario che si inviano messaggi utilizzando mezzi e supporti diversi e in differenti modalità. Queste ultime, che si possono definire come le maniere in cui si opera lo scambio comunicativo, sono sostanzialmente due: quella scritta e quella orale.
Le differenze tra scrittura ed oralità
2

La modalità comunicativa scritta è molto diversa da quella orale, anche intuitivamente. Le differenze che intercorrono tra l'una e l'altra si possono raccogliere in cinque categorie generali:
a. quella della persistenza; b. quella della contestualità; c. quella della risoluzione; d. quella della portata; e. quella della ricchezza (o plurimedialità).
Le analizziamo partitamente nei capoversi che seguono.
PERSISTENZA. La modalità comunicativa orale produce testi che sono caratteristicamente volatili: in mancanza di attrezzature tecniche specifiche - che però ne alterano almeno in parte lo statuto originario - essi vengono fruiti nel momento stesso della produzione, nell'ordine in cui si sviluppano e poi si dileguano. Non è di norma possibile, per questo, percorrere i testi orali in senso inverso a quello di produzione o accedervi più volte di seguito: essi, infatti, proprio perché non persistenti sono anche lineari. In modalità scritta, invece, si producono testi persistenti: il loro destinatario può leggerli e rileggerli, sezionarli, analizzarli, valutarne con calma il senso, modificare a più riprese la loro interpretazione. Volendo dare seguito alla metafora geometrica in base alla quale si sono definiti lineari i testi orali, si potrebbe dire che quelli scritti sono planari. Questa caratteristica planarità del testo scritto è importante, naturalmente, oltre che per il suo destinatario, anche per il suo emittente, che vi può intervenire ripetutamente, modificandolo, riordinandolo, emendandolo prima di renderlo pubblico. Tale complesso di possibilità ha conseguenze significative sia sulla forma che sul contenuto del messaggio: se scritto, infatti, esso è sempre più unitario, meno discontinuo, più vicino a modelli socioculturali accreditati, meglio strutturato che non se orale..CONTESTUALITÀ. Per il fatto che la modalità comunicativa orale prevede la produzione di testi che devono essere fruiti nella stessa situazione contestuale, che vengono, cioè, generati ed usati nello stesso momento dal mittente e dal destinatario, gli attori di uno scambio comunicativo orale possono sfruttare gli indizi offerti dall'intorno fisico e dall'ambiente socioculturale; ciò significa che essi si possono permettere, entro certi limiti, di essere meno espliciti, di passare sotto silenzio alcuni elementi informativi, inferibili dal contesto, senza far perdere efficacia ed efficienza comunicative al proprio testo
Ed è sempre il contesto a chiarire, nei testi orali, il valore di elementi linguistici come i pronomi dimostrativi, alcuni pronomi personali, i pronomi e gli aggettivi possessivi, alcuni avverbi di luogo o di tempo. Questi elementi quando servono a "puntare" a precisi oggetti dell'intorno fisico in cui si svolge la comunicazione sono detti deittici. Se - ad esempio in un dialogo - si dice: "Eccolo", oppure: "È lui", sarà la presenza, nelle vicinanze, di un oggetto cui punti lo sguardo o un dito del parlante a chiarire quale sia la persona o la cosa cui si sta facendo riferimento.Proprio per il fatto di essere prodotto e fruito in un contesto condiviso, il testo prodotto in modalità comunicativa orale si sviluppa anche, in genere, interattivamente: nel contesto di un dialogo - un tipico esempio di scambio comunicativo orale - è possibile negoziare il senso da attribuire ad un testo nel suo complesso o ad un suo segmento, ad una serie di enunciati quando la loro interpretazione risulti difficile
Nella modalità comunicativa scritta, viceversa, si generano testi che non vengono di norma fruiti nel medesimo contesto in cui sono prodotti: essi vengono prodotti e letti in momenti ed in condizioni molto diverse. Per questa ragione, chi produce testi scritti non è in grado di sfruttare il feedback dei suoi interlocutori producendo, in maniera interattiva, un messaggio particolarmente funzionale: deve, invece, agire in maniera proiettiva, creando il suo testo per un
3

lettore ideale, un lettore modello, che naturalmente può essere del tutto difforme dal suo lettore reale.
Mancando, inoltre, la possibilità di un diretto confronto con il destinatario del proprio messaggio, l'emittente, quando opera in modalità scritta, non può presumere di poterne chiarire eventuali passaggi che risultino poco chiari o ambigui. Dovrà, quindi, necessariamente, fare ogni sforzo perché il testo che egli produce sia completo ed unitario, autonomo; questa è la ragione per cui, in generale, i testi scritti sono più ordinati, corretti, ricchi di informazione e ridondanti di quelli orali e lasciano meno spazio all'inferenza del destinatario.
RISOLUZIONE. Il termine risoluzione indica - nell'ambito scientifico (informatico) da cui proviene in questa specifica accezione - la quantità di informazioni che uno strumento di visualizzazione, ad esempio un monitor, è in grado di riprodurre; ad una risoluzione più alta, naturalmente, corrisponde un maggiore livello di dettaglio, e quindi una maggiore qualità dell'oggetto riprodotto. Volendo, dunque, estendere metaforicamente l'uso del termine, nell'accezione specifica che abbiamo appena indicato, anche ai testi ed alle loro caratteristiche, possiamo dire che un testo è "ad alta risoluzione" quando include dati ad una densità mediamente elevata.
I testi prodotti in modalità orale presentano, di norma, una risoluzione linguistica inferiore rispetto a quelli prodotti in modalità scritta: la comunicazione orale, infatti, tende a privilegiare, come abbiamo già detto, l'efficienza e l'economicità e, dunque, a ridurre il numero degli elementi linguistici non strettamente indispensabili. Vengono eliminati, ad esempio, molti elementi strutturali, quali le congiunzioni subordinative o alcuni avverbi; ciò comporta anche che i testi orali siano sintatticamente più semplici e disorganici di quelli prodotti in modalità scritta.
PORTATA. In modalità comunicativa orale l'emittente di un messaggio utilizza, per la sua trasmissione, il canale uditivo; esso può veicolare, in condizioni normali (senza, cioè, che si impieghino, per correggerne i limiti, artifici tecnici), segnali - e, quindi, dati, informazioni - solo a breve distanza; ha, cioè, una portata limitata. Al crescere dello spazio che separa la fonte di emissione dei segnali dal punto della loro ricezione, dunque, la qualità del segnale subisce un degrado inaccettabile ed i resti che esso veicola divengono incomprensibili.
I messaggi - i testi - prodotti in modalità scritta, invece, utilizzando il canale visivo ed essendo affidati a mezzi che assicurano loro una certa persistenza possono essere fruiti anche a grande distanza spazio-temporale dal punto di origine: un libro, ad esempio, si può leggere a migliaia di chilometri di distanza dal luogo in cui è stato scritto, ed anche a distanza di anni senza che per questo l'operazione diventi necessariamente più difficile che se effettuata nella stanza accanto a quella in cui lavora l'autore, dopo cinque minuti che egli l'ha stampato con la sua ink-jet.
RICCHEZZA. I testi prodotti in modalità orale utilizzano tipicamente, come si è appena sottolineato, il canale uditivo per la trasmissione dei segnali che li costituiscono fisicamente; va tuttavia precisato che - in tale modalità - l'emittente ha la possibilità di impiegare contemporaneamente più di un canale: il più utilizzato, in sinergia con quello uditivo è quello visivo: mentre si parla, infatti, è abbastanza normale che si indichino oggetti, o che si gesticoli - magari inconsciamente - per manifestare il proprio stato d'animo; ed è del tutto consueto che - parlando con una persona con cui si è in rapporti confidenziali, amichevoli o intimi - si tenda ad
4

avvicinarglisi, ad assumere posizioni rilassate, a "lasciarsi andare", insomma, anche fisicamente. Nei casi che abbiamo citato, peraltro, oltre che di canali diversi, si fa uso anche di codici differenti: oltre a quello linguistico - cui è affidato in condizione normale il nocciolo della comunicazione - anche quello cinesico, cioè dei gesti e quello prossemici, cioè della vicinanza, per usare termini tecnici.
Riepiloghiamo, quindi, in una tabella, i tratti che differenziano i testi prodotti in modalità orale da quelli prodotti in modalità scritta.
TESTI PRODOTTI IN MODALITÀ SCRITTA
TESTI PRODOTTI IN MODALITÀ PARLATA
Persistenza - planarità (possibilità di lettura e rilettura)
Volatilità - linearità (necessità di decodifica lineare)
Progettazione attenta, organizzazione complessa, revisione accurata, realizzazione "proiettiva" (e, quindi, dal punto di vista linguistico: scelta di forme più corrette, di varianti più alte, di strutture più ricche ed articolate, di lessico più preciso, di un'articolazione più organica e coerente dei contenuti).
Pianificazione a breve gittata, organizzazione semplice, realizzazione dinamica e collaborativa (feedback, vedi il punto successivo: dal punto di vista linguistico ciò significa spesso tendenza alla selezione di varianti più correnti ed espressive, di strutture più semplici e meno coerenti, di lessico piuttosto generico, di un'articolazione più debole, di strutture atte a mettere in luce gli elementi comunicativamente salienti)
Non-contestualità: la comunicazione non può dipendere dagli apporti inferenziali ed interpretativi che il destinatario trae dal contesto, perché questo non è necessariamente condiviso; il dominio dell'implicito è ridotto.
Contestualità: la comunicazione riposa pesantemente sugli apporti inferenziali ed interpretativi che il destinatario trae dal contesto in cui avviene lo scambio comunicativo; esso è condiviso; il dominio dell'implicito è quindi di norma piuttosto grande.
Elaborazione in absentia del destinatario; il messaggio viene costruito per lettori-modello, oggetti comunicativi astratti, non concreti. Il feedback è impossibile o posticipato.
Elaborazione in praesentia ed in maniera "contrattuale"; si sfrutta a fini comunicativi un meccanismo comunicativo di azione-reazione.
Risoluzione linguistica e semantica tendenzialmente alte. Abbondanza dei mezzi che garantiscono l'unità del testo.
Risoluzione linguistica e semantica tendenzialmente basse. Economia di mezzi linguistici che garantiscono l'unità del testo.
Possibilità di sfruttare elementi paratestuali di tipo grafico.
Possibilità di sfruttare codici paralinguistici (tono, timbro, ritmo, curve intonative) e di altro tipo (cinesici, prossemici).
Portata ampia. Portata ridotta.
5

6

Le varietà situazionali, funzionali: registri e sottocodici
Su questi argomenti della lezione 3 sono disponibili le schede aggiuntive 1 e 2 nella pagina dei materiali
Una delle più importanti abilità del comunicatore professionale è quella di sapere scegliere lo stile comunicativo più adeguato alla situazione conversazionale in cui si trova e di saperlo gestire coerentemente: parla - e scrive - bene non chi si esprime sempre e comunque in maniera monocordemente dannunziana, ma chi sa stare, per sfruttare un vecchio adagio, "in chiesa coi santi e in taverna coi ghiottoni".
Ma come determinano parlanti e scriventi il proprio stile comunicativo? Attraverso una scelta ragionata delle varietà della propria lingua, soprattutto di quelle situazionali e funzionali: i registri ed i sottocodici. Mentre i registri sono manifestazioni della lingua che si caratterizzano per la loro differente formalità, diversa accuratezza, variabile adesione agli standard grammaticali, i sottocodici sono contraddistinti dalla maggiore o minore specificità del lessico e dall'articolazione maggiore o minore della testualità.
I registri, in dettaglio
Come, nella lingua dei musicisti, un registro è l'estensione sonora coperta da uno strumento o una voce e, per ciò stesso, non più che una sezione dell'ampiezza globale teoricamente disponibile, così in quella dei linguisti, che hanno mutuato il termine musicale per metafora, un registro è uno specifico "livello" di lingua, che congloba una certa quantità delle possibilità espressive messe a disposizione dal sistema.
Esistono livelli, cioè registri) più elevati, adatti a situazioni di particolare formalità e più bassi, appropriati a circostanze più amichevoli ed ufficiose; gli studiosi ne distinguono un numero differente, ma in generale identificano, agli estremi dell'area di possibile variazione stilistica, una varietà aulico-formale ed una informale-trascurata. Tra le due varietà estreme si collocano le altre, elevate, medie e colloquiali, che virano lentamente a costituire un continuum.
Da un certo punto di vista, un registro è una varietà "completa" della lingua: ciò significa che la sua adozione comporta sempre - in maniera meditata o irriflessa - l'impiego di una serie ben precisa di varianti linguistiche che si collocano a tutti i livelli del codice, e cioè a livello lessicale, sintattico, morfologico, fonologico, intaccando anche molti aspetti della testualità.
Per chi si occupa di pratica della scrittura è proprio la capacità di discriminare tra le molte varietà situazionali disponibili e di scegliere quella più adatta al sistema di relazioni in cui egli opera a determinare la maggiore o minore abilità del singolo scrivente; ed è tale capacità ad incidere in maniera rilevante sulla possibilità di raggiungere i suoi fini comunicativi.
I sottocodici, in dettaglio
I sottocodici, detti anche linguaggi settoriali, sono varietà del codice collegate a specifiche attività o a determinate discipline. Il loro primo nome (sotto-codici) vuole sottolinearne lo statuto di segmenti, di sottoinsiemi del codice generale della lingua standard o, forse meglio, della lingua considerata in senso astratto, come sistema omnifunzionale; il secondo (linguaggio settoriale), invece, ne indica soprattutto la natura di varietà distinte (soprattutto dal punto di vista lessicale e testuale) dalla lingua dell'uso medio (ossia da quel settore del macrocodice più comunemente usato
7

dai parlanti nella conversazione comune e colta, ma non specialistica).
Sono sottocodici di importanza rilevante le lingue tecnico-scientifiche (come quella della tipografia, o della medicina), che presentano, tuttavia un tasso differente di specializzazione: in alcuni casi molto alto (e tale da dare luogo a vere e proprie terminologie: si pensi a quella della chimica), in altri relativamente basso (si pensi alla lingua dei politici e ad alcune lingue di mestiere, come quella dei fabbri, o dei calzolai).
I sottocodici hanno formato (e formano) il loro lessico attraverso i normali meccanismi della prefissazione e suffissazione, della composizione e del prestito. Prefissi e suffissi vengono impiegati, nelle terminologie in maniera deliberatamente rigida; nelle lingue speciali meno formalizzate, invece, il loro impiego è meno rigoroso e quindi sostanzialmente conforme a quello della lingua comune.
I prestiti vengono attinti a serbatoi differenti, a seconda della disciplina e della sua storia: scienze e tecniche moderne - come l'informatica - sono grandi debitrici dell'inglese (si pensi ad anglicismi non adattati come mouse, monitor, floppy disk, hard drive o ad adattamenti come formattare, scannerizzare); discipline di tradizione più antica, invece - come la medicina, o la biologia - hanno pescato a larghe mani dal greco e dal latino (e lo si nota in parole come apoplessia, emiplegia, sclerosi, ictus). Esistono anche scienze che hanno teso ad utilizzare in abbondanza anche lessico comune, risemantizzandolo e normalizzandolo (e cioè, assegnando a ciascuno dei suoi elementi un significato nuovo ed univoco): è il caso della fisica, che usa, in accezione molto specifica, termini come campo, banda, potenziale.
L'italiano d'oggi: le varietà sociali e geografiche
L'italiano, come abbiamo già detto, non è un insieme monolitico di elementi, ma, piuttosto, un dinamico aggregato di varietà le cui caratteristiche dipendono dalla cultura e dalla classe sociale dei parlanti e degli scriventi, dal contesto in cui essi si trovano ad operare ed a comunicare, dalle zone da cui essi provengono o nelle quali vivono e risiedono e dal mezzo che essi impiegano per scambiarsi informazioni.
Dopo aver trattato le varietà situazionali e funzionali (diafasica) e lei varietà strutturali (diamesiche); ci occuperemo ora delle varietà geografiche (diatopica) e sociali (diamesica).
Le varietà geografiche sono quelle legate agli usi delle diverse aree di un dominio linguistico (nel nostro caso: quello italiano), e sono per lo più contraddistinte da una fonetica, da un lessico e da una sintassi particolari. L'italiano di Puglia, ad esempio, è una tipica varietà regionale.
Su questo argomento della lezione 3 è disponibile la scheda aggiuntiva 3 nella pagina dei materiali.
Le varietà sociali sono quelle connesse con l'estrazione sociale e con il livello culturale dei parlanti e degli scriventi e - come quelle situazionali - sono caratterizzate da parametri quali la
8

formalità, l'accuratezza, l'adesione agli standard grammaticali, oltre che dalla maggiore o minore coloritura regionale o dialettale. Una varietà sociale è, a sua volta, un contenitore di varietà situazionali, nel senso che anche persone scarsamente istruite impiegano le loro risorse linguistiche in maniera sensibile al contesto della comunicazione. L'italiano popolare (link 6) è una tipica varietà sociale.
Caratterizzare le une e le altre in astratto risulta piuttosto difficile; più agevole è farlo attraverso qualche esempio. Si provino a leggere, ad esempio, i brani che seguono, buoni rappresentanti il primo di una varietà sociale (l'italiano popolare) ed il secondo ed il terzo di due varietà geografiche (gli italiani regionali di Sicilia e del Veneto:
1. [...]e poi il mio amico Romeo sentendo questo racconto gli fece una proposta e andò dal suo padrone della ragazza e gli disse: Se ci date una buona dote alla ragazza la sposo io e il bambino lo legittimo io, se viceversa tutto verrà svelato, e per il tentato suicidio diremo che si è sentita meno è svenuta e si è appoggiata alla ringhiera del ponte e non cera nessuno ad aiutarla e è precipitata nel fiume per disgrazia e se non gli date nulla sarà denunciato il vostro figlio per violenza carnale senza il consenso della giovane donna.
Danilo Montaldi, Autobiografie della leggera, Torino, Einaudi, 1961, p. 228.
2. [Montalbano] Dei morti se ne fotteva altamente, poteva dormirci 'nzemmula, fingere di spartirci il pane o di giocarci a tressette e briscola, non gli facevano nessuna impressione, ma quelli che stavano per morire invece gli provocavano la sudarella, le mani principiavano a tremargli, si sentiva agghiacciare tutto, un pirtuso gli si scavava dintra lo stomaco. Riattaccò e esplose in un nitrito, altissimo, di gioia. Subito, nella cucina, si sentì un rumore di vetri infranti: per lo spavento, ad Adelina doveva essere caduto qualcosa di mano. Pigliò la rincorsa, satò dalla veranda sulla rena, fece un primo cazzicatummolo, poi una ruota, un secondo capitombolo, una seconda ruota. Il terzo cazzicatummolo non gli arriniscì e crollò senza sciato sulla sabbia. Adelina si precipitò verso di lui dalla veranda facendo voci...
Andrea Cammilleri, Il cane di terracotta, Palermo, Sellerio, 1996, p. 278.3. "Este, noi siamo arrabbiati con la Mantiero, eh?" La Este mi disse: "Taci, sprotòne, cosa
vuoi sapere tu?" Mi resi conto che ero rimasto io solo a stare arrabbiato con la Mantiero: le grande avevano tradito la loro stessa causa con una frivolezza quasi incredibile. E non fu nemmeno l'ultima che mi fecero le grande. Scendevamo verso la piazza io la Flora e la Este: davanti a noi sul marciapiede uscì la signora Ramina, rossa di capelli, snella e presuntuosa. Mie cugine spettegolavano criticando la figuretta che ci precedeva ancheggiando. "La tra 'l culo", bisbigliavano. Io camminavo in mezzo e volevo partecipare anch'io alla conversazione, dare un contributo. Ci pensai su e dissi: "La trà la fritola".
Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, Milano, Mondadori, 1986, p. 20
Prescindendo dalle ovvie differenze di contenuto e di genere, un confronto tra i testi mette in evidenza che il brano 1 mostra una grande quantità di quelli che si considerano normalmente "errori" (se ci date; se viceversa; cera 'c'era') e che gli altri si differenziano, oltre che per stile e struttura, soprattutto per la presenza, nel loro interno, di elementi dialettali: meridionali (siciliani) nel primo ('nzemmula, pirtuso, satò, cazzicatummolo, tra i più evidenti), settentrionali (veneti) nel secondo (ad esempio: sprotone, trar là, fritola).
Pur tanto diversi tra di loro, però, i brani che abbiamo analizzato sono tutti scritti in italiano:
9

non nello stesso tipo di italiano evidentemente; non nella lingua appresa nei suoi aspetti formali sui banchi di scuola. Le varianti regionali sono sempre sentite come marcate; ciò significa che chi le impiega a sproposito, cioè nei contesti sbagliati, può passare per persona rozza o poco colta. Per questa ragione, occorre evitarle sempre, soprattutto nello scritto di una certa formalità, come i testi professionali, a meno che non vi siano impellenti ragioni di ordine comunicativo che impongano di derogare al principio generale che raccomanda, nella redazione di testi scritti, l'aderenza alle varietà standard o neo-standard.
L'italiano standard: una definizione ed alcuni caratteri
Iniziamo la nostra descrizione delle caratteristiche salienti dell'italiano standard da una definizione, la seguente: l'italiano standard è la varietà di lingua che - posseduta soprattutto dalle persone colte - viene assunta, anche implicitamente, come modello da tutti i parlanti e gli scriventi e che viene prescritta come esemplare nell'insegnamento. Esso è anche - per definizione - privo di coloritura regionale a tutti i livelli, incluso quello fonetico. Per il fatto di avere un notevole prestigio, l'italiano standard è altresì tradizionalmente riservato agli usi scritti più "nobili" e formali, come quello intellettuale, scientifico, letterario e burocratico.
Caratteri analoghi a quelli che noi abbiamo considerato propri dell'italiano nella sua "versione" standard sono stati riconosciuti come costitutivi per una lingua standard anche da Berruto 1987, che l'ha infatti descritta come:
a. dotata di stabilità, garantita da istituzioni capaci di esprimere una norma (grammatiche e dizionari);
b. caratterizzata da capacità di intellettualizzazione, ossia dotata di caratteristiche tali da permettere a chi la parla di esprimere testi di alto contenuto culturale (letterario, filosofico, religioso, scientifico, tecnico); tale capacità è assicurata da una tradizione maturata a seguito di una prolungata elaborazione da parte delle classi colte;
c. dotata di prestigio, garantito dal suo uso negli ambiti letterari, ufficiali, formali, oltre che dalla formalizzazione grammaticale.
In realtà, quello dello standard è un concetto che rinvia ad una realtà molto singolare, che si manifesta solo in determinate occasioni, in particolare nei testi scritti più curati. La maggior parte dei parlanti e degli scriventi dell'italiano impiega, infatti, di norma, nella conversazione e nella scrittura non formale una varietà di lingua più "agevole", e cioè più semplice, più adatta a dare corpo all'espressività, più incline all'accoglimento di alcune forme regionali: si tratta dell'italiano neo-standard.
L'italiano standard dunque costituisce la scelta più frequente per il redattore di testi di rilievo intellettuale, scientifico, letterario e burocratico. Nelle scritture poco formali, come nella divulgazione o nell'informazione giornalistica, esso può essere vantaggiosamente sostituito dal neo-standard, con i suoi moduli più semplici e colloquiali.
L’italiano neo-standard
Le modifiche cui l'italiano è andato soggetto nel corso dell'ultimo secolo sono molteplici: grazie ad esse, usi e forme che la precettistica ha sempre condannato hanno tanto espanso il proprio
10

dominio da vedersi riconosciuto un diritto di cittadinanza nel parlato e nello scritto poco o mediamente formale e da vedersi garantita una certa accettabilità anche in grammatiche e dizionari. In tali situazioni, anzi, l'impiego di tali forme tende a configurarsi come una sorta di nuova, implicita norma, che tende a scalzare l'altra, più conservativa; a fianco dello standard ancien regime, per via della progressiva diffusione della lingua nazionale, si va affermando, insomma, un nuovo standard. Anzi: il nuovo standard, che si incarna in una varietà che uno studioso ha recentemente battezzato italiano neo-standard (Berruto 1987).
Una definizione dell'italiano neo-standard
L'italiano neo-standard è una forma semplificata e più o meno colorita regionalmente dell'italiano standard; esso è anche una varietà stilisticamente aperta dell'italiano: a differenza di quest'ultimo, infatti, esso verrebbe infatti comunemente impiegato - sia nell'oralità che nella scrittura - da qualsiasi italiano normalmente scolarizzato per l'espressione e la comunicazione quotidiane a tutti i livelli di formalità, sia nello scritto che nel parlato.
L'italiano neo-standard viene definito una varietà semplificata di quella di riferimento (lo standard) in quanto caratterizzata da importanti processi di semplificazione che comportano la riduzione di alcuni paradigmi (come quello dei pronomi personali, nel quale alcune forme tendono a sparire dall'uso comune) e la diminuzione della complessità d'uso di alcuni elementi linguistici (come, tra i tempi ed i modi verbali, il condizionale ed il congiuntivo). Esso è, inoltre, caratterizzato come una variante più o meno colorita regionalmente dell'italiano normativo in quanto - sempre marcata per ciò che riguarda l'intonazione e la fonetica - lo è talora anche per ciò che concerne il lessico e la sintassi. L'italiano neo-standard è, infine, caratterizzato come una varietà stilisticamente più aperta dello standard (più aperta, cioè, dal punto di vista diafasico) perché utilizzabile per il soddisfacimento di tutte le esigenze comunicative, anche quelle pratiche e quotidiane; questa sua particolare disponibilità è legata anche all'accoglimento di numerose forme e modalità espressive attinte ai sottocodici più disparati, tra i quali primeggiano quello medico, quello tecnico-scientifico e quello burocratico.
Alcuni caratteri dell'italiano neo-standard
Su questo argomento della lezione 3 è disponibile la scheda aggiuntiva 5 nella pagina dei materiali
Chiarito come sia sorto e che cosa sia l'italiano neo-standard, può essere utile cercare di individuarne i caratteri linguisticamente salienti, come già si è fatto per le altre varietà dell'italiano.
In generale occorre osservare che il neo-standard si caratterizza rispetto allo standard a tutti i livelli del sistema del codice linguistico, cioè, per quanto riguarda la fonetica, la morfologia, la sintassi, la testualità ed il lessico.
In particolare,per quanto attiene alla morfologia, sottolineiamo come l'italiano neostandard presenti, nell'ambito di un più generale processo di semplificazione dei paradigmi dell'italiano standard, una notevole tendenza a sostituire forme colte, letterarie e di uso complesso a favore di altre più correnti. A livello pronominale, ad esempio, forme (come lui, lei, gli) vedono espanso il proprio dominio a scapito di altre (come loro, egli, ella, essi, esse), che vengono invece usate sempre meno spesso,
11

mentre alcuni tipi piuttosto colti e ricercati (tra gli altri, ciò) tendono a scomparire, a tutto vantaggio di altri di uso più immediato (come quello che funge anche, in condizioni normali, da deittico, e che ha quindi un'alta frequenza d'uso).
La tendenza alla semplificazione agisce anche sulla sintassi: sono particolarmente comuni, per esempio, soprattutto nell'oralità, usi analogici ed estesi di alcuni elementi giunzionali (in espressioni quali Il giorno che vieni in ufficio ti passo tutta la documentazione o Prendi l'ombrello che piove: si tratta di casi di quello che i linguisti chiamano “che polivalente”) o modificazioni dei rapporti d'uso di tempi e modi verbali (per esempio: l'uso del presente invece del futuro in enunciati come Domani vado in università; giovedì, invece, sono a casa, o dell'imperfetto invece del condizionale in Volevo chiederle un favore: può telefonare al prof. Rossi per fissare un appuntamento; oppure l'indicativo al posto del congiuntivo, come in Non so perché sei così agitato, ma cerca di calmarti).
La testualità, a differenza della morfologia e della sintassi, è caratterizzata da una tendenza all'espressività, più che da quella alla semplificazione.Si segnalano, in particolare, numerosi artifici che mettono in rilievo elementi particolarmente importanti ai fini della comunicazione, che sfruttano, nell'oralità, semplici mezzi prosodici (come l'intonazione) e, nella scrittura, sia la punteggiatura che strumenti sintattici come lo spostamento degli elementi nella frase o la segmentazione di quest'ultima:
1. nel costrutto Io, il giornale lo leggo solo al mattino!, il rilievo del soggetto io è evidenziato non solo dalla presenza fisica del pronome (che non deve necessariamente figurare, in italiano), ma anche dalla virgola, nel testo scritto, da un accento di frase nell’oralità;
2. il costrutto È nella camera sterile che si devono eseguire le campionature, è il risultato dello "spezzamento" di una frase semplice come Le campionatura si devono eseguire nella camera sterile. I linguisti chiamano questo costrutto frase scissa.
Infine, nel lessico dell'italiano neo-standard, le due tendenze alla semplificazione ed all'espressività operano congiuntamente; si trovano, infatti, nell'italiano dell'uso medio vari regionalismi (in genere non troppo marcati, come cornetti settentrionale per fagiolini), stranierismi (soprattutto anglismi, come wordprocessor, editing) in copia, numerosi derivati, termini ottenuti per scorciatura (come scorporo da scorporare) e sigle (HTML, WWW); sono poi comuni forme verbali con pronome (il tipo entrarci) e termini un tempo stilisticamente marcati.
L'uso dell'italiano neo-standard nei documenti professionali
La varietà neo-standard dell'italiano è utilizzabile nella redazione di documenti professionali e tecnico-scientifici? La risposta, come sempre, non può essere perentoria. Se è chiaro che la semplicità, la generale comprensibilità e l'ampia disponibilità in termini di adeguatezza alle più diverse condizioni diafasiche sono caratteristiche che autorizzano e suggeriscono l'uso del neo-standard in una serie significativa di situazioni comunicative, la presenza di forme e strutture piuttosto "rilassate", amichevoli e colloquiali, vivaci ed espressive - oltre che, talora, colorite in senso regionale - ne può sconsigliare l'impiego nel caso in cui si debbano redigere documenti istituzionali e formalizzati e quando sia necessario mantenere un alto decoro espressivo: non proprio di rado, dunque, nel caso dei testi professionali e tecnico-scientifici.
12

Gli argomenti della lezione 3 sono riassunti e spiegati negli allegati seguenti, accessibili dalla pagina dei materiali:
Schema introduttivo alle varietà di linguaSchema esplicativo del modello di BerrutoSchema di commento al modello di Berruto
13