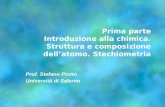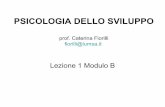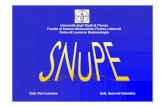Lezione 1
-
Upload
paolo-lattanzio -
Category
Documents
-
view
1.160 -
download
1
Transcript of Lezione 1

La comunicazione e i mass media

La comunicazione
La comunicazione non soltanto come scambio di informazioni da un soggetto ad un altro, ma come dimensione significativa dell'esistenza umana che si sviluppa a partire dalle relazioni e interazioni degli esseri umani.

Etimologia
• Greco, koinoo e koinoneo (mettere in comune, essere coinvolti).
• Latino, communico (“condividere”, “rendere comune”).
La rilevanza della cooperazione

Ma cosa intendiamo per comunicazione?
• Sintassi• Semantica• Pragmatica effetti della comunicazione umana sul
comportamento

• Comunicazione face to face• Comunicazione mediata

Secondo Goffman gran parte della vita sociale può essere divisa tra
• RIBALTA: che è costituita da quelle circostanze sociali in cui gli individui agiscono secondo ruoli formalizzati e codificati: si tratta cioè di vere e proprie “rappresentazioni sceniche”.
• RETOSCENA: che sono quegli spazi in cui gli individui approntano gli arredi scenici e si preparano all’ interazione che dovrà avvenire in contesti più formali.

Ogni media ha la sua storia e le sue caratteristiche mediatiche in termini di:
• Efficacia comunicativa • Usabilita’ • Accessibilita’• Accettazione socio/culturale

Ma cosa sono i mass media?
Particolari interfacce orientate alla costruzione, negoziazione e condivisione di significati, sostenute da un supporto tecnologico predisposto all’elaborazione di sistemi simbolici socialmente identificabili.

Comunicazione specialistica e generalista
• È necessario utilizzare sempre la dinamica T-R-T (tema – rema- tema)
• È necessario partire da una motivazione che poi è spesso la ricaduta sul quotidiano
• Al quotidiano bisogna ritornare sempre

Quindi mass media possono avere effetti
• Di attivazione• Di rafforzamento• Di conversione
Questi effetti alle volte possono essere mediati

Attività dei media
• Sorveglianza dell’ambiente
• Interpretazione degli eventi
• Trasmissione culturale
• Intrattenimento

Funzioni dei media
• Allertare i cittadini• Fornire gli strumenti per realizzare alcune attività
quotidiane • Attribuire status e prestigio a persone e gruppi • Rafforzamento del prestigio di coloro che si
conformano all’aspettativa sociale di essere “cittadini ben informati”
• Rafforzamento delle norme sociali

Pubblico

Quando comunichiamo con chi parliamo?
• Il pubblico o i pubblici?
• Costruzione deI lettore modello

• Pubblico: l’insieme di tutti coloro che possono essere raggiunti da un medium
• Target: un gruppo-bersaglio cui indirizzare un dato prodotto
• Audience: pubblico reale, quantificato, numericamente rilevato
• Massa: vasta aggregazione di individui isolati e anonimi • Comunità interpretativa: fascia di pubblico caratterizzata
da interessi comuni durevoli

• Con il passare dei decenni, le diverse scuole di ricerca sui media attribuiscono al pubblico un ruolo via via meno passivo, fino alla concettualizzazione contemporanea di “pubblico attivo”
• Il “pubblico attivo” è caratterizzato da selettività, utilitarismo, intenzionalità, refrattarietà all’influenza esterna e coinvolgimento

Giornale

• Giornalismo: produzione di notizie basata su precisi fattori economici, organizzativi, culturali
• Redazioni trasformano dati grezzi (eventi) in prodotti confezionati (notizie). In questo passaggio si modifica il fatto stesso (distorsione involontaria)
• Notiziabilità: possibilità che un evento possa trasformarsi in notizia
• Criteri notizia: regole pratiche che guidano il lavoro redazionale

La notizia – variabili in gioco
• L’evento non è la notizia; non tutti eventi sono notizia; scelta della notizia avviene in base a una presunzione; singolarità; originalità; importanza per la collettività; sviluppo.
• Novità, emotività, esclusività

Locale e nazionale
• Un giornale locale si baserà su proprie fonti più di quanto faccia un giornale nazionale

Come si costruisce una copertura
• Fatto
• Cronaca
• Analisi
• Testimonianze

2) Il boom dell’infografica

Il primo sfoglio
• Trasformare l’evento-notizia in fatto-problema
• La notizia non è più una storia in sé conclusa, con attacco, svolgimento e conclusione, ma si inserisce in un insieme correlato di articoli

La tematizzazione
• E’ stata chiamata “tematizzazione”• La notizia “esplode”, il tema viene
“spalmato” su più pagine• I rischi: le pagine monografiche cacciano
le altre notizie

Ogni medium ha delle priorità
L’agenda setting
- Attività di framing
Donald Shaw

L’agenda
• “Questo è importante”, “questa è la notizia del giorno”
• Il giornale non pretende più di registrare neutralmente la realtà
• Il giornale fissa, cioè impone/suggerisce, un’agenda di priorità e una visione del mondo

• Ipotesi fondamentali di “agenda setting”:– i media dicono quali sono i temi e problemi importanti e di
quali vale la pena occuparsi– i media stabiliscono l’ordine di priorità tra gli argomenti in
agenda
• I media non dicono all’individuo che cosa pensare, ma definiscono gli ambiti rispetto ai quali pensare qualcosa
• Fissare una visione del mondo è una operazione culturale, cioè fa riferimento ad un insieme di valori (politici,sociali,civili)
• Il rapporto giornale-lettore diventa una questione di identità

Hard news e soft news
• Non basta più dargli solo notizie. Vogliono fumetti, gare, cruciverba. Vogliono sapere come cuocere una torta, farsi degli amici e influenzare il futuro. Ergo, oroscopi, consigli per le scommesse, interpretazioni dei sogni per vincere al lotto. E se, accidentalmente, inciampano nella prima pagina….notizie!”

Il “mielismo”• “Inconfondibile miscela di spirito alto e materia bassa;
attenzione a tutto quanto è televisivamente popolare e popolarmente televisivo;(…); apparente leggerezza; allegra e spavalda disponibilità al pettegolezzo; visione conflittuale della realtà, con conseguente sottolineatura di “casi”, “polemiche”, “duelli” e, quando possibile, spargimento di polpettine di zizzania, destinate soprattutto a uomini politici e intellettuali che si prendono troppo sul serio; culto del dettaglio, talvolta tirato all’estremo limite e cioè ben oltre la vicenda entro cui esso dettaglio si inscriverebbe…”
• (Filippo Ceccarelli)

BisogniBisogni•Comunicare liberamente
e non solo in forma canonica
•Scegliere una propria forma di espressione
•Veicolare
•Leggersi
•Esporre non solo ciò che “si studia”
•Documentare
opinioni, conoscenze,
informazioni, sensazioni, emozioni …
esperienze, prodotti realizzati singolarmente o
col gruppo classe, competenze …
situazioni, modi di essere,
idee, messaggi,
riflessioni …

… consente di …•Favorire la comunicazione all’interno e all’esterno dell’istituto
•Utilizzare mezzi di comunicazione che siano vicini al vissuto dei ragazzi
•Educare all’uso dell’informazione
•Garantire una produzione partecipata da più soggetti (studenti, docenti, genitori …)
•Valorizzare la cultura vissuta del ragazzo
•Far affiorare saperi ed interessi che rischiano di essere ignorati sia dagli autori sia dai docenti
•Dare “un senso” alle produzioni scritte
•Avviare un confronto fra “pari” come mezzo di costruzione del sapere sociale
•Abbattere le barriere delle aule
•Aprire la scuola al territorio