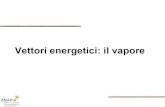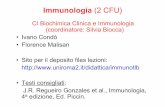Lezione 01 (17-11-06) Immunologia
-
Upload
manuela-orani -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Lezione 01 (17-11-06) Immunologia
-
8/7/2019 Lezione 01 (17-11-06) Immunologia
1/5
IMMUNOLOGIA DEL 17/11/2006 PRIMA LEZIONE(PRIMA ORA)
tutti noi siamo dotati di un sistema che e in grado di reagire a tutto quello che ci circonda e di bilanciarlo in modo tale da
evitare che si modifichi lomeostasi del nostro organismo: questo sistema e il sistema immunitario. lorigine
dellimmunologia come scienza che studia il s.i. viene fatta risalire alla fine del 700 quando jenner pubblico su una rivista
scientifica i risultati della sua prima sperimentazione fatta inoculando a livello cutaneo del materiale di pustola vaiolosa del
bestiame in alcuni soggetti e noto che questi soggetti non morivano nellepidemia del vaiolo. jenner quindi fece la prima
vaccinazione,il termine vaccino e riferito alla specie animale da cui era stato ottenuto il materiale per vaccinare, cioe estata indotta una immunizzazione provocando il contatto programmato tra lindividuo e il materiale che potesse indurre uno
stato di protezione contro lagente virulento.
jenner decise di sperimentare lutilitadi questo materiale per verificare il grado di protezione e da allora praticamente
iniziolimmunologia,che inizio appunto con una vaccinazione.cose il sistema immunitario? e un insieme articolato di cellule e molecole che si integrano nel determinare il
mantenimento dellorganismo nella sua integrita nei confronti di agenti esterni.. abbiamo detto che serve a mantenere
lomeostasi dellorganismo nei confronti degli agenti esterni. quindi primo recquisito necessario e che il s.i sappia
distinguere cio che e esterno e cio che non lo e .il s.i discerne da cio che e proprio (self) e da cio che non e
proprio(non self).questa e una condizione essenziale per il mantenimento dellintegrita dellorganismo. esiste un aspetto
dellimmunopatologia in cui il s.i perde questa capacita di discriminare,questa condizione e rappresentata dalle malattieautoimmuni,indotte dal fatto che il s.i perde questa sua capacita di discriminazione.
come puo distinguere da self e non self?chiamaremo innanzitutto il non self come antigeni. leliminazione degli antigeni
puo avvenire secondo due modalita:-una modalita non specifica:esistono delle componenti del s.i che noi abbiamo dalla nascita,che hanno delle
caratteristiche di funzionalita che sono indipendenti dallesperienza dal contatto con le varie sostanze
-una modalita specifica:ci sono delle cellule e delle molecole che sono in grado di distinguere non soltanto tra cio che e
self e non self,ma anche tra una sostanza e laltra. la risposta di queste componenti si verifica solo dopo il contatto,questa e
la differenza,e la risposta che operano nei confronti di queste sostanze migliora ad ogni successivo contatto,a differenza diquella del sistema non specifico,dove entita e qualita della risposta rimangono sempre uguali che sia la prima o centesima
volta.
le componenti del s.i sono rappresentate dai linfociti t,dai linfociti b,da altri linfociti che hanno una morfologia particolare
ovvero sono piu grandi del normale,presentano delle granulazioni e vengono definiti lgl(large granular limphocyte) ,dalle
cellule mononuclueate ad attivita fagocitaria,dai polimorfonucleati e dalle piastrine. un ruolo importante svolgono le
mastocellule che troviamo a livello dei tessuti e sono implicate in molti meccanisimi di difesa soprattutto nei confronti dei
parassiti.
vediamo come sono inquadrate queste cellule: le cellule del sistema specifico sono essenzialmente linfociti e in particolare 2sottogruppi di linfociti :i linfociti t e i linfociti b. la componente solubile ovvero molecolare del sistema specifico detto
anche acquisito, perche viene acquisita lesperienza di una particolare sostanza estranea, e rappresentata dagli anticorpi oimmunoglobuline,mentre nel sistema specifico innato abbiamo i linfociti detti natural killer che hanno la morfologia a large
granular limphocyte,i macrofagi,i monociti,i polimorfonucleati e abbiamo una quantita di fattori solubili quali
complemento,lisozima,proteine della fase acuta ,citochine ecc.
il sistema specifico acquisito e il s.i per eccellenza: in qualche modo viene reclutato in seconda battuta solo quando il primo
non e in grado di gestire completamente la difesa.
quali sono le caratteristiche essenziali di questi 2 gruppi?
il sistema acquisito si caratterizza per 2 cose :la specificita e la memoria.
specificita:il sistema innato e in grado di riconoscere dei pattern molecolari presenti su vari patogeni. riconosce a volteanche pattern molecolari presenti sulle nostre cellule, ma in genere in questo caso abbiamo un doppio riconoscimento del
pattern molecolare, e le altre strutture inibiscono lattivazione della cellula. nella forma adattativa o acquisita invece le
cellule presentano dei recettori che sono specifici per una determinata sostanza e che sono in grado di discriminare tra unasostanza e laltra,quindi una singola molecola puo essere distinta da unaltra grazie al recettore di superficie delle cellule.
la diversitanel s.i innato e abbastanza limitata cioe gruppi di recettori riconoscono gruppi di sostanze mentre nella forma
adattativa abbiamo unampia diversita.
la memoria manca nel s.i innato o aspecifico ed e presente in quella adattativa.
tornando a jenner,cose che ci protegge da un successivo contatto dopo il vaccino?con la vaccinazione noi abbiamointrodotto una memoria immunitaria quindi il s.i riconosce per es il virus dellepatite b e gli impedisce di penetrare.
la non reattivita verso il self in condizioni normali e caratteristica di tutte due i sistemi.
per quanto riguarda il s.i innato le barriere fisiche,integre anatomicamente e funzionalmente quali cute e mucose, di per se
rappresentano la prima difesa. un ustionato e infatti un immunosoppresso,gli manca una componente fondamentale che
serve a difenderlo.
-
8/7/2019 Lezione 01 (17-11-06) Immunologia
2/5
nella forma adattativa lunica molecola specifica e rappresentata dagli anticorpi.
linfociti:
da un punto di vista morfologico i linfociti sono cellule abbastanza piccole,7-8 micron,rapporto nucleo/citoplasma a favore
del nucleo che ha in genere una cromatina molto addensata e scarso citoplasma.
non solo i linfonodi,la milza e le tonsille ma anche delle strutture localizzate a livello delle mucose,non organizzate
anatomicamente,ovvero in modo non visibile, che costituiscono il tessuto linfoide annesso alle mucose, collaborano con il
sistema innato per assicuraci il miglior risultato possibile.limmunita acquisita si sviluppa durante lintera esistenza e si basa sullesperienza antigenica e sul fatto che ce una
memorizzazione da parte dei linfociti. cosa significa tutto questo?significa che in pratica noi abbiamo un sistema di cellule
rappresentato dai linfociti che possiamo distinguere in tre gruppi particolari:i linfociti t e b che sono specifici e i natural
killer che non sono specifici. tutte queste cellule vengono prodotte a livello del midollo osseo,dove avviene appunto oltre
che lemopioesi anche la linfopoiesi. i linfociti specifici maturano a partire dalle cellule staminali in linfociti b nel midollo
osseo mentre altre cellule altamente indifferenziate lasciano il midollo osseo e si recano nel timo ,maturando a linfociti t.
quindi linfopoiesi a partire dalle cellule staminali,linfopoiesi b che si completa nel midollo osseo mentre la linfopoiesi t si
completa nel timo. quindi la fase di ontogenesi in cui il linfocita da cellula indifferenziata diventa linfocita t o b,avviene a
livello dellorgano linfatico primario. gli organi linfatici primari sono il timo e il midollo osseo. questo tipo di evoluzione
avviene indipendentemente dal contatto con gli antigeni esterni non self,cioe e un processo automatico di maturazione.solo quando il linfocita b e t acquisiscono le caratteristiche che li rendono tali lasciano lorgano linfatico primario,vanno in
circolo e ricircolano tra sangue e linfa e organi linfatici secondari.
noi nasciamo con un sistema immunitario immunocompetente,nel senso che gia dallultimo trimestre di gravidanza il fetoe in grado di produrre immunoglobuline,pero acquisiamo lesperienza solo dopo la nascita .in questo caso abbiamo che il
neonato avra il suo patrimonio di cellule gia formate che pero non hanno avuto ancora nessun contatto, quindi durante la
vita le nostre cellule vengono a contatto ciascuna con il proprio antigene e maturiamo la nostra esperienza. daltra parte se
un bambino molto piccolo viene inserito in comunita, inizia a sviluppare una serie di malattie perche e stato esposto
bruscamente a mille stimoli,gli manca lesperienza antigenica,se la fa e poi non si ammala piu.quindi nellimmunita specifica avviene una fase di differenziazione a livello degli organi linfoidi primari , che porta alla
produzione di linfociti maturi,cosiddetti vergini cioe che non hanno avuto contatto con lantigene proprio. da un precursore
avremo una serie di cellule e ciascuna di queste sara dotata di un recettore per una sostanza specifica diversa dagli altri
quindi se qui ci fossero 15 cellule avremo 15 cellule ciascuna con un recettore per una sostanza diversa dagli altri. una volta
ottenuta questa diversita ciascuna di queste cellule ,se incontra il suo antigene cioe quella sostanza per cui ha il recettore
specifico, viene attivata e la prima attivazione si manifesta con una proliferazione, quindi da una sola cellula avremo una
serie di cellule. badate che ad ogni successivo contatto ciascuna di queste cellule proliferera:questa e la base della
memoria immunitaria ,cioe la prima volta che vi hanno somministrato il vaccino contro lepatite b sono stati selezionati icloni cellulari che avranno recettori specifici per quella sostanza. quindi alla base della memoria sta lamplificazione del
clone cellulare che ha specificita per quell antigene.le caratteristiche del s.i acquisito sono :specificita,diversita(grazie al fenomeno della generazione di diversita durante
lontogenesi)e la memoria(che comporta un miglioramento della risposta a ogni successiva esposizione allagente infettivo).
il neutrofilo che incontri uno o mille volte un determinato patogeno o che incontri diversi patogeni reagisce sempre allo
stesso modo.le sue caratteristiche biologiche quali sono?rispondere agli stimoli chemiotattici,attivarsi,fagocitare,attivare il
meccanismo che porta al killing e cosi via. il s.i specifico ha invece una caratteristica:in base al tipo di stimolo seleziona il
tipo di risposta .es.: se arriva un micobatterio tubercolare il s.i specifico selezionera un tipo di risposta che utilizza
prevalentemente le cellule, se vengo tramite la vaccinazione a contatto col tossoide tetanico,il s.i. specifico selezionera untipo di risposta prevalentemente anticorpale perche in base al tipo di stimolo seleziona la risposta piu efficace per
eliminare quello stimolo e questa e unaltra grande differenza. pero la selezione inadeguata allo stimolo puo dare
manifestazioni immunopatologiche,quali le reazioni di ipersensibilita.autolimitazione:esistono dei meccanismi che regolano la risposta immune e fanno si che raggiunto lo scopo ovvero
leliminazione dellantigene la risposta cali
abbiamo visto :malattie autoimmuni dovute alla non discriminazione tra self e non self,reazioni di iper sensibilita dovute a
una non adeguata selezione del meccanismo da utilizzare in risposta a un determinato stimolo.quando il sistema
immunitario non e adeguato a dare una risposta efficiente avremo linsufficienza immunologica ovverolimmunodeficienza.
qui(vedi lucido) ce la distribuzione del s.i :il timo e il midollo osseo che sono gli organi linfatici primari, poi abbiamo una
serie di organi linfatici secondari come la milza, che e deputata soprattutto alla gestione degli antigeni circolanti ,quindi
gestione di batteriemie e setticemie,ha un ricco e articolato s.i ,ben integrato con la vascolarizzazione e non e casuale
perche quella e la sua funzione. es nel tifo e nella salmonellosi abbiamo splenomegalia. perche abbiamo splenomegalia?
-
8/7/2019 Lezione 01 (17-11-06) Immunologia
3/5
perche ce una risposta immunitaria a livello della milza in risposta alla batteriemia. linfoadenomegalia:salvo problemi di
neoplasie ,perche i linfonodi ingrossano rapidamente? perche localmente ce una risposta a uno stimolo antigenico che
puo provenire da un molare cariato o da una ferita cutanea.
quindi milza:infezioni attraverso il sangue. linfonodi :drenano e rispondono .infine abbiamo un terzo sistema annesso alle
mucose che si chiama m.a.l.t o tessuto linfatico annesso alle mucose che consente di gestire una grande quantita di stimoli
esterni perche la superficie delle mucose e enormemente superiore a quella della cute. il massimo contatto antigenico
labbiamo a livello delle mucose. a livello delle mucose ci sono delle cellule del s.i, specifico , organizzate in modo tale da
poter dare una risposta locale,e lo gestiscono con modalita diverse da quello sistemico,in modo da limitare i fenomeniinfiammatori e salvaguardare lintegrita anatomica.
immunita specifica-selezione clonale:
quando una sostanza entra incontrera(nel s.i specifico)quella particolare cellula che ha quel particolare recettore specifico.
selezione clonale significa che ci sono tanti cloni disponibili che hanno quel recettore specifico che e presente prima del
contatto con lantigene. la specificita si crea nellorgano linfatico primario ed esiste prima dellesperienza antigenica.
ricapitolando: durante lembriogenesi e durante il corso della vita si sviluppa un numero di cloni linfocitari, questi cloni
vanno incontro a proliferazione e contemporanemante vanno incontro a una severa selezione infatti non tutte le cellule
proliferanti arrivano a maturazione,esistono vari fenomeni selettivi, uno di quelli piu importanti e rappresentato dal fattoche i cloni self reattivi vengono eliminati,indotti allapoptosi,e quindi abbiamo un primo processo di autotolleranza che
avviene proprio a livello dellorgano linfatico primario ,le cellule dotate di forte autoreattivita non sopravvivono e quindi
non passano in circolo.terminato il processo di sviluppo,una volta che la cellula ha lasciato lorgano linfatico primario, ricircola e se viene a
contatto con lantigene specifico viene attivata,comincia a proliferare quindi ce unespansione del clone e alla fine
abbiamo la differenziazione in cellule effetrici e in cellule memoria,questultime non entrano attivamente nella risposta ma
rimangono quiescenti, pronte per un successivo eventuale contatto.
una volta lasciato lorgano linfatico primario la cellula linfatica matura passa attraverso gli organi linfatici secondari, lilascia attraverso la linfa,arriva al dotto toracico, rientra in circolo, va agli organi linfatici secondari, quindi un circolo
continuo. se viene a contatto con lantigene abbiamo lattivazione con proliferzione ed espansione clonale e comincia la
differenziazione in cellula effetrice,che ha un fine principale:leliminazione dellantigene. a questo scopo puo provvedere
da sola o puo utilizzare ,indirizzandoli, altri sistemi come il complemento e i fagociti.
quindi la risposta immunitaria efficace si traduce nelleliminazione dello stimolo che lha indotta. voi avete visto lesempio
di un fenomeno dovuto a una mancata eliminazione dello stimolo in corso di infiammazione:il granuloma.il granuloma e
lespressione morfologica di una mancata eliminazione dellantigene. in questo caso lo stimolo persiste,la risposta persiste e
si forma il granuloma. perola risposta immunitaria normale arriva alleliminazione dellantigene.Maria Eugenia Caboni
IMMUNOLOGIA 17-11-06 2 ora
Il concetto di selezione clonale sta alla base della risposta immunitaria specifica.
Solo quella cellula con quel recettore viene attivato, prolifera, la proliferazione comporta un aumento del numero delle
cellule accompagnato da una differenziazione in cellule di risposta ed in cellule memoria. Per esempio il linfocita Bprolifera, comincia a differenziare, la cellula di differenziazione terminale del linfocita B la plasmacellula, la cui
funzione , ormai esclusiva, quella di produrre anticorpi che rappresentano le molecole effettrici specifiche. L'attivazione
del clone che ha il recettore per l'antigene if, recettore che nel linfocita b un'immunoglobulina di membrana, comporter la
proliferazione e la differenziazione delle cellule effettrici che sono le plasmacellule. Queste non hanno pi la capacit di
riprodursi e non hanno pi il recettore sulla loro superficie ma sintetizzano e secernono all'esterno immunoglobuline chehanno la stessa specificit di quelle presenti come recettore sulla cellula originaria da cui derivano. Una quota minoritaria
torna apparentemente con le stesse caratteristiche della cellula di partenza, quindi linfociti con un recettore
immunogloblulinico.ATTIVAZIONE
Richiede due componenti:
-SEGNALE 1 cio l'antigene interagisce con il recettore specifico sulla cellula, in questo caso chiaramente un linfocita B,
perch il recettore ha la struttura immunoglobulinica.
-SEGNALE COSTIMOLATORIO dato da molecole o presentate da altre cellule o secrete che vanno ad agire su recettori
presenti.
-
8/7/2019 Lezione 01 (17-11-06) Immunologia
4/5
Questa la base per avere una risposta che sia di tipo attivo, produttivo cio che porti a proliferazione e differenziazione.
Questo riconoscimento dell'antigene, con o senza segnale costimolatorio, avviene in modo molto diverso per le due classi di
linfociti specifici:linfociti T e linfociti B. La modalit di riconoscimento dell'antigene rappresenta una differenza essenziale
tra questi due sottogruppi linfocitari.
Il linfocita B ha come recettore delle immunoglobine di membrana, praticamente i suoi recettori sono rappresentati da
anticorpi con la parte in grado di legare l'antigene posta verso l'esterno e l'altra parte che arriva fino al citoplasma attraverso
un tratto transmembrana. Ogni singola cellula pu avere sulla sua superficie solo recettori di una data specificit cio tutti i
recettori per un antigene sulla superficie di una cellula sono uguali tra di loro. Questi anticorpi, per la loro caratteristicastrutturale, sono in grado di riconoscere l'antigene nativo, cio non modificato, che pu essere una molecola libera o una
superficie cellulare, comunque non ha bisogno che questo antigene venga trattato, degradato o presentato, in grado di
agire con la molecola al suo stato naturale.
Viceversa il linfocita T, che selezionato solo quando il suo recettore per l'antigene, chiamato TCr, interagisce con una
struttura che piuttosto complessa perch formata da molecole proteiche di membrana, delle hla presenti sulla superficie
delle cellule nucleate. Queste strutture proteiche di membrana sono fatte in modo tale da avere una zona di legame per dei
peptidi e per il complesso peptide-hla che viene riconosciuto dal linfocita T.
HLA significa human leucocite antigen, l'HLA il sistema maggiore di istocompatibilit dell'uomo. MHC un termine che
viene usato spesso come sinonimo di HLA ma in realt un termine generico che serve ad indicare il sistema maggiore di
istocompatibilit di qualsiasi specie. Queste strutture proteiche sono state identificate durante i trapianti. Si visto chealcuni trapianti sopravvivevano e altri andavano in necrosi e venivano rigettati. Si cercato di capire il perch della
differenza per prevenire la necrosi dei trapianti.
Queste sostanze fanno quindi un p da marcatori genetici per ciascuno di noi.La funzione delle HLA non quella di determinare il rigetto di un trapianto, anche perch il trapianto, a parte il feto, non
qualcosa di fisiologico, la loro funzione fisiologica quella di permettere la comunicaizone tra le cellule dell'organismo
umano e quelle del sistema immunocompetente.
Il linfocita T non quindi in grado di riconoscere l'antigene come tale. Se lo mettiamo davanti a una salmonella o ad un
micobatterio tubercolare rimane completamente indifferente. Invece riconoscer delle proteine derivate dalla degradazionedel micobatterio, oligopeptidi lineari, quindi senza una struttura terziaria, e che siano presentate nel contesto di molecole di
istocompatibilit.
Sono diverse anche le modalit di reazione dei linfociti B e T, come risposta immunitaria infatti si distinguono due tipi
principali:
-la RISPOSTA CELLULO MEDIATA dove la cellula, in primo luogo, che si attiva e risponde e da anche la fase
effettrice. Mediata dai linfociti T-la RISPOSTA UMORALE che mediata dalla molecola effetrice specifica che sono gli anticorpi secreti e che messa in
opera dai linfociti B che si sono attivati, hanno proliferato e si sono differenziati in plasmacellule.I linfociti T non sono una popolazione omogenea ma sono a loro volta composti da varie popolazioni.
Abbiamo due sottopopolazioni di T principali:
-Linfociti T Helper, la cellula che in qualche modo guida la funzione delle altre cellule sia specifiche come i B che non
specifiche;
-T Citotossico, cio una cellula che ha una funzione killer specifica.
Nell'ambito dei Th c' una ulteriore suddivisione in Th1 e Th2. Th1 promuove la selezione di risposta prevalentemente
cellulo-mediata mentre il Th2 promuove prevalentemente una risposta di tipo anticorpale. Il Th quindi quello che
seleziona il tipo di risposta.In base alle modalit di induzione possiamo distinguere delle forme attive e passive. Attiva naturale o artificiale. Passiva
artificiale (inoculazione passiva di immunoglobuline, la protezione dura per il tanto che durano le immunoglobuline) o
naturale (immunizzazione passiva del feto da parte delle immunoglobuline G della madre, in pratica il feto condividel'esperienza antigenica della madre. tutte le immunoglobuline di classe G che sono abbondanti nel siero sono in grado di
attraversare la placenta, quindi tutte le immunoglobuline G che la madre produce verso qualsiasi antigene vengono
condivise col feto. Questo passaggio avviene per gradiente di concentrazione, quindi il neonato alla nascita ha un
patrimonio anticorpale che rispecchia l'esperienza antigenica materna. Questa protezione gli durer 4 o 5 mesi per dargli il
tempo di fare un'esperienza antigenica individuale, attiva, graduale per garantire la copertura da almeno alcuni patogeni).
COME AVVIENE LA SELEZIONE
Tutto quello che antigene extracellulare o patogeni extracellulari viene in genere gestito con una risposta prevalentemente
umorale. Tutto ci che patogeno intracellulare viene gestito prevalentemente con una risposta cellulo mediata. Se il
micobatterio tubercolare andato nei macrofagi lanticorpo non serve a niente perch nei macrofagi non entra. Ci sono per
-
8/7/2019 Lezione 01 (17-11-06) Immunologia
5/5
dei casi in cui anche lanticorpo pu seguire per esempio nella fase extracellulare certe infezioni virali, pu neutralizzare il
virus, impedire lattacco alla cellula ecc
Nellambito dellimmunit cellulare, una cosa una risposta cellulo mediata in cui ha il ruolo prevalente il linfocita T
Helper e unaltra quella in cui ha il ruolo prevalente il linfocita T citotossico.
Il linfocita Th viene attivato solamente da poche linee cellulari, queste cellule si chiamano cellule presentanti lantigene
(apc).
Abbiamo 3 categorie principali:
-linfociti B che non sono solo cellule di risposta ma sono anche cellula che presenta lantigene;-macrofagi monoliti;
-cellule dendritiche follicolari o altro
La caratteristica che unisce queste tre linee cellulari in grado di attivare il Th che tutte presentano sulla loro superficie
molecole Hla di seconda classe. Il Th attivato di norma da cellule che hanno endocitato, fagocitato, a seconda del
materiale esterno alla cellula, lhanno degradato e poi lhanno presentato sotto forma di oligopeptide lineare.
Il T citotossico specifico viene attivato da qualsiasi cellula enucleata, quindi non dagli eritrociti che non hanno nucleo ne
molecole di Hla sulla loro superficie. Una volta attivato il T citotossico interagisce direttamente con la cellula bersaglio che
lha attivato, ho la produzione di varie citochine e induce la morte per apoptosi. La risposta di una cellula che viene attivata
specificamente da poche linee cellulari si fa sentire prima sui macrofagi potenziandone il metabolismo e il killing poi si fa
sentire sui T citotossici e in parte anche sui linfociti B. Il Th quindi agisce prevalentemente in maniera indiretta, ilcitotossico direttamente.
DOVE AVVIENE?Riconoscimento, selezione clonale e differenziazione avvengono negli organi linfatici secondari, li che arriva tutto il
materiale antigenico, cambia a seconda della provenienza. Se circolante nel sangue viene fermato a livello splenico, dalla
cute arriva ai linfonodi tributari di quella zona di cute e lo stesso per gli organi.
Nellorgano linfatico secondario avviene in contatto fra il linfocita e il suo antigene specifico.
Una volta avvenuta la differenziazione in cellule memoria ed effettrici si ha anche il ricircolo quindi tutte le esperienzecondivise a livello sistemico.
Una cosa il primo contatto con un antigene e la prima risposta, una cosa il contatto successivo al primo e la risposta
successiva al primo. La prima viene definita risposta primaria, sar lenta perch una risposta anticorpale per essere dosabile
richiede una settimana/10 giorni. Una risposta secondaria richiede 2 giorni quindi lintervallo tra il contatto e la comparsa
della risposta molto pi breve.
Altro fatto importante, per determinare la sensibilizzazione necessaria una certa carica antigenica. Se io ho pochissimi
linfociti in tutto lorganismo, specifici per quella sostanza, perch ci sia una certa probabilit che la sostanza e il linfocitaspecifico vengano a contatto, necessario che della sostanza ne venga immessa tanta. Per una risposta secondaria bastano
quantit minime sempre pi basse di sostanza perch il numero di cellule circolanti, per quella sostanza, maggiore. C
quindi un abbassamento del valore di soglia.
Per quanto riguarda limmunit innata abbiamo nelle prime ore limpegno delle barriere fisiche, dei fagociti, del
complemento dei linfociti nk, che sono soprattutto efficaci nei confronti delle infezioni virali insieme agli interferoni. Per
quanto riguarda la risposta adattativa per avere una risposta ci vogliono giorni quindi unintegrit di questa componente
fondamentale perch molto viene gestito senza bisogno di arrivare al coinvolgimento dellimmunit adattativa. Quandoquesto avviene necessario comunque che venga speso un po di tempo prima di avere una risposta efficace.