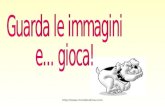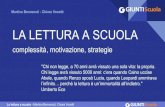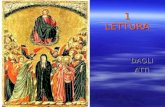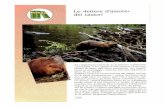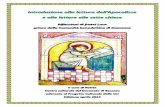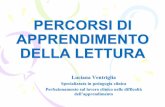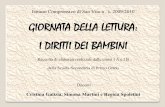LETTURA(2015_09_13)
-
Upload
giuliodellanna -
Category
Documents
-
view
128 -
download
1
description
Transcript of LETTURA(2015_09_13)

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 1/48
Nathalie Djurberg e Hans Berg per il Corriere della Sera
#198Domenica
13 settembre 2015EURO 0,50
A n n o 5 - N .
3 7 ( # 1 9 8 ) P o s t e I t a l i a n e S p e d . i n
A . P . - D . L .
3 5 3 / 2 0 0 3 c o n v . L .
4 6 / 2 0 0 4 a r t . 1 , c
1 , D
C B M i l a n o -
S u p p l e m e n t o c u l t u r a l e s e t t i m a n a l e d a v e n d e r s i e s c l u s i v a m e n t e i n a b b i n a m e n t o a C o r r i e r e d e l l a
S e r a ¤ 1 , 0
0 ¤ 0 , 5
0 + i l p r e z z o d e l q u o t i d i a n o .
I n C H T i c . F r 1 , 0
0
/

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 2/48
2 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
Il dibattito delle idee
dal nostro inviato a New York MASSIMO GAGGI
«Tecnologia e globalizzazione hannodi certo prodotto grossi cambia-menti nel mondo del lavoro, mal’estrema disparità nella distribu-zione dei redditi che stiamo speri-mentando ormai da troppi annideriva soprattutto dal nostro mo-
do di organizzare il mercato. Con la scusa di non lasciarespazio a chi vuole più Stato, la coalizione di interessi che dadecenni domina l’America ha ostacolato in tutti i modi l’ade-guamento delle regole alla nuova realtà economica. E senzaregole efficaci per mantenere il sistema in un equilibrio so-cialmente accettabile, il capitalismo non funziona». Fin dal-le prime battute dell’incontro de «la Lettura» con RobertReich per discutere di Come salvare il capitalismo, il suonuovo libro (uscito in questi giorni in Italia per Fazi addirit-
tura qualche giorno prima della pubblicazione negli Stati Uniti), il celebre economista liberal dell’Università di Berke-ley, ministro del Lavoro di Bill Clinton, met te le mani avanti:«Partecipo a moltissimi dibattiti sui temi più disparati, maogni volta, prima o poi, si finisce lì: la difesa del libero mer-cato da ogni interferenza esterna, niente nuove regole. Comese il mercato esistesse in natura e non fosse una creazionedegli uomini».
Però il maggior dinamismo degli Stati Uniti rispetto al-l’Europa ce lo siamo spesso spiegato anche con la complessi-tà delle normative in vigore e con l’alto costo del welfare nel-la Ue. Fin dai tempi di Guido Carli, in Italia si è discusso di«lacci e lacciuoli» soffocanti. «Una cosa — replica Reich —sono le stratificazioni burocratiche, un’altra le regole per far funzionare bene un sistema economico. Norme che a volteandrebbero addirittura alleggerite: ad esempio quelle cheproteggono troppo a lungo o in modo troppo esteso certi brevetti, offrendo un vantagg io eccessivo a molti grandigruppi, ormai talmente potenti da avere la forza di o pporsi aogni cambiamento: bollano ogni correzione come un’altera-zione delle regole del libero mercato. Balle che ci beviamoormai da decenni. Ma non è stato sempre così nella storia
americana. Da dove vogliamo partire? Nel libro cito EdwardRyan, presidente della Corte Suprema del Wisconsin che nel1873, parlando agli universitari del suo Stato, disse: “Un gior-no dovremo pur chiederci chi deve decidere: la ricchezza ol’uomo? Chi deve guidare: il denaro o l’intelletto? E gli incari-chi pubblici a chi devono andare? A uo mini liberi e istruiti oa servi feudali del capitale aziendale?”».
Quella però era l’America selvaggia dei robber baron, ma-gnati dediti alla concorrenza sleale. «Certo. Poi alla fine del-l’Ottocento arriva la legge antitrust, lo Sherman Act. E all’ini-zio del XX secolo a frenare gli abusi dei capitalisti senza scru-poli e a spezzare i monopoli fu un presidente conservatore:
Theodore Roosevelt. Uno che attaccava quelli che chiamava i“malfattori delle grandi ricchezze”, sostenendo che, oltre aopprimere i lavoratori, mettevano in pericolo la stessa esi-stenza dello Stato».
Reich sostiene che, dopo l’era di progresso e crescita equi-librata del secondo dopoguerra, negli ultimi trent’anni ab- biamo vissuto un’involuzione: «Fino agli anni Settanta il be-nessere si diffondeva anche tra i lavoratori più umili. Poi lasvolta: oggi la sperequazione nella distribuzione dei redditiè la più acuta degli ultimi 80 anni».
Ma perché la politica non riesce più a introdurre corretti- vi? Perché le lobby imprenditoriali sono troppo potenti? Operché i tycoon di oggi non sono più gli odiosi padroni dell eferriere di un tempo, molto visibili nel loro mondo di acciaioe carbone, ma i «principi rinascimentali» delle tecnologiedigitali dai meccanismi geniali, impalpabili e invisibili in
un’economia sempre più complessa? «Le due cose insieme:il potere si è spostato verso le élite economiche a causa dellacomplessità tecnologica e finanziaria dell’economia. La gen-te fa più fatica a capire. La complessità non spiega tutto, maconsente alle grandi coalizioni di interessi di accumulare ildenaro col quale nascondono il modo nel quale stanno pie-gando l’economia nella direzione per loro più favorevole.Fanno il loro gioco, ma lo fanno indebolendo sistematica-mente la politica e l’autorità di chi fa le regole».
Dalle industrie farmaceutiche che pagano le compagniedei medicinali generici perché non mettano sul mercato i lo-ro prodotti a basso costo, al monopolio agro-industriale difatto della Monsanto, agli abusi delle società che distribui-scono le connessioni a banda larga, al mercato plasmato da Amazon, nel libro di Reich si raccontano molti casi contro- versi e anche vere e propriehorror story del capitalismo Usa.
Ma alla fine a cambiare il mercato, a far sparire decine dimilioni di posti di lavoro, è soprattutto l’evoluzione della tec-nologia. Lo stesso Reich in passato aveva previsto un calo
drastico dell’occupazione in molti settori e nel libro raccontadi un amico che da casa sua a Tucson progetta, produce (conuna stampante 3D) e vende (su internet) una macchina capa-ce di rilevare certi elementi inquinanti nell’aria. Tutto da so-lo. «È vero, sono mutamenti radicali. Ma penso ugualmenteche nel valutare le nostre difficoltà di o ggi, negli Usa e in Eu-ropa, stiamo dando un peso esagerato all’impatto di globa-lizzazione e tecnologia, mentre sottovalutiamo l’influenzadella politica. I problemi che dobbiamo affrontare, a Washington come a Roma, hanno più a che fare con le deci-sioni politiche che con l’economia. Viviamo in società moltoricche: i margini per correggere la rotta sono ancora ampi.
Anteprima L’economista Robert Reich, già ministro di Clinton, sostieneche monopoli e strapotere dei grandi gruppi abbiano snaturato lospirito originario e vitale della libera iniziativa. «Bisogna ridistribuire laricchezza subito, nella fase in cui viene prodotta». Lo sostiene in un libro,che esce in Italia prima che negli Usa, e in un colloquio con «la Lettura»
corriere.it/lalettura
Orizzonti .
Materiali spessi un atomo:
la riscossa del mondo piatto
di LUCIA SORBA e GIULIO GIORELLO
Libri.
La punteggiatura diventa il nuovo zodiaco
di GIUSEPPE ANTONELLI
Sguardi.
Artisti a Nord, artisti a Sud Dialogo al Lac di Lugano
di ARTURO CARLO QUINTAVALLE
Maschere .
«La bella addormentata»ora danza come nel 1890
di VALERIA CRIPPA e VIVIAN LAMARQUE
Percorsi .
«Ancora qui»Il mio viaggio nel tempo
18
8
28
34
40
Il capitalismo
minacciatodai capitalisti
I L L U S T R A Z I O N E D I F R A N C E S C A C A P E L L I N I
I L L U S T R A Z I O N E D I L U C A D A L I S I
ROBERT REICHCome salvare il capitalismo
Traduzionedi Nazzareno Mataldi
FAZIPagine 332, 22Bio-bibliografia
Robert Reich (1946) è stato
segretario al Lavoro nelprimo mandato
presidenziale di Bill Clinton(1993-97). Docente della
University of California aBerkeley, collabora con
«New York Times» e «WallStreet Journal». Fazi ha
pubblicato anche Aftershock (2011), Supercapitalismo
(2008), Perché i liberalvinceranno ancora (2004)
i
40
graphic novel diRICHARD McGUIRE

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 3/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 3
Ma non li usiamo. Il problema è che man mano che il potereeconomico si concentra al vertice della piramide, la stessacosa accade al potere politico. Così torna la filastrocca del“giù le mani dal libero mercato”. Anche quando si trattereb- be solo di eliminare nuovi monopoli o di evitare eccessiveconcentrazioni nell’economia digitale».
Cresce anche un’economia in parte alternativa a quella deigrandi gruppi tradizionali: i servizi on demand forniti damolte start up a clienti che li richiedono attraverso smar-tphone e app. Servizi erogati da personale che lavora quandorichiesto, senza rapporti stabili. Reich critica anche questomodello. La precarietà, dice, ridurrebbe addirittura la capa-cità di apprendere. «Sì, l’eccessiva irregolarità negli orari dilavoro può provocare problemi gravi. Stress, l’impossibilitàdi programmare la propria vita: accantonare le risorse per mettere su casa, sposarsi, fare figli, prepararsi alla pensione.
Ma la precarietà può ridurre anche la capacità di apprende-re. Non ne parlo nel libro: in un articolo che ho scritto alla vigilia del Labor Day ho citato i dati di una ricerca dell’Econo-
Steve Lambert (1976), Capitalism works for me!True / False (2011,installazione, mixed media),courtesy Charlie JamesGallery, Los Angeles, Usa
vere la creazione di nuova ricchezza. Un approccio più sensa-to può, allora, essere quello di condividere in modo più am-pio la ricchezza futura, con misure come l’attribuzione aogni cittadino di una certa quota dei benefici economiciprodotti da quei brevetti».
Allarmi per le gravi conseguenze anche politiche della fi-ne del ceto medio vengono lanciati da almeno 10 anni: non èsuccesso nulla. Reich, che ha lavorato con Bill Clinton e co-nosce bene la famiglia, pensa che Hillary potrebbe e vorreb- be cambiare rotta? «La politica da sola non ce la f a: servonouna presa di coscienza e un’iniziativa della società. Il puntonon è togliere ai ricchi per dare ai poveri con le tasse, ma dar-si regole che portino verso una più equa distribuzione giànella fase di produzione della ricchezza, anziché redistribui-re a posteriori. Complicato? Sì. Ma essenziale, perché nellecondizioni attuali una società non può durare. Non è una sfi-
da per la tecnologia o l’economia: è una sfida per la demo-crazia».© RIPRODUZIONERISERVATA
«Essa rimane ancora oggi carne e sangue dellaciviltà. Distrutta o finita Roma, io credo che ilmondo perderebbe l’equilibrio sulla traiettoriadelle sue orbite, e precipiterebbe miseramentenel vuoto». Modesta proposta a Ignazio
Marino, attuale sindaco della capitale: rileggersil’articolo che Virgilio Lilli, firma del «Corriere»,dedicò alla Città eterna. Titolo: «Vivere aRoma». Conclusione: si viveva benissimo.Ottant’anni fa. («La Lettura», dicembre 1935)
L’orbita di Roma
{RiLetturadi Claudio Colombo
mic Policy Institute. Lavorare in modo saltuario, a volte conturni lunghi o di notte, alla lunga riduce l e capacità cognitivedel lavoratore e anche dei suoi figli, inevitabilmente trascu-rati da chi deve accettare più lavori per sbarcare il lunario».
Quali sono le terapie possibili? Alcune delle misure pro-poste nel libro o sono interventi molto costosi che vengonodiscussi da anni, ma sembrano di difficile applicazione, co-me l’introduzione di un salario minimo universale, o sonoinnovazioni suggestive, ma tutte da inventare anche sul pia-no giuridico e finanziario, come la condivisione dei beneficidei brevetti tecnologici. «Deve nascere, e spero che nascadalla crescente consapevolezza della gente, un movimentodi massa per la creazione di un nuovo sistema di contrappesinell’interesse di quei cittadini, la grande maggioranza, chenon hanno condiviso i guadagni dell’economia degli ultimidecenni. Non si può andare oltre nello schiacciamento del
ceto medio. I modi possono essere diversi. Si può tassare laricchezza di pochi, ma si rischia di fare un’operazione staticadi redistribuzione del benessere esistente anziché promuo-
ravenna 13 settembre
palazzo rasponi
Editori Laterza
bologna 14 settembre
libreria coop ambasciatori
roma 15 settembre
la feltrinelli colonna
piacenza 26 settembre
festival del diritto
n o v i t à
i n l i b r e r i a
Gianrico Carofigliocon parole precise breviario di scrittura civile

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 4/48
4 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 5/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 5
Futuro prossimoPer lo scienziato francese cisaranno automi in grado diriconoscere le emozioni altrui ele loro cause, ma non
di accettare la reciprocità.«Nessuna legislazione peròpotrà considerare esseriartificiali come fossero viventi»
Cercate un investimento alternativo? Puntate suuna bottiglia di whisky. Purtroppo non basteràpassare al supermercato se volete vedere ilvalore del vostro investimento aumentare del34% in un anno, come è accaduto in Gran
Bretagna, dove nei primi sei mesi del 2015 sonostate battute in asta 20.638 bottiglie dacollezione. Il più prezioso? Un Karuizawa,whisky giapponese del 1960. C’è chi ha pagato76.933 sterline per averne una bottiglia.
Risparmi in bottiglia
{Il dibattito delle ideePost it
di Stefano Righi
Serge Tisseron esplora l’empatia fra uomini e macchine«La tecnologia porta speranze, basta non confonderla con noi»dal nostro corrispondente a Parigi
STEFANO MONTEFIORI
P
ersonalità diverse come StephenHawking o Elon Musk mettonoin guardia sulla potenza e i peri-
coli soprattutto sociali e politicidell’intelligenza artificiale. Lopsichiatra e psicanalista francese SergeTisseron, che da tempo dedica la sua ricer-ca alle conseguenze psicologiche e indivi-duali delle nuove tecnologie, in questigiorni invece ha pubblicato un saggio (Le jour où mon robo t m’aimera. Vers l’empa-thie artificielle, Albin Michel) in cui riflet-te su come la psiche umana reagirà all’av-
vento di robot capaci di mimare le nostreemozioni.
L’empatia artificiale è un rischio per l’empatia umana?
«Nell’essere umano il termine empatiadesigna diverse facoltà: quella di identifi-care le emozioni dell’altro; quella di com-prendere la sua rappresentazione delmondo e dunque la ragione delle sue emo-zioni; infine l’accettazione della reciproci-tà, preludio al senso morale e alla giusti-zia. I robot “empatici” saranno dotati solo
delle prime due dimensioni dell’empatia.Non potrà che trattarsi di un’empatia par-ziale, ma sufficiente a consentire diverseforme di manipolazione. Inoltre, i robotpotranno comunicare in tempo reale ai lo-ro produttori tutto quel che il proprietariodirà e farà. Dovremo fare attenzione a nondimenticarlo mai».
Per quando possiamo attenderci lanascita di robot capaci di imitare i senti-menti?
«Sono già in funzione in certe case di ri-poso e scuole. In Giappone, il robot Pep-per è pensato per un uso individuale, a ca-sa. Ci sono molte persone sole e il mercatoè considerevole».
Perché offrire «un robot con un cuo-re» sarà la priorità dell’industria?
«La messa a punto dei robot è estrema-mente costosa. Bisognerà dunque vender-ne molti. E per riuscirci, l’industria cercagià di farci credere che provino “vere emo-
zioni”. Il capo di Softbank ha presentato ilrobot Pepper sostenendo che “ha un cuo-re”. Questa confusione è estremamentepericolosa».
Il rischio è che preferiremo un robotdocile e soprattutto prevedibile a un es-sere umano incostante e umorale?
«Tutto dipenderà da come saranno pro-grammati. Per essere venduti in grandiquantità, i robot saranno concepiti per piacerci il più possibile. Li chiamo “robotNutella”, creati all’unico scopo di lusinga-
re il nostro gusto. Ma le tecnologie finisco-no sempre per modificare il nostro funzio-namento psichico e le nostre aspettative
sociali. Internet e telefonino ci hanno resiintolleranti all’attesa. Con l’avvento dei“robot Nutella”, finiremo per pretenderedai nostri simili che anche loro faccianocome i robot e non ci contraddicano mai».
L’attaccamento affettivo ai robot di-pende dal loro aspetto antropomorfo?
«No, pensate a R2D2 in Guerre stellari.Sembra un barile, ma noi gli prestiamo vo-lentieri delle emozioni. Il robot Paro, cheassomiglia a una specie di piccola foca im-mobile coperta di pelliccia, suscita ungrande attaccamento presso gli anziani. Se
voglia mo un robot che poss a camb iareuna lampadina elettrica sul soffitto al po-sto nostro, è in quel caso che allora deveavere due braccia e due gambe come noi».
Quali sono le strutture psichicheumane che entrano più in gioco nell’in-terazione con i robot?
«La tendenza a proiettarci nell’altro e aidentificarci con l’altro. Con tre rischi: la
confusione dei punti di riferimento chedanno all’uomo un valore superiore ri-spetto alle macchine; la dimenticanza deirischi che i robot faranno correre alla no-stra vita privata; l’impoverimento delle re-lazioni con i nostri simili».
Tra i vari film sul tema, qual è a suoavviso quello che racconta meglio situa-zioni che potrebbero realmente verifi-carsi?
«Il migliore è Her di Spike Jonze. Il pro-tagonista crede di comunicare come seavesse davanti una vera persona, ma il ro-
bot è programm ato p er r inviarg li es atta-mente quel che si aspetta. Potrebbero svi-lupparsi un giorno forme di robot-dipen-denza come si parla oggi di cyber-dipen-d e n z a . D o b b i a m o c o m i n c i a r e arifletterci».
Nel suo libro lei racconta l’affetto chealcuni soldati americani hanno dimo-strato di provare per i loro robot anti-mine. È uno scherzo della mente o c’èqualcosa di etico in questo atteggiamen-to? In futuro, in presenza di robot sem-pre più sofisticati, sarà ragionevole rico-noscere loro una dignità, dei diritti?
«Alcuni soldati americani si sono attac-cati in effetti ai loro robot al punto di ri-schiare la vita per loro, mentre altri conti-nuano a considerarli come delle semplicimacchine. Riconoscere dei diritti ai robotsarebbe pericoloso, perché baseremmo ilnostro approccio legislativo su quelli tra
noi che sono più portati a fare confusione.È l’errore che compie a mio avviso KateDarlin, la ricercatrice del Mit: propone che
delle leggi proteggano i robot contro i mal-trattamenti, non per il dolore che i robotstessi potrebbero provare, ma in ragionedel dolore che i loro proprietari potrebbe-ro sentire, credendo che soffrano. Secon-do me questo non farebbe che aggravare ilrischio di confusione tra simulazione e ve-re emozioni, e tra i robot e le creature sen-sibili che sono gli animali e gli umani».
Per chi non crede all’anima, e consi-dera l’uomo come un insieme di mate-ria, organi e circuiti nervosi, il robot po-trebbe servire anche a soddisfare il so-gno umano di creare la vita?
«Sì, certamente. A mio parere, la suacreazione risponde innanzitutto al deside-rio di raggruppare tre regni che l’essereumano è stato obbligato a separare sin dal-le origini: i suoi simili, con i quali comuni-ca attraverso la voce e le espressioni; glioggetti, che crea e padroneggia; e infine leimmagini, che l’uomo si aspetta agiscano
da intermediarie tra lui e i mondi invisibi-li. Una volta creati dei robot umanoidi aiquali potremo dare l’apparenza di una per-sona amata scomparsa, per esempio, que-sti tre regni saranno riuniti. Chi tra noi
vorrà credere che quel robot sia un essere vivente potrà farlo, ma nessuna legis lazio-ne dovrà mai assecondarlo».
Lei si considera più affascinato o pre-occupato dall’avvento dei robot dotati diempatia? È più ottimista o pessimistadavanti allo spazio assunto dalla tecno-logia nelle nostre vite?
«I robot sono portatori di speranze for-midabili, soprattutto nel campo della sani-tà e dell’educazione, ma a condizione chenoi si sia in grado di anticipare il loro av-
vento. Le leggi e l’educazione sono semprein ritardo sulla tecnologia, e spesso le per-sone che sviluppano una tecnologia nonpensano alle implicazioni legali e etichedelle loro creazioni. Dobbiamo incorag-
giare la costruzione di robot che favorisca-no le relazioni tra gli uomini. Per questo isoftware che domani equipaggeranno irobot dovranno essere oggetto di un largodibattito pubblico. Serviranno delle misu-re in favore dell’open source e della prote-zione della vita privata. E dovremo inse-gnare ai nostri figli a programmare questemacchine secondo i loro desideri, senzaperdere mai il gusto dell’umano».
@Stef_Montefiori© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il personaggio e il libroLo psicoanalista e psichiatra
francese Serge Tisseron(Valence, 1948) è membro del
Centro di ricerca sullapsicoanalisi dell’Università
Parigi VII «Denis Diderot». Le jour où mon robot m’aimera. Vers
l’empathie artificielle (ovvero,«Il giorno in cui il mio robotm’amerà. Verso l’empatia
artificiale») è pubblicato daAlbin Michel (pp. 208, 16)
Biblio-filmografiaCentrale nel libro Ma anche gli
androidi sognano pecore elettriche? , scritto da Philip K.
Dick nel 1968, è proprio ilrapporto tra uomini e androidi:
il romanzo è stato ristampatoquest’anno da Fanucci
(traduzione di RiccardoDuranti, pp. 256, 15). Dal
testo Ridley Scott ha tratto nel1982 il film Blade Runner,
debitore anche di Metropolis ,girato da Fritz Lang nel 1927.
Tisseron cita Her (2014) diSpike Jonze con Joaquin
Phoenix che si innamora di un
sistema operativo con la vocedi Scarlett Johansson
i
I robot ci ameranno, niente paura
Zaven Paré (1961, Fort de l’Eau, Algeria),Lindberg Flug (2002, installazione sonora.dimensioni variabili): l’artista, naturalizzatofrancese, attualmente vive a Rio de Janeiro;nel 1996 aveva creato la sua prima«marionetta elettronica» seguita nel 1999
da una versione «in forma digitale»
di DONATELLA DI CESARE
C he cosa vuol dire avere una«coscienza ecologica»? Nondimenticare il futuro — così
risponde Hans Jonas sollevando perprimo, tra i filosofi, il problema delrapporto con l’ambiente nell’età del-la tecnica.
Immaginare la sventura delleprossime generazioni è il solo mododi elaborare strategie che permetta-no di arginare la devastazione dellaterra, inghiottita nella logica dellaproduzione e del consumo, ridotta aserbatoio. Gli esseri umani sono or-mai da tempo pazienti e medici di un
male che hanno autonomamenteprodotto. Ma per quanto possa esse-re acuta, la «coscienza ecologica» di fronte agli interessi dell’industria,alle necessità energetiche, alle esi- genze del mercato, sembra risolversiin belle parole e buoni propositi.
Pur dovendo vivere all’ombra diuna incombente calamità, non sidovrà tuttavia cedere alla rassegna-zione. Non si tratta di fare, inventa-re, creare. Per troppo tempo la crea-tività umana si è contrapposta alcreato. La natura non può più sop-portare la nostra inventiva. Da tem-po lancia segnali inequivocabili. Assumersi una responsabilità versol’ecosistema vuol dire chiedersi inche modo, con quella stessa inventi-va, si possa accogliere il compito cheancora resta: la riparazione del mon-do.
© RIPRODUZIONERISERVATA
Tesi
UN’INVENTIVARIPARATRICE

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 6/48
6 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
Notizie di un comportamentoscorretto di Richard Nixon, nel-le elezioni presidenziali del1968, per sconfiggere il demo-cratico Hubert Humphrey, era-
no apparse fin dalle settimane successivesu alcuni organi di stampa. I l «WashingtonPost» e il «Chicago Daily News» riferivanodi legami intercorsi tra l’aspirante presi-
dente, all’epoca un privato cittadino, e il go- verno del Vietnam del Sud. E nel genna io1969, quando Nixon non si è ancora inse-diato alla Casa Bianca, il «St. Louis Post-Di-spatch» titola in prima pagina: «I colloquidi pace sono stati rinviati da Saigon in se-guito a pressioni repubblicane?»
Un libro recente, scritto da un giornalistache aveva seguito nel 1968 la campagna diNixon e insegna adesso all’American Uni-
versity, Don Fulsom, racconta in ogni det-taglio la vicenda, sulla base di documentiche sono stati via via declassificati. E sostie-ne, come recita il titolo Treason, che si trat-tò di un vero e proprio atto di tradimento,come oggi ritengono alcuni costituzionali-sti intervistati e come allora lo giudicarono
il presidente uscente Lyndon Johnson e illeader della minoranza (repubblicana) inSenato, Everett Dirksen in una telefonatache si può adesso ascoltare. Johnson: «Nondovrebbero fare una cosa simile. Questo ètradimento». Dirksen: «Lo so».
La campagna elettorale del 1968 era statatutta incentrata sulla guerra in Vietnam e,dopo l’assassinio di Robert Kennedy in giu-
gno, la convention democratica di Chicago,teatro di proteste e violenze, aveva sceltoHumphrey contro il candidato «pacifista»Eugene McCarthy. Johnson aveva annun-ciato in marzo che non si sarebbe ricandi-dato e si era dedicato, da allora, a cercare ditrovare una soluzione per la guerra, la prin-cipale preoccupazione per gli elettori ame-ricani. Nel maggio erano iniziati i colloquidi pace a Parigi, accompagnati da una ridu-zione dei bombardamenti e in settembre idirigenti comunisti di Hanoi avevano ac-cettato che sedesse al tavolo anche il gover-no di Saigon. Ma è solo il 31 ottobre, a unasettimana dalle elezioni, che Johnson an-nuncia la fine dei bombardamenti sul Viet-nam del Nord, per accelerare un risultato
tangibile. Inaspettatamente, per Johnson egli Usa, il 2 novembre il capo del governosudvietnamita, Nguyen Van Thieu, annun-cia che si rifiuta di andare a Parigi.
Che cosa era successo? Nixon era riuscitoa convincerlo — attraverso l’operazioneLittle Flower, gestita dalla dragon lady ci-nese Anna Chennault, vedova di un genera-le americano — di attendere la propria ele-zione per avere un accordo più favorevole,sabotando così il tentativo di Johnson. A in-formare Nixon dell’andamento dei colloquidi Parigi era uno degli inviati di Johnson,Henry Kissinger, che raggiunse proprio
con Nixon l’apice della propria influenzapolitica.
Johnso n e Humphre y non parler annodell’accaduto, per paura di indebolire il lo-ro Paese, mentre Nixon riprese la guerra,l’ampliò con i bombardamenti in Cambo-gia e divenne poi il primo presidente co-stretto alle dimissioni della storia Usa. Ilprimo ufficio che i suoi uomini scassinaro-no nell’azione illegale che provocò il caso
Watergate fu quello di La rry O’Brien, che Johnson e Humphrey avevano messo a par-te di quanto successo nel 1968.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il dibattito delle idee
Storia Guerra in Vietnam e corsa alla Casa Bianca del 1968. Cosìla sete di potere tradì l’interesse nazionale (prima del Watergate)
di MARCELLO FLORES
Scrupoli zero:l’altro casoNixon
Stefan Brüggemann(1975; Mexico City),No in 12 different colours (2009, neon): nel 2012Brüggemann era statotra i protagonisti al Macrodi Roma della Neon.La materia luminosa dell’arte
Il Papa li aveva chiamati «arrampicatori» (23aprile 2013), «carrieristi e nepotisti» (22 maggio2013), «cristiani vantaggisti» (5 giugno 2014); eaveva suggerito loro di «andare verso il Nord efare l’alpinismo invece di venire in chiesa per
arrampicarsi» (5 maggio 2014). Ma ora — nonpotendone più, c’è da supporre — Bergoglio halanciato un neologismo imparabile e li hachiamati «escalofonisti» (3 settembre 2015): daescala, cioè scalatori. Come a dire: non ho parole.
Bergoglio contro gli «escalofonisti»
{Due parole in crocedi Luigi Accattoli
DON FULSOMTreason. Nixon
and the 1968 ElectionPELICAN PUBLISHING
Pagine 336, $ 32.95
i

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 7/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 7
Intervista Il filologo dantista ha scritto un giallo e apprezza Radio Deejay. Non ama invece la satira politica, per la quale ha vinto un premio
Il dibattito delle idee
Claudio Giunta: il premier parla da semplificatore puerilema al governo non servono i pensierosi, ci vuole entusiasmodi TERESA CIABATTI
Normalista, filologo medievista,oggi tra i più importanti stu-diosi di Dante, Claudio Giunta,44 anni, distingue «da unaparte il professore universita-
rio, dall’altra il saggista-scrittore». PerchéGiunta, oltre agli scritti accademici, tra cuiun commento alle Rime di Dante Alighieriper i Meridiani Mondadori, scrive saggi, eadesso anche un romanzo giallo Mar Bian-co (Mondadori). Per l’ultimo saggio Essere#matteorenzi (Il Mulino) ha appena vinto ilpremio Satira Politica Forte dei Marmi.
La sua è satira politica?«Non mi piace la satira politica, non mi
fa ridere, e non saprei farla».Che cos’è allora «Essere #matteoren-
zi»?«Una specie di etnografia, un tentativo
di descrivere Renzi da osservatore parteci-pe: un quadro — quadretto, poche pagine
— il più possibile oggettivo, ma con medentro».Dov’è lei, nel libro?«Sono la voce che racconta e tenta di far
ridere, e sono la contro-voce che nel librosi chiama “amico snob”».
Come nasce l’idea?«Ero a Trento quando Renzi è venuto al
Festival dell’Economia. Da allora ho inizia-to a studiarlo: sono andato alla Leopolda,mi sono letto i suoi libri, buono quello incui ripubblica le email scritte quand’erapresidente della Provincia, molto menoquelli più programmatici, quelli con untentativo di “visione”; poi ho ascoltato isuoi discorsi, visto i suoi interventi televi-sivi».
Che cos’è la simpatia di Renzi?«Nel libro dico che Berlusconi era un
raccontatore di barzellette, Renzi è un bat-tutaro. Con un repertorio di battute di li-
vello medio basso anche per un uom o po-litico, battute che persone normali, in con-dizioni normali, accoglierebbero alzandogli occhi al cielo: “sine qua non, cioè siamoqua noi” (risata), “condivido la mia opinio-ne” (risata)».
Autoironico?«Per finta. Il sottotesto è sempre: guar-
date come sono autoironico, anche se po-trei prendermi infinitamente sul serio».
Lo definisce un entusiasta, giusto?«Sempre nel libro dico che non c’è altro
presidente del Consiglio nella storia re-
pubblicana a cuisi adattino meno
bene aggettivi co-me tormentato ointrospettivo. Per-sino Veltroni ha isuoi luoghi oscuri, e li infila nei romanzi.Renzi no. A Matteo Renzi è estranea l’ideadi conflitto. La descrizione delle cose uma-ne che offre ai suoi ascoltatori è quasi sem-pre una descrizione polare, manichea,puerilmente semplificatoria: ci sono i buo-ni professori e i cattivi professori, e perchéla scuola funzioni bene è sufficiente tenerei buoni e licenziare i cattivi; ci sono i ricchie ci sono i poveri, e il problem a della pover-tà si risolve convincendo i ricchi ad esseregenerosi».
Nel libro l’amico snob, che criticaRenzi, chi rappresenta?«È il disilluso, quello che sa, perché ha
studiato, che le cose sono infinitamentepiù complicate di come dice Renzi, e quin-di finisce per essere un pessimista, uno vo-tato all’inazione. Sono io, appunto, neimiei momenti di cattivo umore».
Una critica a Renzi dell’amico snob?«Nel libro gli faccio dire “Questo è uno
che dice Ci metto la faccia! È uno che diceche quando il tal dei tali parla di Firenzedeve sciacquarsi la bocca! Lo so che è as-surdo, ma quando in treno sento la vocedell’altoparlante che dice Concediti unapausa di gusto!, io penso a Matteo Renzi.Quando il cameriere al bar dice bollicineinvece di spumante, a me viene in mente lafaccia di Matteo Renzi...”»
E l’amico snob non ha ragione?«Non ha ragione se si parla di politica,
che è un ambito della vita in cui le paturniedegli intellettuali non hanno senso, e l’en-tusiasmo può contare più dell’intelligenza.
Uno slogan renziano comeL’Italia deve fa-re l’Italia all’amico snob fa venire voglia di
vomitare, e un po’ anch e a me, ma s e fun-ziona...».
Un politico deve essere ottimista?«Non può vivere contro il proprio tem-
po. Un intellettuale può: a volte deve, persi-no».
Nel libro scrive che «un quarantenneche conserva la mentalità, la frenesia, il
linguaggio, la determinazione di quan-do aveva venticinque anni può essere uncoglione infrequentabile, uno di quelliche si schiantano facendo bungee jum-ping. O può essere un condottiero».
«Mi sembra chiaro in quale delle duecategorie cada Renzi. Credo che non siamai rimasto sveglio la notte a domandarsi:ma non starò sbagliando tutto? Del restoanche Napoleone mica stava sveglio».
Berlusconi?«Stava sveglio».Lei scrive un romanzo giallo, «Mar
Bianco», in cui fa sparire tre uomini tor-
mentati, non tre entusiasti. È forse unmodo di stare dalle parte degli entusiastipur essendo tormentato?
«Più semplice: il tormento dei tormen-tati genera dramma. E in un giallo serve undramma che inneschi l’azione».
Perché ha scritto un giallo?«Volevo provare a fare q ualcosa di simile
a La donna della domenica di Fruttero e
Lucentini. Non ci sono riuscito, è venutafuori un’altra cosa, più nera».
Chi è lei: un accademico, un saggista,o uno scrittore?
«Io passo quasi tutto il mio tempo a stu-diare, leggere tesi, preparare lezioni, parla-re con gli studenti. Poi scrivo cose non ac-cademiche».
Cosa la impegna di più?«Una volta Roberto Gervaso intervistò il
tennista Björn Borg e gli chiese: “La impe-gna di più un set con McEnroe o un set conConnors?”. E Borg: “M’impegna tutto, an-che un set con mio nonno”».
Il racconto-saggio su Radio Deejay nelsuo libro «Una sterminata domenica»,quanto studio ha richiesto?
«Ascolto sempre Radio Deejay, ognimattina. Per scrivere il saggio ho solo au-mentato la dose. Ero in Australia a inse-gnare, e al pomeriggio ascoltavo i podcast,
2-3 ore al giorno per un mese».Perché scrivere di Radio Deejay?«Perché mi piace, e a me piace scrivere
delle cose che mi piacciono, mi piace elo-giare: è molto più facile criticare, inveceelogiare, spiegare perché una cosa è buo-na, è più difficile. E poi perché la radio me-rita di essere studiata, specie se è una radioche ha milioni di ascoltatori».
Ma se tutti — da Matteo Renzi a Linus— sono un buon soggetto di studio per l’etnografo, su Fabio Volo lei si sbilanciadi più, perché?
«Il modo in cui Fabio Volo fa la radio(anche la Tv) è praticamente perfetto. Peròc’è una lunga nota in cui distinguo bene —professoralmente, com’è giusto — il de-ejay dallo scrittore».
Esiste un rapporto fra Radio Deejay eMatteo Renzi?
«Vuol dire se c’è una ragione per cui unosi occupa di Radio Deejay e insieme diMatteo Renzi? No, è sbagliato cercare sem-pre la connessione».
Perché?«Non c’è nessun bisogno di far tornare
tutto, dimostrando che ogni singola pagi-na che si scrive è un frammen to di qualchecolossale Intero. Non c’è nessun Intero,nessun principio ispiratore o organizzato-re, almeno nel mio caso. Semplicemente,mi interessano molte cose molto diversetra loro. Come a tutti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il professoreNato a Torino nel 1971,
Claudio Giunta (nella foto)insegna Letteratura italiana
all’Università di Trento.Filologo medievista, hacurato con Guglielmo Gornie Mirko Tavoni il Meridiano
Mondadori con le Rime diDante (2011). Visiting
professor in varie università,ha pubblicato per il Mulino
un libro sul Giappone, IlPaese più stupido del mondo
(2010), e la raccolta di saggiUna sterminata domenica
(2013). Si è inoltre occupatodel mercato dell’arte in Come
si diventa «Michelangelo»(Donzelli, 2011). Con Essere
#matteorenzi (Il Mulino,2015, pp. 80, 8), ha vinto
il premio Satira Politica Fortedei Marmi. È appena uscito il
suo romanzo giallo Mar Bianco (Mondadori,
pp. 286, 19,50 )
i
«Renzi funziona. Fabio Volo di più»
Marcello Maloberti(1966), Amen (2012 -neon rosso, courtesydell’artista, GalleriaRaffaella Cortese, Milano.
di MARCO VENTURA
Ha passato cinque notti in prigione Kim Davis, per essersi rifiutata diregistrare matrimoni tra coppie
dello stesso sesso. In quanto ufficiale distato civile nel Kentucky, Kim era tenutaa garantire a quelle coppie il diritto allenozze riconosciuto loro dalla Corte supre-ma. In quanto cristiana, si sentiva inobbligo di non cooperare al male, di nonconsentire l’odiosa estensione del matri-monio a relazioni contro natura.
Il giudice federale Benning ha dispostola reclusione e ha poi rilasciato Kim,intimandole di non interferire con laregistrazione dei matrimoni gay. Per chila pensa come il giudice, la cella in cui èstata rinchiusa Kim è la necessaria ri spo-sta a una libertà religiosa falsa: in nomedella quale l’annuncio del missionario sitrasforma nell’aggressione del fanatico.Per Kim Davis, invece, in quella cella s’èvoluta rinchiudere la libertà religiosavera. Quella in nome della quale il cre-dente adempie la volontà del Creatore.
Alle migliaia di sostenitori che al suo-no di Eye of the Tiger l’attendevano fuoridel carcere, la donna ha rivolto un com-mosso appello a render gloria a Di o, e anon mollare. «Serviamo il Dio vivente»,ha scandito Kim al microfono: «Egli è quie sa esattamente perché ciascuno di noi èqui».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
TesiKIM MISSIONARIAVS. KIM FANATICA
A 36 anni Agatha Christie assapora il successoe la felicità con un marito sposato di corsa, pocoprima che lui parta per la Grande guerra. Maecco che la scrittrice scompare una notte didicembre. Di lei resta l’auto, abbandonata sulla
riva di uno stagno. Che fine ha fatto la giallista?Anne Martinetti e Guillaume Le beau affidanoAgatha. I misteri di una vita (Edizioni Bd, pp. 120, 15,90) alle chine di Franc, per un fumetto stileligne claire a metà tra Hergé e Satrapi.
Agatha Christie sulla china
{Segnali di fumodi Alessandro Trevisani
Tra le righeScherzando il leader del Pd
sottintende: «Guardatecome sono autoironico,
anche se potrei prendermiinfinitamente sul serio»

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 8/48
8 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
di LUCIA SORBA
L a rivista «Nature», in un articolo dello scorsogiugno spiritosamente intitolato 2D or not 2D,stima che possano esistere circa 500 materiali bidimensionali, contando — oltre al grafene eai materiali composti da un solo elemento, co-
me silicene, fosforene, germanene — anche altre tipo-
logie come i singoli strati di ossidi metallici e di cristallidetti «dicalcogenoidi di metalli di transizione». Po-tremmo definirla la «rivincita di Flatlandia», nel sensoche gli scienziati si stanno chiedendo ormai già da unsecolo come mai il mondo che conosciamo abbia tre di-mensioni e che cosa succederebbe se ne «togliessimo»una, un po’ come si narra nel racconto fantastico scrittoda Edwin Abbott nel XIX secolo, Flatlandia, in cui un«mondo piatto» entra in contatto con un essere in tredimensioni (3D). Dopo tanti anni di grande successo,sia tra gli studenti e gli studiosi affascinati dal curiosoapproccio a una problematica di fisica così importante,sia tra i critici e i «semplici» lettori che hanno invece vi-sto nel racconto una sorta di satira letteraria della socie-tà vittoriana e del positivismo, oggi Flatlandia potrebbeconoscere un successo del tutto impensabile per il suoautore. Da inquietante invenzione distopica — nel mon-do creato da Abbott non si sta affatto bene, vigono unrigido classismo e un’ottica limitata che riduce tutto a li-nee — a prefigurazione di una realtà fisica che prospettapossibilità di sviluppo anche materiale di straordinariointeresse.
Questa evoluzione è un dono della meccanica quanti-stica che, sin dall’inizio del XX secolo, ha permesso disviluppare modelli per comprendere almeno a livello te-orico la cosiddetta «bassa dimensionalità», cioè che co-sa accade nella materia quando una delle sue dimensio-ni si riduce fino all’ordine dei nanometri (i milionesimidi millimetro). Successivamente, i fisici hanno imparatoa realizzare dispositivi bidimensionali (2D) inserendo inuna matrice di sostegno pochi strati atomici di un mate-
riale, per cui gli elettroni sono costretti a muoversi sol-tanto su due dimensioni.
Va chiarito che per i fisici esiste una differenza praticafondamentale tra un oggetto bidimensionale e uno tri-dimensionale: nel primo caso, la terza dimensione con-sente di controllare e manipolare le proprietà dell’og-
getto, cosa che nella normale tridimensionalità non èpermessa, poiché non abbiamo una quarta dimensione.Cosa significa, in concreto? La corrente elettrica che at-traversa un dispositivo a due dimensioni, per esempio,essendo confinata in un piano è controllabile sia dallospazio superiore, sia da quello sottostante; ciò ha avutoun enorme impatto tecnologico e ha permesso di realiz-zare transistor ultraveloci utilizzati oggi nei nostri cellu-lari e computer.
Al di là dell’enorme interesse teorico, quindi, gli stu-diosi hanno da tempo previsto per questi materiali pro-spettive applicative di grande utilità. La ricerca in questosettore è però di estrema difficoltà: non basta prendereuna sorta di mattarello per «appiattire» la materia e an-che i primi dispositivi, che pure possedevano proprietà bidimensionali, erano in realtà sempre oggetti in tre di-mensioni, poiché per molto tempo non siamo riusciti aisolare i pochi strati atomici del materiale piatto dallamatrice estesa in cui erano inseriti. Anzi, l a teoria preve-deva che essi nel mondo tridimensionale non potesseroessere stabili, cioè esistere indipendentemente dallamateria «normale» in cui venivano intrappolati.
Le cose sono cambiate una decina di anni fa, quandoè stato scoperto un metodo per isolare un solo pianoatomico di carbonio da un cristallo di grafite, il grafene.Questo risultato — che nel 2010 è valso il premio Nobelper la fisica ad Andre Geim e Konstantin Novoselov, duefisici dell’Università di Manchester — ha suscitato gran-de interesse nel mondo scientifico e non solo, p oiché hapermesso di ottenere un materiale con caratteristicheuniche: ottimo conduttore elettrico, trasparente alla lu-ce, flessibile, leggero ed estremamente stabile. Nel frat-tempo abbiamo capito anche che il grafene che maneg-giamo nei laboratori è stabile grazie a un’impercettibile
corrugazione, come a dire che nel mondo reale un sin-golo piano atomico può esistere solo se la sua natura bi-dimensionale diviene «imperfetta». Da allora la ricercasul grafene e sui materiali bidimensionali è decollata.Non a caso, lavorano nel settore anche tanti ricercatoriitaliani e ben 16 istituti del Consiglio nazionale delle ri-
cerche. E l’Unione europea ha disposto per la ricerca sulgrafene una «Flagship» con finanziamento di un miliar-do di euro che ci si augura porti, nell’arco di un decen-nio, a ulteriori, sostanziali avanzamenti: vi partecipauna compagine che comprende in totale 23 partner ita-liani, la presenza nazionale più cospicua (tra cui il Cnr con gli Istituti nanoscienze, per la microelettronica e imicrosistemi e per la sintesi organica e fotoreattività), e142 tra università, istituti di ricerca e imprese provenien-ti da 23 Paesi.
L’isolamento del grafene è stato facilitato da una pro-prietà della grafite, che è un cristallo di Van der Waals,cioè composto da piani atomici sovrapposti debolmen-te legati tra di loro. Questa proprietà è in realtà sfruttatainconsapevolmente quando scriviamo con una matitasu un foglio di carta: l’attrito della mina che scorre sulfoglio è sufficiente a rompere i deboli legami tra i pianiatomici, che si sfaldano e restano sulla carta a formare latraccia scura.
Tra i materiali tridimensionali esistono metalli, semi-conduttori e isolanti, quindi con proprietà molto diver-se tra di loro. Anche i materiali a due dimensioni espri-mono peculiarità assai differenti: per esempio, il grafe-ne è un semimetallo i cui elettroni si muovono nel pianocome se non avessero massa e pertanto potrebbe essereutilizzato in transistor ad alta frequenza, mentre il fosfo-rene è un semiconduttore e potrebbe essere molto piùadatto per applicazioni in transistor a basso consumoenergetico. Negli ultimi anni, però, singoli piani atomicisono stati ottenuti anche da altri cristalli Van der Waals,come il bisolfuro di molibdeno (MoS2) e il nitruro di bo-
Fisica Flatlandia non è più solo letteratura ma un eccezionale filone di ricerca
La rivincitadel mondo piatto
Il convegnoGrafene e materialibidimensionali sono il tema
del workshop internazionale«GraphITA», in programma
presso l’area del Consiglionazionale delle ricerche di
Bologna (via Piero Gobetti,101) da domani, lunedì 14,fino al 18 settembre. Oltre260 tra scienziati e tecnici,
provenienti dalla ricercapubblica e dall’industria,
discutono di ricerca eimpiego tecnologico. Il
programma spazia dallascienza ai progressi nella
sintesi e produzione delgrafene, fino alle
applicazioni nei settoridell’energia, dei materialicompositi, dell’elettronica
flessibile e all’interazionecon la materia vivente.
Previsto il lancio diGraphene Factory, nuovo
portale che offre ai suoiutenti contenuti e
informazioni su grafene emateriali bidimensionali
L’autriceLucia Sorba è di rettore
dell’Istitutodi nanoscienze del Cnr
i
Sono circa 500 i materiali sottilissimiestesi su un singolo strato atomicoE aprono un universo di opportunità
SCOPERTE
di MARIA FILOMENA LORETO Studi condotti negli ultimi decenninell’Oceano Atlantico e Indiano hannosvelato un fondale costellato da lunghe
catene montuose le cui cime rocciose,emerse per alcuni periodi, vivono una vitada isola, ospitando colonie di uccelli marini(sule e sterne) e grossi granchi. Queste isole,dette «fredde», sono fondamentali nel ciclomigratorio di molte specie marine. Recentistudi, condotti dalla giovane ricercatrice
Camilla Palmiotto presso l’Università di
Bologna e l’Ismar-Cnr di Bologna, hannopermesso di ricostruire la loro evoluzione.Attraverso l’analisi morfologica,morfotettonica (da sismica a riflessione) egeochimica (datazioni isotopiche dellostronzio) è stato possibile individuare edatare diverse di queste isole fossili. La piùfamosa è la Vema (Oceano Atlantico), lungapiù di 50 chilometri e larga solo 3, chefiancheggia l’omonima faglia trasforme. Ma
perché queste isole sono dette «fredde»?
Queste isole subiscono una tettonica di tipoverticale: dal fondale oceanico risalgono finoad emergere oltre il livello del mare lungoprofonde fratture, le faglie trasformi. Sonoquindi formate da materiale di crostainferiore e mantello superiore, e non darocce vulcaniche «calde». È stato osservatoche queste paleoisole, un tempo emerse,vengono erose e troncate dall’azione delmare, divenendo per un certo periodopiattaforme carbonatiche, per poiinabissarsi. Le attuali isole San Pietro ePaolo, appartenenti al Brasile, presenti lungola faglia trasforme San Paolo (Atlantico) econ le quali i dati delle paleoisole sono staticonfrontati, nei prossimi milioni di annivivranno lo stesso fato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ecco la mappa delle «isole fredde»Un tempo emerse, ora s’inabissano
Orizzonti.
Nuovi linguaggi, scienze, filosofie, religioni
Marco Petrella (Roma, 1958) è illustratore edisegnatore di fumetti. Ha collaborato, tra le altretestate, con «Cuore» e nel 2013 ha pubblicatoStripbook (Edizioni Clichy), raccolta dellerecensioni disegnate uscite ogni settimana su«l’Unità» per una decina d’anni. Nel 2014 allagalleria Nuages di Milano ha esposto nellacollettiva Booking accanto a Moebius, Muñoz,Altan, Sempé, Toppi. Da oggi su Twitter consigliaun libro al giorno ai follower de @la_Lettura.
Marco Petrella è il #twitterguest
Stormi sulle isole di SanPietro e Paolo (foto concessa
dal dottor Enrico Bonatti)

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 9/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 9
ro (BN). Tutti questi materiali bidimensionali stannoconsentendo di realizzare nuovi sistemi con proprietàancora diverse dai materiali originari che li costituisco-no, a confermare gli straordinari orizzonti che questosettore di ricerca dischiude.
La prossima sfida che molti scienziati immaginano è,paradossalmente, di partire dai materiali bidimensio-nali per costruire nuovamente strutture tridimensiona-li, «impilando» strati di differenti materiali 2D ognunocon proprietà diverse. L’obiettivo è ottenere dispositivicompletamente nuovi: veri e propri materiali mai esisti-ti prima, con potenzialità ancora inedite. Altra ideaesplorata di recente è quella di ridurre ulteriormente ladimensionalità, ritagliando «strisce» sottilissime dalpiano atomico e creando così anche mondi a una di-
mensione e quindi oggetti con proprietà ancora diverse.In particolare, strisce di grafene potrebbero essere l’ele-mento base di transistor per dispositivi superpotenti dinuova generazione.
Se nel racconto di Flatlandia gli abitanti sono delle fi-gure geometriche che si muovono su un piano e l’incon-tro con la sfera proveniente da Spacelandia provoca unareazione di sconvolgimento, diciamo — per restare allametafora letteraria di Abbott — che la ricerca scientificasembra voler rendere possibile un «dialogo» tra mondia diverse dimensioni.
© RIPRODUZIONERISERVATA
La versione di Pratchett
Ma no, la realtà è un disco
Che il mondo sia piatto lo sanno bene i lettori di TerryPratchett (ragazzi ma non solo), che da sempre se loimmaginano come un disco circolare sorretto da quattro
elefanti appoggiati sul dorso di una enorme tartaruga che giranello spazio. La saga del Mondo Disco (in Italia è uscita daSalani e Tea) è arrivata all’ ultima puntata, quarantunesima
della serie, direttamente in testa alle classifiche inglesi. TheShepherd’s Crown ha venduto oltre 50 mila copie in tre giornied esce a sei mesi dalla scomparsa del suo autore. I libri diPratchett offrono, attraverso la non banale declinazionecomica del fantasy, una satira sui cliché della letteratura e sutemi sociali, religiosi, culturali. I suoi maghi sono inetti, i lupimannari vegetariani, gli elfi cattivi, gli alchimisti inventano HolyWood, la Morte viene licenziata. Pratchett cavalca tutti i temi,dalla storia antica al femminismo, dal totalitarismo alla societàdei consumi. Può essere spietato o demenziale, ma piatto mai.
©RIPRODUZIONERISERVATA
di CRISTINA TAGLIETTI
S
offia un vento di ribellione«contro la tracotanza che
vor reb be lim ita re le di-mensioni a due o tre o a
qualsiasi numero che nonsia infinito». Esclama così il prota-gonista di Flatlandia (1884), «rac-conto a più dimensioni» dovuto al-la fantasia del versatile reverendoEdwin Abbott (1838-1925). L’eroedella storia (disponibile in italianoin tre edizioni: Adelphi, a cura diMasolino d’Amico; Bollati Borin-ghieri, a cura di Michele Emmer;Einaudi, a cura di Claudio Bartocci)è un Quadrato, che invita i lettori a«immaginare un enorme foglio dicarta in cui Linee Rette, Triangoli,Quadrati, Pentagoni, Esagoni e al-tre figure si muovono liberamenteper tutta la superficie, senza peròavere il potere di elevarsi al di sopradi essa o sconfinare al di sotto». A lungo, non diversamente dai suoicompatrioti, questo Quadrato pen-
sante ha ritenuto che Flatlandiacoincidesse con l’intero universo. Un giorno l’i ncontro con un esseretridimensionale, una Sfera che haattraversato quella superficie pia-na, lo ha costretto ad ammettereche nel cosmo ci sono più cose diquante ne sogni la misera filosofiadel suo Paese. Lo «straniero» gli hacomunicato una sorta di «Vangelodelle tre dimensioni»; anzi, perchénon ammetterne una quarta? E per-ché limitarsi a un numero finito?Con queste domande scandalizza lastessa Sfera che lo ha ammaestrato,per la quale dimensioni superiori atre non sono che «passatempimentali»! L’allegoria di Abbott di-
venta così — com e scr ive Bar tocci— «un’opera plurivoca», che riuni-sce in sé conoscenza, politica e teo-logia.
Negli stessi anni in cui il raccon-to di Abbott veniva offerto al pub- blico, i m atematici avevano gi à co-minciato a svincolare la geometriadalle ristrettezze dello spazio del-l’esperienza quotidiana. Così Ber-nhard Riemann, nella dissertazio-ne Sulle ipotesi che stanno alla ba-se della geometria (1854), aveva ri-definito la disciplina come lostudio dello spazio con un numeroqualsiasi di dimensioni. Se i puntidi un piano sono identificati da duenumeri e i punti dell’usuale spaziotridimensionale da tre, «per analo-gia» i punti di uno «spazio a n di-mensioni» sono identificati da nnumeri; n è quella che oggi i mate-matici chiamano «dimensione to-pologica», perché una deformazio-ne continua senza strappi e incolla-ture (come si vuole in topologia) lalascia invariata.
La Quarta Dimensione era anco-ra considerata, alla fine dell’Otto-cento, una regione ove potevanoaggirarsi spettri e fantasmi — co-me sostenevano «spiritisti» tipo
Alf red Rus sel Walla ce, l’es tro soconcorrente di Darwin, o Arthur Conan Doyle, l’inventore del razio-nale Sherlock Holmes — o prende-re forma le immaginarie escursionidella Macchina del temp o (1895) di
H.G. Wells. Pochi anni dopo quellaelusiva dimensione avrebbe fornitol’adeguato scenario per la relativitàdi Einstein. In una conferenza del
1908 Hermann Minkowski avrebbeproclamato che «lo spazio in sé e iltempo in sé erano destinati a svani-re come pure ombre, e solo una for-ma di unione tra i due avre bbe con-servato una realtà indipendente».
Non è stata questa l’unica moda-lità in cui sono proliferate variantidella nozione di dimensione. Il«fiocco di neve» ideato nel 1904dallo svedese Helge von Koch è de-finito come il limite di una succes-sione di curve ottenute iniziandocon un triangolo equilatero e divi-dendo a ogni passo ciascuno dei la-ti in tre parti uguali, rimuovendoquindi le parti centrali e sostituen-dole con due segmenti di ugualelunghezza che vengono così a for-mare nuovi triangoli equilateri, ri-
volti verso l’esterno e più piccoli. Se
dividiamo un oggetto geometricoin N parti, uguali per forma all’ori-ginale, ma rimpicciolite di un fatto-re r , possiamo definire una nuovadimensione data dal rapporto dellogaritmo di N col logaritmo di r .Nel caso di una figura euclidea co-me il Quadrato di Abbott, questadimensione coincide con quella to-pologica. Ma per la curva di Koch,essendo N =4 e r =3, il rapporto deilogaritmi risulta 1,26… e la nuovadimensione non è più un numerointero, ma un numero reale, oppor-tunamente approssimato da unafrazione. Per questo un oggetto delgenere è detto frattale.
La realtà, ancora una volta, battela fantasia: i frattali non sono pure
astrazioni. Infatti, servendosi «diocchio, di mano, e poi del compu-ter», il matematico Benoît Mandel-
brot ( 1924-2010) ha tr asformato leintuizioni di Koch e altri pionieri inuna disciplina coerente e ha rivela-to che i frattali (il termine è suo) so-no davvero ubiqui. Oltre ai fiocchidi neve, sono tali le nuvole, i fulmi-ni, le catene dei monti, gli alberi…e basta rivolgerci al nostro ortolanoper un frattale di dimensione all’in-circa 2,3: il cavolfiore.
Mandelbrot, che si è autodefini-to (nell’autobiografia pubblicatapostuma, edita in Italia nel 2014 daRizzoli col titolo La formula dellabellezza) «un profugo dell’intellet-to», potrebbe essere lui stesso ilsoggetto di un «racconto a più di-mensioni». Come Flatlandia è soloun frammento del cosmo, anche ilPaese elegante e semplice, ove lecurve sono tutte «lisce», è solo unapiccola regione del più complessoe più ricco mondo delle figurecomplicate e «rugose». Mandel-
bro t si è lam ent ato di non ave r nemmeno subito un processo per «eretica sedizione»! Ma nel campodell’invenzione matematica — co-me già intuiva Abbott — non esistealcuna «ortodossia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
di GIULIO GIORELLO
Geometria I frattali nei fiocchi di neve e altri segreti
Le dimensioninon finiscono mai
ILLUSTRAZIONEDI FRANCESCA CAPELLINI

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 10/48
10 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 11/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 11
to che, nel condurci dai territori dell’artegreca alle ri-locazioni filmiche di Pasolini eBill Viola fino alle decostruzioni dell’archi-tettura postmoderna, mira a elaborare unastimolante ecologia iconografica.
Secondo Bredekamp, le immagini si dan-no come spazi ambigui e sfuggenti. Per un verso, sono un nostro prodotto; per un altro,
possiedono una vita propria. Sono un arte-fatto umano, ma detengono una loro auto-nomia che le allontana da noi e le eleva ri-spetto alle cose inanimate: non sono desti-nate a cambiare né a mutare. Si pongonosempre sulla soglia tra staticità e dinami-smo. Le contempliamo, e intanto ci contem-plano. È quel che accade quando ci troviamoal cospetto di tanti capolavori del passato:fissiamo negli occhi i protagonisti di queiquadri, mentre ci sentiamo spiati da essi. Unsortilegio: ne siamo tutti inconsapevoli pre-de.
Le immagini, perciò, non sono solo og-getti, ma posseggono lo statuto di soggettiattivi. Custodiscono una segreta volontà,una misteriosa performatività. Tendono adelineare i contorni di un altro mondo: defi-niscono un ambiente ulteriore e, insieme,neutralizzano quello in cui sono ospitate.Nel momento in cui vengono toccate dal no-stro sguardo, passano «da uno stato di la-
tenza a una liberazione di energheia». Nonsi limitano a subirci, ma determinano speci-fiche esperienze percettive e comportamen-
Ci laviamo troppo? Forse sì, al punto che ibambini delle fattorie, che vivono fra la polveree a contatto con la terra, si ammalano meno dialtri (di asma e malattie respiratorie, il lavoro èsu «Science»). Perché? C’è endotossina nelle
fattorie — una componente della parete deibatteri — che li protegge e c’entra anche ilsistema immune. Insomma, ai bambini giocarealmeno qualche volta nella terra e nella polveresenza paura di sporcarsi dovrebbe far bene.
Sporcarsi fa bene alla salute
{Orizzonti EsteticaSopra le righe
di Giuseppe Remuzzi
Visioni e percezioniIl proliferare infinito diicone suscita riflessioniapocalittiche o
rassegnate. HorstBredekamp le affrontacriticamente ma sidimentica del web
Noi le creiamo, loro vivono da soleSenza immagini la realtà non c’èdi VINCENZO TRIONE
Immagini ovunque. Ci ossessionano. Ciassediano. Spesso esito parossisticodell’industria dell’intrattenimento, siinsinuano nella nostra quotidianità at-traverso vari dispositivi: giornali,
smartphone, web. Ci avvolgono e ci domina-no. Si propagano disegnando l’identità del-l’iconosfera attuale. Violano ogni aura, ogni
staticità. Si consegnano come motivi mi-granti, indifferenti alla site specificity. Cir-colano e si moltiplicano, trasgredendo ogniautorità e ogni autenticità. Simulacri chenon sostano mai, tendono a essere dapper-tutto. Alimentano un caos indistinto nelquale confluiscono eventi minimi di brevedurata. Come uno sciame di insetti che vola-no in ogni direzione e trasmettono un fitto vociare.
Intorno a noi, un profluvio di icone pron-te a essere immediatamente consumate.Senza profondità, prive di ogni spessore po-etico e semantico, non sbocciano né ri-splendono: semplicemente esistono. Appe-na ne affiora una, subito viene sostituita daun’altra e da un’altra ancora, in un corteo chenon ci lascia il tempo di riflettere. Anche se,talvolta, nell’epoca della «mediacrazia», al-cune immagini permangono, imponendosinella nostra memoria, fino a influenzare ge-sti e relazioni: sono immagini il cui valore
può essere, di volta in volta, testimoniale,simbolico, propagandistico. Tra i casi piùrecenti, gli scatti che documentano le di-
struzioni archeologiche dell’Isis e quelli cheritraggono il bambino siriano senza vita aBodrum.
Dinanzi a tali scenari, sono possibili di- versi atte ggia ment i. Cons ider are ques to brusio un fenomeno irreversibile, cui occor-re adeguarsi, pur se criticamente, come sug-gerisce David Joselit in Dopo l’arte. Oppure,
si può contestare apocalitticamente questainvasione di riproduzioni addomesticateche restituiscono una «realtà ottimizzata»,annullando «l’originario valore iconico del-l’immagine», come invita a fare Byung-ChulHan in Nello sciame.
Su un fronte diverso si situa Horst Bre-dekamp in Immagini che ci guar dano. Unimpegnativo trattato, frutto di anni di ricer-che. Denso di rimandi dottrinari, fortemen-te legato alla metodologia warburghiana,questo manifesto dei visual studies si offrecome una sorta di navigazione in mare aper-
Isaac Julien (Londra, 1960), Ten Thousand Waves (2010): l’installazione dell’artista-filmaker (finalistanel 2001 del Turner Prize) si basa sulla immersionetotale del visitatore ottenuta grazie alla continua
proiezione di immagini su nove maxi schermi
ti, agendo nella sfera della nostra esistenza.La sfida, ci dice Horst Bredekamp, sta nel re-lativizzare lo spazio dell’io «alla luce dell’at-tività intrinseca delle immagini». Che non sitrovano davanti o dietro la realtà, ma la co-stituiscono: non ne sono un’emanazione,ma una «condizione necessaria».
Su queste basi si fonda quell’«atto iconi-
co» (complementare all’«atto linguistico»)intorno a cui ruota il discorso critico dellostorico dell’arte tedesco, che sembra oscilla-re tra l’interesse per il divenire della contem-poraneità e una certa nostalgia per le formedel passato. Anche se sorretto dal bisogno dicomprendere la civiltà dei media, egli prefe-risce dedicarsi soprattutto allo studio di pra-tiche e di generi «classici»: quadri, sculture,incisioni, stampe, architetture, film.
Pur acuta, suggestiva e segnata da inatte-se connessioni tra discipline poco contigue,la sua analisi si concentra in modo particola-re su creazioni che si prestano ancora a unafruizione rallentata, meditata, approfondita.E, tuttavia, sembra sottrarsi al confronto conl’universo della Rete. Una geografia che met-te in crisi categorie e strategie interpretativeconsolidate, costringendoci a inventarne al-tre. Labirinto perturbante senza confini, cheesige una mobilitazione totale. Costellazio-ne di immagini liquide. Che è ancora in atte-
sa di un’ermeneutica capace di decifrare imobili paesaggi della postmedialità.© RIPRODUZIONE RISERVATA
BibliografiaI tre testi citati in
quest’articolo sono uscitida poco: HorstBredekamp, Immagini che
ci guardano. Teoria dell’atto iconico (edizione italiana a
cura di FedericoVercellone, traduzione di
Simone Buttazzi, RaffaelloCortina Editore, pagine
382, 29); Byung-ChulHan, Nello sciame
(traduzione di FedericaBuongiorno, Nottetempo,pagine 107, 12); David
Joselit, Dopo l’arte (traduzione di Karen
Tomatis, Postmedia Books,pp. 95, 14,90)
i
ScenarioLa rete è una geografia
che mette in crisi strategieinterpretative consolidate,
impossibile non tenerneconto nel mondo di oggi

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 12/48
12 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
Una mostra Un progetto In collaborazione
orario:
martedì, mercoledì, venerdì, e domenica
dalle ore 9.30 alle ore 20.30
giovedì e sabato
dalle ore 9.30 alle ore 22.30
lunedì chiuso, ultimo ingresso
un’ora prima della chiusura
Palazzo della Ragione Fotografia
Piazza dei Mercanti, 1
www.palazzodellaragionefotografia.it
Info: 02 43353535
Ufficio stampa [email protected]
© Edward Burtynsky / courtesy Admira, Milano
dal3 •9 al 1 • 11 •2015
EDWARD
BURTYNSKYACQUASHOCK

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 13/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 13
Beni immateriali La disputa sulla vetta più alta degli Usa, l’eredità controversa del colonialismo: in gioco c’è il controllo dell‘immaginario
Orizzonti Antropologia
Chi dà il nome ai luoghi domina la memoria dei popoliIn Alaska, Oceania, Alto Adige: un conflitto sempre apertodi ADRIANO FAVOLE
Dal mese scorso la vetta più altadegli Stati Uniti, con oltre 6 m ilam et r i , no n s i c hiam a p iùMcKinley, in onore di WilliamMcKinley, 25° presidente ame-
ricano, bensì Denali, un nome degli indi-geni Koyukon che significa «alto». È la finedi una contesa aperta ufficialmente nel1975, quando lo Stato dell’Alaska chiesel’adozione del nome Denali nella cartogra-fia federale. Ad opporsi è stato, fino ad og-gi, lo Stato dell’Ohio, di cui era originarioMcKinley (che, per inciso, non mise maipiede in Alaska). Qualche mese fa l’antro-pologo Alan Boraas aveva provocatoria-mente proposto di cambiare il nome del-l’Ohio (derivato dall’irochese Ohi-yo ,«Grande fiume») qualora la proposta nonfosse stata accettata. Lo stesso Boraas ri-corda che forse la denominazione più cor-retta dell’ex McKinley sarebbe Dghelay Ka’a
(di difficile pronuncia), il nome che gli vie-ne dato dai nativi Dena’ina, che vivono an-ch’essi nei dintorni, e vuol dire «grandemontagna». Dare, e ancor più, ridare i no-mi ai luoghi è una faccenda complessa, chepresenta spesso ben più di due contenden-ti. Denali però è, a parere di Boraas, un
buon compromesso perch é soddisfa le ri-chieste delle popolazioni Inuit e perché ilprimo a salire sulla cima fu il ventenne
Walter Ha rper, un Koyukon reclutato dalcelebre esploratore Harry Karstens.
L’imposizione di nomi ha accompagna-to un po’ ovunque la conquista coloniale.Battezzare laghi, fiumi, cime e catene mon-tuose, città e villaggi è parte integrante del-la colonizzazione dell’immaginario, comela chiama Serge Gruzinski. È anche in que-sto modo che la dominazione militare di-
viene controllo politico e id eologico. Nonc’è allora da stupirsi che i processi di deco-lonizzazione o, come è il caso dell’Alaska, ilprogressivo riconoscimento della presen-za e dei diritti dei popoli indigeni, portinocon sé trasformazioni onomastiche. Bastaguardare ai numerosi casi africani: Léopol-dville, la capitale del Congo belga, divenneKinshasa; l’Alto Volta fu ribattezzato daThomas Sankara nel 1984 Burkina Faso,«La terra degli uomini integri», unendodue termini delle lingue moré e bama-nankan, rispettivamente delle etnie Mossie Dioula. Altre volte prevalgono scelte con-divise: proprio in fronte a Kinshasa sorge
Brazzaville, la capitale della Repubblica delCongo, che prende il nome dall’«esplora-tor gentile» Pietro Savorgnan di Brazzà,friulano. Libreville, la capitale del Gabon, ela Liberia raccontano le difficili vicendedell’uscita dalla schiavitù.
I nomi (e le loro variazioni) delle cimepiù alte, delle capitali, persino degli Stati cicolpiscono in modo particolare, ma è so-prattutto nel microtessuto dei nomi localiche opera la colonizzazione dell’immagi-nario, come mette in evidenza MaurizioGnerre in un volume dedicato all’Amazzo-nia, La saggezza dei fiumi. I processi dionomatizzazione (dare nomi a luoghi epersone), come li chiamano gli specialisti,sono spesso distruttivi. La sistematica can-cellazione della toponomastica nativaequivale alla distruzione di un patrimonioimmateriale fatto di conoscenze e storieinscritte nel paesaggio, il deposito lingui-
stico di una memoria condivisa.
In epoca precoloniale, i gruppi politici eparentali Kanak che abitavano l’isola mela-nesiana della Nuova Caledon ia si muoveva-no costantemente sul territorio, sfruttandola temporanea fertilità dei terreni disbo-scati. Nel tempo, i clan disegnavano traiet-torie complesse segnate dal diffondersi dinomi (torrenti, colline, massi, montagne)che permanevano nella memoria collettivaattraverso le genealogie, una sorta di geo-grafia o topografia degli antenati. La colo-nizzazione francese di metà Ottocentospazzò via le denominazioni locali, che
vengon o oggi fatic osam ente recup eratedalla memoria orale e diventano strumen-to di rivendicazione delle terre. Allo stessomodo, la battaglia degli aborigeni austra-liani per il riconoscimento dei native title,
i «titoli» nativisulla terra, passaattraverso la rico-struzione della to-ponomastica in-digena.
Il caso Kanak mostra quanto sia pre-gnante la colonizzazione dell’immaginariogeografico: l’isola fu chiamata (e si chiamatuttora ufficialmente) Nuova Caledonia da
James Cook che m irava a «r iprodurre» ilRegno Unito in Oceania. Infatti il NuovoGalles del Sud è uno degli Stati australiani,la Nuova Britannia è una grande isola allargo di Papua Nuova Guinea, le NuoveEbridi erano un arcipelago che solo nel1980 prese il nome nativo di Vanuatu (davanua che significa «la terra» o «il pae-se»). La Nuova Caledonia si trova secondogli atlanti in Melanesia, un termine di chia-ro taglio razzista con cui vennero indicale
le isole abitate da popolazioni di pelle scu-ra, utilizzando l’etimologia greca melas,essendo il latino niger già impegnato interre d’Africa! E infine Kanak, l’etnonimoche oggi utilizza con orgoglio la stessa po-polazione indigena, è parola di originehawaiiana che i colonizzatori europei uti-lizzarono in senso spregiativo per indicaregli abitanti del Pacifico, una parola ripresain una forma grafica nuova (da canaque akanak) durante i moti nazionalisti deglianni Ottanta del secolo scorso.
La querelle sui nomi è un aspetto impor-tante delle politiche e delle relazioni inter-culturali e non mancano esempi nel nostroPaese. L’italianizzazione forzata dei topo-nimi operata dal regime fascista, a voltecon effetti comici come la trasformazionedel Col du Beaux Soleil in Soleglio Bue (val-le Maira) ha lasciato strascichi fino a oggi.Montagne come il Cervino-Matterhornstentano a trovare un nome ufficiale con-diviso. Province autonome come il Trenti-no e l’Alto Adige hanno scelto la strada delmultilinguismo. Il riconoscimento dellostatuto di lingua minoritaria ha comporta-to la possibilità della doppia denominazio-ne per i paesi delle valli occitane del NordOvest. I nomi che diamo ai luoghi sono tut-t’altro che etichette convenzionali, ma con-densano rappresentazioni culturali, rap-porti di potere, storie che guardano al pas-sato e persino prospettive di futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
BibliografiaAlla questione dei nomi difiumi, luoghi e persone tra
gli Shuar dell’Amazzonia,Maurizio Gnerre,
etnolinguista, ha dedicato illibro La saggezza dei fiumi.Miti, nomi e figure dei corsi
d’acqua amazzonici (Meltemi,2003). Il libro mette in luce i
saperi relativi all’ambiente,alle piante, agli animali e
alle persone che si celanonei molti nomi dei fiumiamazzonici, così come il
venire meno delle «voci»indigene e l’imposizionecoloniale dei toponimi.
Cristiano Tallé, antropologoculturale, in un libro di
imminente pubblicazionedal titolo Sentieri di parole.
Lingua, paesaggio e senso delluogo in una comunità
indigena del Messico del Sud (Seid), dedicato alla
comunità Huave, analizza ilvalore della toponimia
nativa e del suo recupero intempi recenti (anche
attraverso causegiudiziarie), come forma di
di recupero di autostima perla comunità locale. Ai
significati e alle pratichelegati al dare nomi agli
essere umani nelle varie
culture, Gabriele Vom Brucke Barbara Bodenhorn hanno
dedicato il volume AnAnthropology of Name and
Naming (CambridgeUniversity Press, 2006)
Resta poi fondamentale suquesti temi il libro di SergeGruzinski La colonizzazione dell’immaginario(a cura di
Duccio Sacchi,Einaudi, 1994)
i
Il monte è mio e lo battezzo io
Graeme Patterson (1980),The Mountain (2012,installazione, particolare),Halifax (Canada), ArtGallery of Nova Scotia
di MARCO DEL CORONA
La Corea del Nord brandisce orgoglio-sa il suo Juche: ideologia nostrana fatta di materialismo dialettico più
ultranazionalismo più militarismo piùautarchia. Eppure nel Paese di Kim Jong-un riemerge lo sciamanesimo, religioneancestrale della penisola coreana.
Tornano rituali accantonati a lungo,dice la fuggitiva Kang Mi-soon, che halasciato Pyongyang nel 2014 e da gennaiovive a Seul. Kang racconta di co me la
catastrofe alimentare negli anni Novantae le croniche difficoltà del regime abbianoprodotto sia disaffezione verso i verticisia diffusi traumi psichici. Vacilla la leal-tà politica, si cerca altro. Nelle campagne,ma anche tra l’embrionale classe mediadi Pyongyang, gli sciamani si fannoavanti. Economia di mercato dell’anima.
Si moltiplicano pure le truffe, sedicenti guaritori chiedono denaro e riso, poi spa-riscono. Le «pratiche superstiziose» sono fuorilegge ma, riferisce ancora Kang, leautorità non sembrano essere particolar-mente zelanti. Il fenomeno ricorda l’effer-vescenza spirituale nella Cina «de-maoiz-zata» degli anni Ottanta e Novanta. Diràil tempo se si tratta di un trend passegge-ro: in Nord Corea, in fondo, un grandesciamano c’è, e si chiama Kim Jong-un.
@marcodelcorona©RIPRODUZIONERISERVATA
Tesi
GLI SCIAMANIDI KIM JONG-UN
Una bella ragazza ride delle sofferenze del suoamante, ma lui la paragona al fiore delgarofano e al volo leggero della primavera.«Da dieci anni io ti guardo» dice l’innamoratoderiso. E lo dice in griko, il dialetto di origine
ellenica parlato in alcune località del Salento:evo se kanonò deka kronu panta . La canzonetradizionale Rirollalla del gruppo Canzonieregrecanico salentino (nell’album Quaranta)risuona di accenti greci e dei ritmi della taranta.
Io ti canto in griko
{Grechedi Alice Patrioli

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 14/48
14 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
SGUARDO DI DONNADADIANE ARBUS A LETIZIA BATTAGLIA
LA PASSIONE E IL CORAGGIOVENEZIA / TRE OCI 11.09 > 08.12.2015a cura di Francesca AlfanoMiglietti
25 donne 25 storie25 sguardi sul mondo
D a l l ’ a l t o i n
b a s s o ,
d a d e s t r a a s i n i s t r a
M a r t i n a B a c i g a l u p o ( A g e n c e V U ’ ) , S h i r i n N e s h a t ( G l a d s t o n e G a l l e r y e F o n d a z
i o n e S a n d r e t t o R e R e b a u
d e n g o ) , D i a n e A r b u s ( M
. & E
. W
o e r d e h o f f v o n G r a f f e n r i e d ) ,
B e t t i n a R h e i m s ,
N a n G o l d i n ( G u
i d o C o s t a P r o j e c t s ) , C a t h e r i n e O
p i e ( R e g e n P r o j e c t s e F o n d a z
i o n e S a n d r e t t o R e R e b a u
d e n g o ) , D o n n a
F e r r a t o
Un progetto di Con In collaborazione con Mostra in collaborazione con

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 15/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 15
Dimensionidell’azienda
Età
Livellodi istruzione
Settoreeconomico
Tipodi professione
Avvocato
Commercialista
Designer grafico
Docente universitario
Funzionario superiore di partito politico
Insegnante di scuola elementare
Medico di base
Muratore
Operaio siderurgico
Ortolano
Tecnico di laboratorio biologico
Ufficiale di polizia
Avvocato
Commercialista
Designer grafico
Docente universitario
Funzionario superiore di partito politico
Insegnante di scuola elementare
Medico di base
Muratore
Operaio siderurgico
Fruttivendolo
Tecnico di laboratorio biologico
Ufficiale di polizia
Industria di processo
Industria manifatturiera
Edilizia
Utilities
Commercio
Servizi
Servizi finanziari
Totale
Industria di processo
Industria manifatturiera
Edilizia
Utilities
Commercio
Servizi
Servizi finanziari
Totale
Micro (fino a 10 dipendenti)
Piccola (da 11 a50 dipendenti)
Media (da 51 a250 dipendenti)
Medio-grande (da 251 a1.000 dipendenti)
Grande (oltre1.000 dipendenti)
Micro (fino a 10 dipendenti)
Piccola (da 11 a 50 dipendenti)
Media (da 51 a 250 dipendenti)
Medio-grande (da 251 a 1.000 dipendenti)
Grande (oltre1.000 dipendenti)
Fino a 24 anni
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
65 anni e più
Fino a 24 anni
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
65 anni e più
Non laureati
Scuola dell'obblig0
Diploma di scuola professionale
Diploma di media superiore
LAUREATILAUREA
Laurea triennale
Master di I livello
Laurea magistrale
Master di II livello
Dottorato di ricerca
NON LAUREATI
Scuola dell'obblig0
Diploma di scuola professionale
Diploma di media superiore
Laurea triennale
Master di I livello
Laurea magistrale
Master di II livello
Dottorato di ricerca
Agricoltura
0
9
9
0 -
. 4
2 2 . - 3 4 9 3 5 - 4 7
4 7 - . -72 7 . 5 -
.
9 . 4 9
9 7.
-
. 9 9
1 2 2
> 1 2
5
. 9 9
1 - 2 2 . 4 9
2 2 . 5 - 4 9 9
3 5 - .4 9 4 7 . 60 . 9 . 5 - 4
9 9 8
. 4 9
9 7.
.
0
2
> 1 2
.
0 -
. 9
1
2 2 . 4
2 2 . 5 4 9 9
- 4 7 9 . 60 4 9 2. 5 - 84
. 9 9 8
. 4 9
7.
.
-
9
> 1 2
0 -
. 9
1 0 2 2 . 4
2 2 . 5 - 4 9 9
3 -
4 7 9 60- 9 2. 5 - 84. 9 9
8. 4
7.
.
-
> 1
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Olanda
Belgio
Rep. Ceca
Slovacchia
Ucraina
Ungheria
Francia
Bulgaria
Italia
Spagna
Portogallo
5 10 15 20 25 30 35 40 450
La visualizzazione evidenziale differenze salariali esistentinel mondo del lavoro in Italiatra dirigenti, quadri, impiegati
e operai e tra diverse professioni.Gli indicatori rappresentati ne
evidenziano l’entità per areageografica, tipo di contratto, età,
dimensioni dell’azienda, livellod’istruzione e settore economico.
Nella parte inferiore della visualizzazione vengono
confrontate tre differenti fascesalariali (stipendio basso,
stipendio medio, stipendioalto) in diversi Paesi europei.
Fonti:«JP Salary Outlook 2015»
www.wageindicator.org www.iltuosalario.it
Comesi legge
I salari in Italia
dirigenti
quadri
impiegati
operai
Indicatore Differenzeretributive per inquadramento:
Variabili
lunghezza della linea = salariocolore=qualifica
spessore=esperienza
5 annidi esperienza
di esperienza10 anni
Il confronto con l’Europa
il dato relativo all’esperienzaviene indicato solo nel casodelle diverse tipologiedi professioni
stipendio bassostato
minimodato non disponibile
massimo
stipendio mediostipendio alto
+ Retribuzione mensile in euro (migliaia)* Retribuzione annuale in euro (migliaia)
- 1 . 7 4 9
1 . 7 5 - .
2 - .
9
.2 .4 9
. 5-
-
.. 4
. 5
. 7
. 7 - 3
. 9
>
+
*
Area geog rafic a
-
. 9
0 2 2 . 4 9
2 2 . - 3 4 9 9
3 -
4 7 -7 9 . 5 - 84
. 9 9 8
. 4 9
7.
.
-
> 1
Tempo indeterminato
Tempo determinato
Interinale
Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia e isole
Tempo indeterminato
Tempo determinato
Interinale
Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia e isole
Tipodi contratto
Sembrano tanti pianeti, inqualche modo immobili.Nonostante la tecnologia,nonostante la diffusionedei saperi, nonostante la
mobilità sociale accelerata dallepossibilità del virtual mondo e deglispostamenti a basso costo tra unPaese e l’altro. Anche se c’è una cosache lascia ben sperare: nonostantetutto, il grado d’istruzione, chequalche volta viene messo in di-scussione come occasione di cresci-
Nonostante la tecnologia e i flussi migratori, il livello di scolarizzazionerimane il motore della crescita professionale e dunque della retribuzione.In un universo dove, più che altrove, regna la diseguaglianza
La mappa dell’istruzione tra i pianeti deisalari
Società
ta (anche salariale), funziona anco-ra. Anche se non offre più le certez-ze di un tempo.
A se guire le linee curve de lla d i-stribuzione dei salari dell’età pre-sente vengono in mente tante cose.Il sale, moneta con la quale i legio-nari romani venivano pagati, non èpiù una moneta da tempo. Ma il sa-lario naturale di Adam Smith oquello definito necessario da JohnStuart Mill appaiono spesso di nuo-
vo s ulla scena dei reddit i contem-poranei. Redditi il più delle volte alivelli di poco superiori alla sussi-
stenza. Mentre quel vecchio mottosindacale del salario come «variabi-le indipendente», che occupò granparte degli anni Settanta, appare un
vecch io slogan se si osse rvano letrattative contrattuali dell’età pre-sente. Causa e vittima dell’inflazio-ne allora, elemento centrale nellacompetitività oggi.
Eppure il mondo appare propriocome te lo aspetti, se lo vedi con lalente delle retribuzioni. Il Paese-mi-raggio resta ancora la Svezia mentrel’industria manifatturiera cede an-cora il passo ai servizi finanziari.
Inutile scomodare la «giusta merce-de» dell’enciclica Rerum novarumper osservare un mondo denso diineguaglianze, dove Piero Sraffasollevò suggestivamente la questio-ne se il salario dovesse essere inqualche modo avvicinato di più al
sistema sociale che non al valore delcontributo produttivo di chi lo rice-
ve (Enciclopedia Treccani).Perché — e tutte le sfere-pianeta
sono lì a dimostrarlo — il salario re-sta uno degli argomenti in assolutopiù controversi, a maggior ragionese è vero, come ci ricorda l’Ocse, chela media del reddito in Italia, rispet-to al resto dei Paesi industrializzati,supera di poco i 35 mila dollari an-nui: oltre 11 mila dollari in meno.Distanze, divari, ineguaglianze, ap-punto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
di NICOLA SALDUTTI
Gli autoriVisualizzazione e analisi dei dati sono a curadi Federica Fragapane e Francesco Majno,information e communication designer.Portfolio: www.behance.net/FedericaFraga-pane e www.behance.net/francescomajno
«Quando preparo un vasetto, prendo inmano le acciughe delicatamente e lecontrollo una a una, perché mi piace vederlecosì belle. Poi, il vasetto parte per la suastrada e non so dove arriverà…». L’amore per
il lavoro di Marietta, filettatrice. Personaggiodi una storia di famiglia e di impresa (lunga130 anni) attorno a un «pesce povero», oggirivalutato: Alice o acciuga? , a cura di IreneRizzoli (Mondadori Electa, pp. 189, 26).
Un pesce mica tanto povero
{Orizzonti Visual dataCotture brevi
di Marisa Fumagalli

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 16/48
16 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 17/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 17

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 18/48
18 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
IL CLANDESTINO
di MARCO RIZZI
Nel libro La salvezza e il pericolo (Donzelli,pp. 116, 17), passato quasi sottosilenzio, Adriano Labbucci si misura a
fondo con un aspetto della figura di papaFrancesco che fin qui non è statoadeguatamente messo a fuoco, ovvero iltratto profetico di molti suoi gesti, percepiticome strappi al protocollo o modi di farespontanei e un po’ naïf. Uno su tutti,l’improvviso stop del corteo papale a
Betlemme in prossimità del muro che divide
Israele dai Territori palestinesi, per permettereal pontefice di avvicinarvisi e soffermarsi inraccoglimento. Gesto profetico perché legavapolitica e spiritualità, conflitto israelo-palestinese e forma della preghiera al Murodel pianto. La profezia, infatti, a lungo è stataparte integrante del discorso politico, tutt’altroche un utopico annuncio di qualcosainarrivabile. Ne è consapevole persinoMachiavelli, quando nell’ultimo capitolo del
Principe indossa i panni del profeta per
esortare i Medici a liberare l’Italia dai barbari.Nella Pasqua ebraica, la sera della cena siapparecchia la tavola e si lascia una sediavuota: è la sedia del profeta. Il vuoto dellaprofezia è anche il vuoto della politica. L’autoreconclude con un duplice interrogativo: sullaspinta di Francesco, la politica saprà tornare aprendere posizione, a dire da che parte sta inquesto mondo diviso? A sua volta, saprà papaFrancesco condurre effettivamente la Chiesasul cammino del discernimento di ciò che èrealmente il cuore del messaggio cristiano? Ilprimo viaggio pastorale di papa Francesco èstato a Lampedusa. Allora quel gesto sembròcadere nel vuoto. L’inattesa apertura dellefrontiere di questi giorni lo colloca forse in unaluce differente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il libro di AdrianoLabbucci dedicato a
papa Francesco
Profezia come intervento politico E Bergoglio sembra Machiavelli
Viaggio di nozze in crociera nei mari del Sud perMarnie. In cabina il marito legge Animals of theSeashore di Horace G. Richards e, come chi studiail comportamento animale, osserva la giovanesposa: strana ossessione per il colore rosso,attrazione verso il furto. Nel 1964 Hitchcockdirigeva Marnie, «mistero sexy» dal romanzo diWinston Graham. Protagonisti Sean Connery,già James Bond, e Tippi Hedren, un anno dopo Gliuccelli . Scarso successo al botteghino, purtroppo.
Uccelli, furti e colore rosso
{Ciak, si leggedi Cecilia Bressanelli
Di che segno sei? Punto, virgola o punto e virgola?I segni di punteggiatura stanno diventando unpo’ come quelli zodiacali. Percepiti sempre piùcome indicatori di una certa personalità (i duepunti ragionano da filosofi, le virgolette copia-
no sempre gli altri, le parentesi tendono a isolarsi). O addi-rittura come rivelatori dell’umore di un dato momento. Diche segno vi sentite stamattina? Esclamativo! Interrogati-
vo? Di sospensione.Questione di gusti
Certo, all’interno della norma grammaticale le regoledella punteggiatura hanno sempre avuto un loro statutospeciale. Al punto che, come notava un manuale scolasticodi fine Ottocento, «anche i migliori grammatici finisconoper levarsi d’impiccio col dire che la punteggiatura si deveimparare coll’uso». Una percezione soggettiva della pun-teggiatura, d’altra parte, c’è sempre stata. «L’uso della vir-gola sembra sciolto da ogni regola o legato soltanto al ca-priccio dello scrittore», notava in quegli stessi anni il filo-logo Giuseppe Rigutini, censurando il fittissimo uso delle
virgole nella seconda edizione dei Promessi sposi. Per gliscrittori, appunto, era una questione di gusti. Se Manzoniamava le virgole, d’Annunzio le aborriva («costrutto molto
virgolato è costrutto molto ba cato») e Carducci le evitavanelle enumerazioni: «Finita la villeggiatura, me la batto tral’aure i raggi gli zefiri e l’ombre a veder ballare le stelle». Lalineetta, usata spesso da Foscolo nelle Ultime lettere di Ja-copo Ortis, era considerata da Leopardi come il segno diun’allarmante deriva: «Che è questo ingombro di lineette,di puntini, di spazietti, di punti ammirativi doppi e tripli,che so io?», sbottava nel suo Zibaldone il 22 aprile 1821. Poicontinuava, profetico: «Sto a vedere che torna alla moda lascrittura geroglifica, e i sentimenti e le idee non si voglionopiù scrivere ma rappresentare, e non sapendo significare lecose colle parole, le vorremo dipingere e significare con se-gni, come fanno i cinesi».
Profetico perché sembra già prevedere l’allora impreve-dibile avvento degli emoticon, le faccine che cercano direndere iconicamente (cioè, grosso modo, come dei gero-glifici) le emozioni di chi scrive. La prima fu usata dal gio-
vane informatico americano Scott Fahlman nel 1982; era —
neanche a dirlo — una faccina sorridente :-). In fondo, ba-stava ruotare lo sguardo di novanta gradi perché la punteg-giatura assumesse tutto un altro aspetto.
Con l’avvento degli emoji, provenienti dal Giappone, ilpassaggio ai pittogrammi sembra compiuto. Al posto dellefaccine si usano disegnini già pronti che riproducono og-getti e situazioni di ogni tipo e ormai coi segni di punteg-giatura non hanno più nulla a che spartire. Secondo una ri-
cerca dell’americana Global Language Monitor, la «parola»più usata in Rete nel 2014 è stata proprio l’emoji che rappre-senta un cuoricino pulsante (al secondo posto, sia dettoper inciso, c’era l’hashtag, l’ultimo nato tra i segni dellanuova interpunzione: #).
Tra simboli e sentimentiÈ evidente che l’influsso di emoticon ed emoji sta cam-
biando anche la percezione collettiva dei segni di punteg-giatura tradizionali. Nell’ ambito di una scrittura che è —per frequenza, utenti, mezzi — molto diversa da quella tra-dizionale, anche la punteggiatura è oggi interpretata inmodo diverso. Un tempo si oscillava tra la punteggiatura«per l’orecchio» (mirante a rendere soprattutto le pausedel discorso) e quella «per l’occhio» (più attenta alle scan-sioni logiche e sintattiche). Oggi sarebbe forse più giustoparlare di punteggiatura «per il cuore». Il sentiment dellapunteggiatura è diventato sentimentale: a dominare sono— come per emoticon ed emoji — le emozioni.
Negli sms, in chat, nei social network la punteggiaturagode di una centralità e di un’autonomia che finora avevaconosciuto solo nei fumetti. In una storia di metà anni Set-tanta, Snoopy assiste a una diatriba tra il suo amico Wood-stock e altri uccellini gialli. Tutta la discussione avviene per mezzo di cartelli in cui è disegnato un segno di punteggia-tura. Quando alla fine la spunta la virgola, Snoopy com-menta: «Sono contento che abbia vinto… Sto sempre per ilproletariato…».
In una concezione simbolica della punteggiatura la vir-gola è l’elemento più debole, più fragile, più delicato. Diqui l’atteggiamento protettivo mostrato anche di recente inun libro come Between You and Me. Confessions of a Com-ma Queen scritto da Mary Norris, a lungo editor del «New
Yorker» e considerata, come ricorda il sottotitolo, la «regi-
Scrittura La grammatica non dà regole certe e la mente trova il nuovo zodiaco
Punteggiatura per l’occhio, per l’orecchio, ora per il cuoreL’interpunzione ci descrive (e il punto fermo fa litigare)di GIUSEPPE ANTONELLI
TrasformazioneL’influsso degli «emoticon» e degli
«emoji» sta cambiando anche lapercezione collettiva dei segni
tradizionali. E comunque adominare sono le emozioni
EvoluzioneNegli sms, in chat e nei social
network la punteggiatura gode diuna centralità e di un’autonomia che
finora aveva conosciutosoltanto nei fumetti
Il punto e virgolaNella lingua inglese se la passa molto
peggio rispetto a quanto succede initaliano. I manuali di seduzione losconsigliano perché è come truccarsi
per andare in palestra
Libri.
Romanzi, saggistica, poesia, ragazzi, classifiche
... )! ; Di che segno sei? , - *
ILLUSTRAZIONEDI LUCA DALISI

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 19/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 19
Ti chiami Tom. È una domenica di luglio,
famiglia e amici sentono l’odore che sispande dal barbecue. Un flash nel cer- vello, scappi via , nel tuo studio d i avvo-cato, bevi Jack Daniel’s fino ad ubriacar-
ti. Il caldo, il fumo, il vociare dei bambini. Pum. Tihanno riportato in Vietnam, dove avevi visto corpi
bruciati, il tuo p lotone mass acrato. Non sei fu ggi-to da casa, ma dalle foreste umide e opprim enti.Il tuo corpo ti ha riportato lì, non puoi tollerarlo.
Ti chiami Marilyn. Sei infermiera. Esci conMichael, lo hai conosciuto al circolo del tennis,da quattro anni non passavi la serata con un uo-mo. Al ristorante parlate di musica, cinema, beve-te un po’, ridete. Andate a casa. Finite a letto, nonricordi bene quello che è successo. Nella nottesenti il suo corpo vicino. Dentro ti si fa ghiaccio,sciolto da un’esplosione di rabbia. Lo insulti, lotempesti di pugni. Lui non capisce e non ti rivol-gerà la parola mai più. Tuo padre ha abusato di tequando avevi otto anni. Crac. Tua madre ti rim-proverava perché lo facevi arrabbiare.
Ti chiami Valerio. Sei al parco giochi con tuo
figlio. Vedi una mamma che allatta il figlio. H aiun accesso di dolore a un braccio, la paura ti som-merge. Vorresti correre da un medico. Non temil’infarto, ma di avere una malattia neurologica enon puoi spiegarlo a tuo figlio mentre gioca apallone. Resti lì, paralizzato, con gli occhi sbarra-ti, estraneo a quello che succede intorno. Tuamoglie, anni prima ha avuto un tumore al seno,diagnosticato durante l’allattamento. Tre anni di
battaglie, po i è morta. Pum. Aveva sintomi alle braccia qua ndo la malattia è ar rivata al cervello.
Storie vere, sono pazienticon i traumi psichici di cuiparla Bessel van der Kolk nel
bellissim o Il corpo accusa ilcolpo (Raffaello Cortina). Vitespezzate da eventi unici e
veloci o terribili e ri petuti.Siete stati in Iraq, all’Aquila lanotte del terremoto, in unreparto di ospedale mentre
per mesi una persona caracercava di sopravvivere? L’11 settembre lo avete sentito,per rubare il titolo a SafranFoer, Molto forte, incredibil-mente vicino? Allora questolibro parla di voi.
Il trauma non si imprimesolo nella memoria, quella èla parte meno difficile. I ri-cordi si potrebbero mettereda parte. Il trauma incide isuoi segni con uno scalpello
nel vostro corpo. Scava molto. Nel profondo delcervello c’è l’amigdala, una mandorla che sparaemozioni, centro di attivazione di rabbia e, so-prattutto, paura. Le botte della vita la istruisconoad accendersi facilmente. Uno stimolo minimoinnesca l’allarme. Intanto la corteccia medialeprefrontale, la parte deputata a dire «Ok, ok, èsolo fumo, stai tranquillo, non ti si brucia casa»,funziona meno. Il trauma fa questo scherzo, atti-
va la sirena e mand a in pensione i sa ggi che vidicono di stare tranquilli. Fa altro: altera il siste-ma immunitario, che a volte si indebolisce, altre
volte vi spara addo sso fuoco am ico, generan domalattie autoimmuni. Congela i muscoli o li ten-de allo spasimo, torce le viscere attraverso l’azio-ne del nervo vago. Scolpisce mem orie cattive den-tro di voi.
Van der Kolk il trauma lo ha studi ato a fondodai tempi in cui curava i veterani del Vietnam. Sache cosa serve per riparare i danni. Intanto unopsicoterapeuta aggiornato, che sappia far da testi-mone al dramma e aiuti a riorganizzare in unastoria sensata i frammenti dell’esperienza. E men-tre vi fa ricordare l’orrore, vi aggancia al mondointorno finché capite: non sta succedendo più.Poi, calmare il corpo, spegnere gli allarmi: farma-ci se serve, e molta mindfulness , la meditazioneche rinvigorisce le aree sagge del cervello mentreprestate attenzione al respiro che placa l’animo.Imprigionati nel passato, non vivete più con chi vista vicino, quindi: ridare vita al corpo. Arti mar-ziali, yoga, danza, teatro.
Valerio inizia un cors o di fitboxe coreografata.Calci e pugni al sacco e si balla. Entrando in sala
vedeva la sua imm agine nelle sp ecchiere e avevapaura. Poi iniziava la musica, One Day, Baby We’llBe Old, l’istruttore incalzava. «Jab, montante,gancio, tre-e-quattro, schiva, calcio circolare,stabilizza, mambo kick». Valerio riprende ad agi-re, a vivere, impara a svincolarsi da servomeccani-smi che amplificavano vortici su vortici di dolorealle prime avvisaglie dell’autunno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
na delle virgole» (virgola, in inglese, è comma). Il capitolospecifico s’intitola, giocando su una vecchia canzone di Boy George, Comma Comma Comma Chameleon.
In un libro sulle nuove forme di scrittura quel capitolo sisarebbe potuto chiamare, parafrasando un titolo dei Mas-sive Attack, Karma Comma. In rete, infatti, l’uso delle vir-gole e degli altri segni di punteggiatura sembra affidato alkarma individuale più che a una serie di regole condivise.
Le licenze che prima erano riservate agli scrittori appaionoadesso un diritto di tutti, il che rende la punteggiatura mol-to più libera. In alcuni casi persino licenziosa. Su una ma-glietta pubblicizzata in vari siti internet c’è scritto: «Thecomma sutra. Making grammar sexy since 1875» (da noi,in realtà, il comma sutra fa pensare più che altro alle con-torsioni di certo linguaggio giuridico). Ma proprio qui sta ilpunto, verrebbe da dire; perché invece quest’uso della pun-teggiatura è sempre più distante dalla grammatica. Le sueimplicazioni, più che linguistiche, sono psicologiche.
Psico-punteggiatura?Prendiamo il caso del punto fermo. Si è diffusa da qual-
che tempo l’idea che il punto fermo abbia — nel dialogotelematico — una valenza ostile, che corrisponda a un at-teggiamento aggressivo. La questione è stata sollevata unpaio d’anni fa da Ben Crair in un articolo del «New Repu-
blic»: «Nelle mie conversazioni online la gente non lo uti-lizza semplicemente per chiudere una frase, ma per segna-lare una cosa del tipo “non sono contento di come si stiamettendo la conversazione”». Di qui un uso che si starebbefacendo sempre più raro.
Nel lungo dibattito che ne è seguito, qualcuno ha scrittoche a uccidere il punto fermo sarebbe stato il punto escla-mativo. Forse per via di quella forma da «pugnalettacciodell’enfasi», da «daga dell’iperbole», da «alabarda della re-torica» che tanto infastidiva il giornalista e scrittore UgoOjetti (la sua celebre invettiva risale al 1 928). La vera alter-nativa, però, quella che in questo mondo s empre connessoconsente di non chiudere mai del tutto la comunicazione, èun’altra: «Applico alla vita i puntini di sospensione — can-tava Morgan — che nell’incosciente non c’è negazione ... ».
Solo che il punto è tutt’altro che morto e sepolto. A testi-moniarlo, negli stessi anni e negli stessi Stati Uniti, l’uso
vincente che Ob ama ne h a fat to duran te la sua secondacampagna elettorale, aggiungendolo al suo slogan cheprometteva di andare avanti. «Forward.». Fermo. Sicuro.Perentorio.
Segni di vitaDodici anni fa, nel suo Prontuario di punteggiatura, Bi-
ce Garavelli notava il diffondersi di un atteggiamento che
definiva «estremismo interpuntorio». Ovvero la tendenza ausare solo due segni: la virgola e il punto. A caratterizzare lanuova percezione collettiva è, invece, un radicale relativi-smo interpuntorio. La sensazione diffusa che non esistauna punteggiatura oggettivamente corretta, ma che l’usodipenda — di volta in volta — dai diversi contesti e dai di-
versi (è proprio il caso di dirlo) punti di vista. Un’interpre-tazione soggettiva e contingente dettata dal prevalere dellafunzione emotiva su tutte le altre. Come per il punto e vir-gola, che nella lingua inglese se la passa molto peggio ri-spetto a quanto succede in italiano. I manuali di seduzionelo sconsigliano, perché — dicono — usare un punto e vir-gola in chat è un po’ come truccarsi per andare in palestra.Ma a sconsigliarlo sono anche i manuali di scrittura creati-
va, for ti d i a ffermazioni come questa di E.L. Doctorow:«Detesto i punti e virgola. Non hanno nulla a che fare con ilraccontare una storia». O come quelle — lapidarie — diKurt Vonnegut, per cui i punti e virgola «non rappresenta-no assolutamente niente. Dimostrano solo che avete fattol’università». E poi: «Quando Hemingway si è ucciso, hamesso un punto fermo alla sua vita. La vecchiaia somigliapiuttosto a un punto e virgola».
In inglese il tanto detestato segno porta il nome di semi-colon. E proprio Semicolon project si chiama un’iniziativalanciata nei mesi scorsi che deliberatamente rovescia ilsenso delle parole di Vonnegut. Il progetto invita chi abbiasofferto di ansia o depressione, chi in passato abbia seria-mente pensato al suicidio, a disegnare sul polso o su un’al-tra parte del corpo un punto e virgola. «Il punto e virgolarappresenta una frase che l’autore avrebbe potuto chiude-re, ma ha deciso di non farlo. Quell’autore sei tu e la frase èla tua vita». Metterci la faccina non basta più: la punteggia-tura va vissuta sulla propria pelle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
BibliografiaSull’argomento della
punteggiatura, su regolee storia della grammaticasegnaliamo i seguenti testi:
Mary Norris, Between You and Me. Confessions of a Comma
Queen (W. W. Norton &Company, pp. 240, $ 24,95);
Bice Mortara Garavelli,Prontuario di punteggiatura ,
(Laterza, pp. 170, 12);Lynne Truss, Virgole per caso.
Tolleranza zero per gli errori di punteggiatura (traduzione
di Annalisa Carena, Piemme,pp.219, 9,90); Francesca
Serafini, Questo è il punto.Istruzioni per l’uso della
punteggiatura , (Laterza,pp. 160, 8,50); SimoneFornara, La punteggiatura ,
(Carocci, pp. 128, 12).Storia della punteggiatura
in Europa , a cura di BiceMortara Garavelli
(Laterza, pp. 670, 58)Gli appuntamenti
Giovedì 24 settembre negliStati Uniti si festeggia il
National Punctuation Daymentre in Italia venerdì 25 esabato 26 settembre si tiene
a Santa Margherita Ligure(Genova) il primo Festival
della punteggiatura
i
di GIANCARLO DIMAGGIO
Psicologia Sofferenza, guarigione
Traumi e luttiincidono il corpo:liberarsi si può
BESSELVAN DER KOLKIl corpoaccusa il colpoTraduzionedi Sara Francavillae Maria Silvana PattiRAFFAELLO CORTINAPagine 501, 33

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 20/48
20 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
nia) quando lui si è la-sciato cadere di sotto?
A ce ntina ia di chilo-metri di distanza, co-me quasi ogni giorno
negli ultimi vent’anni». Tra loro, che nonsanno se odiarsi o amarsi, sarà un procede-
re a tentoni cercando di non toccarsi ma fi-nendo comunque, in una notte più minac-ciosa delle altre, per sfiorarsi e per scopri-re, con felice sorpresa, una epifanica possi-
bilità di condivisione.Capita, ogni tanto, di riuscire ad annulla-
re le distanze. Sembra un miracolo, ma puòcapitare. Capita che la malattia — così co-me la morte del padre, nell’ultimo racconto— riesca ad aprire smagliature e varchi, asvelare verità inattese, a rivelare luci, colorinuovi a occhi che sembravano per sempre«invagati dal buio». Improvvisamente «ve-ro verde il verde,/ il sole vero sole, vero il
bosco», scrive Rilke in una poesia che co-mincia «Ma quando te ne andasti»: capitache «trascinati recitiamo/ qualche istantela vita non pensando all’applauso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Amato da Graham Green («Fu il primo acomprendere i l valore drammaticodell’avventura in un ambiente familiare»), JohnBuchan (Perth 1875 - Montréal 1940) è l’autoredei Trentanove gradini , da cui Hitchcock trasse Il
club dei 39. L’intrigo internazionale de Il destinodi David Crawfurd (traduzione di Elisa Porziani,Castelvecchi, pp. 92, 17,50) è ambientato inSudafrica e non è meno hitchcockiano: trafficodi diamanti, rivolte zulù, memorie di riti satanici.
Sudafrica hitchcockiano
{Libri NarrativaMani in alto
di Roberto Iasoni
Il filologo Giovanni Fontana esplora i confini (labili) tra follia e saluteUn esordio che lascia senza respiro e senza risposte, ma con tante domande
Vertigini, gorghi e occasioni mancateFoto di famiglia con fantasmi
Racconti
di PAOLO DI STEFANO
Stile
Storie
Copertina
GIOVANNI FONTANABreve pazienza di ritrovarti
INTERLINEAPagine 119, 12
i
Il racconto, si sa, in Italia non è un ge-nere fortunato. Poco intreccio per unPaese che ama le trame (non solo let-terarie), respiro breve per un Paeseche predilige le ampie volute. Non
sempre le cose sono però così nette: e sequalcuno avesse voglia di leggere un librodi racconti dal respiro ampio, che a trattilascia senza respiro — e senza risposte, macon tanti punti interrogativi — legga que-sto libro d’esordio.
Giovanni Fontana è un filologo, allievodi Cesare Segre, si è laureato sui cantariquattrocenteschi, ha studiato la poesia di
Mario Luzi e quella di Giorgio Orelli, si è oc-cupato anche di prosatori come Emilio Ta-dini ed Elsa Morante, insegna da anni in unliceo ticinese. Il titolo, Breve pazienza di ri-trovarti, proviene da una poesia inedita delpadre dell’autore, Pio Fontana, che è statoun ottimo studioso, tra l’altro, dell’Ariosto edei contemporanei, Pavese in particolare. Ilsottotitolo, Nel gorgo di salu te e malattia,richiama un poema dell’amato Luzi e nien-te sarebbe stato più adatto a definire il cir-cuito spiraliforme, che è anche una vertigi-ne mentale, entro cui si svolgono i singoliracconti e il libro nel suo insieme. Gorgoche confonde e inghiotte è l’immagine piùcalzante del movimento che avviene nellamente di molti dei personaggi, toccati co-me sono, in vario modo, dall’insania, dallafollia, dall’allucinazione che stanno loro ac-canto. Fontana va sondando gli «esili dia-frammi», i confini permeabili tra equili-
brio e ab isso, tra salute e malattia, il lentoinsinuarsi di questa in un tessuto apparen-temente sano, l’erosione, i primi segnaliche affiorano, il suo erompere inatteso, isuoi effetti persecutori, le sue onde sismi-che che oltrepassano le generazioni.
Sono per lo più interni familiari, piccolecrudeltà ed escursioni sentimentali neirapporti tra genitori e figli, tra fratelli, op-pure di coppie in bilico tra dono totale di sée repulsione. Rapporti resi precari da me-morie che tornano pressanti e insostenibi-li. O da equivoci. Nel bellissimo testo inizia-le, Organza, l’«io infetto» di Bruno emergegrazie alla voce narrante di Anna che ricor-da un episodio a dir poco inquietante avve-nuto anni prima dentro un box, mentre inparallelo (corsivato e chiuso tra le parentesidi una segregazione psichiatrica) scorre ilflusso dell’uomo, che converge verso lastessa immagine fantasmatica: un velo, unmascheramento, uno «scherzo» feroce che
non può che rivelarsi fatale nel rapporto trai due, rimanendo come «una cisti che nes-sun intervento chirurgico potrà mai rimuo-
vere». Sono anche raccon ti di occasi onimancate che in genere sovrappongono (econfondono) diversi piani narrativi e mol-teplici punti di vista su incubi, rovelli, tra-salimenti.
È infatti la mobilità della narrazione, lasua pluralità vocale ad aggirare la fissità os-
sessiva e claustrofobica, quel fuoco incan-descente che viene restituito per approssi-mazioni e per variazioni minime, per im-percettibili slittamenti di tempi e di luoghi(e anche di stile), per calibrate in crespatureliriche (spesso notevoli), per scambi sotter-ranei tra prima e seconda persona, capacidi sommuovere e aprire una narrazione chealtrimenti correrebbe il rischio della mo-nocromia.
Il secondo racconto, Coricarsi presto,che prende avvio da un pranzo di famigliaallargato, è una ricerca della distanza giustatra Guido e la sorella Virginia, assalita dal-l’angoscia di essere invasa dal «fiotto bitu-minoso di parole che filtra dagli interstizidella porta e si allarga rapidamente sui ri-quadri del vecchio parquet»: è o non è ilsussurro del fratello che chiede di essere
salvato dal precipizio della psicosi?Si potrebbe leggere il libro di Fontana in-seguendo il senso di colpa: «Dov’era (Virgi-
Giallo-rosa GiovannaZucca e un caso all’Ikea
Il delitto
coi puntinisulla Ädi IDA BOZZI
Una flebile trama gialla è lospunto del romanzo giallo-rosa di Giovanna Zucca, Äs-
sassinio all’Ikea (la dieresi sulla Afa il verso alla grafia svedese deiprodotti del grande magazzino, equesto fa intendere al lettore che iltono del libro è comico): Amilcare,amante trentennale di Anna Laura,
viene trovato assassinato in unmobile letto esposto nel grande
magazzino, aPadova. Lenarrazioni che
dovrebberoguidarci nelmondo pro-
vinciale intor-no all’omicidiosono due: ledivagazioni inprima personadi Erminia,migliore amicadi Anna Laura,e la narrazionein terza perso-na che seguele indagini
della questura, dove sboccia la pas-sione tra il commissario Loperfidoe l’ispettrice Luana. La trama noir è
volutamente secondar ia, ed è unpeccato, perché la coppia Loperfi-do-Luana è quella raccontata me-
glio, la più simpatica e quella checresce di più nel libro. L’interesse èfocalizzato più sulle vicende senti-mentali delle amiche Erminia e
Anna Laura, ma la narratrice Er mi-nia dà spesso troppo per scontato,trancia giudizi che non trovanosostegno nella storia, a volte si per-de in un chiacchiericcio che vor-rebbe essere ironico e invece lasciascettici come davanti a un pettego-lezzo (perché mai i figli dell’uccisosono chiamati «i bradipi»? E quan-do il m arito innamorato delle pri-me pagine diventa il marito bolsoche spunta a metà libro? E così via).Insomma una lettura lieve, che nonsempre riesce a esserlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
GIOVANNA ZUCCAÄssassinio all’IkeaFAZIPagine 286, 16
Stile
Storia
Copertina
Ottonella Mocellin -Nicola Pellegrini, Eccoil guaio delle famiglie (2014, installazione)
NOI, LE PIANTE, L A NATURA , L’AMBIENTEA MILANO DAL 14 AL 20 SETTEMBRE
www.labuonapianta.it S
C A R I C A L ’ A P P
L A B U O N A P I A N T A
Condividiconnoiletueimmaginidirelazionetranatura,uomo,cittàconl’hashtag
#labuonapiantaLepiùsignificativericeverannounasorpresadinaturaesalute!
Gliincontrie spettacoli di A Seminarla BuonaPianta sonogratuiti,senza prenotazione,fino adesaurimentoposti
DaLunedì14aSabato19settembreOrtoBotanicodiBreraCORSODIFITOTERAPIA EACQUERELLOBOTANICOWORKSHOPSESTAFFETTA DIGREENKNITTINGPerinfoe iscrizioni:www.labuonapianta.it
Venerdì 18s ettembrePalazzodiBrera -Sala Napoleonica17.30 LEPIANTENELMITOENELL’ARTE
EvaCantarellaeLuciaTomasiTongiorgi
21.00 PIANTALA! ClaudioBisio
22.00 ALLYOUCANEAT DiegoParassole
Sabato19settembrePalazzodiBrera -Sala Napoleonica11.00 VIETATONONCALPESTARE LEAIUOLE
Agroecologia in cittàDibattitoapertoconespertie Istituzioni
17.00 L’INTELLIGENZADELLE PIANTEStefanoMancuso
18.30 COMELE ARTIRACCONTANOLE PIANTEGianlucaBalocco,VittorioCosma,
MichelangeloPistolettoeMarcoBuzzini
21.00 ILDILUVIOSOTTODINOI LellaCosta
Domenica20settembre10.00 ORTOBOTANICODI BRERA
PARTENZAPASSEGGIATABOTANICA MicheleSerrapresentaBotanicaUrb ana
10.30 DALL’ORTOBOTANICOAI GIARDINIMONTANELLI
Riconoscimentodellepiantespontaneeincittàcon ibotaniciAboca
11.30 GIARDINIINDROMONTANELLILANATURATRALERIGHEReadingcon VanessaDiffenbaugh,MichelaMurgia
eAndreaVitali.Con VittorioCosma,pianoforte
13.30 PASSEGGIATADAI GIARDINIMONTANELLI AL GIARDINO DELLA GUASTALL A
14.30 GIARDINIDELLAGUASTALLA LANATURATRALERIGHEReadingconRoberto Vecchioni
15.30 DALGIARDINODELLA GUASTALLA ALLA TRIENNALERiconoscimentodellepiantespontanee
incittàconi botaniciAboca
17.00 TRIENNALEDIMILANO - ATTRAVERSOL’ALBEROMostraeinterventodiTullioPericoli
17.30 TRIENNALEDI MILANO- L ANATURATRALE RIGHEReadingconFilippoTimi
19.00 TEATROBURRI-GRANFINALE ConlaBandaOsiris
Finoal31ottobrePinacotecaeOrtoBotanicodiBrera
ARTE HORTO Percorsoar tistico-botanico
Spettacoli,corsi, incontri,letture,mostre, passeggiateper esplorareilrapportocheabbiamoconle pianteeconl’ambientein cuiviviamo.
Allaricercadellabuonapiantaanche incittà!
P h o t o
F .
F r a t t o

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 21/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 21
Ha battuto la Boston sede del Mit (ferma al 29%)e pure la Silicon Valley di San Francisco (24%);ha stracciato Seattle e Berlino (inchiodateaddirittura al 9). E con una quota rosa del 30%,l’insospettabile Chicago in tre soli anni s’è presa
il titolo di «capitale delle startup fondate dadonne». Un risultato non casuale: organizzazionifemminili e grandi aziende hanno lavorato percreare le condizioni migliori. E per una volta, nonci sarebbe niente di male nel copiare.
La capitale delle startup femminili
{Libri NarrativaCittadini
di Edoardo Vigna
Stile
Storia
Copertina
ADRIÁN BRAVIL’inondazioneNOTTETEMPO
Pagine 184 , 13
Come se, scrutando in controlucela sua scrittura, si potesse ricono-scervi la sua fisionomia. In fondoè questo lo stile, no? L’espressio-ne, nella forma, di un carattere, di
un modo di essere. Adrián Bravi è un tipominuto, fine, delicato. Ha cinquant’anni ma
è di quelli che hanno l’aria dell’eterno ragaz -zo, per non dire bambino, forse per il piace-re e il divertimento che mette nelle cose chefa. Parla con un lievissimo accento sudame-ricano, molto esotico e charmant, lui che ènato in Argentina, a Buenos Aires, e il suoitaliano è tutta una poesia: come è tipico dichi acquisisca come proprio, nella vita e nel-l’arte, un idioma diverso dalla madrelingua. Vive in Italia, a Recanati, il paese di GiacomoLeopardi ma anche di suo padre e di suamadre che vi erano nati prima di emigrare,durante la guerra, in Argentina, e dove Adrián, in cerca d elle proprie radici, all’ini-zio degli anni Ottanta ha scelto di ritornare.
Dopo gli esordi in lingua castigliana, dal2004 scrive romanzi in italiano: Restituisci-mi il cappotto, La pelusa, Sud 1982, Il ripor-to, L’albero e la vacca, tutti usciti da Notte-
tempo tranne il primo pubblicato da Fer-nandel e l’ultimo edito da Nottetempo incollaborazione con Feltrinelli. Sono libripoetici e spassosi, fiabeschi e pensosi. Sto-rie di una quotidianità feriale e incantatatratteggiate col nitore di un apologo e pun-tualmente animate da una sorpresa. Libriche si leggono col sorriso sulle labbra, lostesso con cui forse sono stati scritti. Nelsuo ultimo romanzo, L’inondazione, chi loha già letto riconoscerà al volo la voce e il volto di Bravi: il tono assorto e stupito dellasua prosa, lo sguardo affilato e indulgentecon cui, tra le righe, tiene d’occhio i suoipersonaggi senza fargliene passare una. MaBravi, che è un maestro nel non rifare sestesso, che con ogni nuovo titolo è riuscito afare un passo più in là in termini di sapienzae di originalità, all’ultima narrazione ha im-presso — in tutta naturalezza — un ritmoaffatto nuovo.
È il ritmo del fiume, il Río Sauce: è lui a
decidere la sorte del paesino immaginarioche sorge sulle sue rive e a segnare l’andatu-ra del racconto di quell’inondazione che ar-riva lenta e inesorabile come il destino, inat-tesa e travolgente come il più intimo e re-moto dei ricordi, misteriosa e seducente co-me il tempo. Preceduta da pochi segnalidecifrabili solo col senno di poi — i ramidegli alberi che si muovevano senza vento,l’odore più intenso delle cose, l’aria umida ecome carica di un certo timore —, l’acquaera salita nello spazio di una notte a som-
Con «L’inondazione» Adrián Bravi imprime un ritmo nuovo alla capacità di trattare lestorie. Rimane fedele allo stile vicino a una quotidianità incantata e sorprendente. E dietroil mondo sommerso dalla piena sta un ricordo personale dell’infanzia a Buenos Aires
Dentro una barca ma sopra il giardino
Fantastico
di ALESSANDRA IADICICCO
dell ’osteria diGuadalupe, i duesciacalli, più goffiche loschi, PiedeFelpato e Trombettista, che vorrebbero raz-ziare le case inondate di fango (ma il fiumenon molla la sua preda), il dandy Cisnero,
che anche con l’acqua fino al collo si preoc-cupa di allisciarsi i capelli all’indietro colpettine, e poi rumeni nostalgici, cinesi«cianfrusagliari»… Ma tutti costoro hanno voltato le spalle a Río Sauce. Sentendosi tra-diti dal fiume, lo hanno tradito.
Morales li guarda a distanza, e a tratti gliappaiono come fantasmi, come creaturefantastiche, «come se non fossero mai esi-stiti davvero». Lui è l’unico che accetta lanuova conformazione imposta alla terra dalRío, una forma magica, onirica: mai piùavrebbe pensato di remare sopra le strade, o«di stare sopra il giardino dentro una barca,gli sembrava una specie di chimera». Fanta-stico, come un insetto preistorico, gli appa-re l’elicottero della protezione civile cheruota sulla provincia inondata. Fantastici gli yacaré, cioè gli alligato ri, i pigri bestioni-statua che prendono a nuotare per Río Sau-ce. Fantastica perfino la mappa del paesecom’era, con le sue strade sterrate e i muret-
ti scorticati, ormai sommersi dall’onda deltempo. Nel finale, che non si vuole svelarequi, Morales sceglierà a suo modo di restaresott’acqua, in una dimensione in cui «il fu-turo è solo un ricordo».
Sveliamo invece, su confidenza dell’auto-re, che nel passato di Adrián Bravi una storiadi inondazione c’è. È un ricordo lontano,«un’immagine così remota che non credocorrisponda più alla realtà», racconta.Quando aveva meno di 4 anni e viveva nel barrio di San Fernando a Bueno s Aires, unazona lambita dal Luján, un affluente del Ríode la Plata, accadeva spesso che il fiumestraripasse e che al mattino ci si ritrovassecon mezzo metro di fango in casa. «Alloramia mamma mi metteva sul tavolo, al-l’asciutto, ad aspettare». Da quel quartiere iBravi se ne sarebbero andati presto. E Adrián, proprio come i compaesani di Mo-rales, avrebbe voltato le spalle al suo f iume ealla sua terra. Ma dei riosaucini, gente di fiu-
me che non va mai di fretta, avrebbe conser- vato l’indole e un misterioso senso de l tem-po: del tempo che, come l’acqua, scorre, sì,ma anche sale, sommerge, trattiene in sé,restituisce magicamente quel che era stato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Andreas Franke (1967),foto da The Sinking World (2010, courtesy dell’artista)
Straniera Ricardo Menéndez Salmón: la perdita di un figlio e il potere della scrittura
Con lo stesso titolo di Ian McEwan un secondo inizio che nasce da una fine
RICARDOMENÉNDEZ SALMÓN
Bambini nel tempoTraduzione di Claudia Tarolo
MARCOS Y MARCOSPagine 221, 15
«Un giorno scriverai di tuttoquesto». Prostrata dal dolore piùgrande, la perdita del figlio di
pochi anni, Elena predice ad Antares, ilmarito romanziere, che con la scritturaproverà a uscire dalla voragine di quellamorte. Ma prevede anche il possibile esitodi tanta sfida: «Io ti odierò per questo».Rivelandosi, in entrambi i casi, un’acutaCassandra. Il valore e i limiti dellaletteratura, le reali possibilità che ha laparola scritta di curare le ferite più profondedella vita, sono il cuore di Bambini neltempo, nuovo romanzo del44enne scrittore spagnolo RicardoMenéndez Salmón, che mutua con espliciteanalogie il titolo di un celebre romanzo del1987 di Ian McEwan. È un libro, il suo, chene raduna di fatto tre. Il primo, potente eamaro: la storia dell’effetto disgregantedella morte di un figlio su una coppia che siscopre indifesa di fronte a un luttointollerabile (e qui emerge con più evidenzail riferimento allo scrittore britannico). Ilsecondo, spiazzante e dissacratorio: iltentativo di narrare, immaginandola,
l’infanzia che i Vangeli hanno negato alBambino di Nazareth, Gesù, in una sorta diimpossibile compensazione. Il terzo, forseun po’ ostentatamente lirico: il racconto diun nuovo incontro e di un possibile nuovoinizio sotto i cieli di Creta, l’isola dove ilmito si insinua in ogni anfratto e il temporesta sospeso. Con una scrittura matura, chealterna agilmente i diversi registri impostida ciascuna «sezione», Menéndez Salmóncompone un vero e proprio inno allascrittura, «ossimoro benedetto: sole nero,luce tenebrosa, lampo oscuro sul biancoprimordiale della pagina». Ma soprattuttostrumento prezioso per «dare parola allarovina», per dire la morte e provare così acombatterla. Scrittura che pare dunque nondiscostarsi molto da una forma di religione:in principio era il Verbo...
©RIPRODUZIONE RISERVATA
di MARCO OSTONI
mergere le case. E gli abitanti se ne eranoandati, non esattamente in preda al panico:«I riosaucini erano tutta gente di fiume, chenon andava mai di fretta», nota l’autore, chedella corrente del Río aveva appena rilevatol’antico passo rassegnato. Solo il vecchio Ila-rio Morales era rimasto. Per nessuna ragio-
ne al mondo avrebbe abbandonato il luogodella sua infanzia e dei suoi morti «ancoraun po’ troppo vivi per lasciarli soli». Così,trasferitosi nella soffitta della grande casa difamiglia con pochi oggetti ben lontani dal-l’essere beni di prima necessità — i vinilidelle opere liriche adorate dal suo patrigno,le foto incorniciate, i guantoni che trent’an-ni prima gli aveva regalato il pugile CarlitosMonzón — vive per tutta la durata della pie-na di pane secco e ricordi. Non è completa-mente solo. In quel paesaggio surreale doveci si muove in barca sulla distesa liquida dacui affiorano solo i tetti delle case, apparetutta una sfilata di figurette grottesche e co-lorate. Il turco Hasan, sentenzioso gestore
Stile
Storia
Copertina
PersonaggiIl vecchio Morales si rifugia
nella soffitta con i vinili di
opere liriche, le fotoincorniciate e i guantoniche gli ha regalato Monzón
Paesaggio surrealeCi si muove
sulla distesa liquida da cuiemergono solo i tetti delle
case. Tutti hanno voltatole spalle a Río Sauce
i

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 22/48
22 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
Quando i migranti eravamo noi. E quandoancora l’uso virale della fotografia nondiffondeva globalmente l’immagine dellatragedia. C’era però la canzone, la grandecanzone napoletana. Nel 1925, parole di
Libero Bovio, musica di FrancescoBuongiovanni, si canta Lacreme napulitane .«I’ ch’aggio perzo patria, casa e onore, i’ so’carne ‘e maciello: so’ emigrante »: una voltaeravamo noi la carne da macello.
Carne ‘e maciello
{Libri OfficinaIncanti
di Ranieri Polese
Personaggi Ann Goldstein mette in inglese Ferrante(e Pasolini, e Levi...): «Ecco perché l’America la ama»
Elena, l’amica genialeche io non conoscodi COSTANZA RIZZACASA D’ORSOGNA
BERNARD FRIOTStorie di quadri(a testa in giù)
IL CASTOROPagine 128, 13,50
Dagli 11 anniEsce giovedì 17 settembre
iDei traduttori, a meno che non sia-no un Montale o una Nanda Piva-no, si parla spesso troppo poco. Eperò, notava l’«Atlantic», l’ostina-zione di Elena Ferrante nel tener
nascosta la propria identità ha involontaria-mente acceso, negli Stati Uniti, un faro su Ann Golds tein, il capo dei corre ttori del«New Yorker» che ha tradotto in inglese tut-te le sue opere, oltre a Pasolini, Baricco, Pi-perno, Leopardi e Primo Levi (di cui a finemese uscirà l’opera omnia, da lei anche cura-ta). Sempre presente a una lettura o al lanciodi un suo libro, Goldstein ha dato un volto al-
la Ferrante. Tanto che per un paio di amichela scrittrice sarebbe proprio lei. «È un po’uno scherzo, ovviamente. Non credo chequalcuno ci creda davvero. Ma simbolica-mente forse rappresenta un più generale bi-sogno del lettore moderno di trovare unapersona dietro il libro».
«Ferrante fever», febbre Ferrante, tito-lava il «New Yorker» in occasione del-l’uscita di «Storia della bambina perdu-ta». Perché gli americani sono pazzi di lei?
«La saga de L’amica geniale ci immergenelle vite di Elena e Lila. Famiglie, amici, ma-trimoni: tutto ciò che accade loro in sessan-t’anni. Vediamo questi personaggi lottare,invecchiare, a volte morire. È uno degliaspetti che rendono i suoi libri così appas-sionanti. Non sono tanto le circostanze: lamaggior parte di noi non è cresciuta nellamiseria di un rione della periferia napoleta-na. Ci identifichiamo con le loro storie. La
capacità di Ferrante di scavare nelle emozio-ni è commovente».Come ne è diventata traduttrice?«Dopo il 2001 i suoi editori, Sandro e San-
dra Ferri (E/O, ndr ), decisero di sbarcare ne-gli Usa. Soprattutto, volevano pubblicareFerrante, per anni rifiutata dalle case editriciamericane. Stabilirono che la prima uscita diEuropa Editions sarebbe stata I gi orni del-l’abbandono, e chiesero ad alcuni traduttoridi sottoporre una prova. Era la prima voltache la leggevo, l’ho amata all’istante».
Dove ha imparato l’italiano?«Al college avevo seguito due volte lo stes-
so seminario su Dante. Anni dopo, al “New Yorker”, d ove lavoro dal ’74, scoprii che an-che altri colleghi volevano studiare la lingua.Organizzammo un corso: la prima insegnan-te fu la figlia di Maristella Lorch, celebredantista della Columbia University. In Italiacerco di venire almeno due volte l’anno. Ilgrande rimpianto è non avervi mai vissuto».
Come riesce a rendere i termini gergalio dialettali della prosa di Ferrante?
«Lei usa pochissimo il vernacolo. Spessoquando incontro una parola in dialetto, o in
un italiano intraducibile, il trucco che adottoè quello di citare la parola originale e poispiegarla. Se ricompare, la scriverò solo in vernacolo».
Nell’Italia sessista, la speculazione sul-l’identità della Ferrante si è indirizzata alungo su autori maschili. Anche in Ameri-ca è stato così?
«No. Del resto, gli scrittori con cui è stataidentificata non sono molto noti da noi. Ionon ho mai pensato che potesse essere unuomo. E non ricordo, nella nostra letteratu-ra, episodi in cui un’autrice con pseudonimofemminile sia stata presunta maschio».
Non vi siete mai incontrate?«Non le ho mai neanche parlato. E non
comunichiamo direttamente per email.Quando ho iniziato a tradurla, se avevo unadomanda la ponevo all’editore, che glielainoltrava. In seguito si è resa un po’ più di-sponibile, ma avendo avviato questo non-
rapporto, non ho mai desiderato cambiarlo.Lei non legge le bozze dei manoscritti tra-dotti, io non sento il bisogno di conoscerlapiù di quanto già non la conosca».
Quale libro della Ferrante preferisce?« I giorni dell’ab bandono . Forse, banal-
mente, perché è il primo che ho tradotto.Ora sto traducendo La Frantumaglia, la col-lezione di lettere e interviste che uscirà in in-glese in inverno».
@CostanzaRdO©RIPRODUZIONE RISERVATA
EsperimentiI ragazzi del liceo bolognese «Galvani»hanno lavorato sui racconti di Bernard Friot. Con libertà
Compagni di classetraduttori sul seriodi SEVERINO COLOMBO
«Steso nel letto, Totò nondorme». È l’inizio di unadella ventotto Storie diquadri (a testa in giù) diBernard Friot, libro di rac-
conti — nati prima, dopo e intorno alla vi-sione di opere d’arte — che sta per uscire inItalia. L’originalità del volume di Friot trovarisonanza in un lavoro di traduzione, chepuò rappresentare anche un modello per ilfuturo.
Il lavoro è stato realizzato dalle classi 4 G,4 H e 3 G della sezione internazionale difrancese EsaBac del liceo «Luigi Galvani» di
Bologna, nell’anno scolastico 2013-14.«L’idea vincente anche dal punto di vista di-dattico — spiega Michela Mengoli, docentedel «Galvani» e referente del seminario-concorso Seuils per studenti traduttori — èquella di lavorare insieme. Il traduttore èsempre meno un mestiere che si fa da soli esempre più una attività di gruppo o, comenel caso del testo di Friot, di coppia». E ag-giunge Mengoli: «Questo testo, che ci è statoproposto da Grazia Gotti e David Tolin del-l’Accademia Drosselmeier, ha una naturamolto particolare, perché non appartiene aun genere preciso e presenta una varietà diregistri, tonalità e sfumature». Insommaun’opera perfetta per esercitarsi in un lavorodi traduzione.
Ogni coppia di studenti si è misurata conuna storia, poi, tutti insieme hanno collabo-rato al lavoro di revisione. «Abbiamo divisoil brano a metà — racconta a “la Lettura”Emma Lolli, 18 anni, allora in terza, che oggi
frequenta la V G e che ha lavorato con lacompagna Maria Chiara Cloutier — e ognu-no ha tradotto la sua parte, poi ce le siamoscambiate per correggerle». La loro storia èintitolata Sorpresa: «Abbiamo avuto solo undubbio su un vocabolo che aveva a che farecon il mondo dei volatili. Abbiamo chiestoalla prof».
Per altri giovani traduttori i dubbi sonostati: come far parlare un dio? i bambinifrancesi e italiani sono golosi delle stessecose? Il racconto di apertura ha per protago-
nista Apollo. «È unad i v i n i t à m a p a r l aslang, un aspetto cheai ragazzi è piaciuto molto», ricorda MariaLuisa Vezzali, docente del «Galvani», poe-tessa e consulente per la traduzione. Nel rac-conto La bambina grassa, invece, i dolcifrancesi sono stati adeguati al gusto italiano(e al suono della nostra lingua): «Bavaresealle fragole, torta di mele, bigné, charlotte ailamponi, delizia alle pere». «La prima ver-sione — aggiunge Vezzali — era letterale,nella successiva sono stati tenuti presentiaspetti di metrica e fonetica».
Ulteriori dubbi di traduzione sono statisottoposti direttamente all’autore in un in-contro che Friot ha avuto con docenti e ra-gazzi nella primavera dello scorso anno allaFiera dei libri per ragazzi di Bologna. Ricor-da Bernard Friot: «Con i ragazzi ho discussodi letteratura, lingua, traduzione e di come ilsenso di una frase si gioca su una sola paro-la». E aggiunge: «I ragazzi hanno fatto un ot-timo lavoro».
Laura De Nuzzo, oggi studentessa allaBocconi, ha partecipato al progetto ma nonsi è limitata alla traduzione (con Claudia Va-talaro) del racconto Alla mostra. «Ho segui-to l’organizzazione e la grafica dei testi; misono appassionata; un’esperienza che mi èstata molto utile, ad esempio per strutturareil piano di studi».
Nell’incontro con Friot alcuni ragazzihanno perfino chiesto (e ottenuto) il per-messo di cambiare sesso a un personaggio.Così, se a qualcuno venisse in mente di leg-
gere l’originale francese scoprirebbe chenon c’è nessun Totò steso nel letto a dormi-re, al suo posto c’è, invece, Lili, un personag-gio femminile.
Dal 18 al 27 settembre Friot è in Italia per un tour che lo vedrà anche nelle vesti di gui-da al Museo degli Eremitani, a Padova, e alMuseo del Novecento, a Milano. Il nuovo li- bro è «un invito rivolto a bambini e adul ti aguardare i quadri con la fantasia. Raccontarestorie è un modo di interpretare il mondo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’americana Ann Goldstein è laresponsabile dei correttori del«New Yorker», dove lavora dal1974. Ha tradotto anche Pasolini,Baricco, Piperno, Leopardi ePrimo Levi (di cui a fine meseesce l’opera omnia, da lei curata)
ILLUSTRAZIONIDI ANNA RESMINI

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 23/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 23
I resti di Federico García Lorca non sarebberonella fossa comune di Víznar in cui il poeta fugettato dopo la fucilazione, nel 1936. Ifranchisti li avrebbero traslati in un luogosegreto di Madrid, «vicino alla famiglia». Lo
rivela Marta Osorio in El enigma de una muerte (Editorial Comares, pp. 308, 21), basato sullacorrispondenza tra lo storico Agustín Penón eEmilia Llanos, amica di Lorca, informata deifatti da «una persona importante».
L’enigma di una morte
{Libri PoesiaStanze
di Angela Urbano
GIANCARLO SISSAAutoritrattoPostfazione
di Alberto BertoniITALIC PEQUOD EDIZIONI
Pagine 164, 15
i
Da Autoritratto ( Poesie 1990-2012)di Giancarlo Sissa (Mantova, 1961)edito da Italic
Potrei dirvi che mi manca il bere
il sapore di certi liquori almenoma in realtà in realtà vi dico
quando mi sveglio è mattino
e non inferno e nella noia
mi alleno, non mi maledico,
pedalo in bicicletta, non freno
la mia voglia d'inverno, ma senza fretta,
e di lavoro non voglio parlare proprio,
sono poco produttivo, bensì veglio
copio, trascrivo l'eresia del nulla, mi p rovo
vivo, durante lente passeggiate stremo
nauseato il furore del passato – mi invento
una culla di foglie e poesia con la sosta
– senza comprare – in librerianon ingabbio più il desiderare
lo chiamo adesso e p osso quasi
confessare che mi manca
abbastanza spesso e dunque sì
qualche volta anche il bere quando,
più spesso nel buio che s'annuncia,
so di non sapere...
Potrei dirvi che mi manca il bere
C.d.S.
R iflettere per generazioni in poe-sia lascia sempre il tempo chetrova. Lo sappiamo, si rischia inogni caso di diluire nella generi-cità o nella sociologia quel qual-
cosa d’irriducibilmente individuale che lapoesia porta sempre con sé. Qualsiasi con-siderazione dipende poi dai poeti e dai li-
bri che volta a volta si sono presi come rife-rimento. E da questo punto di vista i nomie i titoli, e di conseguenza gli argomenti,possono completamente cambiare. Così,se penso ai poeti che più apprezzo tra i nati
negli anni Sessanta, cioè di una generazio-ne che è anche la mia — Dal Bianco, Dona-ti, Sissa, Franzin, Iacuzzi, Riccardi, Zucca-to, Bonito, Raimondi, Gibellini, Socci e for-se qualche altro con loro — posso di re sol-tanto che per chi ha iniziato a scrivere versia vent’anni o poco più, la poesia era proba-
bilmen te l a passio ne più astrus a e fuoriluogo che si potesse coltivare. Perfino lacontrapposizione tra politica ed esteticache aveva improntato gli anni precedentiera venuta meno. Non è un caso che tranneuno o due questi poeti siano tutti nati ecresciuti al di fuori della cosiddetta grandeeditoria, che a differenza dei fratelli mag-giori e tanto più di chi è venuto dopo, nonsi siano organizzati o auto-promossi attra-
verso alcu na a ntologia, e ch e si siano di-stinti soltanto col tempo, in lunghi anni dipresa di coscienza e di riconoscimento re-ciproco. Comunque sia, ci hanno creduto,hanno avuto una loro forza e tenuta. Credo
sia un merito che gli si debba riconoscere.
Mi ha spinto a queste riflessioni la rilet-tura delle poesie che Giancarlo Sissa, man-tovano del 1961 da più di tre decenni resi-dente a Bologna, ha raccolto in una propriaauto-antologia, Autoritratto (Poesie 199 0 – 2012), uscita per le edizioni I talic. Il volu-me comprende testi tratti dai suoi quattrolibri, tre di versi e uno, l’ultimo, di breviprose, da Laureola (1997, Book Editore) a Ilbambino perfetto (2008, Manni), con l’ag-giunta di qualche inedito. Il motivo non sitrova però in una mera questione editoria-le, bensì nel taglio a tratti drammatica-mente, fieramente generazionale della suapoesia, e ancor più nel suo destino di poe-ta che per sussistere non ha avuto bisogno,quasi fosse contro la sua stessa natura, dialcuna legittimazione dall’alto, ma sempli-cemente del riconoscimento e dell’amici-zia poetica di alcuni lettori autorevoli, senon d’eccezione. Penso dapprima a Gio-
vanni Giud ici, che individuando subito laqualità melodica del suo primo libro loaveva definito un «tenero poeta d’amore»,ma con «l’originalità di una sobria graziache già in partenza dissipava fumosità escorie, insomma, ogni sospetto di pur faci-le sentimentalismo».
Da quei primi, già esatti versi, Sissa hacompiuto un cammino piuttosto lungo.
Auto-antologieGiancarlo Sissa haraccolto parte dellapropria produzione,
legata a una mitologiaesistenziale toccatadal gusto della sconfitta
di ROBERTO GALAVERNI
anti-borghese, l’affinità con la notte, il di-sgusto di se stesso. Tutto in una particolaremescolanza d’ironia, sarcasmo, rabbia epassione.
Il fatto è che Sissa ha raggiunto una po-sizione estremamente proficua per mette-re «la vita in versi» (questa formula d i Giu-dici rappresenta a tutti gli effetti il norddella sua bussola poetica), abbassandola allivello dell’asfalto cittadino o della suaamata pianura, e togliendo a se stesso ogniscopo, doppi fini, ambizioni, desideriod’affermazione o anche solo del cosiddetto
benessere. Al livello dei marciapiedi e an-che più giù. Credo sia questo il tratto piùnotevole e specifico di questo poeta nelloscenario della nostra poesia. Non è un casoche sia uno dei pochissimi capaci di parla-re di chi patisce, di chi lavora duramente,di chi ha perso, di chi vive ai margini, sen-za retorica, senza ideologia, ma semplice-mente da pari a pari, a tu per tu. Propriocome un cane randagio che, non visto, co-nosce e si riconosce negli anfratti della cit-tà, «nell’elemosina del tempo/ nell’intimofallimento di ognuno/ io per primo senzaesitazioni/ io smarrito in altre stazionisenza/ cielo in misere consunte passioni /schiavo di altra vergogna/ o via crucis ditrascorsa menzogna».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ogni scrittore, ogni letteratura ha lapropria leggenda. Quella di MirceaCartarescu (1956) passa per il
Cenacolo del Lunedì, in cui si riunivano aBucarest, nei primi anni Ottanta, i miglioripoeti di una generazione. Era la Bucarestcomunista, plumbea e di regime: lì, guidatidal critico Nicolae Manolescu, i giovaniscrittori gravitanti intorno alla facoltà diLettere discutevano, leggevano i propri
lavori, si affinavano. Erano ancora gli annidi Ceausescu: non era una dissidenzapolitica, la loro, ma poetica. La leggendadel Cenacolo del Lunedì si nutre diesperienze di gruppo, di tentativi dievadere dal buio circostante («come un bicchiere, Bucarest si era riempita dellanotte» suona un verso di Cartarescu), masoprattutto si alimenta del sogno dellaletteratura.Sarà anche per questo che lo scrittoreuscito da quella palestra è capace di
composizioni labirintiche. La parolaletteraria produce un organismo vivo, unpiccolo cosmo, e interroga l’enigmadell’esistente. Chi abbia letto le prime dueparti della trilogia narrativa Abbacinante (edite in Italia da Voland, come gli altri testiin prosa dell’autore) sa come Cartarescu siacapace di costruire universi, di portarel’interrogazione ai limiti del pensabile. Anche nei suoi versi, che possiamo scoprire
grazie all’antologia Il poema dell’acquaio(traduzione di Bruno Mazzoni,Nottetempo), lo scrittore romeno evocaipotesi vertiginose, crea mondi in cui glioggetti prendono vita (come nel testo cheintitola il libro), inventa apologhi surreali.Cartarescu emula la gloriosa avanguardiadella Beat Generation e gioca conl’elencazione, con le forme, mettendosi alato della poesia, sospendendola perrivolgersi al lettore, come un Baudelairepostmoderno.
Ispirazione
Traduzione
Maledetto ma non troppoHa via via sporcato, strappato, ingiuria to lasua poesia quanto a temi, figure, ritmi, so-norità, parallelamente a una sua piccolama autentica stagione all’inferno esisten-ziale, e a una specie di sofferto, a tratti an-che compiaciuto autolesionismo che gli hafatto rifiutare qualsiasi orizzonte di pacifi-cazione che non trovasse un riscontro ef-fettivo — di verità — nella sua vita. Eppurequella spinta melodica, quel trascinamen-to ritmico e prosodico fondato anzituttosulle rime, le semi-rime, le assonanze, leriprese sonore, gli enjambement, non è gli
mai venuto meno.Sissa costruisce la sua poesia anzituttograzie all’ipersensibilità dell’orecchio, chepossiede buonissimo. Nella postfazionead Autoritratto, Alberto Bertoni ha parlatocon ragione d’immaginazione acustica. Ilprincipale veicolo di persuasione dei versidi Sissa, molto più che concettuale o filo-sofico, è infatti di natura musicale. I suoipoeti, che talora ha anche tradotto, sononon a caso i simbolisti francesi, primo fratutti Verlaine, e poi Lorca e Machado. Ed è
vero c he un po’ di malede ttismo, di vitaspericolata, o meglio bastonata, di esteticadella sconfitta, come il poeta stesso lachiama, talora può avvertirsi in questi ver-si. Ma è altrettanto vero che nella poesia diSissa c’è sempre qualcosa di non compro-missorio e di senza ritorno che rendeestremamente credibile la sua mitografiapoetica: l’amore, la passione fisica, il bere,la solitudine, l’eterna immaturità, i malan-
ni fisici e psicologici, l’inedia, la polemica
Romania Mircea Cartarescu nasce dalla dissidenza, non politica ma estetica, al regime. E ora è tra i maestri
Un irridente Baudelaire postmoderno, alla faccia di Ceausescudi DANIELE PICCINI
MIRCEA CARTARESCU
Il poema dell’acquaioTraduzione di Bruno Mazzoni
NOTTETEMPOPagine 272, 12
GenerazioneL’autore appartiene a ungruppo di nati negli anni
Sessanta non organizzato:figure che si sono distinte
soltanto col tempo
PercorsoDagli inizi in poi non gli è
mai venuta a mancare unaspinta melodica fondata
sulle rime, le assonanze, leriprese sonore
Stile
Ispirazione
Usando l’ironia, il tono colloquiale, leallusioni (ad esempio al poeta romeno del XIX secolo Eminescu), la sua scritturaattraversa e mima lo «spettacolo delmondo» e tuttavia non rinuncia a guizzi diassolutezza: «Mattine felici accanto alfornello, guardando come le stelle dighiaccio/ lentamente si sciolgono —mattine felici/ quando la neve si posa, siposa, si posa/ fra gli edifici. Oh, Signore/
perché mi offri delle mattine felici? [...]».Nel finale dello stesso testo, il poeta tornapoi al ludus, a spiazzare giocosamente illettore: così sembra dirci che nella suapoesia c’è tutto, anche gli opposti, ancheciò che abbaglia la percezione, sorprende.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 24/48
24 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
Mi sembra una verità universale che il sen-tirsi soli nel proprio tempo sia una con-
dizione che è sempre esistita. Se si sfo-gliano i libri di storia, si vedono grandi enobili spiriti lamentare che, per qualche
ragione, l’epoca in cui vivono non è fatta per loro. Devoammettere che ultimamente anch’io, nel mio piccolo,mi sento sempre più solo nel mio tempo. Sono un gio- vane romanzie re, e dal mio osservator io londinesesento che l’atmosfera letteraria in cui mi trovo, a Lon-dra — ma potrebbe essere Milano, New York o Buenos Aires — è piuttosto falsata o confusa. Sì, la scena lette-raria, nel breve tempo del mio apprendistato, sembraattratta da idee che trovo insoddisfacenti o incomple-te.
Non è una situazione che mi piace: sentirmi estra-niato dalla mia epoca. Quello che voglio fare qui è pre-sentare quindi qualche annotazione sulle mie crescen-ti perplessità, una piccola mappa per riuscire a riorien-tarsi in futuro.
Come cominciare? In questa nostra mini-era, il gu-
sto vigente è focalizzato sulla realtà. La critica sconfinanella sociologia, la narrativa tende all’epica realistica oalle confessioni senza ritegno. Quel che sembriamoprivilegiare è l’inflazione dell’interiorità, sia che il ro-manziere tratti temi di importanza mondiale, sia cheparli di sé. Viviamo in un’epoca in cui, nel mondo lette-rario, è chic dire la cosiddetta verità. Mentre ovviamen-te la fiction è il contrario della verità. Per questo l’eroedella nostra mini-era è probabilmente lo scrittore dimemoriali Karl Ove Knausgård, la cui vena di depres-sione potrebbe esemplificarne i principi: «Il solo pen-siero di scrivere un romanzo, di inventare personaggiin una trama inventata, mi dà la nausea».
Qui sorgono subito dei problemi.Il primo è di natura storica. Nell’estetica che va ora di
moda c’è una sostanziale negazione della storia. Quan-te rivoluzioni delle avanguardie hanno comportatouna retorica del reale! — da quando Cervantes ci haraccontato degli inganni della mente. E hanno soste-nuto la retorica dell’assenza di forma, da quando Lau-rence Sterne, Proust e Gadda hanno contaminato i lororomanzi con le sostanze dissolventi del pensiero saggi-stico. È stata Clarice Lispector, in La Passione secondoG. H., a dare una esemplare definizione di questa svol-ta estetica verso il non-estetico, con la preghiera di«avere il grande coraggio di resistere alla tentazione diinventare una forma»...
Di Lispector consideriamo però anche l’audacia. Nelsuo romanzo c’è un bellissimo passaggio in cui dice:«Ho scritto “ondate di mutismo”, cosa che non avreimai fatto prima, perché ho sempre rispettato la bellez-za e la sua intrinseca moderazione... Ho infine persol’intero impianto del buon gusto? Ma è tutto qui quelche ho guadagnato? Devo aver vissuto così prigioniera
da sentirmi ora più libera solo perché non temo più lamancanza di estetica...».
C’è qui un’ardita saggezza che distingue l’amore diLispector per l’argomento che espone dal gusto allamoda. È sensibile alla complessità filosofica — atteg-giamento visibilmente assente nella melodrammatica«nausea» di Knausgård. Perché la vera obiezione che ilgusto contemporaneo muove alla fiction temo sia eti-ca, non estetica. Possiamo chiamare questo atteggia-mento protestante, filisteo o semplicemente america-no. A seconda della nostra collocazione, possiamo sce-gliere il peggiorativo che ci piace di più... L’errore rima-ne però lo stesso: a) pensare che quel che è fittizio siaimmorale; e b) pensare che il mondo sia così facilmen-te accessibile alla nostra intelligenza.
Provare noia per i soliti romanzi va benissimo! Quel-la di chi si annoia è una posizione nobile e corretta. Mala via d’uscita da queste convenzioni non è credere feli-cemente nella realtà, come se la storia della filosofianon fosse mai stata scritta. Quel che il romanzo richie-de, sempre, è l’opposto del realismo: l’irreale. (Ovvia-mente nulla di tutto questo è una novità. «Faccio Odali-sche per fare il nudo», osservava Matisse, l’imperatoredelle apparenze. «E come fare il nudo senza che sia co-
struito?»)Consideriamo la nostra età in senso più ampio. L’etàdell’informazione elettronica! Sembra brillante ma na-turalmente, come ogni età, ha i suoi demoni oscuri.Perché, mentre nell’età digitale potrebbe sembrare chequalcosa come la realtà sia la valuta corrente, e che ilmondo di Instagram e SnapChat rappresenti l’età del-l’io nudo — l’età del reality show, non della telenovela—, non sono sicuro che questo sia vero. In realtà, sia-mo nella grande era della fiction. Tutti, in fin dei conti,sono ora nel business della costruzione narrativa. E inun periodo del genere, la vera novità nell’arte della fic-tion si annida in travestimenti molto più metaforici.
Perché c’è qualcosa di antiquato nell’idea apparente-mente contemporanea del reale. Che si tratti di roman-zo realistico o di uno sfogo memorialistico, alla basec’è sempre la convinzione modernista che i progressinell’arte della narrativa consistano nell’aumento nellasua comprensività — nell’inclusione di materiale pri-ma trascurato. Il modernismo è stato in parte un gran-de smantellatore di quel che Lispector chiamava l’inte-ro impianto del buon gusto. Ma mentre condivido que-st’impegno verso l’assenza di forma, verso un oggetto ilpiù letterale e comprensivo possibile, non sono peròsicuro che basti — se si auspica un ideale del genere —il puro incremento della tendenza a mettersi a nudo. La vera invenzione consisterebbe nell’ampliare l’ambitodelle tonalità estetiche permesse... Dopo tutto, nuovetonalità si affacciano nell’atmosfera in Technicolor at-torno a noi — in cui il superficiale sforzo di essere affa-bili coesiste con un’espressione di sé molto più profon-da, degradata (i toni volgari, invidiosi, disperati, degliaggiornamenti e dei post dei blog), e questi toni dipen-dono dalla vischiosa mescolanza di distanza e intimità
Libri Pordenonelegge
Bilanci Viviamo una mini-era segnata dalla realtà a tutti i costi,anche in letteratura: per dire, Knausgård ha la nausea al pensierodi scrivere fiction. Ma è con l’invenzione che scopriamo la verità
Il cuore a nudo non bastaBisogna fare gli acrobati
di ADAM THIRLWELL
Lo scrittore Adam Thirlwell ènato nel 1978 a Londra,dove tuttora vive. Il suoromanzo d’esordio, tradottoin trenta Paesi, è Politics (2003) pubblicato in Italiada Guanda come isuccessivi, La fuga (2010) eMademoiselle O (2010). È
membro del «MetaphysicalClub» della Domus Academydi Milano. Un suo librosperimentale non rilegato,Kapow! , edito da VisualEditions nel 2012, è inclusonella collezione permanentedell’Art Institute of Chicago
FilosofiaMi sento solo nel mio tempo. Quel
che si privilegia è l’inflazionedell’interiorità. Nell’estetica che va
ora di moda c’è una sostanzialenegazione della storia
ScelteTutti quanti, in fin dei conti, sono
ora nel business del racconto. E in unperiodo simile, la vera novità si
annida in travestimentimolto più metaforici
EsempioProust ha inventato il più grande
narratore-scrittore mai esistito e unpaesaggio in cui nomi reali e inventati
coesistono. La creazione avvia unatrasformazione fondamentale
Il libroTenero & violento , di Adam
Thirlwell, è edito da Guanda(traduzione di Riccardo Cravero,
pp. 364, 18,50)L’appuntamento
Thirlwell sarà a Pordenoneil 20 (Istituto Vendramini, ore 15)
intervistato da Tullio Avoledo
In una terra di montagne, un libro sulle vette esu un’amicizia tra alpinisti. In occasione delfestival esce il volume In cordata (Rizzoli, pp.252 più un sedicesimo a colori, 18), di MarioCurnis e Simone Moro, due alpinisti di
generazioni diverse che insieme hannoscalato anche l’Everest. Gli scalatori neparleranno domenica 20 allo SpazioITASincontra, in piazza della Motta (ore 15),insieme a Luca Calzolari e Roberto Mantovani.
Amici a 8 mila metri: Simone Moro e Mario Curnis
(

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 25/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 25
divenuta la norma nella piazza digitale. Ma la tonalità,naturalmente, è una mediazione tra lo scrittore e il let-tore. Perciò credo che per gestire correttamente questaestraneità un romanziere debba creare una strutturanarrativa simile alla norma vigente in ambito digitale— dove il molto intimo è contemporaneamente im-personale. L’ideale è produrre nel lettore quel sensoclaustrofobico che tutti riconosciamo grazie alla no-stra esistenza digitale — e per fare questo il romanzie-re dovrà fornire al lettore i mezzi per comprendere co-me è costruito il romanzo. Il lettore deve sentirsi in dia-logo con il narratore assente del romanzo. Abbiamo bi-sogno, in altre parole, di progressi non solo nelcontenuto, ma anche nella struttura narrativa.
Si consideri l’esempio di Marcel Proust. In Alla ricer-ca del tempo perduto, Proust ha inventato il più grandenarratore-scrittore mai esistito — che in un romanzoin cui i confini tra reale e irreale sono estremamentesfocati ha reso possibile non solo produrre la nota am- biguità sul fatto che il narratore si chiami effettivamen-te Marcel, ma anche creare un paesaggio vago, da so-
gno, in cui nomi reali coesistono con quelli inventati, epersonaggi di fantasia sono inseriti in veri dipinti. E laragione per cui Proust ha potuto creare un’atmosferacosì ambigua e strana è che ha esposto e poi sfruttatoin modo tanto giocoso e singolare la costruzione delsuo romanzo. Il suo romanzo è basato sull’esposizionedella struttura. L’aperta ostentazione di quel che è fitti-zio gli permette di condurre i suoi intricati e malinco-nici giochi con il tempo.
Questo è quel che penso. Questo è il quadro del mioisolamento dal mio tempo. Naturalmente, voglioquanta più verità possibile. Ma per me essa può esseregenerata solo da forme abilmente metaforiche. Questaè la sapienza ultramoderna che ho trovato in Proust, ein Tenero & violento, il romanzo che ho scritto in que-sto periodo di crescente isolamento. Voglio pertantoinserire un piccolo omaggio al mio maestro nell’artedella realtà romanzesca: «Ho avuto la visione molto
chiara di un libro in cui avrei registrato la mia espe-rienza totale, sapevo come avrebbe dovuto essere:avrebbe dovuto contenere tutti i toni che nessuno ap-prezza — la Ripugnanza, la Tenerezza, la Povertà, la Volgarità, la Noia, il Disgustoso e il Grazioso. In questetonalità tremende vorrei raccontare la mia storia kawa-ii, senza che vi sia distanza tra me e la persona assente acui parlo. Lo vedo come una cosa continua, una piccolacascata con gorghi e vortici. Perché ho sempre e solo voluto vivere. E la vera vita — e questa non è una miascoperta — la vita che è stata infine scoperta e illumi-nata, e quindi l’unica a esser stata davvero vissuta, èquella che si osserva a ritroso, da qualche punto lonta-no tra le nuvole, e una parola che descrive quel tipo diprospettiva potrebbe forse essere letteratura. O, se nonletteratura, almeno un parlare».
Ecco qui, pensavo, sono un figlio borghese del capi-talismo globale. Ma raccontare la storia della nostragenerazione globale — la mia generazione che vive an-cora in casa, che è allo stesso tempo pura innocenza epura corruzione, puro fascino e pura malizia, che haereditato il processo digressivo e incontenibile del di-
gitale come propria tremenda condizione — richiedemosse narrative acrobatiche. Le confessioni non sonosufficienti. C’è bisogno di una trama potente e folle,piena di sangue e capovolgimenti e, soprattutto, c’è bi-sogno di una costruzione potente e folle, dove il lettoreassente è in dialogo costante con il narratore assente eimplorante...
Perché inventare? Questa è una domanda che tuttigli scrittori devono farsi ogni giorno — ma non credoche la risposta sia rifiutare la categoria della finzione.La risposta è molto semplice. Facciamo dei modelli im-maginari perché in questo modo creiamo delle dina-miche più profonde, più ricche di quelle che potrem-mo scoprire per caso, nel corso della vita quotidiana.Giocando con l’invenzione scopriamo delle verità. O,come ha osservato Roland Barthes in un saggio suStendhal, notando la trasformazione che dai suoi diariporta alla ricchezza dei suoi romanzi, «Quel che è avve-nuto tra i Diari di viaggio e La Certosa di Parma è lascrittura». Il processo della scrittura segna una trasfor-mazione ontologica fondamentale. Stendhal lo sapeva.In una copia di Il rosso e il nero, ora nella BibliotecaSormani di Milano, c’è questa sua annotazione:
«Roma, 24 maggio 1834. Quando ero giovane hoscritto delle biografie (Mozart, Michelangelo), che inun certo senso erano storie. Mi pento di averlo fatto.Credo che nelle piccole come nelle grandi cose sia qua-si impossibile raggiungere la verità — almeno una ve-rità che sia abbastanza attendibile. Monsieur de Tracy soleva dirmi: la verità si può trovare solo nei romanzi.Ogni giorno che passa vedo più chiaramente che altro- ve incontriamo solo ostentazione».
(Traduzione di Maria Sepa)©ADAMTHIRLWELL
Flight , performance degliacrobati australianiStrange Fruits(Roma, 27 luglio 2000)Foto Ap/Gregorio Borgia
In rassegna anche i temi dell’economia, dellafilosofia, della storia. Il 16 settembre ilfilosofo Carlo Sini interviene sull’etica delquotidiano, e in particolare su La lettura comepratica del viver bene allo Spazio Bcc (ore
10.30); il 19 al Palaprovincia, l’economistaRoger Abravanel spiega che La ricreazione èfinita (ore 11); e il 20 si discute di Un buon usopubblico della storia con Ferruccio de Bortolie Ernesto Galli della Loggia (ore 11).
Il punto sul mondo con Abravanel, de Bortoli e Galli della Loggia
(
Dal 16 al 20 settembre con 32 anteprime
Viaggio in Italia, al centro la poesia
Con l’idea di una cultura inclusiva, che possaspaziare dalle discussioni letterarie allecontaminazioni pop, torna per la sedicesima
edizione Pordenonelegge: circa trecento incontri dal 16al 20 settembre nella città friulana intorno al tema Crisivs futuro. Due scrittori francesi tengono a battesimo ilfestival. Sono Daniel Pennac che lo inaugura il 16 edEmmanuel Carrère che riceve il 19 il Premio FriulAdria«La storia in un romanzo»; e poi i ritorni al romanzo di
David Leavitt e della scrittrice Ann-Marie MacDonald,la tunisina Azza Filali e l’iraniana Azar Nafisi, i mondiagli antipodi dell’ucraino Andrej Kurkov edell’argentino Marcelo Figueras: in tutto saranno 32 leanteprime nazionali e internazionali. Numerosi gliautori italiani, ma addirittura un festival nel festivalsarà lo spazio della poesia: tra gli incontri, quelli conFrancesco Targhetta, Franco Buffoni, Claudio Damiani,Antonio Riccardi, e le presentazioni dei nuovi libri diMilo De Angelis o del poeta e traduttore spagnolo JuanCarlos Reche. Una conversazione a tre, guidata da
Eraldo Affinati, farà incontrare la regista FrancescaArchibugi e il protagonista del suo biopic, il poetaPierluigi Cappello, per la presentazione del dvd del filmParole Povere (edito da CG Entertainment). E poi, inarratori: bestseller come Corrado Augias, RobertoVecchioni, Massimo Gramellini e Concita De Gregorioaffiancano nelle giornate dibattiti con scrittori di vagliacome Marco Missiroli e Mauro Covacich, MargheritaOggero e Letizia Muratori. Oltre agli incontri dedicati
alla saggistica di storia, scienza e filosofia, da citare unfilone nuovo, intitolato Viaggio in Italia, alla ricercadell’identità dei diversi territori. Otto scrittoriracconteranno al pubblico aree del Paese che abitanonei loro romanzi: Giuseppe Culicchia, Mauro Corona,Tiziano Scarpa, Sandra Petrignani. Per lecontaminazioni con il cinema, le conversazioni conSilvio Soldini, Ivan Cotroneo e altri sceneggiatori eregisti, e per i giovani scrittori il fight reading a colpidi inediti. (i.b.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Spettacoli, parole e teatro al festival diPordenone: giovedì 17 La resurrezione dellacarne , il recital di Francesco Bianconi deiBaustelle (ore 21.30); il 18 alle ore 15 l’incontrocon la tunisina Azza Filali che conversa con
Camilla Baresani (ore 15). Sabato 19 il readingdel premio Strega 2014 Francesco Piccolo (ore21.30); sempre il 19, al Palaprovincia, il raveletterario Carnediromanzo con NatalinoBalasso e Massimo Cirri (ore 22).
Teatro con Bianconi, reading con Piccolo e il romanzo di Azza Filali
(

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 26/48
26 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
«Millennium», Jo Nesbø e Pedro Chagas Freitas: stranieri al comandoCamilleri è primo negli italiani e papa Francesco insegna a sorridere
La pagella
David LagercrantzQuello che non uccide
Marsilio
di Antonio D’Orricovoto
8
Lagercrantz è bravoquasi come Larsson
F
accio parte dei larssoniani persi (nelsenso dell’autore di Millennium).Sono stato addirittura a Stoccolma aripercorrere le vie battute dai suoieroi. Ho visto la casa di Mikael
Blomkvist e quella di Lisbeth Salander, ilmiglior personaggio della letteratura recente.E ho rimpianto quello che poteva essere enon è stato e, cioè, gli altri sette roman zi cheLarsson aveva immaginato ma non scrittoperché è morto a 50 anni d’infarto nellaredazione del suo giornale (sono stato anchelì). Si disse allora che la sorte di Larsson erasegnata perché aveva fumato troppe sigarette,
bevuto troppi whisky, mangiato troppeschifezze fast food. Sarà. Ma di quella mor teimprovvisa, che spezzò il sogno di Larsson edei suoi 80 milioni di lettori, non ho mai datola colpa allo stile di vita dell’autore bensì aldio capriccioso della letteratura che, come
disse Capote, assieme aldono della scrittura ti dàuno scudiscio con cuifustigarti. In quantolarssoniano perso, nonho guardato di
malocchio, anche soloper far dispetto a queldio crudele, l’idea cheDavid Lagercrantzproseguisse la Trilogia.Lagercrantz è il felice
biografo di ZlatanIbrahimovic, un
personaggio a suo modo larssoniano. Era lapersona giusta. Per come Larsson l’avevacongegnata, Millennium è una macchinanarrativa quasi capace di autoriproduzione.Infatti, dopo qualche cigolio iniziale, ilmeccanismo ha ricominciato a funzionare, ilmondo di Lisbeth e Mikael a girare attorno aitemi epocali della violenza contro i deboli,della corruzione e avidità universali, dellapossibilità orwelliana che i computerdiventino più intelligenti degli umani einstaurino una dittatura da Grandi Fratelli.Lagercrantz è abile come Larsson nellasuspense. Lo è meno in qualche dialogo
eccessivamente didascalico e (pertimidezza?) nell’affrontare il latosentimentale dei personaggi e dei luoghi. Maè stato molto bravo, all’altezza della d ifficileeredità che gli è toccata. Il suo è un piccolomiracolo.
© RIPRODUZIONERISERVATA
David Lagercrantz, 53anni (foto Karlsson)
Top 10
David LagercrantzQuello chenon uccideMarsilio, € 22
Paula HawkinsLa ragazza del treno Piemme, € 19,50
E. L. James
Grey Mondadori, € 19
John GreenCittà di carta
Rizzoli, € 16
Anna ToddAfter
Sperling & Kupfer, € 14,90
Jo NesbøScarafaggi
Einaudi, € 20
Andrea CamilleriLa targa
Rizzoli, € 10
Anna ToddUn cuorein mille pezzi. AfterSperling & Kupfer, € 17,90
Pedro Chagas FreitasPrometto disbagliareGarzanti, € 16,90
Marcello SimoniL’abbaziadei cento delitti Newton Compton, € 9,90
1(3)
1 100
2(1)
5 88
4(5)
1 43
5(4)
5 40
7(-)
N 36
9(-)
N 30
10(8)
5 28
8(6)
5 34
6(-)
N 39
3(2)
5 50
ebookdi Alessia Rastelli
L’Antartidedel 1999gela i rivaliLe novità (senza l’aiutodelle promozioni)dominano nella classifica
digitale. Conquistano lavetta settimanale leavventure in una grottadell’Antartide narrate daJames Rollins ne La città dighiaccio , romanzo uscitonel 1999 negli Stati Uniti epubblicato per la primavolta in Italia a fine agosto.L’edizione elettronica è alprimo posto su Net-eBook,libreria del sitoMediaworld.it. Seguonogialli, thriller e storiesentimentali, che siconfermano tra i generi piùletti su ereader e tablet. Inseconda posizione Quelloche non uccide , quartovolume della serieMillennium, firmato da
David Lagercrantz, neldifficile ruolo di non farrimpiangere Stieg Larsson.Al terzo posto Una famigliaquasi perfetta, debuttoletterario del medicobritannico Jane Shemiltsulla scomparsa di unaquindicenne che sconvolgela vita della madre. Quarto,Pericolose tentazionidell’americana Lora Leigh,in cui l’indagine su unomicidio si mescola con lapassione tra un agente eun’affascinante testimone.Chiude in quinta posizioneJø Nesbo con Scarafaggi ,secondo romanzo dellaserie con protagonista ilpoliziotto Harry Hole, uscito
in Italia due settimane fa.Questa volta l’inchiesta sisvolge a Bangkok eriguarda la morte di undiplomatico norvegese.
@al_rastelli© RIPRODUZIONE RISERVATA
1 100 James RollinsLa città di ghiaccio
Nord, 8,99ePub con Adobe Drm
2 81 David LagercrantzQuello che non uccide
Marsilio, 13,99ePub con Adobe Drm
3 72 Jane ShemiltUna famiglia quasi...
Newton Compton, 2,99
ePub con Social Drm4 63 Lora Leigh
Pericolose tentazioniMondadori, 3,99
ePub senza Drm
5 54 Jo NesbøScarafaggi
Einaudi, 9,99ePub con Adobe Drm
(31 agosto-6 settembre 2015)
La classifica
Narrativa italiana
1(6)1 36Andrea CamilleriLa targa
Rizzoli, € 10
2 (2) S 28Marcello SimoniL’abbaziadei cento delitti
Newton Compton, € 9,90
3 (1)5 28Antonio ManziniEra di maggio
Sellerio, € 14
Andrea Camilleri è primo nella classifica di categoriacon un racconto già uscito con il «Corriere» e propostooggi da Rizzoli in una nuova edizione. Si dimezza lapresenza italiana in top 10: oltre a Camilleri (settimo)resiste il giallista Marcello Simoni, decimo. NegliItaliani scala sette posti il romanzo d’avventura diMarco Buticchi che mescola leggenda e attualità.
Narrativa straniera
1(3)1 100David LagercrantzQuello che non uccide
Marsilio, € 22
2 (1)5 88Paula HawkinsLa ragazzadel treno
Piemme, € 19,50
3 (2)5 50E. L. JamesGrey
Mondadori, € 19
La top ten parla straniero (otto titoli su dieci) e haun nuovo re: è David Lagercrantz che con il quartoatto della saga Millennium scavalca il thriller diPaula Hawkins e l’eros di J. L. James; è in salita ilromanzo Città di carta, storia di adolescenti in fugadiventato ora film. Due new entry : il norvegese JoNesbø e il portoghese Pedro Chagas Freitas.
Saggistica
1(1) S 17Carlo RovelliSette brevi lezionidi fisica
Adelphi, € 10
2 (-) N 12Oriana FallaciLe radicidell’odio
Rizzoli, € 20
3 (-) N 11Oliver W. SacksL’uomo chescambiò sua moglieper un cappelloAdelphi, € 11
Il podio si rinnova per due terzi. Il leader resta il fisicoCarlo Rovelli, dietro arrivano due novità: Oriana Fallacicon una raccolta di articoli dedicati all’islam; e ilcelebre neurologo appena scomparso Olivier W. Sackscon una delle sue opere più note. Tra le new entryanche papa Francesco, su fede e allegria, e la«biologia quantistica» di Al-Khalili e McFadden.
Varia
1(1) S 21
Marie KondoIl magico poteredel riordino
Vallardi, € 13,90
2 (2) S 15Giulia EndersL’intestino felice
Sonzogno, € 16,50
Ragazzi
1
(-) N 12AA.VV.Minions.La storiaFabbri, € 8,50
2 (4)1 10AA.VV.Minions.Megasticker
Fabbri, € 10,90
{Libri Le classificheLegenda
(2) posizione precedente S stabile
1 in salita R rientro
5 in discesa N novità
100 titolo più venduto (gli altri in proporzione)
3 Louise PennyThe Nature of TheBeast
Minotaur, $ 27
2Harper LeeGo set aWatchman
Harper, $ 28.99
1Sue Grafton X
Marian Wood/Putnam, $ 28.95
Stati Uniti
A parità di percen-tuale di vendita, laposizione è deter-minata dal valoredecimale non in-dicato in classifica

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 27/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 27
4 (4) S 23Elena FerranteL’amica geniale
e/o, € 18
5 (3)5 22Andrea CamilleriLa giostradegli scambi
Sellerio, € 14
6 (16)1 17Maurizio MaggianiIl Romanzodella Nazione
Feltrinelli, € 17
7 (5)517Nicola LagioiaLa ferocia
Einaudi, € 19,50
8 (14)1 15Marco ButicchiIl segnodell’aquila Longanesi, € 18,60
9 (10)1 15Elena FerranteStoria del nuovocognome e/o, € 19,50
10 (11)1 14Elena FerranteStoria di chi fuggee di chi resta
e/o, € 19,50
11 (12)1 13Elena FerranteStoria dellabambina perduta
e/o, € 19,50
12 (9)5 13Concita De GregorioMi sa che fuoriè primavera
Feltrinelli, € 13
13 (8)5 13Giorgio FalettiLa piuma
Baldini & Castoldi, € 13
14 (7)5 11AA. VV.Turisti in giallo
Sellerio, € 14
15 (15) S 10Maurizio de GiovanniAnime di vetro
Einaudi, € 19
16 (-) R 10Silvia ZuccaGuida astrologicaper cuori infranti
Nord, € 16,40
17 (-) N 10Claudia SerranoMai più così vicina
Giunti, € 12
18 (17)5 10Sveva Casati ModignaniLa vignadi Angelica
Sperling & Kupfer, € 19,90
19 (13)5 9Luca BianchiniDimmi che credial destino
Mondadori, € 17
20 (19)5 8M. GramelliniC. GamberaleAvrò cura di te
Longanesi, € 16
4 (5)1 43John GreenCittà di carta
Rizzoli, € 16
5 (4)5 40Anna ToddAfter
Sperling & Kupfer, € 14,90
6 (-) N 39Jo NesbøScarafaggi
Einaudi, € 20
7 (6)5 34Anna ToddAfter 2. Un cuorein mille pezzi
Sperling & Kupfer, € 17,90
8 (7)5 30Pedro Chagas FreitasPromettodi sbagliare
Garzanti, € 16,90
9 (18)1 14James RollinsLa cittàdi ghiaccio
Nord, € 13,90
10 (8)5 13Fred VargasTempi glaciali
Einaudi, € 20
11 (-) N 13Nicolas BarreauParigi è sempreuna buona idea
Feltrinelli, € 15
12 (9)5 12Lucinda RileyL’angelodi Marchmont Hall
Giunti, € 11,90
13 (11)5 11Jamie McGuireUno splendidodisastro
Garzanti, € 9,90
14 (-) N 10James DashnerLa fuga.Maze Runner
Fanucci, € 14,90
15 (10)59E. L. JamesCinquantasfumaturedi grigioMondadori, € 10
16 (12)5 9E. L. JamesCinquantasfumaturedi rosso
Mondadori, € 10
17 (14)5 9Jane ShemiltUna famigliaquasi perfetta
Newton Compton, € 9,90
18 (13)5 9E. L. JamesCinquantasfumaturedi nero
Mondadori, € 10
19 (16)5 8Markus ZusakStoria di unaladra di libri
Frassinelli, € 16,90
20 (17)5 8Glenn CooperDannati
Tea, € 5
4 (-) N 7Gabriele RomagnoliSolo bagaglioa mano
Feltrinelli, € 10
5 (2)5 6Eugenio BorgnaParlarsi.La comunicazioneperdutaEinaudi, € 11
6 (5)5 6Massimo RecalcatiLe manidella madre
Feltrinelli, € 16
7 (3)5 5Papa FrancescoLaudato si’
San Paolo, € 5,90
8 (11)1 5Giuseppe ClozaFelicitàin questo mondo
Soka Gakkai, € 2,75
9 (4)5 4Malala Yousafzai(con C. Lamb)Io sono Malala
Garzanti, € 12,90
10 (8)5 4Papa FrancescoLaudato si’
San Paolo, € 2,50
11 (-) N 4J. Al-KhaliliJ. McFaddenLa fisica della vita
Bollati Boringhieri, € 24
12 (-) N 4Papa FrancescoDio ride.Umorismo e gioianella fedePiemme, € 15
13 (-) N 3Vittorio SabadinElisabettal’ultima regina
Utet, € 16
14 (10)5 3Clarissa Pinkola EstésDonne checorrono coi lupi
Frassinelli, € 14
15 (7)5 3Aldo CazzulloPossa il miosangue servire Rizzoli, € 19
16 (-) N 3Hannah ArendtSocrate
Raffaello Cortina, € 11
17 (6)5 3Tiziano TerzaniUn indovinomi disse
Tea, € 5
18 (9)5 3Papa FrancescoLaudato si’
Edb, € 2
19 (-) N 3Jon KrakauerAria sottile
Corbaccio, € 19,90
20 (13)5 3Papa FrancescoLaudato si’
Piemme, € 9
3 (6)1 10P. Mozzi, M. MozziL. ZiglioLa dietadel dottor MozziCoop Mogliazze, € 19
4 (4) S 6Andre AgassiOpen.La mia storia
Einaudi, € 14
5 (7)1 5FavijSotto le cuffie
Mondadori Electa, € 12,90
6 (-) N 5E. Mozzi, G. NegriLe ricettedel dottor Mozzi.Mangiare con gusto...Coop Mogliazze, € 17
7 (9)14Marco BianchiIo mi voglio bene
Mondadori , € 18,50
8 (-) R 4Daniele NovaraUrlarenon serve a nulla
Bur, € 13
9 (-) R 4Benedetta ParodiMolto bene
Rizzoli, € 9,90
10 (-) R 4E. Mozzi, G. NegriLe ricettedel dottor Mozzi Coop. Mogliazze, € 17
3 (7)19AA.VV.Minions.Il libro gioco
Fabbri, € 8,90
4 (-) R 8R. J. PalacioWonder
Giunti, € 9,90
5 (6)1 8AA.VV.Quadrottino.Paw Patrol
Edibimbi, € 3,50
6 (1)5 8AA.VV. Frozen.Con adesivi
Disney, € 3,50
7 (-) N 8AA.VV. Inside out
Disney, € 6,90
8 (-) R 7R. J. PalacioIl libro di Julian.A Wonder Story
Giunti, € 7,90
9 (-) R 7AA.VV.Una squadraspeciale.Paw PatrolEdibimbi, € 4,90
10 (-) R 7J. K. Rowling Harry Potter e lapietra filosofale
Salani, € 10
07 0Città e cibi, pozzi e passeggiate: una guida alle guide turistiche
Visto il positivo andamento dell’annata turistica in Italia el’imponente afflusso di visitatori a Milano per l’Expo, sisuppone che anche qualche guida turistica in più sia statavenduta. Sulle oltre 700 guide uscite tra maggio e agosto2015, almeno la metà sono dedicate a città e località
italiane, e si può notare che sono sempre più dettagliate especializzate (guida ai luoghi salesiani, mappa dei saporinelle aree protette liguri, le più belle passeggiate nellecolline torinesi, fonti e pozzi sacri della Sardegna, ecc.);126 di questi titoli coprono Milano in tutti i suoi aspetti
storico-culturali e commerciali, ed è facile prevedere chetra poco anche su Roma, con il Giubileo straordinario, siregistreranno per le guide turistiche sviluppi interessanti.Già in questi mesi sono stati pubblicati 112 titoli e sisuppone che nei prossimi raddoppieranno.
di Giuliano ViginiIl numero
(Elaborazione a cura di GfK. Dati relativi alla settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2015)
Il podio del criticodi Cristiano Cupelli
Cristiano Cupelli (Roma, 1973) è ricercatore di dirittopenale all’Università di Roma Tor Vergata e docente diDiritto penale delle scienze mediche presso la Luiss; èautore di pubblicazioni, tra le quali le monografie, editeda Edizioni Scientifiche Italiane, La responsabilità penaledello psichiatra (2013) e La legalità delegata (2012).
Inghilterra
1Terry PratchettThe Shepherd’sCrown
Doubleday Childrens, £ 20
2Jeffrey ArcherMightier Thanthe Sword
Pan, £ 7.99
3Jamie OliverEverydaysuper food
Michael Joseph, £26
Germania
1D. LagercrantzS. LarssonVerschwörung
Heyne, € 22,99
2Dörte HansenAtles Land
Knaus, € 19,99
3Günter GrassVonne Endlichkait
Steidl, € 28
Francia
1David LagercrantzMillénium 4 - Cequi ne me tue pas
Actes Sud, € 23
2Giulia EndersLe charme discretde l’intestin
Actes Sud, € 21,80
3AA.VVLarousse de poche
Larousse, € 7,90
1Daniele GiglioliCritica della vittima
Nottetempo, € 12
2Martin SuterAllmen e le libellule
Sellerio, € 13
3Giuseppe AmarelliLiquirizia
Rubbettino, € 10

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 28/48
28 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
CANTIERI
di GIANLUCA PELUFFO
L’idea di partenza per la nuova sededell’Autorità portuale di Savona è quelladi un edificio come essere vivente: il
viaggio, lo sguardo, il movimento degli occhisono le «azioni» che l’«edificio corpo» mettein atto. Così la sua «forma» è quella di unapersona accovacciata, che tiene le gambepiegate e gira lo sguardo a 360 gradi, a Nord,Est, Ovest, Sud. La composizione è quindi undialogo fra un elemento orizzontale (il ponte
sopra la ferrovia portuale, che ospita
l’ingresso al pubblico, la sala convegni e tutti iservizi comuni) e i due elementi verticali,l’appoggio a terra (l’ingresso al di qua delvarco doganale) e la torre (al di là del varco),23 metri x 23 di lato, che ospita gli uffici.Questa posizione, a cavallo fra città (urbanità)e porto (un altrove ), è la chiave espressivadell’edificio come passaggio e connessionefra i due territori, fisici e amministrativi. Latorre presenta a ognuno dei quattro lati degli
ultimi quattro piani uno sbalzo, che contiene
le sale riunioni: la «concretizzazione» dellostesso sguardo del viaggiatore verso tutte ledirezioni possibili. Il linguaggio si esprimeattraverso una composizione geometricasemplice: container rivestiti di una pellemetallica cangiante, nei colori del verde, blu eargento. Non una scelta di rarefazione, ma diricchezza espressiva legata all’incidenza dellaluce nel giorno e nelle stagioni, o rispetto almovimento dello sguardo. Anche in questocaso, si è cercato di interpretare il ruolodell’edificio pubblico come «monumentocontemporaneo», capace di «rappresentare»un’istituzione o un’Autorità e di assumere sudi sé il compito di connettere il cittadino alleistituzioni. L’edificio, dopo quattro anni dicantiere, sarà inaugurato nel corso del 2016.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Per Savona un simbolo dello Statoin bilico tra la città e il porto
Il 29 agosto scorso Michael Jackson avrebbespento cinquantasette candeline. The King ofPop, leggenda mai dimenticata, ci ha lasciatosei anni fa mentre si trovava a Los Angeles perun concerto. Nella stessa città gli rende oraomaggio il murale di Owen Dippie. Lo streetartist neozelandese lo ha ritratto soffermandosisu un dettaglio del vi so: inconfondibili, in mezzoagli occhi, i ricci scuri che si muovevano al ritmodi Thriller e Billie Jean.
Gli occhi di Michael Jackson
{Sulla stradadi Davide Francioli
Sguardi.
Pittura, scultura, fotografia, design, mercato
Studio 5+1AA (AlfonsoFemia e Gianluca Peluffo),
Autorità portuale di Savona
S i comincia dalle Alpi, Il ponte del diavolo diCaspar Wolf (1777), un orrido, il torrente fra lerocce, l’arco sospeso sulla schiuma delle ac-que. Goethe, nel Viaggio in Italia, parlando diquelle cime, scrive: «Noi le crediamo morte
per la loro fissità, le crediamo inoperose a causa del lo-ro vago stato di quiete. Ma già da tempo non riesco adastenermi dall’attribuire la maggior parte dei muta-menti che si producono nell’atmosfera a una forza inte-riore che tacitamente, occultamente emana da esse».Ecco il mistero, ecco il sublime, ecco una chiave possi- bile per leggere il viaggio che è anche cammino, sco-
perta, conoscenza. Perché questo è stato sempre il viaggio al Sud, viaggio di formazione; lo è stato per ilnarratori, per i pittori, i poeti, gli studiosi della natura;di questo è ben consapevole Marco Franciolli che, nelcatalogo della mostra Orizzonte Nord-Sud (di cui è cu-ratore con Guido Comis) al Lac di Lugano appena inau-gurato, del viaggio coglie la dimensione europea.
Dalle terre del settentrione dunque si viaggia versol’Italia, i pittori per formarsi sull’arte antica e sul Rina-scimento, ma, nel caso dei narratori, per scoprire forsealtro, il negativo, il demoniaco, come Horace Walpolene Il castello di Otranto(1764) che inizia il romanzo go-tico. Del demoniaco, dunque, cercheremo le tracceproprio nelle opere in mostra, che è costruita accostan-do artisti a Nord e Sud delle Alpi. Wolf si confronta conGiovan Battista Piranesi che scava nell’antico come ro- vina e, insieme, memoria del tempo. Poi ecco un viag-gio diverso, quello di Turner con le sue trascolorantiluci delle valli e dei monti, visione sospesa che evoca lapittura di Hubert Robert e quella dei vedutisti venezia-ni, a cominciare da Francesco Guardi. Quindi ecco ilconfronto fra Arnold Böcklin e Giorgio de Chirico, da
un’ossessione di morte che forse muove da Nietzsche,e Ferdinand Hodler attento al Rinascimento italianoma più ancora a Courbet e a Rodin; dunque L’ora sa-cra (1911) dipinta dallo svizzero è densa di angoscia co-me i quadri con l’amata Valentine sul letto di morte. Un altro momento significativo della mostra è il con-fronto fra Medardo Rosso e Giovanni Segantini: le fi-gure di Medardo appaiono come attraverso un velo, dicera, marmo o bronzo non importa, forme che si di-
sfano nel dialogo con Ro-din e con Degas; dall’altrauna visione nuova dellamontagna e del lavoro,un rifiuto della città e lo
spazio della Engadina ri-pensato attraverso Millete Pissarro.
Con Felix Vallotton eFelice Casorati si con-frontano due culture: Vallotton formato a Pari-gi, Casorati attento alleSecessioni, il primo cheisola le figure nel segnodi una raffinata, tradizio-nale scrittura pittorica, ilsecondo che sceglie il vuoto, l’assenza, come neLa donna e l’armatura(1921). In mostra ancorala analitica descrizionedegli oggetti del pittoreottocentesco Albert Anker e le sublimi, archi-tettate nature morte diGiorgio Morandi. Quindilo spazio futurista di Gia-como Balla e le immaginigiocose di Fortunato De-pero; ma forse, di Balla, sipotevano proporre le im-magini realiste degli ini-zi, documenti civili legatialla fotografia. Poi eccoun blocco di importantiopere di Sophie Taeuber- Arp formatasi a Monaco,attenta alla musica, alla
Il dialogo a distanza tra artisti di epoche diverse in unadelle quattro mostre che celebrano l’inaugurazione del Lac
di ARTURO CARLO QUINTAVALLE
Gli appuntamentiSi è inaugurato ieri a Lugano
il Lac, il nuovo centro culturaleprogettato dall’architetto Ivano
Gianola e dedicato alle artivisive, alla musica e alle arti
sceniche (Piazza BernardinoLuini 6, CH-6901 Lugano).
L’inaugurazione si svilupperàper altri due fine settimanafino al 26 settembre con un
programma che prevede (tral’altro) lo spettacolo teatrale
La Verità della Compagnia FinziPasca, che avrà come sipario
la grande tela Tristano e Isotta di Salvador Dalí.
Le quattro mostreLe mostre inaugurate ieri al
Lac (Info Tel +41 58 866 4200;www.luganolac.ch) sono
quattro: Orizzonte Nord-Sud Protagonisti dell’arte europea ai
due versanti delle Alpi 1840-1940 (fino al 10/01/2016); In
Ticino. Presenze d’arte nella Svizzera italiana 1840-1960
(fino al 28/02/2016); lapersonale dedicata a Andy
McCall (fino al 30/01/2016);Teatro di Mnemosine di GiulioPaolini (fino al 10/01/2016)
Le immaginiA destra: Caspar Wolf
(1735-1783), Il Ponte del Diavolo (1777). Al centro:
Giorgio de Chirico (1888-1978), Lotta di Centauri (1909).
In alto: Sophie Taeuber-Arp(1889-1943), Personaggi,
animali e anfore (1926)
i
In viaggio attraverso le Alpi
Lugano scruta i due versantiuna parte Lotta di centauri (1872), forme sfatte nel se-gno di Rubens, dall’altra Lotte di centauri (1909) dove ilmodello si trasforma, cupe figure sotto un cielo corru-sco; così ecco l’antico contemplato di Böcklin di fronteall’angoscia del Centauro morente del pittore di Volos,dove il corpo si fa roccia spezzata sotto il cielo azzurro.
Dello stesso segno il confronto fra Adolf Wildt eFerdinand Hodler: Wildt legato alle Secessione vien-nese, a Koloman Moser e a Egon Schiele, che racconta
Nord e Sud sulla via del lago
Faccia a facciaCaspar Wolf , con il suo orrido
montano, trova echi in Piranesi,come Turner sta in consonanza con le vedute veneziane di Guardi.E ancora:
Adolf Wildt e Ferdinand Hodler

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 29/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 29
Nemmeno l’allestimento al limite del mini-malismo (panneggi neri, scritte e pannellisemplicissimi ma comunque ben com-prensibili) riesce a mortificare una mostrasorprendente come quella che il Palazzo
Mosca di Pesaro dedica a Pasquale De Antonis (1908-2001), «fotografo di dive, dee, di mostri sacri», come loaveva definito il poeta Leonardo Sinisgalli. Personag-gio forse non notissimo al gra nde pubblico ma profes-sionista eccellente, De Antonis è stato autore tra glianni Quaranta e i Cinquanta di immagini cult come laPaolina Borghese del Canova impellicciata: impellic-ciata in senso letterale, perché nella Galleria Borghesedi Roma alla statua fu fatta indossare una sontuosa
cappa di volpe bianca firmata Balzani. O come l’Erma- frodita dormiente con i sandali (stesso procedimento).O, ancora, come la top model americana Ivy Nicholson(la musa di Andy Warhol che qualche tempo più tardisarebbe diventata una homeless) abbracciata a unsarcofago etrusco nel Museo di Villa Giulia.
Il fascino del progetto fotografico messo in piedi daDe Antonis sta nella sua complessità o, meglio, nellasua voglia di contaminazione. Perché le sue immagini,perlopiù in bianco e nero, nascono dalla volontà diriunire due elementi fondamentali dell’identità italia-na: la moda (quella degli atelier romani, da Schubert aGattinoni, da Capucci a Simonetta Visconti) e l’arteclassica (quella che delle antiche rovine, dal Mausoleodi Cecilia Metella alle Terme di Diocleziano, davan tialle quali le modelle si mettono in posa ).
C’è di più. Tutto questo accadeva in un preciso con-testo storico, quel dopoguerra che vedeva il nostroPaese protagonista di un’eccezionale rinascita stilisticae imprenditoriale. De Antonis racconta dunque un’Ita-lia che si modernizza ma che non dimentica la propriastoria. A cominciare dalla provincia piena di curiositàe voglia di nuovo. Perché Pasquale nasce a Teramo escatta le prime istantanee al Campanile del «suo»Duomo, apre il primo studio nel 19 34 a Pescara, dove siera trasferito per seguire l’azienda di famiglia e doveconoscerà Ennio Flaiano, e soltanto più tardi scapperàa Roma per frequentare il Centro sperimentale di cine-matografia. E sarà proprio a Roma che inizierà la colla-
borazione e l’amicizia con Irene Brin, giornalista escrittrice che lo avrebbe convinto a intraprendere lacarriera di fotografo. La Brin era la proprietaria dellafamosa Galleria Obelisco, in via Sistina 146, e grazie alei Pasquale sarebbe entrato nel «gruppo» del Caffè
Greco (dal compositore Goffredo Petrassi allo scrittoreCarlo Levi). Inizierà a lavorare come fotografo di scenae conoscerà Visconti, Strehler, Squarzina, Zeffirelli;ritrarrà Silvana Mangano, Sibilla Aleramo, GiannaManzini, Gina Lollobrigida. Diventerà insomma il«fotografo di dive, dee, di mostri sacri».
Una sezione particolare della mostra curata dal fi-glio Riccardo (anche lui fotografo) e da Giorgio Bra -mante Donini è poi dedicata ai ritratti che richiamanoidealmente la grande tradizione della pittura italiana,del Rinascimento e soprattutto del barocco (la donnacon la faccia rossa, il ritratto della figlia di Marinetti alTempio della Fortuna Virile, i posati sull’Appia Anti-ca). Ma anche stavolta De Antonis non è «un semplice
pittorialista» ma un fotografo tout court, assillato (die-tro un’apparenza placida da professore) dalla voglia dicambiare linguaggi e soggetti. Per questo inizier à ilproprio percorso fotografando i ricchi borghesi pesca-resi per poi realizzare gli scatti delle feste popolaridella sua terra, diventando uno dei pi onieri della foto-grafia etnografica italiana. Mentre, dopo la moda el’arte antica, concluderà idealmente il suo tragittosotto il segno dell’avanguardia: con gli scatti dedicatialla sfilata-performance alla Galleria Gavina, in occa-sione della prima romana del film di Stanley Kubrick2001 Odissea nello spazio, dove si vede l’avveniristicalinea Alluminio di Germana Marucelli. Immagini chesembrano lontanissime anni luce dai ritratti stilosidella Brin alla Galleria Obelisco o dalla atmosfera fata-ta, fatta di tramonti, di rovine, di basiliche, di musei,di gallerie d’arte che dialogano con gli abiti: i Giardinidella Farnesina per un vestito di Carosa, lo studio diConsagra per uno di Myricae. Ma grazie alla sua gran-dissima padronanza tecnica e alla sua sensibilità «puòcon spirito divertito permettersi citazioni dell’universopittorico».
Ultimo consiglio. Palazzo Mosca, oltre alla mostra diDe Antonis, ospita nella sua prima sala uno dei capola-
vori del Rinascimento italiano: la Pala dell’Incorona-zione della Vergine (1475) di Giovanni B ellini. Vale unasosta. Peraltro compresa nel prezzo del biglietto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riscoperte Antichità, moda, cinema: Pesaro ripropone Pasquale De Antonis, fotografo geniale
Sembra Venere in pelliccia
È Paolina Borghese: allora clic!dal nostro inviato a Pesaro STEFANO BUCCI
L’appuntamentoPasquale De Antonis
La fotografia di moda ,Pesaro, Palazzo Mosca /
Musei Civici,a cura di Giorgio
Bramante Doninie Riccardo De Antonis,
fino al 31 ottobre 2015(Info Tel 199 151 123;www.pesaromusei.it),
Catalogo Grapho 5,Fano (pp. 128, 15)
Il personaggioPasquale De Antonis
(Teramo, 1908-Roma, 2001) apre il suoprimo studio nel 1934 a
Pescara. Nel 1936si trasferisce a Roma
per studiare al Centrosperimentale dicinematografia.
Negli anni Quaranta,inizia a frequentare il gruppo
di intellettuali e artistiche faceva capo
al Caffè Greco, realizzandoservizi fotografici dedicati
in particolare alla moda,al cinema, al teatro,
alle gallerie, ai musei
idanza, al teatro al tempo di Dada-Zurigo fra 1916 e1919: marionette per Il re cervo (1918) e progetti grafici,texture astratte del secondo decennio importanti an-che per comprendere le ricerche a venire dellaBauhaus. E poi un dialogo finalmente diretto, quellofra Max Bill e Luigi Veronesi, sulla ricerca di un’arte as-soluta, non legata alla rappresentazione ma alla mate-matica e all’armonia musicale.
Nodo della rassegna, senza confronto a Sud delle Alpi, è il gruppo delle opere di Paul Klee; il pittore, for-matosi a Monaco, attento alle Secessioni, ma anche, eper un breve momento, al Futurismo, racconta di aver scoperto il colore nel corso del viaggio in Tunisia(1914), ma in realtà il colore lo scopre a Parigi nel 1912
vedendo le pitture di Robert Delaunay.
Ecco, in mostra, Luna piena fra le mura (1919) at-tenta anche alla scomposizione del Cubismo analiti-co, e poi Rosso-violetto x giallo-verde graduato (1922)dove i toni dei colori si scalano fra i segni della pirami-de, del quadrato e lo spazio misurato della cit tà. Anco-ra, il pittore, in Paesaggio (1932), propone una dimen-sione evocativa dello spazio: tracce di monti, della cit-tà, di una casa con finestre, le forme scomposte dauna vibrante serie di tocchi. Ma il mito del viaggio alSud, i colori, le luci, nel corso degli anni Trenta si tra-sformano in segni di angoscia: l’artista, malato, sentel’approssimarsi della fine, ed ecco apparire un segnonero come in Senza titolo (1940) dove le case diventa-no scomposti frammenti, mentre in altri dipinti appa-re le forma di un volto, presenza ossessiva accanto al-l’artista, come nel caso di Doppio (1940). Dunque il viaggio al sud non è solo gioia, scoperta, ma anche an-goscia di morte, come nel romanzo gotico. L’ultimoconfronto è fra Alberto Giacometti e Lucio Fontana, ipassi lunghi de L’uomo che cammina (1960) del primoe il gesto che segna i Concetti spaziali del secondo:due modi per rappresentare l’alienazione.
Se si legge il viaggio al sud nel segno di EdmundBurke e del suo trattato sul Sublime (1751), come sug-gerisce Guido Comis, si ha forse la chiave per com-prendere il senso della mostra: viaggio al sud dunquecome scoperta dell’antico, del colore, di un’altra luce,certo, ma anche di quello spazio corrusco del «natu-rale» dove si incontra il divino.
© RIPRODUZIONERISERVATA
A fianco: l’americanaIvy Nicholson, unadelle prime top modele musa di Andy Warhol,accanto a un sarcofagoetrusco in una saladel Museo Nazionaledi Villa Giulia (Roma,1956, vestito Gattinoni,gioielli Luciana DeReutern). Sotto:la Paolina Borghese di Antonio Canova allaGalleria Borghese (Roma,1947, vestito Balzani).Nella foto grande: Ala
Marinetti, secondogenitadel poeta e scrittorefuturista FilippoTommaso Marinetti,fotografata da PasqualeDe Antonis al Tempiodella Fortuna Virile(Roma, 1949, vestitoSimonetta Visconti)
Allestimento
Rigore scientifico
Catalogo

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 30/48
30 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
La danza parla francese: le posizioni delcorpo, combinate con i passi, formano uninfinito elenco di termini. Ad aiutare le giovaniballerine interviene Elisabetta SimeonsBongi, con un vero e proprio dizionario della
danza. Il libro analizza ogni passo con schededettagliate e sequenze di disegni stilizzati echiari, ben lontani dai soliti bozzetti tecnici(Passi di danza. Dizionario illustrato delballetto , Cult Editore, pp. 200, 10).
Danza a capitoletti
{Sguardi DiscussioniIn punta di piedi
di Giovanna Scalzo
Due città mediterranee, due diverse visioni della creatività e del suo compito nella società contemporaneaLa Biennale evoca ideologie del passato mentre nella capitale greca prevale la partecipazione civica
Venezia eAtene, c’è di mezzo il mare
Confronti
di ROBERT STORR
S iedo in riva a un lago in mezzo ai boschi norda-mericani, dopo aver trascorso mesi molto inten-si facendo il giro dell’Europa. In questo viaggio,mi son guardato dal seguire gli itinerari migra-tori del «mondo dell’arte», ovvero ho saltato la
Fiera dell’Arte di Basilea così come il bagno di folla allaBiennale di Venezia nei giorni di apertura. È la prima vol-ta in tanti anni che manco a quest’ultima. Una serie difattori ha contribuito alla mia decisione di aspettare a vi-sitare la manifestazione finché il contingente «professio-nale» non si fosse disperso: in particolare, il desiderio dievitare di dover assistere alla farsa del direttore dell’edi-zione di quest’anno, Okwui Enwezor, che fa finta di di-sprezzare lo spettacolo di cui è stato protagonista.
Non si era mai vista prima la retorica di un direttorecosì palesemente in contraddizione con la realtà dellamostra che questo presiede. A voler credere alle sue di-chiarazioni pubbliche, Enwezor non ha assolutamenteniente a che fare con i collezionisti, i mercanti d’arte el’atmosfera carnevalesca delle mostre internazionali,sebbene nessun curatore attivo abbia organizzato cosìtante manifestazioni o servito volentieri altrettanti pa-droni istituzionali. Infatti, se dovessimo prenderlo allalettera, Enwezor sarebbe l’erede diretto dei combattentiper la libertà post-coloniali della metà del XX secolo, macon abiti eleganti su misura più che traumi di guerra.Inoltre, vorrebbe farci credere di essere il difensore dellecomunità emarginate contro il pensiero dominante, deideboli contro i forti, sebbene, in modo imbarazzante,non abbia apparentemente niente da ridire sull’improv-
visa c hiusura, da parte dell’amministraz ione vene ziana,del progetto della moschea realizzata in una chiesa scon-sacrata ad opera dell’artista svizzero Christoph Büchel.
Né ha onorato l’impegno preso nei confronti del col-lettivo anonimo di cineasti siriani «Abounaddara» di
presentare la loro satira amara su Bashar Assad in modotale da raggiungere realmente un pubblico, censurando-li quindi efficacemente. Quando gli artisti hanno prote-stato, Enwezor li ha insultati, come è solito fare quando èmesso in discussione. In breve, è difficile trovare qualcu-no più abile e di successo nel trarre vantaggio dal mondodell’arte agendo da mediatore e, al contempo, atteggian-dosi a rivoluzionario. Eppure, è evidente che i poteri fortidel mondo dell’arte fra le maschere contraddittorie diEnwezor (dell’abile mediatore piuttosto che dello spac-cone demagogico) abbiano riconosciuto perspicace-mente quella a cui credere, facendo di Enwezor il lorodelfino.
Il massimo dell’ironia dell’ostentazione di Enwezor èla sua teatralità nella lettura pubblica de Il capital e diMarx. La trasformazione di un denso testo economico inuna interpretazione artistica indica la contemporaneaestetizzazione e feticizzazione del radicalismo autenticodelle passate avanguardie, che oggi imperversa nei cir-
cuiti accademici, museali e della Biennale. Ma propriocome la guerra nei Balcani accese inaspettatamente leBiennali negli anni Novanta, gli eventi di quest’estatehanno evidenziato l’incapacità di così tanta arte «politi-ca» di rendere conto delle realtà politiche, soprattuttol’arte che «teorizza» gli avvenimenti attuali. Infatti, chi
volesse oss ervare l’azione e conomica e politica del capi-talismo «globale» del XXI secolo farebbe meglio a legge-re le notizie quotidiane da Bruxelles e Atene piuttostoche ascoltare la recita di un’opera del XIX secolo, la cuicomplessità non può essere compresa o afferrata in unaserie di letture pubbliche.
Il caso ha voluto che mi trovassi ad Atene quando èscoppiata la crisi, all’inaugurazione di un festival dell’au-diovisivo di tre giornate — dal tramonto all’alba — orga-nizzato da me in collaborazione con altri tre curatori:Barbara London, Kalliopi Minioudaki e Francesca Pietro-paolo. Il programma delle prime due notti ha incluso unmisto di opere di artisti che andavano da Cindy Sherman,ZimmerFrei, Chantal Akerman, e Olga Chernysheva, ad
Alterazioni Video, Gary Hill, Wangechi Mu tu, B ill Vi olaand Yang Fudong. L’ultima notte è stata dedicata a tuttele cinque parti del ciclo Cremaster di Matthew Barney.Come per gli altri, l’opera di Barney è stata proiettata suschermi situati all’aperto di fronte a un prato gigantesco,un po’ come se avessero fuso la cornice di un anfiteatrogreco classico con quella di un concerto rock e un cine-ma drive-in americano. Il pubblico affluiva mentre il soletramontava, e i fan irriducibili si trattenevano fino all’al-
ba.Il festival era giusto un ingrediente di una settimana di
concerti, eventi sportivi, spettacoli circensi e partite discacchi (condotte da Garry Kasparov) che avevano luogonei giardini del nuovo Centro della fondazione culturale
Stavros Niarchos, ancora in costruzione al confine tra Atene e la città portuale del Pireo. Il vasto complesso pro-gettato da Renzo Piano abbina una nuova imponente Bi-
blioteca nazi onale a un nu ovo, grandi oso Teatro nazi o-nale. Quest’ultima è un’enorme struttura inserita in unpadiglione di vetro, che si erge sull’ampio pendio delparco in cui si estende quasi tutto il resto del campus Sn-fcc, un padiglione il cui tetto sensibile alla luce producela maggior parte del fabbisogno di energia elettrica delcentro e degli edifici annessi.
Principalmente frutto dell’ingegno di uno dei nipoti diNiarchos, Andreas Dracopoulos, co-direttore della fon-dazione, Snfcc non è solo una nuova sede internazionaledi manifestazioni, ma rappresenta anche un segnale in-novativo nella filantropia europea. Progettato e intera-mente finanziato dai privati, dopo il suo completamento,l’intero complesso sarà messo in condizione di assumer-si tutte le responsabilità del suo futuro successo o falli-mento. In qualunque eventualità, specie quelle emersedurante l’inaugurazione del sito a giugno, rappresentauna scommessa e anche un gesto patriottico, come quel-lo di un membro di una famiglia greca il cui patriottismosi spinge fino al pagamento delle tasse e all’incitare co-raggiosamente gli altri a fare altrettanto. Tale impegnoprosegue con donazioni elargite attraverso la sua fonda-zione di famiglia, non ultimi i 200 milioni di euro donatida Snfcc per alleviare il peso sulle spalle dei suoi concit-tadini gravemente colpiti dalla stagnazione del Paese,metà dei quali sono stati spesi per promuovere l’occupa-zione e la formazione professionale per i giovani.
Il ruolo mio e dei miei colleghi in questa impresa è sta-to marginale, ma il fatto che gli artisti invitati a presenta-re i loro video abbiano prontamente accettato senza al-cun compenso suggerisce che ci sono vie alternative al-l’impasse ideologica che attanaglia il mondo dell’artequando opera secondo le logiche tradizionali. Kant so-steneva che la vera arte fosse intrinsecamente disinteres-sata. Da scettico sessantottino quale sono mi è difficileaccettarlo, per cui condivido alcuni valori critici a voltesposati, ma troppo spesso scimmiottati da così tante«pratiche» recenti nel mondo dell’arte e delle manifesta-zioni artistiche. In ogni caso, l’interesse per qualunquedei due ambiti può — e dovrebbe — trascendere la fama,il guadagno o le mode intellettuali. Nel caso di Snfcc, ifinanziatori filantropici hanno allocato il loro capitale se-condo i loro dichiarati convincimenti, e gli artisti hannoinvestito il loro capitale artistico secondo i loro principi,con il risultato che un pubblico greco provato e demora-lizzato ha potuto assistere a opere lungimiranti, attraver-so un mezzo di comunicazione contemporaneo, senzacosti o barriere sociali.
Gli oratori e i demagoghi professionali possono svalu-tare tali sforzi ritenendoli ingenui o peggio, ma per unasettimana, appena prima che l’economia greca crollassee la società greca cominciasse a perdere i pezzi, una pic-cola utopia è fiorita sotto il cielo luminoso del Mar Egeo.Non appena il cielo diventa più scuro nuvoloso, si puòsolo sperare che non sarà dimenticata la dimostrazioneche la Grecia è capace di andare avanti con ottimismo,anche sull’orlo del precipizio.
(traduzione di Ettore Claudio Iannelli)© RIPRODUZIONE RISERVATA
VeneziaLa cinquantaseiesima
Biennale d’arte curata daOkwui Enwezor
si intitola All The World’s Futures e rimarrà aperta
ai Giardini e Arsenalefino al 22 novembre 2015
(www.labiennale.org)Atene
Lo Stavros NiarchosFoundation Cultural Center,progettato da Renzo Piano,
è attualmente in fasedi costruzione nella baia
di Phalironis e comprenderà(tra l’altro) la NationalLibrary of Greece
e la National Opera.Una volta concluso,
nel 2016, il complesso,costo previsto 566 milioni
di euro, sarà donatoalla nazione greca
L’installazioneIn alto: Maria Papadimitriou
(Atene, 1957),Why Look At Animals?
Agrimiká (2015, particolare):l’installazione rappresenta
la Grecia alla Biennaledi Venezia in corso
i
VALUTAZIONI DI
STRUMENTI MUSICALI
Sotheby’s Roma
Piazza SS Apostoli 61
mercoledì 23 settembre
Sotheby’s Milano
Corso Venezia 16
giovedì 24 settembre
Cremona
venerdì 25 settembre
Per prenotare
un appuntamento
011 544898
0338 9955547
www.ingleshayday.com

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 31/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 31
«Visualizzare il peggio». Ecco il mantra di ChrisHadfield, astronauta in pensione ed excomandate della Stazione spazialeInternazionale. È il consiglio che dà ai giovani incerca di lavoro in una video-intervista pubblicata
nella sezione «occupazione giovanile» dell’Ilo.Prepararsi al peggior scenario possibile; inquesto modo — racconta — tra 5 mila candidatiè riuscito a essere selezionato. E a realizzare ilsuo sogno: cantare Space Oddity nello spazio.
Il bello di visualizzare il peggio
{Sguardi Le mostreVoci dal mondo
di Sara Banfi
Memoria e fantasia, pezzi storici e inediti alla Fondazione Roma Museo-Palazzo CipollaOmaggio a un talento apolide: «Il ruolo dell’intellettuale? Fino agli anni Ottanta c’era, oggi è sparito»
Il naufragio, gli indios, il circo, l’ItaliaKokocinski, vita di un artista nomade
Antologica
di PAOLO CONTI
Storia di un artista migrante, natoapolide e che oggi vorrebbe torna-re in quella condizione, libero daappartenenze nazionali «perchémi sento cittadino del mondo».
Una ragione c’è, ed è legata a un’immagineche segnerebbe qualsiasi vita: tanto, tropposimile a quelle che vediamo tra le decine dimigliaia di immigrati che approdano in Eu-ropa disperati, perseguitati, affamati.
Siamo alla fine del 1948, o forse i primimesi del 1949, i ricordi sono confusi: unacoppia cosmopolita, formata da Janusz Ko-
kocinski, polacco con sangue in parte geor-giano, che ha conosciuto i gulag sovietici inKamchatka ed è finito sul fronte adriaticocol Secondo corpo d’armata polacco, e Ele-na Kostantinovna Glovatskaya, russa diKiev, fuggita dalla Russia e sopravvissuta fi-no all’Italia dipingendo ritratti, si ritrovanosul porto di Genova. Apolidi. L’unica lororicchezza è il piccolo Alessandro, nato per un caso del destino (e del marasma europeodi quel tempo) a Porto Recanati il 3 aprile1948. Si imbarcano su una nave militare in-glese per raggiungere l’Argentina, il NuovoMondo, sanno che laggiù ci sono colonie dirussi e forse c’è una vita diversa che li atten-de. Lontani dalle follie dell’Europa, dal nazi-smo, dal comunismo, dalle persecuzioni.
Poco prima dell’attracco a Buenos Aires,il naufragio. Alessandro Kokocinski lo rac-conta sorridendo, ma dai suoi occhi azzurritraspare se non un’emozione comunque unlampo: «Era una vera carretta, cominciò aimbarcare acqua. Sotto c’erano i più deboli,donne e bambini. Affogarono in molti. Misalvai perché mia madre mi tenne sollevatosulle braccia chissà per quanto tempo, conl’acqua che le arrivava alla bocca. Sopravvis-suti per caso». Il caso è il compagno di tuttal’esistenza di questo artista che dal 17 set-tembre propone alla Fondazione Roma Mu-seo-Palazzo Cipolla di Roma una sua mo-
stra, La Vita e la Maschera: da Pulcinella alClown. Chi conosce la sua produzione ritro-
verà le figure r arefatte, che e mergono dauna indefinibile nebbia di memorie e fanta-sia, assorte nei loro pensieri figli di pianetilontani. Sei sezioni — L’arena, Pulcinella,Petruska, Sogno, Clown, Maschera interio-re — con una ricca serie di inediti messi adisposizione da questo artista sottile, daltratto personale elegantissimo come po-trebbe esserlo indifferentemente quello diun lord britannico o di un misterioso ascetaslavo, e dalla Fondazione a lui intitolata.Quelle maschere, ancora una volta, dimo-strano come il legame tra la fantasia, l’espe-rienza personale e quindi il prodotto finalesia indispensabile per approdare a una poe-tica di fondo.
Quei clown, avvolti nelle loro nubi, han-no una radice biografica che aumenta il fa-scino del racconto di una vita: «Quando ar-rivammo in Argentina — dice a “la Lettura”— decidemmo di dirigerci verso il Nord,dove sapevamo di queste colonie russe.Non le trovammo e fummo adottati da unacomunità nomade di indios guaranì. Sonocresciuto ignorando il significato del con-cetto di proprietà personale ma nutrendoun immenso rispetto per la natura, per isuoi ritmi. Poi dovemmo tornare a Buenos
Aires e io ebbi un rigetto per quel mondoche vedevo violento, sporco, anche perché
L’artistaAlessandro Kokocinski (sotto)
è nato a Porto Recanati(Macerata) nel 1948 da madre
russa e padre polacco. Halavorato in un circo, è vissuto aBuenos Aires, per rifugiarsi poi
in Cile e quindi in Europa. ARoma è accolto da RafaelAlberti, Alberto Moravia,
Carlo LeviL’esposizione
Kokocinski. La Vita e la Maschera: da Pulcinella al Clown si apre il17 settembre alla Fondazione
Roma Museo - Palazzo Cipolla,in via del Corso 320 a Roma
(fino al 1° novembre).L’ingresso è libero: lunedì 15-20, dal martedì alla d omenica
11-20, ultimo ingresso alle19.30. Info: tel. 06. 69924641o al sito www.mostrakocinski
roma.it e www.fondazioneromamuseo.it. Il percorso è in sei
sezioni. Molti gli inediti fornitipersonalmente dall’artista e
dalla Fondazione che porta ilsuo nome
(www.kokocinski.org)
i
Alberti e poi Alberto Moravia , ovviamentePier Paolo Pasolini, Carlo Levi, quindi leamicizie e gli scambi con Ennio Calabria,Renzo Vespignani, Alberto Sughi, Ugo At-tardi, Lorenzo Tornabuoni. Arriva il succes-so, anche commerciale. E qui riemerge lasua natura più intima, quella dell’apolide.Riappaiono anche le radici libere della tribùdegli indios Guaranì: «Nel 1985 lasciai tutto.Sentivo che gli obblighi legati alle richiestepressanti dei mercanti mi toglievano la li-
bertà. Direi, il res piro». E così i l noma detorna sulle strade del mondo. Dieci anni di
viaggi: l’Oriente, la Thailandia, la Cina, an-che l’Australia.
Infine il rientro in Italia: «Io non ho rim-pianti nella vita, ma guardandomi indietromi dispiace di aver abbandonato l’Italia per così lungo tempo. Ora, da anni, vivo a Tu-scania. Ho ritrovato la cultura del rispettoper l’ambiente, per il paesaggio da conse-gnare ai posteri, per i rapporti veri tra gli es-seri umani. Il ruolo dell’intellettuale oggi?Fino agli anni Ottanta c’era, era solido echiaro. Oggi non c’è più. È sparito». E allora,Maestro, perché organizzare una mostrasulla propria produzione? Una pausa: «Ve-ramente me lo chiedo anch’io». E nellosguardo trasparente, nel sorriso un po’stanco, si materializza un’ironia antica disecoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le immagini e il catalogoQui sopra: Come la mia notte spogliata dellestelle (bronzo patinato, 2012); in alto: Cercandol’illusione (olio su tela, 2012). A fianco,centrale: Secondo vestito di luna (bassorilievo sutela a tecnica mista: cartapesta, olio, tessuto,carta, 2013). In alto a sinistra: Liberato dallapesantezza (installazione: bronzo, rame,vetroresina, ceramica, argento, 2013-14);sotto: Poesia (tecnica mista su pergamena,2013: particolare). Il catalogo della mostra èpubblicato da Skira (pp. 128, 29) e contienesaggi di Paola Goretti, della narratrice Margaret
Mazzantini, di Fabio Lazzari e di Tiziana Gazzini
l’unico alloggio che trovammo fu nella zonapiù degradata del porto industriale, ancoraoggi ritenuta pericolosissima». Ancora unpasso e Alessandro sarebbe diventato un«adolescente di strada» consegnato allamalavita, a una probabile morte precoce.
E qui suo padre e sua madre compionoun gesto perfettamente in linea con le loronon-radici di apolidi: affidano Alessandro aun circo uruguayano a conduzione familia-re: «Non ho più rivisto per anni i miei geni-tori. Ho girato per tutto il Sud America. Hofatto di tutto, l’acrobata sui cavalli, lo sceno-grafo. Ma nelle pause lavoravo anche comemetalmeccanico. Ho fatto solo la prima ele-mentare a scuola. La mia vera istruzione si ècompiuta lì, nel circo. E sono ancora gratoai miei genitori per quella intuizione. Mihanno salvato». Perché lo hanno consegna-to non solo al piccolo circo uruguayano masoprattutto all’universo dell’arte, a una con-cezione planetaria dell’esistenza, al faciledialogo con la materia fantastica.
Poi c’è stata la vita, un inizio da grafico, lafuga dalle dittature, prima dall’Argentina epoi dal Cile, l’approdo in Italia (un ritorno,infatti ha due passaporti, argentino e italia-no), l’amicizia con i tanti intellettuali diquella irripetibile stagione italiana: Rafael

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 32/48
32 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
Sguardi ilCartellone.
R acconta — in forma d’arte italiana — il «Se colo Brevissimo» dopoquello «Breve», il tempo chiuso fra la Caduta del Muro e quella delleTorri Gemelle. E, come annuncia il titolo della mostra, apre le porte
verso il futuro: Liberi tutti, con le parole della band torinese dei Subsonicauscite proprio a metà «percorso», nel 1999. «Mani in alto fuori di qua/ Nonresteremo più prigionieri/ Ma evaderemo come Steve Mc Queen» , diceva lacanzone, traccia di un approccio (anche sociale, non social) al percorsoespositivo con cui il Museo Ettore F ico (fino al 18 ottobre, www.museofi-co.it) riunisce e snoda le opere dentro un ventennio che è stato tante cose,ma anche quello in cui nell’arte tutto è (ri)cominciato. L’elenco degli artistiè lungo: 80 per 186 opere, da Maurizio Cattelan (sotto: Untitled, 1995, Cour-tesy Armin Linke), Paolo Canevari, Vanessa Beecroft e Mario Dellavedova,che introduce col maiuscolo slogan fiorito «Ahi, disperata vita». Dispera-zione, ma con libertà di creare. E di lanciare quell’infantile grido di batta-glia che vuole impedirci di nasconderci ancora. (edoardo vigna)
MUSEO ETTORE FICO
Diario di un secolo brevissimorivoluzionario come una canzone O
ggi può stupire il fascino intenso che il mito del-
l’Unione Sovietica, compresa la corrente artisticadel «realismo socialista», esercitò sul mondoculturale italiano nel dopoguerra. Ma il fenomeno ebbeall’epoca un grande rilievo e merita la riconsiderazionecritica proposta dalla mostra Guardando all’Urss. Rea-lismo socialista in Italia dal mito al mercato , allestita aMantova presso le Fruttiere di Palazzo Te fino al 25 otto-
bre dalle cura trici Vanja Strukelj, Francesca Za nella eIlaria Bignotti sulla base di un’idea di Arturo Calzona.La rassegna dà conto dell’arte legata al regime (sotto:
Anatolij Cern ov, Festa del grano), ma non solo. Registrale scosse determinate dopo il 1956 dalla destalinizzazio-ne. E dedica ampio spazio al Premio Suzzara, che dal1948 al 1974 venne destinato ad autori d’indirizzo reali-sta le cui opere trattassero i problemi del lavoro. Senzacontare che oltre al mito dell’Urss, alimentato dal Pci, viera anche l’antimito, nel complesso certo più giustifica-to, promosso dagli anticomunisti. (antonio carioti)
FRUTTIERE PALAZZO TE
Tutti pazzi per il Cremlinoe il realismo alla sovietica
S
ei metri di lunghezza. Una piccola
prateria su tela dove le forme abitanoin libertà. Murale (sotto), l’opera piùgrande di Jackson Pollock (1912-1956), è inmostra alla Collezione Peggy Guggenheim(fino al 16 novembre, www.guggenheim-ve-nice.it) dopo un restauro durato 18 mesi.Proveniente dall’University of Iowa Museumof Art, arriva per la prima volta in Italia, acura di David Anfam. Considerata una delleopere più importanti dell’arte americanadel Novecento, è stata realizzata nel 1943 per l’appartamento newyorchese della famosacollezionista. Il monumentale Murale hatirato una riga sulla storia della pitt ura sta-tunitense, c’è un prima e un d opo. Qui Pol-lock riversa la sua fascinazione per l’Ovest,un viaggio verso la «nuova frontiera» dellacreatività. Il risultato è tellurico. Una scenadove si intravedono confusamente figureavanzare, in un vortice di linee e colori. Mapoco conta: emergono il gesto, l’azione. Chesi trasformeranno nel dripping , il gocciola-
mento del colore che ha reso famoso Pol-lock. (alessandro zangrando)
PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION
Pollock, la creatività in un (mega) murale
Se la potenza del colore che anima i soggetti visionari di Marc Chagall(1887-1985) ha incantato i visitatori della mostra tenutasi al PalazzoReale di Milano nello scorso inverno, protagonista a Monza fino al
prossimo 6 gennaio sarà la forza delle linee e dei tratti delle incisioni del-l’artista russo; esposte oltre trecento acqueforti che compongono i tregrandi cicli grafici dedicati alle Anime mortedi Gogol, alle Favole di LaFontaine ( sopra: La Vecchia e le due Serve, 1952) e alla Bibbia. L’esposizio-ne Chagall, la grafica del sogno, ospitata negli spazi dell’Arengario e dellaCasa degli Umiliati, sede dei Musei Civici di Monza (www.museicivicimon-za.it), ruota intorno a quella parte meno conosciuta, ma non meno interes-sante della produzione di Chagall di cui lui stesso ebbe a dire: «Qualcosami sarebbe mancato se, a parte il colore, non mi fossi impegnato, ad uncerto momento della mia vita, anche con l’incisione». Esposte anche operedi Picasso, Matisse, Rouault che approfondiscono il rapporto che legavaChagall e questi artisti al mercante d’arte Ambroise Vollard. (chiara pagani)
ARENGARIO / CASA DEGLI UMILIATI
Gogol, La Fontaine e la Bibbia:la grafica è sogno, parola di Chagall
«Non sono un artista, sono un fotoreporter. Hosempre pensato che in fotografia sia importan-te la verità. E la denuncia. Lo stile di Robert
Capa mi ha ispirato più di qualsiasi altro, soprattutto per lasua semplicità, uno sguardo senza facili estetismi. Troppaestetica uccide la verità»: questa la visione del mondo diMario Dondero. E la «verità» del grande fotografo si può
vedere (sino al 1° novembre alle Gallerie Piedicastello diTrento, www.museostorico.it) in una mostra sul lavoro diEmergency (dal 1999 a Kabul) che interpreta pienamente lospirito etico della sua idea di fotografia (sopra). La mostra In Afghanistan è un intenso viaggio dentro il prezioso edifficile lavoro dei medici di Emergency in quel tormenta-to teatro di conflitti. Dondero (Milano, 1928), grande leonedel fotogiornalismo, anche in queste immagini in cui ri-trae la devastazione della guerra, il dolore delle vittime e illavoro di chi cerca di portare un a iuto mantiene fermo ilsuo sguardo poetico con cui difende, sopra ogni cosa, ladignità di ogni essere umano. ( gianluigi colin)
GALLERIE PIEDICASTELLO
Emergency in Afghanistan:lo sguardo di Mario Dondero
Baffoni, tuta blu, attrezzi da lavoro,ruote, fili, ingranaggi e macchine inmovimento. Così René Burri fotogra-
fò il suo amico Jean Tinguely (1925-1991). Un inventore, un operaio, un pensatoreche credeva che le sue opere immediate eun po’ dissacranti fossero perfette per i
bambini. Tinguely era tutto questo e tuttoquesto emerge alla Fondazione CulturaleHermann Geiger di C ecina (Livorno) dovefino al 20 settembre (www.fondazionegei-ger.org) rimarranno in mostra I filosofi,omaggio ai pensatori che lo hanno forma-to. Le sculture di Heidegger, Bergson, En-gels, Kropotkin, Wedekind, Wittgenstein,Burckhardt e Wackernagel provengono dalMuseo Tinguely progettato a Basilea daMario Botta e inaugurato nel 1996 (sopra: Jean-Jacques Rousseau. Filosofo, 1988). Ilmovimento del pensiero (che personal-mente l’avrebbe portato all’abbandono delmarxismo degli anni giovanili) è ben rap-presentato prima di tutto nello slanciodelle sculture, ben lontane da ogni impo-stazione monumentale. (cristina taglietti)
FONDAZIONE HERMANN GEIGER
I filosofi di Tinguelysono solo giocattoli
MANTOVATORINO
CECINA (LI)
TRENTO
MONZA VENEZIA

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 33/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 33
F
enicotteri Rosa (1972), Hairspray
(1988), Cry Baby (1990) sono alcuni deifilm che hanno fatto di John Waters(Baltimora, 1946) un’icona di stile. Enfantterrible del cinema indipendente america-no, non è solo regista ma anche artista visi- vo. La Kunsthaus di Zurigo (www.kun-sthaus.ch) dedica a Waters la retrospettivaHow Much Can You Take? che raccoglie,fino al 1° novembre, quaranta opere trastoryboard e lavori tridimensionali, donatial museo dal collezionista This Brunner, cherivelano una faccia nascosta di un talentomultiforme. Le sue opere criticano i codicicomunicativi del sistema dell’arte ed espon-gono senza pietà le fobie del la fabbrica deisogni hollywoodiana: come avviene nellaserie Tragedy (2015) che riproduce lo scalpodell’attrice Jayne Mansfield, morta nel 1967,o nell’immagine della star a quattro zampeLassie sottoposta a interventi chirurgici(sotto: Reconstructed Lassie, 2012). A com-pletare la personale, il 23 settembre una
performance live: This Filthy Wolrd, one-man show di 90 minuti. (cecilia bressanelli)
KUNSTHAUS
John Waters, fascinodel trash d’autore
I
ncipit aperto: asserzione o punto interrogativo? È rac-
chiusa nel titolo, Where to start from, la sfida al sensocomune di Maurizio Nannucci. Fiorentino, classe 1939,dagli anni Sessanta Nannucci sperimenta linguaggi e tec-niche diversi. Ai suoi paradossi filosofici, ovvero la capaci-tà di guardare oltre, il Maxxi dedica la personale, a cura diBartolomeo Pietromarchi, allestita fino al 18 ottobre nellaSala 3 (www.fondazionemaxxi.it). Due gli inediti: la gran-de scritta al neon More than meets the eye sulla facciatadel museo progettato da Zaha Hadid (dono dell’artista,farà parte della collezione permanente del Maxxi) e l’in-stallazione sonora Sound samples. Luce, ambiente, colo-re, immagine, parola... Un viaggio nel quale, ai nuovi lavo-ri, si affiancano pezzi storici come la grande parete inneon bianco There is another way of looking at things (sotto: The missing poem is the poem, 1969). «Opere nateper dialogare con l’architettura — sottolinea Anna Matti-rolo, direttore del Maxxi Arte — ma che n egli spazi diHadid assumono un’altra vita». (maria egizia fiaschetti)
MAXXI
Paradossi sonori e al neonNannucci dialoga con Hadid
A Londra vale la pena assentarsi, dal brusio di Piccadilly o dalla quietedi Green Park, per esplorare The Absence of the artist, piccola mailluminante mostra che la galleria Sprueth Magers dedica a Keith
Arnatt (www.spruethmagers.com, fino al 26 settembre). Nato nel 1930 aOxford e morto nel 2008 in Galles, Arnatt è figura chiave (e dimenticata)dell’Arte Concettuale. L’Assenza dell’artista raccoglie lavori del periodo1967-1972 come Self-Burial, Portrait of the artist as a Shadow of his FormerSelf (sotto) o i buchi e gli specchi dei Mirror-lined Pit. Ombre sui marcia-piedi, enigmi sui muri, paradossi e sparizioni che mettono in gioco anche lapresenza dell’osservatore. Così Arnatt saggiava la forza della fotografia, ar-ma che poi usò nella sua guerra ( ricambiata) al mondo dell’arte. Autosepol-tura, sequenza di nove ritratti che mostrano l’autore scomparire sotto terra,andò in onda sulla tv tedesca. Una al giorno, per due secondi, interrompevaun programma nell’ora di punta. Senza spiegazioni o commenti. Se qualcu-no lo rifacesse oggi, alla nostra tv , che meraviglia. (michele farina)
SPRUETH MAGERS
Scusate, ma l’artista è assenteKeith Arnatt contro il sistema
La Sicilia come la vedevano i visitatori tra il Settecentoe l’Ottocento. Epoca di Grand Tour, di viaggi cultura-li e di viaggiatori colti, di memorabili reportage (Go-
ethe su tutti) ma anche di ispirazioni artistiche per dise-gnatori, incisori, paesaggisti. Alle opere di questi ultimi èdedicata la mostra intitolata Uno sguardo al Grand Tourattraverso le collezioni della Fondazione Sicilia, inaugu-rata a luglio a Palermo, a Palazzo Bran ciforte, e aperta finoal 1° novembre (www.palazzobranciforte.it). Cinquanta-due opere grafiche (sopra: Peter De Wint, Temple of Juno,Girgenti, 1821) e diciotto volumi, che sono stati realizzatitra il 1776 e il 184 5 e appartengono alle collezioni dellaFondazione, sono esposti in diverse aree del palazzo,principalmente in Cavallerizza (34 opere raffiguranti, tral’altro, antichità greche di Segesta, Selinunte e Agrigento,l’Orecchio di Dioniso, il Teatro Greco di Taormina) e in unambiente al primo piano, rinominato Sala del GrandTour, che ospiterà in via permanente altre opere (moltesulle Eolie) e i diciotto volumi. (fulvio bufi)
PALAZZO BRANCIFORTE
Grand Tour da collezionistialla maniera di Goethe
Ultimi giorni al Moma di New York per
vedere la mostra sugli inizi del soda-lizio artistico e umano tra Gilbert
Prousch (1943) e George Passmore (1942)che si incontrarono da studenti, nel 19 67,alla St. Martin’s School of Art di Londra.
Artisti inglesi concettualisti in lotta controle élite culturali del tempo, i due — Pas-smore, un’adolescenza vissuta in povertà esenza un padre a Plymouth, mentre Prou-sch era arrivato a Londra dall’Alto Adige,nato a San Martin de Tor e cresciuto nellascuola d’arte di Selva di Val Gardena —cominciarono a stupire con le loro provo-cazioni artistiche e le loro sperimentazionigià alla fine degli anni Sessanta. La mostradel Moma, Gilbert & George: the Early Ye-ars (fino al 27 settembre, www.moma.org)copre proprio il periodo dagli esordi del ’69al ’76 (sopra: The Red Sculpture Album,1975). Stabilito che tutto è arte, compresi iloro dialoghi, i due artisti sfidarono l’«esta-
blishment» del tempo presentandosi comesculture viventi col volto coperto di vernicemetallizzata. (massimo gaggi)
MOMA
I «peccati» giovanilidi Gilbert & George
Non salì verso il cielo solo il Muro, negli Anni Sessanta, a Berlin o. Lacittà, al culmine delle tensioni della Guerra Fredda, fu anche unasfida di Architettura, tra Est e Ovest. Sfida vin ta, alla fine, dall’Occi-
dente: molti dei palazzi della Berlino socialista costruiti nei Sessanta,soprattutto quelli voluti dal regime comunista, sono stati spian ati dopola riunificazione tedesca. Operazione dovuta, secondo alcuni; cancella-zione di un pezzo di storia a oper a dei vincitori, secondo altri. Sull’archi-tettura di quel decennio e sul confronto che comportò ci si può fareun’idea in una mostra che si è aperta il 29 maggio e chiuderà il 26 ottobrealla Berlinische Galerie della capitale tedesca (www.berlinischegale-rie.de). Radikal Modern presenta circa 300 lavori — progetti, fotografie,disegni — di 30 architetti e urbanisti che hanno ridato forma alla città(sopra: Dieter Urbach, Marx-Engels-Plat z , 1972), in quel decennio ancorasegnato profondamente dai bombardamenti: da Ludwig Mies van derRohe a Manfred Zumpe, da Walter Gropius a Josef Kaiser. (danilo taino)
BERLINISCHE GALERIE
Ricostruzione di una metropoli:così l’architettura diventò politica
LONDRA
BERLINO
NEW YORKZURIGOROMA
ALERMO
Si chiama Mots d’ados e indaga il mondodell’adolescenza a partire dalle parole scritte. Èil nuovo progetto del giovane artista I rvinAnneix, che da più di un anno colleziona scrittidi teenager (piccoli messaggi sui diari, lettere,
email, sms, post sui blog) per costruire uncorpus coerente e vario. Ne trarrà una serie diletture, un documentario interattivo eun’installazione per lo Studio 13/16 del CentrePompidou. Si può seguire qui: mots-ados.com.
Le parole dell’adolescenza
{Documentadi Chiara Campara

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 34/48
34 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
È l’altro Phil Collins: non il leggendario batteristadei Genesis, ma l’artista britannico, 45 anni. Cheha voluto chiudere la sua ultima creazione in uncofanetto in 500 copie con due vinili a 33 giri,testi d’autore e altri materiali, My Heart’s In MyHand ... E dentro? Le conversazioni telefonichedi senzatetto registrate da una cabina dentro unricovero di Colonia, montate su musica. Il pattoera: parlate con chi volete, io vi registro. Ilrisultato: un’operazione di struggente poesia.
La musica della cabina telefonica
{Incisionidi Renzo Matta
Maschere.
Teatro, musica, danza, cinema, televisione
Danza Alla Scala il balletto nella versione del 1890 recuperata da AlexeiRatmansky. Con i movimenti di allora e il ruolo di Carabosse «en travesti»
L’Addormentatatorna sui suoi passiGesti piccoli e veloci, così la volle PetipaE la strega cattiva sotto sotto è un uomo
Riletture
Siamo sprofondatinel sonno del bosco(il risveglioè anche peggio)
Che lungo lungo sonno. Cento anni disonno ininterrotto. E, come da titolooriginale, La belle au bois dormant, acadere addormentato è un intero bosco enon la sola protagonista. Un intero bosco
di dormienti. Se in una di queste sere, assenti dadecenni madri e padri chini a narrarci accanto alletto, provassimo a leggercela noi, a noi questaantichissima fiaba rielaborata da Charles Perraultnel 1697, dove ci porterebbe? Che cosa ci direbbe?
Quali echi in noi vecchi bambini del terzomillennio risveglierebbe e con q uali nuove noterisuonerebbe a noi più vicina?
Oggi «la bella nel bosco addormentato» si fa atratti grandiosa metafora della tragedia epocaleche stiamo vivendo e che, proprio perché la stiamo
vivendo, in molti ancora non riescono a vedere. Unintero mondo di cento e cento anni dimenticatimuove verso di noi. «Che cosa sono quelle torriche spuntano da quel bosco?» chiede dopo centoanni il principe, boh, forse regno degli spiriti, glirispondono. E quando, grazie all’incantesimo,riuscirà a farsi strada tra la vegetazione fittissima egiungerà al castello la visione gli gelerà il sangue,ovunque, appoggiati qua e là, corpi di uomini e dianimali come fantocci senza vita. Tutti sinoall’ultima guardia, servitore, cuciniere, tutti e tutto,persino lo spiedo con i fagiani, persino il fuocosotto lo spiedo, tutto dorme in un silenzio surreale.
E all’origine? Una iniquità, un’esclusione. Lesette fate madrine invitate al battesim o e l’ottavano. Perché no? Perché da cinquant’anni non la si
vedeva più in giro. Se non ti vedo non esisti. Midimentico di te. E dopo il mancato invito, unaseconda iniquità: al suo non gradito apparire alcastello, un posto a tavola rimediato in fretta, settepiatti d’oro alle altre fate e a lei no, sette cucchiaiforchette coltelli ricoperti di diamanti e rubini aloro e a lei no. Così il cammina-cammina del male,della maledizione, ha inizio. Tutto un mondo làche sparirà, tutto un altro mondo qui che di loroper cento anni si dimenticherà. Poi un bel giorno ilprincipe arriva, «Siete voi? — gli chiede la bella —Ce ne avete messo del tempo». Dopo tanto dormireil risveglio. Tutti insieme e tutti affamatinaturalmente. Oggi meriterebbe una narrazionequesto risveglio, intanto però la fiaba corre allefelici nozze di principe e principessa e alla nascitadei figli Aurore e Jour. Versioni ridotte e cartonianimati omettono tutta la seconda drammaticaparte del testo originale di Perrault. Anche questatrae origine da un nucleo di male: lo sposo che siallontana per muovere guerra allo s tato confinante.
Pagine e pagine cruente, i figlioletti che l’orchessa vuole divorare ma che, come in Biancaneve, ilpersonaggio buono salverà uccidendo al posto loroun agnellino e un capretto ecc. ecc.
Dopo il lungo sonno, dopo il risveglio, ancoraun lungo estenuante camminare, minacce, pericoliin agguato, ma questa volta sotto gli occhi d i tutti.Il dovere di «vedere». E soprattutto, peud’éloquence et beaucoup d’amour .
© RIPRODUZIONE RISERVATA
di VIVIAN LAMARQUE
di VALERIA CRIPPA
«La si sarebbe presa per un angelo, tant’era
bella; lo svenimento non aveva fatto im-pallidire i bei colori del suo incarnato,aveva le guance ancora rosee e le labbracome il corallo; soltanto, aveva gli occhi
chiusi, ma si sentiva respirare dolcemente e questo indicava
che non era morta». Il sonno ti fa Bella, parola di CharlesPerrault. Nell’imbalsamare in un letargo secolare la più fa-mosa delle sue fanciulle in fiore, lo scrittore le assicura unsolido e radioso avvenire. Sonno salvifico che mette al ripa-ro la quindicenne dalla maledizione mortale di Carabosse,
vendicativa strega esclusa dal battesimo della principessinama anche sonno ibernante, in attesa di un miracolo che lariporti in vita, del Principe che liberi il volo nuziale del «vis-sero felici e contenti». Se, come scriveva Italo Calvino, «lefiabe rappresentano il catalogo dei destini che possonodarsi a un uomo e a una donna», la sorte riservata alla Bellaaddormentata sembra dibattersi nel conflitto tra stasi e mo-
vimento, vincolo al dogma ed eman cipazione, passato epresente. Sull’archetipo della fanciulla dormiente si sonoabbattuti gli strali delle femministe irritate dal modello didonna passiva e afasica, mentre la psicoanalisi ha letto, nelsonno centenario, la metafora del periodo letargico che se-gna la psicologia della pubertà e quindi un percorso inizia-tico (Bruno Bettelheim), il limbo ribollente dell’inconscioalle soglie dell’età fertile (Marie-Louise von Franz).
Lunga vita, in letteratura, ebbe il tema della Bella Addor-mentata, dalle origini orientali all’approdo in Occidente nel
XIV secolo (Troilo e Zellandina dal Roman de Perceforest)fino alla Francia di Perrault, che pubblicò la fiaba nel 1697tra I racconti di Mamma l’Oca, e alla Germania dei FratelliGrimm che la inserirono nelle Fiabe del focolare nel 1812 eall’Italia di Calvino che sposò la versione del Pentameronedi Basile. Se i Grimm introducono, tra le varianti, il baciodel Principe che resuscita la Bella (da loro chiamata Rosa-spina), in Basile la ragazza viene «visitata» dal nobile men-tre dorme imperturbabile restando incinta dei gemelli Solee Luna.
Perrault regala una seconda parte grand-guignol con laBella e il Principe divenuti genitori di Aurora e Sole e mi-
nacciati dalla madre di lui, una regina-orchessa che ordinaal cuoco di corte di cucinarle, in una squisita salsa Robert,nipotini e nuora. La fortuna della fiaba di Perrault si deve aLuigi XIV, il Re Sole, fatalmente attratto dalla bellezza effi-mera: il sovrano lanciò il balletto, arte in cui amava esibirsifin da bambino, e fondò l’Académie Royale de Danse a Pari-
gi, nel 1661. Durante il regno illuminato (1643-1715) del «re ballerino», cui venne dedicato il passo di danza dell’entre-chat royal, il genere letterario del «racconto di fate» pro-sperò rispecchiando la corte sfarzosa di Versailles e, tra il1785 e il 1789, fu raccolto nel Cabinet des Fées.
Ma come riuscì a sgusciare la Bella addormentata daquel fatato scrigno letterario per incarnarsi in una nuova vi-ta, tutt’altro che passiva, danzando sui palcoscenici delmondo? Ci volle, anche qui, l’intervento di un principe. ASan Pietroburgo, nel 1888, il direttore dei Teatri ImperialiIvan Aleksandrovic Vševoložskij, principe e grande estima-tore del Re Sole, propose a Ciaikovskij la commissione di un
balletto «a serata intera» tratto dalla fiaba di Perrault (vennetagliata la seconda parte horror): «Vorrei realizzare la mes-sinscena nello stile di Luigi XIV. S u un tale soggetto si puòdare libero corso alla propria immaginazione e creare me-lodie nello spirito di Lully, di Bach, di Rameau. Se l’idea viaggrada, perché non iniziate a comporre la musica? Per concludere una quadriglia di tutte le fiabe di Perrault è as-solutamente necessaria. Bisogna mettere insieme il Gattocon gli Stivali, Pollicino, Cenerentola, Barbablù con le mo-gli». Il balletto Spjašcaja krasavica (la «Bella» in russo) de-
buttò con clamoroso successo il 3 gennaio 1890 al Mariin-sky: Vševoložskij disegnò i costumi, affidò le scene ad An-dreev, Bocharov, Ivan, Levogt e Shishkov e volle per la core-ografia il maggior artefice del balletto tardo-romanticorusso, il marsigliese Marius Petipa, con cui firmò il libretto(da allora la protagonista si chiamò Aurora).
Così nacque il «balletto dei balletti», essenza del «classi-co» e trionfo dell’opulenza zarista, croce e delizia dei suoiinterpreti (L’adagio della Rosa per Aurora), esempio ideale
L’edizione americanaLa bella addormentata nel
bosco , nella coreografiaoriginale di Marius Petipa
messa in scena e integrata daAlexei Ratmansky su musica di
Pëtr Ciajkovskij, ha debuttatocon l’American Ballet Theatre
nel marzo scorso a CostaMesa, in California, e in giugno
al Metropolitan di New York.La nuova, sfarzosa edizione è
stata prodotta dall’Abt (400costumi, acconciature e
gioielli) insieme alla Scala diMilano (scene dipinte)
La «prima» italianaIl balletto debutterà in Italia
alla Scala di Milano dal 26settembre al 23 ottobre con la
compagnia, gli allievi dellaScuola e l’orchestra del Teatro
milanese diretta da VladimirFedoseyev, con Svetlana
Zakharova (Aurora), DavidHallberg (il Principe) e
Massimo Murru (en travesti neipanni di Carabosse). Scene e
costumi di Richard Hudsonispirati all’allestimento di Léon
Bakst per i Balletti Russinel 1921 a Londra
(www.teatroallascala.org, tel.02.72003744)
i
FUORISCENA
di ENRICO PAROLA
«In questi anni la tecnologia harivoluzionato anche la biglietteria: danoi l’80 per cento del pubblico compra
il biglietto online e arriva in teatro con lapagina web stampata o salvata sullosmartphone». Con 35 dei suoi 62 annitrascorsi alla biglietteria del Gran Teatro laFenice, Nadia Buoso ricorda le lunghe code deituristi che sognavano di assistere a un’operain uno dei teatri più belli e famosi del mondo.
«Non è tutto informatizzato, ogni giorno
arrivano telefonate da Russia, America,Giappone... Le mie collaboratrici devonoconoscere molte lingue. Ci sono alcunispettacoli che si vendono con grande anticipo:è online tutta la stagione 2016, le recite diTraviata sono quasi esaurite; il concerto diCapodanno è sold out da due mesi». Vieneancora qualcuno in biglietteria? «Sì, c’ècomunque tanta gente; per loro teniamosempre alcuni posti per ogni spettacolo.
Inoltre i turisti non si fermano a Venezia
soltanto un giorno: da venerdì a domenica cisono sempre tre rappresentazioni, se non sitrova posto per la sera stessa, per l’indomanimagari sì». C’è una categoria di posti che vienevenduta solo in loco: «Fino a due anni fa sipoteva acquistare qualsiasi posto via internet;poi se i posti erano molto laterali o indietro, lagente si lamentava, anche se gli facevi notareche aveva speso 30 euro invece che 150; cosìabbiamo identificato due categorie, specificatesul retro dei biglietti: “Scarsa visibilità” e “Soloascolto”. Chi viene sa che spende poco e sadove andrà a sedersi». Qualche polemicasorge ancora: «C’è chi passa da certi touroperator e si accorge di aver pagato 300 europer un biglietto da 80: stiamo studiandoalcune procedure per risolvere il problema».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nadia Buoso, 62 anni,bigliettaia alla
Fenice di Venezia
Code di turisti e posti «solo ascolto»35 anni in biglietteria alla Fenice

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 35/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 35
di purezza e rigore dello stile e della struttura tardo-roman-tica. Nell’inanellarsi di pura danza, d’assieme, variazioni,pas de deux saldati dalla pantomima, la fiaba si astrae in unampio respiro e la tecnica si illumina della presenza brillan-te delle ballerine italiane, allora trionfanti in Russia: Carlot-ta Brianza fu l’Aurora del debutto al fianco di Pavel Gerdt, il
Principe Désiré, Enrico Cecchetti si sdoppiò nel ruolo di Ca-rabosse, en travesti, e in quello dell’Uccello Blu. Da allora èstata gara tra i coreografi per legare il proprio nome al capo-lavoro, ideale per mettere a regime l’efficienza di un corpodi ballo.
Chi si è cimentato in ricostruzioni più o meno libere del-l’originale di Petipa (in Occidente approdò quella di Serge-ev), da Nureyev e MacMillan a Grigorovich, chi ha preferitosolcare il mare aperto della rilettura: tra le visioni più ardite,l’Aurora tossicodipendente di Mats Ek. Al capezzale della«Bella» accorre ora il russo Alexei Ratmansky, ex direttoredel Balletto del Bolshoi e, dal 2009, coreografo residente al-l’American Ballet Theatre che si impegna a risvegliarla nellosfarzo delle origini. Per non tradire Petipa.
La nuova, opulenta edizione (400 costumi) prodotta dal-l’American Ballet Theatre insieme al Teatro alla Scala per 6milioni di dollari (budget accreditato dalla stampa statuni-tense) ha debuttato in marzo con l’Abt e le stelle Diana Vish-
neva e Marcelo Gomes in California, in giugno al Metropoli-tan di New York, promossa dalla critica. Ora Ra tmansky siprepara al secondo round, italiano: dal 26 settembre al 23ottobre la sua Bella debutterà alla Scala (subentra a quella diNureyev) con la compagnia milanese e, nei ruoli principali,Svetlana Zakharova e David Hallberg. Con la perizia di unrestauratore nel riportare alla luce un affresco originale, il47enne Alexei, pietroburghese, è ricorso alle notazioni di
Vladimir Ivanovic Stepanov, un sistema di codificazione delmovimento pubblicato a Parigi nel 1892 in Alphabet desmouvements du corps humain ispirato ai principi della no-tazione musicale. «I balletti di Petipa — spiega Ratmansky a “la Lettura” — furono codificati quando il maestro era set-tantenne, i Teatri Imperiali temevano di perderne il reper-torio. L’importanza di questi documenti è immensa: è comescoprire gli interi manoscritti di Leonardo. Un vero tesoro eun miracolo senza precedenti nella storia del balletto». Conla moglie Tatiana, ha studiato il sistema per attingere a Peti-pa senza intermediazioni: «Nelle notazioni, ogni articola-zione del corpo è segnata, se stesa o flessa, ogni movimentoè descritto nel dettaglio, passé, punta, mezza punta. Hoscoperto che la coreografia, per me simbolo dell’armonia e
del fascino del classico, è molto più sofisticata. E ho impara-to molto sulla coordinazione. Molti passi non vengono piùeseguiti: piccoli giochi, battute,ronds de jambe. Interessan-ti, li userò nelle mie creazioni future».
Dal 1890 è cambiata la fisicità dei ballerini: l’Aurora diCarlotta Brianza era minuta e (ai nostri occhi) tozza, quelladi Zakharova sarà longilinea. La tecnica, inoltre, volge all’at-letismo, con estensioni esasperate. «Oggi i movimenti ten-dono a essere grandi e lenti, in Petipa erano piccoli e veloci:
Aurora aveva una vivacità femminile e un dinamismo che sisono persi». Ecco allora la prima sfida di Alexei: indurre i
ballerini a fare tabula rasa. «Alcuni sono rimasti scioccatidal “vero” Petipa, non pareva abbastanza esaltante: “Dov’èl’arabesque penchée, dov’è il développé?”, mi chiedono». Laseconda sfida riguarda il pubblico, abituato ai virtuosismi.«Scoprirà l’originale. Compreso il personaggio della stregaCarabosse en travesti: alla Scala lo danzerà l’étoile MassimoMurru».
Ratmansky ha chiesto allo scenografo britannico Ri-chard Hudson di ispirarsi all’allestimento del 1921 di LéonBakst per i Balletti Russi a Londra per il quale Diaghilev ri-schiò la bancarotta. «Ho fatto ricerche nelle biblioteche eonline – svela a “la Lettura” Hudson, vincitore del Tony
Award per il musical The Lion King — e ho studiato i costu-mi di Bakst a Londra, nelle collezioni del Victoria and AlbertMuseum e al Museum of London. Non ho copiato nulla, latavolozza di colori è mia. I tutù sono più lunghi, resi rigidida strati di pizzo. Le scene, pittorico-architettoniche e pa-storali, sono state dipinte alla Scala, i cappelli realizzati dallaboratorio romano Pieroni, mentre costumi, acconciaturee gioielli escono da sei laboratori di New York. Opulenza?La Bella è una fiaba e tale deve apparire. Minimalista nonavrebbe magia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nelle immagini: lo spettacolo negli StatiUniti con i ballerini dell’American BalletTheatre. Nella foto in alto: Isabella Boylstonnel ruolo di Aurora al debutto alMetropolitan di New York con l’Abt. Alcentro: Craig Salstein interpreta la stregaCarabosse en travesti . Sotto: Diana Vishnevanelle vesti di Aurora durante l’anteprimadel balletto in California

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 36/48
36 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 37/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 37
Come per Barthes e Simenon, le creazioni più sorprendenti e durature nascono spesso dal luttoCosì in concerto a Parigi accade anche per il geniale cantautore americano, il 21 settembre a Milano
Dolore a nudo: «Ti perdono, madre»Il requiem elettronico di Sufjan Stevens
Palcoscenico
da Parigi PAOLO GIORDANO
Ci sono artisti complessi, speri-mentali, perfino ipertrofici, chea un certo punto della carriera ri-nunciano a mostrare la propriatecnica per concepire un’opera
più semplice, scabra e personale. Spesso,questi squarci aperti all’improvviso sull’in-timità coincidono con un lutto appena sof-ferto. La scomparsa di qualcuno di vicinorende momentaneamente futile l’utilizzodi tanti espedienti, del cerebralismo, espinge verso una forma più nuda ed essen-ziale. Altrettanto spesso, si tratta delle cre-azioni più sorprendenti e durature di que-gli artisti. Si ha una sensazione del generescorrendo gli appunti disarmati di un teo-
rico come Roland Barthes sulla perditadella madre. E si prova qualcosa di simileleggendo la lettera che un vero ipertroficocome Georges Simenon scrisse alla terri-
bile Henriette dopo la morte di lei. A marzo scorso Sufjan Stevens, uno fra i
cantautori più geniali e venerati della no-stra epoca, ha pubblicato il suo personalecongedo dalla madre deceduta pochi anniprima, Carrie, con la quale ebbe un rap-porto discontinuo e a dir poco complicato.Come gli scritti degli autori menzionatil’album di Sufjan Stevens, Carrie & Lowell,è breve, spoglio, struggente eppure affilatocome un bordo di carta ben teso fra le dita .
Undici ballate: soltanto voce accompagna-ta da una chitarra acustica, talvolta da unpianoforte o da un ukulele; pochi altri suo-ni ambientali, sempre discreti, e quasinessuna evoluzione. L’opposto esatto, in-somma, di ciò che il musicista espresse nel
suo disco precedente, The Age of Adz , dovecerte suite orchestrali si trasformavano incontinuazione e parevano non finire mai.
Si ascolta Carrie & Lowell dapprima tra-sognati, quasi che si trattasse di un discoleggero, poi lo si sente sprofondare nelle
viscere, qualche centimetro più in fondo aogni passaggio. Il 21 settembre Sufjan Ste-
vens porterà Carrie & Lowell al Teatro dellaLuna di Assago, per l’unica data italianadel suo tour. A Parigi ha suonato al GrandRex, sotto l’arco rosso del teatro storico, inun ambiente sontuoso e insieme pacchia-no che si accordava bene al flusso di ricor-di impolverati del disco. Alle spalle della
band, su uno schermo suddiviso in fa scestaccate l’una dall’altra, scorrevano filmatidell’infanzia di Sufjan, e panorami risalen-ti forse allo stesso periodo: un lago circon-
dato da conifere, un canyon, un mare dinuvole scure.Carrie, la madre di Sufjan, era psichica-
mente instabile, aveva una tendenza all’al-colismo e all’abuso di stupefacenti. Spari-
va per mesi, spess o vagabo ndan do. Ab- bandonò Sufjan all’età di appena un an no.Lui crebbe con il padre, ma ci furono alcu-ne estati, in Oregon, quando era ancoramolto piccolo, nelle quali la vide insiemeal patrigno, Lowell. Quando Carrie si sepa-rò anche da lui, Sufjan la perse di nuovo alungo.
Il disco è costruito sui resti dei pochimomenti con lei, senza sentimentalismo,senza rabbia, piuttosto con gli occhiasciutti di chi conosce da tempo la propriaferita. Scene, oggetti, frammenti, tutti ap-parentemente marginali, ma che nellascarsezza diventano leggendari: uno yo-gurt al limone, un posacenere caduto, unamattina al negozio di videocassette. Gli ar-
rangiamenti che Sufjan Stevens porta inconcerto sono più misticheggianti e insie-me più poderosi di quelli dell’album, mane rispettano l’introversione.
Per due ore, con inquietudine controlla-ta, Sufjan passa da uno strumento all’altroe talvolta accenna delle mosse di ballo, co-me un adolescente che prova i passi nellacamera chiusa a chiave. Il tastierista StevenMoore, con la barba bianca e le vesti ab-
bondanti , ass omiglia a un Baba. Tiene le braccia spalanca te verso le lu ci a rtificiali
per quasi tutto il tempo e anche lui riman-da alla prima infanzia di Sufjan, nella co-munità religiosa dove gli venne assegnatoquello strano nome persiano. Dawn Lan-des, eterea, intreccia alla voce di Sufjan lapropria e si muove nella penombra delpalco come un’incarnazione della sua ani-ma. È un concerto con un’atmosfera quasisoverchiante. In certi istanti sembra di per-
cepire davvero la presenza di Carrie, evoca-ta dall’aldilà con tutti i suoi disastri e an co-ra imprendibile. I versi che Sufjan cantasono tutti per lei, infestati di spettri.
Ricordo che una ventina di anni fa,quando l’elettronica iniziava a dilagarenelle produzioni musicali, serpeggiava iltimore che i bravi musicisti si sarebberopresto estinti. Ebbene, sembra essere ac-caduto il contrario. Esiste una schiera diartisti, ora nel pieno della loro maturità(insieme a Sufjan Stevens, altri comeRufus Wainwright, Ben Gibbard, Justin
Vern on e al me no tre mem br i de i Ra -diohead presi separatamente), che già gio-
vaniss imi non strimpe llavano , b ensì pa-droneggiavano una varietà di strumentidiversi, come se li avessero fra le mani dasempre. E che, nel frattempo, han no un’at-
tenzione costante all’ensemble, da vericompositori. Sono tutti dei secchioni, deiperfezionisti, tutti megalomani a loro mo-do. Ma quando accade che inciampino inun dolore pulsante dell’esistenza, comeSufjan Stevens alla morte di Carrie, sannogenerare dei miracoli di sensibilità. Im-mortali, è ciò che mi viene da dire. I forgi-ve you, mother, I can hear you/ And I long to be near you/ But every road leads to anend/ Yes, every road leads to an end.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’artistaSufjan Stevens, cantautore di
quarant’anni, è nato a Detroit,
e cresciuto in Michigan e inOregon. Il suo nome, diascendenza persiana, è legato
al movimento spiritualeSubud cui avevano aderito i
genitori. Stevens ha all’attivoundici album. L’ultimo disco è
Carrie & Lowell: rimanda findal titolo alla madre, Carrie,
da poco scomparsa, e alpatrigno Lowell Brams, ed è
composto da 11 tracce.Stevens sarà in concerto
lunedì 21 settembre al teatrodella Luna di Assago (Milano),
unica data italiana del tourmondiale che chiuderà la
parte europea a finesettembre. Riportiamo la
traduzione del testo con cui siconclude l’articolo di Paolo
Giordano: «Ti perdono, madre,
posso sentirti/ e ho tempoper esserti vicino/ ma ogni
strada porta ad una fine/ sì,ogni strada porta a una fine»
Le immaginiA destra: un momento del
concerto di Stevens al GranRex di Parigi (Getty Images).Sopra: Joel Sternfeld (1944),
Gresham, Oregon, giugno 1979( stampa a colori,
courtesy dell’artista)
i
L’evento è previsto nel 2016, dall’ 11 febbraioal 22 maggio, ma già se ne parla. Per celebrarei primi cento anni di «Vogue» Gran Bretagna laNational Portrait Gallery di Londra annunciauna grande mostra. Vogue 100, A Century of
Style esporrà 280 scatti dei più grandi artistiche hanno fotografato per la rivista dellaCondé Nast, tra i quali Mario Testino, DavidBailey, Irving Penn e Patrick Demarchelier.Immagini che hanno fatto la storia della moda.
Un secolo in «Vogue»
{Maschere MusicaScatti flessibili
di Fabrizio Villa

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 38/48
38 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
Maschere Cinema
Anteprima Il poemetto di Elio Pagliarani sugli anni del miracolo economico è diventato una pellicola chesarà proiettata al festival di Milano. Nel cast anche Elio delle Storie Tese oltre a disegni e scene di repertorio
di FRANCESCO CEVASCO
Q uesta è la storia di una dinoi. È la storia di La ragaz-za Carla. «Carla Dondi fu
Ambrogio, di anni/ dicias -sette, primo impiego ste-
nodattilo/ all’ombra del Duomo», co-me la descrive Elio Pagliarani, poeta.Per capirci qualcosa si comincia daqui, dal poeta. Lui, questa storia, ascriverla ci ha messo dal settembre1954 all’agosto 1957. Adesso questastoria è diventata anche un qualcos’al-tro di indefinibile. Film? Documenta-rio? Recita? Boh: chi la vedrà al prossi-
mo Milano Film Festival deciderà. Nelfrattempo si può provare a racconta-re...
Siamo nel primo dopoguerra. Il boom econ omi co sta per scop pia rema non ancora, quasi. L’ombelicod’Italia, comunque, è Milano. Qui si vi-
ve, o meglio, si sopravvive. Con il lavo-ro che bene o male si trova. Sottopaga-to, d’accordo, forse; certamente pagatopoco. Ma, in fondo, con 26 mila lire almese (più contingenza) ci puoi cam-pare. La ragazza Carla nasce in questomondo. La mamma poi sarà vedova.
La ragazza Carla è tornata:fa la dattilografa in un film
Per tirar su qualche soldo fa pantofole.Calde, spesse e sobrie, senza esagerarecon i fiocchetti che non servono aniente. Magari la signora Erminia(quella che ha l’alito che sa di liquore)le pagherà tra due anni ma pazienza.
Parole arrabbiateIntanto, però, Carla è cresciuta e con
due (sofferte) mila lire al mese può fa-re la scuola per imparare a scrivere amacchina (con dieci dita!). Ed eccoche, alle parole arrabbiate di Pagliara-ni, si sovrappongono le immagini del
film La ragazza Carla (parole arrab- biate perché il poeta per le ingiustiziesociali, si capisce, s’indignava). Non èproprio come il Pirellone del LucianoBianciardi di La vita agra che voleva
buttarlo giù con la dinamite, m a è co-munque un fallico simbolo del poteremaschile nel mondo del lavoro. Tantoche la nostra Carla trova sì lavoro, manon passa molto tempo che...
Quel bieco padrone della «Transeo-cean limited import export company»,il signor Praték, allunga su di lei nonproprio le mani, ma uno sguardo...
La barca scossa dalle onde, paura, buio, la vocedi tuo figlio che dice: «Non voglio andare inEuropa». Il regista olandese Morgan Knibbericostruisce l’approdo dei rifugiati. Il Nord vistoda Those who feel the fire burning , quelli che
sentono il fuoco bruciare (Milano Film Festival,giovedì 17, Spazio Oberdan, ore 19): «L’obiettivoera cercare di capire cosa provassero. Il desideriodi raggiungere la prospera Europa e la delusionesconvolgente nello scoprire che non c’è posto».
Il viaggio di chi sente il fuoco bruciare
{Terra stranieradi Alessandra Coppola
Le immaginiNella pagina accanto, due
fotogrammi del film La ragazza Carla , tratto
dall’omonimo poemetto diElio Pagliarani: il primo, in
alto, è una delle illustrazionirealizzate per la pellicola da
Gabriella Giandelli; ilsecondo, sotto, è un frame
tratto dal materiale direpertorio utilizzato per
ricreare la Milanodegli anni del boom
Immagini e volti per l’impiegata del boom

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 39/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 39
Ogni tanto si torna a esplorare i rapportifra jazz e romanzi «di genere» (KingsleyAmis lo fece con la fantascienza in Nuovemappe dell’inferno ). Ora Franco Bergogliopubblica per Arcana Sassofoni e pistole
(pp. 330, € 17,50), ricognizione sul noircondotta come l’indagine di un «occhioprivato». Cosa lega detective e jazzisti? Laricerca della verità. E la vitale necessità diimprovvisare.
Le pistole di un altro Bergoglio
{Note bludi Claudio Sessa
Uno sguardo sudato, malato. Unto co-me un ragno. Blasfemo come le sue
bestemmi e: si sen te autorizz ato dalsuo essere un Dio del lavoro, quelloche dà da mangiare alla gente; gli im-piegati gli devono essere riconoscentiperché li paga anche quando lui nonguadagna. Dice Carla: «Ho paura,mamma Dondi ho paura/ c’è un ragnoho schifo mi fa schifo alla gola/ io nonci vado più.// Nell’ufficio B non c’eranessuno/ mi guardava con gli occhiacquosi/ se tu vedessi come gli fa la
vena/ ha una vena che si muove sulcollo/ Signorina signorina mi dice/mamma non ci posso più stare/ è ve-nuto vicino che sentivo»...
Nel labirintoNel film queste e altre mille parole
risuonano attraverso la voce pacata,come deve essere, dell’attrice CarlaChiarelli, che sa vestirsi da «RagazzaCarla» senza tradire il suo, della ragaz-
za, talento (o maledizione) a farsi tra-scinare dall’onda del destino che a vol-te assomiglia a quei binari del tramche c’erano a Milano: storti e a curveche quasi non sai dove ti portino. Ov-
viamente questo film (ma è un f ilm?)ha un regista, Alberto Saibene. Lochiamano esordiente. Non si direbbedalla malizia con cui maneggia le im-magini delle signore in tailleur chedalle parti di piazza del Duomo a Mila-no salgono sulle 600 Fiat essendo co-strette a mostrare un poco le gambe. Odal gioco di quegli schizzi a colori chemacchiano il film (in bianco e nero)con astuti rimandi ad oggi.
Di schizzi, nella storia di Carla, omeglio, nel film che la racconta, ce nesono altri (chissà se al poeta sarebberopiaciuti). Alcuni sono veri spari nel bu-io. Siparietti di Elio (non Pagliarani maquello delle Storie Tese). Questo Elio sitraveste da giornalista che cura una ru-
brica tipo «La posta del cuore» per unimprobabile ebdomadario. C’è del ve-ro in quello che dice, c’è del comico ec’è — quello che gli viene meglio —del surreale. Ci porta in un labirinto
vagamente borgesiano che però non ciallontana troppo dalla storia di Carla.
Ma rieccola, Carla. Aveva detto allamamma che quel maiale schifoso delsignor Praték eccetera... Ma siamo nel-la Milano, nell’Italia, di quegli anni.
Dal ’45 al ’65. Quando un posto di lavo-ro valeva quanto e più di qualsiasi altracosa. E infatti scrive il poeta: «La vedo-
va signora Dondi/ forse si sarà spaven-tata/ ma non ha dato tempo a sua fi-glia/ Non ti ha nemmeno toccata/ glichiederemo scusa/ fin che non ne tro-
vi un altro/ tu non lascerai l’impiego».
Natalino Otto e Giorgio GaberNon c’è rivolta in Carla. C’è una ma-
linconica rassegnazione. C’è l’onda cheti culla, che ti spinge, di questa città.La Grande Città! La capitale morale,macché morale: economica d’Italia.Che ti frulla il cervello, ma hai l’im-pressione che ti ami. E nel film la vedi
bene.
Il poetaElio Pagliarani (1927-2012,
in alto) ha lavorato in ambitoeditoriale. Il poemetto La
ragazza Carla uscì sulla rivista«Menabò» nel 1960 e in
volume due anni dopo perMondadori. Il libro Tutte le
poesie (1956-2005), curatoda Andrea Cortellessa,
è edito da GarzantiIl film e la sorpresa
La ragazza Carla è interpretatoda Carla Chiarelli e Elio
(Stefano Belisario, qui sopra),regia di Alberto Saibene. Ilprogetto è di Luca Bigazzi,
Carla Chiarelli, CarlottaCristiani, Gianfilippo Pedote,Simone Pera. Il film è il titolo
a sorpresa del XX Milano FilmFestival, in corso fino al 20
settembre: giorno, luogo e oradella proiezione saranno
svelati via social e sul sitowww.milanofilmfestival.it
i
A metà settembre, quandoriaprono le scuole, nel no-stro Paese si ricomincia acantare e tre milioni di per-sone, distribuite tra migliaia
di cori, per due volte alla settimanariprendono a provare (dati singingeuro-pe.org ). Lo faranno per tutto l’anno,dedicandosi a repertori diversi — dallapolifonia rinascimentale al gospel, daicanti di montagna al pop, dalla musicadei compositori viventi al gregoriano…— e molti di loro si prepareranno perconcerti, scambi, piccole tournée omagari per esibizioni internazionali di
alto profilo, come quelle che hanno visto protagonisti i cori italiani al Festi- val Europa Cantat svoltosi lo scorsoluglio a Pécs, in Ungheria, dove 5 milacantori da tutto il continente si sonoradunati.
Ora, immaginate che quei tre milionidi persone tra qualche anno n on trovi-no più direttori di coro in grado di gui-darle, perché nessuno ha più potutofrequentare stage e seminari di perfe-zionamento. Immaginate che dalle loromani spariscano le partiture, perché alpiù grande editore di musica corale nelnostro Paese (che è un’associazioneno-profit) sono state tagliate le gambe.Immaginate che il Coro Giovanile italia-no, costituito da ragazzi di tutta Italia,formazione-bandiera che ci rappresen-ta all’estero, non esista più, perché lerisorse necessarie a pagare i viaggi dei
cantori per partecipare alle prove sonostate azzerate. Tocca purtroppo imma-ginare anche che il nostro Paese non siapiù rappresentato in seno alla federa-zione europea dei cori (Eca-Ec) e allafederazione mondiale (Ifcm), che nonpossa mai più organizzare un festivalinternazionale come quello di Torinonel 2012, che sparisca il Festival di Pri-mavera di Montecatini, al quale parteci-pano ogni anno centinaia di bambini eragazzi, che cessi la convenzione con laSiae per semplificare l’organizzazionedei concerti, che sospenda le pubblica-zioni la preziosa rivista «Choraliter» ecosì via.
È, purtroppo, ciò che accadrà nelprossimo futuro, se non viene trovatarapidamente una soluzione al drammache sta vivendo in queste settimane laFeniarco, Federazione nazionale italia-na delle Associazioni regionali corali, il
soggetto che, grazie al lavoro di trepersone e all’apporto di decine di vo-lontari, tiene in piedi il sistema coraleitaliano.
La chiusura, che è dietro l’angolo, viene imposta dall’azzeramento delcontributo ministeriale per i prossimitre anni, dopo che anche la Feniarco èstata inserita nel gruppo di soggettistorici della musica italiana non piùsovvenzionati per via dei nuovi criteri«oggettivi» che il ministero dei Beniculturali ha provato ad adottare, conrisultati unanimemente ritenuti scon-certanti. Ciò che preoccupa è che, men-tre la sparizione di un festival, di un’or-chestra, di una società di concerti la-sciano un vuoto immediatamente per-cepibile, la scomparsa di unafederazione di cori rischia di essereinvisibile. Non basta l’aver contribuitoper anni alla maturazione musicale delPaese: secondo i calcoli ministeriali, iltessuto sociale della coralità italiananon merita di essere mantenuto in vita,e dunque i 160 mila euro erogati loscorso anno (erano stati circa 130 miladal 1986 al 2013) sono stati cancellaticon un tratto di penna. Uno dei nostridirettori di coro più apprezzati, LorenzoDonati, da quando ha appreso la deci-sione del ministero dirige con il lutto al
braccio. Saremo costretti ad imitarlo?© RIPRODUZIONE RISERVATA
Discussioni Azzerati i fondi
Via la vocea tre milionidi coristidi NICOLA CAMPOGRANDE
Pagliarani e Saibene la descrivonocon lo stesso distacco appassionato:nelle parole del poeta le periferie chesono umane perché la gente ci vive,nelle immagini del regista quel biancoe nero d’archivio che non soffre la pol-
vere del tempo. Era già, un poco, la Mi-lano da bere: anche Carla prende l’ape-ritivo e «se lo mescola/ con un po’ di
vergogna/ e in tram le gira la testa».Si capisce che Pagliarani ieri e chi lo
rilegge oggi — in questo film, in que-sta recita, in questi disegni che com-paiono a sorpresa, in queste immaginidi vecchi fotografi, in queste spruzzatedi colore che illuminano la «pellicola»come un arcobaleno, in queste musi-che che sconfinano da Natalino Otto aGiorgio Gaber — Milano la amanodavvero, nonostante tutto. E nono-stante la dedica che il poeta mette intesta ai suoi versi: «Un amico psichia-tra mi riferisce di una giovane impie-gata tanto poco allenata alle domeni-che cittadine che, spesso, il sabato, siprende un sonnifero, opportunamen-te dosato, che la faccia dormire fino allunedì. Ha senso dedicare a quella ra-gazza, questa Ragazza Carla?».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dal 1945 al 1965Le signore in tailleur, le
600 Fiat in piazza delDuomo, le periferie, i tramSono state impiegate pure
immagini d’archivio

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 40/48
40 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
Richard McGuire collabora regolarmente con il«New Yorker». Le sue opere sono apparse sul«New York Times», su «McSweeney’s» e altrove.Ha partecipato come autore e regista ai filmLoulou et autres loups (2003) e Peur(s) du Noir(2007); ha inoltre ideato e prodotto una proprialinea di giocattoli ed è il fondatore, nonchébassista, della band Liquid Liquid. Su «la Lettura»del 7 giugno è uscita una sua conversazione conla scrittrice Valentina D’Urbano.
L’autore
(Graphic novel
di Richard McGuire
Ancora qui
Percorsi.
Racconti, date, biografie, inchieste, reportage
Mentalmente stiamosempre viaggiandonel tempo, tutti presidai ricordi del passatoe dalle proiezioni diquello che dobbiamofare. Ben di rado citroviamo realmentequi, «nel momentopresente». L’idea diquesto «qui» reale èdavvero fugace
La vita umana va eviene costantemente,scorre come unfiume. È questa lasensazione che voglio
dare al «tempo».Osservando il flussoinarrestabile deltempo, cogliamo unaprospettiva a lungoraggio nella quale lenostre vite appaionoassai piccole, doveognuno afferra il suo«momento» e recitala sua parte

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 41/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 41
(Di McGuire è uscito quest’anno in Italia ilvolume Qui (traduzione di Steve Piccolo, RizzoliLizard, pp. 304, 25), del quale la graphic novelinedita pubblicata in queste pagine è uno spinoff (i testi sono dello stesso McGuire, nellatraduzione di Rita Baldassarre). L’autore saràtra gli ospiti internazionali attesi al Lucca Comics& Games (dal 29 ottobre al 1° novembre) e alfestival internazionale del fumetto BilBolBul(dal 19 al 22 novembre a Bologna).
Il libro e gli appuntamenti
Volevo che si leggessecome una poesia,come un’unica voce
Cerco di cogliere queimomenti casuali incui ci si ritrovaesposti, indifesi. Lamia ricerca punta qui:
registrare questipiccoli momenti. Ilmio motto è «renderepiccole le cose grandie grandi le piccole».In ultima analisi,vorrei trasmettere«musicalità» nelritmo delle pagine.Nei momenti di calodi tensione, in queimomenti intermedi e
transitori, ecco, qui miè sembrato di trovareil senso della «vita».Non è mio scopo daregiudizi sulla società,anche se questo mipare inevitabile

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 42/48
42 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
ri da svolgere. Nessun carcerato è mai evaso da Aquila Ne-ra e sono in pochiss imi ad averci provato. «Solo i più forti
riescono a sopravvivere in queste condizioni, quelli chesono più forti mentalmente», dice a «la Lettura» Vladimir Eremeev, 64 anni, condannato per omicidio, che ha tra-scorso più di 40 anni nelle prigioni sovietiche e russe.«Un terzo degli ergastolani impazzisce. Tutti gli altri san-no che usciranno di qui solo nella cassa da morto».
Nel 2000 sono stato il primo giornalista straniero adavere accesso ad Aquila Nera. Di recente, dopo oltre seimesi di trattative per concordare un permesso dalle auto-rità della prigione, ho fatto ritorno in compagnia di Nick Read, un regista pluripremiato, e una troupe televisiva.
Insieme, abbiamo trascorso 21 giorni all’interno del pe-nitenziario per realizzare I Condannati, un documentariosu alcuni dei prigionieri rinchiusi in quel mondo desola-to. Nessuna troupe straniera ha mai ottenuto il permessodi restare così a lungo, e senza vincoli di sorta, in una pri-gione russa, tantomeno in una fortezza impenetrabile eremota come Aquila Nera. Abbiamo intervistato oltre 50detenuti sui loro delitti e castighi, e tra que sti abbiamo se-lezionato sei prigionieri, ai quali abbiamo chiesto di rac-contare la loro storia. Abbiamo provato a esplorare comecambiano la mente e l’animo di un uomo, quando resta
segregato in una cella di quattro metri quadrati per 23 oreal giorno per decenni. Quale speranza resiste, quandoogni speranza è morta? A che cosa si aggrappa un uomo,quando viene spogliato di tutto? Esiste il pentimento, esi-ste la redenzione? E perché taluni carcerati sostengonoche la pena di morte sarebbe una punizione più umana emisericordiosa della condanna a vivere ad Aquila Nera?
In Russia la pena capitale è rimasta in vigore fino al1996, quando il presidente Boris Eltsin la revocò per con-sentire al Paese l’ingresso nel Cons iglio d’Europa. Nell’erasovietica, i criminali come quelli incarcerati ad Aquila Ne-ra venivano giustiziati con un colpo alla nuca e seppellitiin segreto in tombe senza nome. Quando venne varata lamoratoria, il governo fu costretto a decidere sul destinodei detenuti richiusi nel braccio della morte in attesa diesecuzione capitale. Scelse di risparmiar loro la vita e dicommutare la sentenza in 25 anni di reclusione. Sono tra-scorsi 19 anni da allora e oggi restano solo 170, degli anti-chi condannati a morte, a scontare la loro pena in un car-cere di massima sicurezza, e sono tutti rinchiusi ad AquilaNera. Gli altri 90 prigionieri nella prigione sono stati con-dannati all’ergastolo per omicidio, dopo la sospensionedella pena di morte. Non tutti i detenuti nel braccio dellamorte hanno reagito con sollievo alla notizia che gli erastata risparmiata la vita, in cambio di 25 anni di carceredurissimo. Per alcuni, la prospettiva si è rivelata insop-portabile. «Sono stato l’ultimo — dice Eremeev — ad ave-re la condanna commutata. Quando uno dei carcerati cheera con me nel braccio della m orte ha visto il decreto pre-sidenziale che trasformava la pena di morte in 25 anni direclusione... cinque minuti dopo si è impiccato. Un altrolo ha fatto tre giorni dopo, con le mutande. Il terzo si èconficcato un arnese nel cuore. Pensa che coraggio, tra-figgersi a morte. Se mi avessero giustiziato, mi avrebbero
faccia su un fossato, dove gli uomini vuotano i secchi diescrementi. La puzza è insopportabile. Le celle degli erga-
stolani sono di dodici metri quadrati, da condividere indue, oppure quattro metri quadrati per una sola persona.Le celle più piccole sono talmente anguste che basta ap-poggiare la spalla a una parete e tendere un braccio per toccare la parete opposta. Finire rinchiusi là dentro anchesolo per qualche istante dà la sensazione di essere sepolti
vivi. Ai detenuti è consentito fare la doccia una sola voltaalla settimana. Durante i primi dieci anni di carcerazione,gli ergastolani possono ricevere un piccolo pacco ogni 12mesi e due visite all’anno, ciascuna per quattro ore al mas-simo, dietro un vetro spesso. Non è ammesso nessun con-tatto fisico.
Aquila Nera è talmente iso lata, e i parenti dei de tenutisono per la maggior parte talmente indigenti, che alcuniprigionieri qui non vedono un parente da 18 anni. I dete-nuti hanno a disposizione un televisore e qualche libro.Possono tenere con sé qualche effetto personale e spen-dere fino a 700 rubli (9 euro) al mese nello sp accio del car-cere. Durante il giorno è vietato restare distesi sul letto e,tranne che per qualche raro privilegiato, non ci sono lavo-
Una troupe ha trascorso tre settimane nella prigionepeggiore della Russia. I suoi 260 detenuti hanno ucciso
complessivamente 800 persone. Viaggio ai confini delladisperazione, dove però si accendono lampi di umanità
Noi non ci pentiamoTra i dannati del carcere Aquila Nera«Meglio morti: non si può cambiare»da Lozva (Russia) MARK FRANCHETTI
Percorsi Geografie
Mosca
RUSSIA
Yekaterinburg
M o n t
i U
r a l i
LozvaLozva
Nel cuore profondo della Russia, circondata daforeste impenetrabili più grandi della Germa-
nia, si trova una prigione che non ha uguali.La zona un tempo ospitava i famigerati gulag.Denominata Colonia 56 dalle autorità, tra i
detenuti e i bassifondi criminali è conosciuta come Aqui-la Nera. È un carcere solo per assassini. Sono 260 uomini,i detenuti. Collettivamente, hanno ucciso oltre 800 perso-ne. Dietro le sue mura ci sono terroristi, sadici, psicopati-ci, omicidi seriali, stupratori che hanno ammazzato le lo-ro vittime, sicari della mafia russa, assassini di bambini,esponenti della malavita organizzata. Ci sono anche uo-mini che hanno ucciso in un raptus di follia o in preda al-l’alcol. Sono considerati i criminali tra i più pericolosi ditutto il Paese. Per loro, Aquila Nera rappresenta la finedella corsa, un pozzo buio senza ritorno.
Le condizioni di vita, dietro le cinque recinzioni sor-montate da filo spinato, le torrette di sorveglianza e le pat-tuglie dotate di cani poliziotto, sono le più repressive con-sentite dalle istituzioni penitenziarie, e il regime carcera-rio di Putin, come tante altre cose nel suo Paese, non la-scia scampo. Il senso di lontananza e di isolamento dalmondo esterno è drammatico esconvolgente. Prima della co-
struzione di una nuova strada,qualche anno fa, la prigione sitrovava a 14 ore di macchina d allacittà più vicina, Yekaterinburgnegli Urali. Ancora oggi occorro-no 8 ore di percorrenza. Se si pro-
viene dalle regioni più lontane, si viaggia in treno per giorni.
La sensazione di lontananza èinasprita dal fatto che Aquila Ne-ra è circondata interamente daforeste, un oceano verde che siestende per centinaia di chilo-metri in tutte le direzioni. Gli in-
verni fred diss imi dura no settemesi l’anno. Le temperaturescendono fino a 45 gradi sotto ze-ro e la regione resta sepolta sotto3 metri di neve, sprofondata nel
buio e sfer zata dall e bufe re di vento che scendon o d all’Artic o.Le brevi estati sono soffocanti einfestate di zanzare.
La prigione, un insieme di edifici fatiscenti risalenti al-l’era sovietica, non dispone ancora di fognature. I detenu-ti utilizzano dei secchi nelle loro celle, che poi svuotanoall’esterno una volta al giorno. Una linea telefonica per ildirettore è stata installata solo qualche anno fa. Nel fab-
bricato che ospita gli ergastolani, una fortezza di mattonirossi a due piani, costruita negli anni Sessanta, i prigio-nieri sono costretti a restare nelle loro celle 23 ore al gior-no. L’unica ora d’aria al giorno si trascorre in un minusco-lo cortile, da soli o a coppie. Attraverso le maglie della re-cinzione metallica si vede solo il cielo. Ogni cortile si af-
Il luogoLa prigione russa Colonia 56,
conosciuta con il nome diAquila Nera, si trova negli
Urali, 400 chilometri a nord diYekaterinburg e a quasi
2.500 chilometri a nord estdalla capitale, Mosca. Per
raggiungere la prigione, daYekaterinburg, occorrono 8
ore di viaggio in auto.Attualmente vi sono rinchiusi
260 detenuti. Durantel’inverno le temperature
scendono fino a meno 45gradi centigradi
Le immaginiA fianco: un secondino di
guardia; nella pagina accanto,dall’alto: detenuti all’interno eall’esterno del carcere; laporta di una cella con le
indicazioni del prigioniero
i

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 43/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 43
con i loro piatti e posate. Gli altri non si degnano di strin-gere loro la mano né di accettare alcunché da loro, nem-
meno una sigaretta. Uno degli emarginati è Andrei Lebe-dev, che nei primi anni Novanta ha stuprato e ucciso unaragazza e ha passato sei anni nel braccio della morte, per poi vedersi commutare la pena in 25 anni di carcere. Qual-che anno fa la vittima di uno stupro gli ha scritto, nel ten-tativo di scavare nella mente di uno stupratore e assassi-no. I due hanno tenuto in vita una corrispondenza, dallaquale è nata un’amicizia che ha portato al loro matrimo-nio dietro le sbarre.
A diff eren za deg li erg asto lani di Aqui la Nera , agli«scampati» sono concesse visite coniugali in una foreste-ria tenuta sotto chiave. Lebedev e la moglie hanno avutoanche due figli, un maschio che oggi ha nove anni e unafemmina di sette. Il padre gli ha parlato per telefono, manon li ha ancora incontrati di persona: tro ppo giovani per
visitare la prigione. Non gli è stato ancora detto per qualemotivo il padre si trova dietro le sbarre. Nel fabbricato de-gli ergastolani, dove i detenuti possono vedere un con-giunto per un totale di 8 ore l’anno (le visite qui sono an-cor più rare che nel settore degli «scampati»), abbiamofilmato due riunioni. La prima tra Maksim Kiselev e suamadre. Un sociopatico, Kiselev si ricorda soltanto di es-
sersi ubriacato, di aver iniziato una rissa e di essersi sve-gliato con un coltello in mano e 6 persone a terra, tra lequali anche una donna e un bam bino di 10 anni. La donnanon vedeva il figlio da cinque anni e aveva percorso 8 milachilometri, tra andata e ritorno, per potergli parlare per 4ore dietro un divisorio di vetro spesso. In lacrime, diceche sarà l’ultima volta che vedrà suo figlio, perché non ha isoldi per rifare il viaggio.
«Se tu fossi rimesso in libertà, saresti un pericolo per lasocietà?» chiedo a Kiselev, 33 anni, che preferisce restarechiuso in una cella singola da quattro metri quadrati, do-
ve s oprav vive sepol to in un suo mondo immag inari o.«Certo che lo sarei — mi risponde senza esi tare —. Vedreila gente che si gode la bella vita e vorrei farlo anch’io. Maio non ho mai lavorato. Allora mi metterei a rubare, aubriacarmi e ad ammazzare di nuovo. Perché se hai uccisouna volta, ucciderai ancora».
Ho imparato ad apprezzare l’onestà brutale con la qualesi sono aperti a me per parlare dei loro reati, rimpianti,redenzione, mancanza di rimorsi, libertà e famiglia, paz-zia e speranza. «Io ho ucciso, come faccio a pentirmi?»,dice Eremeev, il vecchio detenuto con più di 40 anni dicarcere sulle spalle. «Che senso ha parlare di pentimento?Come fanno assassini e sadici come noi a chied ere perdo-no? Un uomo che ha ammazzato 3 o 4 persone, che ha am-mazzato donne e bambini — che senso ha il pentimento?Nessuno cambia. Una volta tornato libero, un uomo po-trebbe anche non commettere più reati e condurre una vi-ta normale, ma quello non è pentimento. Se vuoi davveropentirti, vai a spararti oppure prendi una corda e impicca-ti. Quello sì che sarebbe pentimento per i tuoi peccati. Èsolo davanti a Dio che ci pentiremo. Nell’altro mondo».
(traduzione di Rita Baldassarre)© RIPRODUZIONERISERVATA
risparmiato tutta questa tortura e questa angoscia. Scon-tare 25 anni non è una sensazione piacevole, nemmeno
per uno come me».Gli ergastolani condannati dopo la moratoria del 1996sono rinchiusi in celle, mentre gli antichi condannati amorte, ai quali è stata risparm iata la pena capitale, vivonoin comunità, in una vecchia caserma di legno, costruita inepoca sovietica. Gli «scampati», come vengono chiamatigli antichi condannati a morte, dormono in stanzoni so-
vraffollati, mangiano in mensa ma — soprattutto — han-no il permesso di passeggiare all’aperto e godersi un po’di sole e di aria fresca. I detenuti malati di tubercolosi so-no isolati in un edificio a parte. Il regime più mite accor-dato agli ex condannati a morte è semplicemente il risul-tato di incongruenze legali, scaturite dalle modifiche ap-portate al codice penale sovietico quando i l Paese si lasciòalle spalle il regime comunista. Le differenze non rifletto-no la convinzione, tra le autorità, che i detenuti «scampa-ti» siano meno pericolosi degli ergastolani, né i loro cri-mini meno raccapriccianti. «Sono tutti uguali, hannocommesso reati inenarrabili», dice Subkhan Dadashiov,direttore di Aquila Nera dal 1986. «Sono qui da 29 anni enon ho mai provato compassione per nessuno di loro.Francamente, preferivo la pena di morte. Se qualcuno
non mi capisce, vuol dire che non ha mai guardato negliocchi uno di questi assassini. Per me la pena di morte èl’unica soluzione».
Dadashiov, 53 anni, vive in una casetta di leg no a pochecentinaia di metri dal perimetro del penitenziario, in unpaesino di meno di 200 abitanti, per la maggior parteguardie carcerarie. Dalla sua stanza da letto gli giunge ilronzio dei sensori del perimetro esterno. Insieme allamoglie ha allevato tre figlie in questo cupo isolamento equando gli ho chiesto se, dopo quasi tre decenni, non fos-se diventato anche lui un carcerato, ha sorriso, sfoggian-do due incisivi d’oro. «Sono arrivato qui che avevo 24 an-ni, adesso ne ho 53, niente male. Perfino gli ex condanna-ti a morte fanno solo 25 anni, io ne ho fatti 29. Buffo, no?Ci scherzo su, dicendo che loro sono arrivati con una con-danna, io con un contratto. Quando siamo arrivati q ui, al-l’inizio, mia moglie mi ha fatto una sola domanda m entreci inoltravamo sempre più nella foresta: perché non ci so -no macchine che viaggiano in direzione opposta?».
La prigione è talmente isolata che quando la sua vec-chia Volga sovietica è in panne, Dadashiov non ha altrascelta che farsela aggiustare dagli ex condannati a mortenel cortile del carcere. Il direttore si fa tagliare i capelli dal
barbiere del penitenziario che, in un raptus di gelosia, haammazzato moglie e suocera. Si fa servire i pasti in ufficiodal suo «maggiordomo», un uomo sulla sessantina, paca-to e cortese, che ha ammazzato sei persone e che mi ripe-te, in tono paterno, che non mangio a sufficienza.
I detenuti si attengono a una severa gerarchia e a un in-sieme di tacite regole assai complesse. In fondo alla gra-duatoria ci sono gli «emarginati», ovvero coloro che han-no ucciso donne e bambini, oppure hanno commess o cri-mini a sfondo sessuale. Nella palazzina degli «scampati»,costoro dormono in disparte e mangiano al loro tavolo,
Un affresco di camere dell’infanzia. Come inun sogno ritrovano fisicità i genitori e lanonna, riappaiono oggetti, specchi, mobili, sisentono gli odori della cucina e del pane nellaraccolta Stanze con case di Letizia Dimartino
(Giuliano Ladolfi, pp. 84, 10). Nata a Messinanel 1953, sull’onda dei ricordi l’autrice meditasulla fragilità umana e sull’incalzare di untempo fugace allora e così adesso, mentre iversi diventano melodie e preghiere.
Melodie e preghiere
{Sogliedi Franco Manzoni
Il reportageCorrispondente da Mosca del
«Sunday Times», ilgiornalista Mark Franchetti
aveva visitato la prigionerussa Aquila Nera nel 2000.
Un anno fa vi è tornato e si èfermato per tre settimane per
girare un documentario, The Condemned . Oltre a
Franchetti, produttore, hannolavorato al documentario
anche il regista e direttoredella fotografia Nick Read,
l’editor Jay Taylor, icompositori Smith & Elms e il
fotografo Dmitry Beliakov,autore delle immagini qui
pubblicate (www.thecondemneddoc.com). Lagallery completa delle foto è
sul sito online de «la Lettura»www.corriere.it/la-lettura
i

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 44/48
44 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
G
oethe ha osservato che bisogna fare molta at-tenzione a ciò che si vuole diventare da gran-de, perché si può finire per riuscirci. Natural-mente ha ragione, ma cosa succede con ciò
che non si vuole in alcun modo diventare dagrande? Non bisogna forse stare attenti anche a quello?Non si può forse finire per riuscirci, proprio perché lo si
voleva evitare?Questa storia tratterà di una questione terribilmente
passata di moda; così passata di moda che in realtà nonso nemmeno bene come formularla: «la responsabilitàdello scrittore» suona pomposo, sebbene non più che«l’attualità della figura dell’intellettuale»; «l’impegnodello scrittore» o «la letteratura impegnata» suonanoantidiluviane. In realtà, tutte queste espressioni comin-ciavano a suonare pompose e antidiluviane già trenta-cinque anni fa, quando io ne compivo diciotto e quando,proprio la settimana successiva, nella sua casa di rue Ed-gar-Quinet, nel quartiere di Montparnasse a Parigi, mo-riva Jean-Paul Sartre, forse il grande intellettuale france-se del XX secolo e senza dubbio la perfetta incarnazionedello scrittore impegnato. Per me, però, allora Sartre erail contrario di uno scrittore, o almeno il contrario delloscrittore che sarei voluto diventare.
Non è difficile spiegare i motivi di quell’avversione.Nel 1980, cinque anni dopo la morte di Franco, io ero unadolescente dell’Estremadura trapiantato in Catalognache aveva trascorso la propria infanzia cattolica guar-dando la televisione, giocando a tennis e leggendo ro-manzi d’avventura e libri di storia, e che in qualche mo-mento aveva deciso, per puro istinto, di combattere leangosce dell’adolescenza e lo sconcerto dello sradica-mento sostituendo la letteratura alla religione e abban-donando tutto o quasi tutto per lei, compresi la televi-sione e il tennis; la mia famiglia non era libresca, io nonconoscevo nessuno scrittore e, sebbene condividessi leletture con alcuni amici del quartiere, ero privo di consi-glieri, sicché sul mio comodino si alternavano, in un di-sordine totale, Dostoevskij e Oscar Wilde, Melville eThomas Mann, Isaac Asimov e J. R. Tolkien, Edgar AllanPoe, Hermann Hesse e gli scrittori del modernismo spa-gnolo: Unamuno, Azorín, Baroja, Valle-Inclán, AntonioMachado. Finché non scoprii Borges. E poi Kafka. E su-
bito dopo un nume roso gru ppo di g randi nar ratori lati-noamericani: da García Márquez a Vargas Llosa, da Cor-tázar e Rulfo a Bioy Casares e Cabrera Infante. E comin-ciai a sognare — vagamente, timidamente: era come so-gnare di diventare astronauta — di diventare scrittore.
Uno scrittore , come ho detto, molto diver so da Sartre,se non del tutto opposto. E dire che a quei tempi cono-scevo a stento l’opera di Sartre: avevo visto rappresentatealcune delle sue opere teatrali, che non mi erano piaciu-te; avevo letto con più sforzo che piacere i tre volumi deLe vie della libertà e, con più piacere che sforzo, La nau-sea e Le parole; avevo anche letto alcuni dei suoi saggi,ma non i suoi grandi libri filosofici, e avevo a stento sfo-gliato Che cos’è la letteratura?, forse convinto che non
mericano, come Italo Calvino). Il mio eroe era Borges,che sembrava ignorare con olimpico intellettualismo lapolitica e la realtà, indifferente alla storia, rinchiuso nel-la sua biblioteca infinita. Il mio eroe era Kafka, così di-
sinteressato a quanto non fosse la lucidità vertiginosadei propri incubi, così assorto in essi che il 2 agosto del1914, dopo aver saputo che si era appena scatenato unterremoto bellico che avrebbe cambiato la faccia dellaTerra, se ne andò tranquillamente a nuotare prima discrivere quella sera sul suo diario: «La Germania ha di-chiarato guerra alla Russia. — Pomeriggio, lezione dinuoto».
Tutto questo era o sembrava essere agli antipodi diSartre, della figura dell’intellettuale e della letteraturaimpegnata, o almeno dell’idea che io ne avevo allora.Detto ciò, è naturale che i miei due primi romanzi, Il mo-vente e L’inquilino, possano essere letti come libri quasiprototipicamente postmoderni, e non sorprenderà chenel 1987, quando venne pubblicato il primo, me ne an-dai negli Stati Uniti con la segreta intenzione di diventa-re uno scrittore nordamericano postmoderno; non sor-prenderà nemmeno il fatto che, come qualunque giova-ne scrittore o aspirante scrittore, in quel periodo io lot-
t a s s i p e r c o s t r u i r m i u n a t r a d i z i o n e p r o p r i a ,esclusivamente mia, e che, a quello scopo, facessi la tesidi dottorato su un singolarissimo scrittore spagnolo, al-lora molto più noto come cineasta che come scrittore,un radicale e isolato pioniere letterario, il primo scritto-re postmoderno del mio Paese: Gonzalo Suárez; né, na-turalmente, sembrerà strano che, negli anni Novanta,ironizzassi a mansalva sugli scrittori e intellettuali impe-gnati, al punto che non mi sarebbe costata alcuna faticasottoscrivere le parole scritte da Tony Judt alla fine di unduro saggio sull’irresponsabilità e l’immoralità dei gran-di intellettuali francesi del primo dopoguerra, a comin-ciare da Sartre: «Un rifiuto di occupare il posto dell’intel-lettuale è forse il più positivo dei passi che possonocompiere i pensatori moderni nel loro impegno per giungere a un accordo con la propria responsabilità nelnostro passato recente e comune».
Quello che invece sorprenderà è una cosa che accaddea metà del 2001. Agli inizi di quell’anno era stato pubbli-cato il mio quarto romanzo, Soldati di Salamina, e a set-tembre Mario Vargas Llosa pubblicò un esagerato elogiodel libro, che mi lasciò perplesso. Ciò che mi lasciò per-plesso non fu, è chiaro, l’elogio in sé, per quanto esage-rato; come scrisse Jules Renard, «quando qualcuno mifa un elogio, non c’è bisogno che me lo ripeta due volte:lo capisco al primo colpo». No: ciò che mi lasciò per-plesso fu il motivo principale dell’elogio. In effetti, allafine dell’articolo Vargas Llosa affermava: «Chi credevache la cosiddetta letteratura impegnata fosse morta develeggerlo (Soldati di Salamina) per sapere quanto è viva,quanto originale e arricchente possa essere nelle manidi un romanziere come Javier Cercas». Io non conoscevopersonalmente Vargas Llosa, però era uno degli eroi let-terari della mia gioventù e — soprattutto dopo quell’ar-
Percorsi Il racconto
In principio furono la provincia e letture voraci, da Dostoevskij a Tolkien. Soprattuttol’avversione per Sartre, «mandarino arbitrario e dispotico», e per la sua idea di letteratura Un incontro con Vargas Llosa cambiò la mia visione. Ma la rivelazione avvenne altrove
L’impegnodanza il pasodoble
in Giapponedi JAVIER CERCAS
Lo scrittore spagnoloJavier Cercas è nato aIbahernando, inEstremadura, nel 1962. Giàdocente universitario, haraggiunto il successointernazionale come autoredi romanzi di contenutostorico e civile, nel 2001, conSoldati di Salamina (edito da
Guanda nel 2004). Tra leopere, La velocità della luce(2006), Anatomia di unistante (2010) e il recenteL’impostore , tutte per Guanda
Pubblichiamo in queste paginela prima delle tre parti di unracconto di Javier Cercas.Le altre due saranno onlinesul sito de «la Lettura»www.corriere.it/la-lettura
avesse il minimo interesse. Perciò quello che mi infasti-diva di Sartre non poteva essere la sua opera, per quantomi annoiasse o mi disgustasse; quello che mi infastidivaera la sua figura, o meglio l’idea che, in modo un po’ ap-
prossimativo o impressionistico, mi ero fatto di lui dallamia impreparata periferia di ragazzo di provincia: unmandarino arbitrario e dispotico, più noto per le sue ca-pricciose virate politiche e per il suo sostegno a regimitotalitari che per la sua opera letteraria, un tiranno intel-lettuale, solenne e presuntuoso, un noioso scrittore rea-lista di seconda categoria che, per disgrazia della lettera-tura, ma anche della politica, predicava l’obbligo di su-
bord inar e la lette ratu ra alla poli tica. Non cono scevotroppo bene la traiettoria intellettuale e politica di Sar-tre, ma quella era la penosa e succinta idea che avevo dilui, e, siccome Sartre era il prototipo dell’intellettuale edello scrittore impegnato, per me gli scrittori impegnatie gli intellettuali erano come lui: individui a cui impor-tava pochissimo la letteratura (o a cui importava moltomeno della politica, supponendo che fossero interessatialla politica), gente frivola e irresponsabile che parlavadi tutto senza conoscere nulla, arrivisti che usavano le
buone cau se per f are carrie ra lettera ria e che firmavanosenza sosta manifesti inutili e nascondevano la loro in-capacità letteraria e il loro disprezzo per la letteraturadietro la loro ipocrita frenesia di attivisti.
Era, insisto, il contrario di ciò che volevo essere. Macosa volevo essere? Che tipo di scrittore aspiravo a emu-lare? Che tipo di letteratura sognavo di scrivere? Non loso con esattezza, perché si sa ciò che si vuole scriveresoltanto quando lo si è già scritto. Però è curioso: nel1980, l’anno della morte di Sartre, John Barth pubblicòsu «The Athlantic Monthly» un saggio intitolato The Li-terature of Replenishment (Postmodern Fiction); io lolessi soltanto tre anni più tardi, quando Quim Monzó —colui che introdusse il postmodernismo narrativo in Ca-talogna — lo tradusse in catalano insieme a un altro sag-gio di Barth, precedente ma collegato a questo, in cui loscrittore statunitense parlava soprattutto di Borges: TheLiterature of Exhaustion.
In ogni caso, io lessi quei due testi quasi come un ma-nifesto di una nuova letteratura: la letteratura postmo-derna. Era quella la letteratura che volevo scrivere? Cre-do di sì. E com’era quella nuova letteratura? Ho già dettoche non mi era troppo chiaro e, per fortuna, nemmenoBarth lo chiariva troppo; sapevo o intuivo soltanto chedoveva essere antirealista, antisolenne, antisentimenta-le, ironica, metaletteraria, irriverente, perfino cinica; e,inoltre, che doveva concepire se stessa come un gioco,anche se, siccome continuavo ad avvertire che la lettera-tura era una cosa assolutamente seria, il gioco dovevaessere un gioco in cui ci si giocava tutto; soprattutto, eper quanto mi interessassero la politica e la storia, dove-
va essere una letter atura pur a, libera da ades ioni po liti-che e concessioni ideologiche. I miei eroi erano i narra-tori latinoamericani, a patto che dimenticassero il lorodebito verso Sartre e il loro impegno politico, o a pattoche li estirpassero dai loro romanzi. I miei eroi erano inarratori postmoderni nordamericani elogiati da Barth,compreso lo stesso Barth (e anche qualcuno non norda-

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 45/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 45
ticolo che contribuì in maniera decisiva a trasformare inun best seller un libro destinato ad avere una manciatadi lettori, e che mi fece diventare uno scrittore professio-nale — ero più che mai pronto a sorvolare sulla sua leal-tà a Sartre e alla letteratura impegnata, e perfino sullasua eminente condizione di intellettuale. Però, Dio san-to, pensai leggendo quella frase tremenda con cui termi-nava l’articolo, adesso viene fuori che anch’io sono unoscrittore impegnato? Com’è possibile cadere così in bas-so? È questo il prezzo del successo?
Così, qualche giorno dopo, esattamente l’11 settembredel 2001, quando conobbi Vargas Llosa, la prima cosache feci fu ringraziarlo per il suo articolo, ma la secondafu ricordargli che mi aveva definito scrittore impegnato.«Ci vediamo fuori» aggiunsi. Vargas Llosa si mise a ride-re. Eravamo seduti in «un ristorante pieno di fantasmi»,come lui stesso scrisse anni dopo, «in una strana sera incui Madrid sembrava essere rimasta deserta e come inattesa dell’annientamento nucleare»; quando smise diridere, lo scrittore peruviano mi spiegò cosa intendesse,a quel punto, con letteratura impegnata. Ciò che disse fupiù o meno la stessa cosa che in realtà aveva già detto nelsuo articolo: impegnata era, per lui, la letteratura chenon è un mero gioco né un semplice passatempo, la let-teratura seria, quella che rifugge dal facilismo e osa af-frontare, con la massima ambizione, grandi questionimorali e politiche. Chiesi a Vargas Llosa di farmi unesempio attuale di scrittore impegnato; me ne fece due,che a quell’epoca conoscevo soltanto di nome: il sudafri-
grazie all’amore e alle cure della madre e del padre, nonsoltanto è vivo ma è un prestigioso compositore musica-le. Così Oe, a q uanto raccontò quel giorno a Tokio, do-mandò al figlio cosa fosse un pasodoble, anche se il fi-glio non poté aiutarlo molto, perché a lui interessa sol-tanto la musica classica. Alla fine, non ricordo come, Oescovò un pezzo con un ritmo di pasodoble nella primaparte del preludio della Carmen, di Bizet, prese sua mo-glie e, nel salotto di casa, si mise a ballare quella stranamusica con lei, sotto lo sguardo del figlio Hiraki, comel’aveva ballata, o come immaginava che l’avesse ballata,in un bosco remoto di un paese remoto, settant’anni pri-ma, il soldato repubblicano del mio romanzo. «È questala letteratura impegnata» concluse Oe. «Una letteraturache t’impegna interamente, una letteratura in cui si vie-ne talmente coinvolti che non soltanto la si vuole legge-
re, ma anche vivere».Non posso assicurare che fossero esattamente quellele parole di Oe; posso assicurare che l’idea era esatta-mente quella. Almeno a partire dal mio spettrale 11 set-tembre 2001 con Vargas Llosa a Madrid, io intuivo che misbagliavo, che bisognava riformulare tutto — special-mente l’idea della letteratura impegnata, ma anchequella dell’intellettuale —, che bisognava tornare all’ini-zio; quel giorno a Tokio, con Oe, capii che era impre-scindibile farlo.
(traduzione di Bruno Arpaia)© JAVIER CERCAS
Trasformare il dolore in qualcosa di prezioso.Ricucire una ferita senza nasconderla. Anzi,valorizzarla con il metallo più importante. È ilconcetto alla base del kintsugi , tecnicaartistica giapponese che usa l’oro liquido o in
polvere (a volte anche l’argento) per ripararee saldare gli oggetti di porcellana caduti infrantumi. Le linee di sutura si chiamanokeshiki , paesaggio, perché cambiano come lanatura. Una nuova bellezza.
L’arte di ricucire le ferite
{Sushi styledi Annachiara Sacchi
Il libroDi Javier Cercas è da poco
uscito per Guanda il romanzoL’impostore
(traduzione di Bruno Arpaia,pagine 416, € 20). Il libroracconta la storia di Enric
Marco, sedicente militanteantifranchista e combattente
della guerra civile spagnola,smascherato nel 2005 da
uno storico: non ha mai
partecipato alla guerra e nonè mai stato prigioniero nel
lager. La vicenda è l’occasioneper Cercas di sperimentare
una narrazione che è fictionnella fiction, per raccontare i
diversi piani di realtà emenzogna del personaggio
L’appuntamentoNell’ambito dell’iniziativa
Officina Expo a Milano (unciclo di incontri che proseguenel periodo di Expo il festival
Officina Italia), a cura diAlessandro Bertante e
Antonio Scurati, uno degliappuntamenti in programma
è la lectio magistralis conJavier Cercas. La lezione dello
scrittore spagnolo si svolgelunedì 14 settembre al
Castello Sforzesco e ha cometema Il futuro degli intellettuali (ore 18.30,
ingresso libero fino aesaurimento posti)
La rassegnaLa caratteristica della
rassegna è che le conferenzedegli autori si terranno in
luoghi scelti dal Comune diMilano come simboli della
città e saranno associate auna delle grandi opere d’arte
che vi sono ospitate. Nel casodi Cercas, la lectio del Castello
Sforzesco avrà come sfondola Pietà Rondanini di
Michelangelo. I prossimiincontri saranno
il 24 settembre con PaulPreciado al Museo del
Novecento davanti al Concetto
spaziale di Lucio Fontana e il15 ottobre con AlessandroBaricco davanti all’Ultima
Cena di Leonardo
i
cano J. M. Coetzee e il giapponese Kenzaburo Oe.Che io ricordi, quella sera non parlammo più della
faccenda. Tuttavia, negli anni successivi Coetzee e Oe di- vennero due autori impor tanti per me. Li co nobbi en-trambi personalmente, ma non ebbi mai l’occasione dichiedere a Coetzee se si ritenesse uno scrittore impe-gnato e cosa intendesse lui con letteratura impegnata;invece una volta mi decisi a chiedere a Oe — che avevafatto la tesi di dottorato su Sartre, che aveva importato laletteratura impegnata in Giappone e che è forse il più in-fluente intellettuale giapponese — cosa fosse per lui laletteratura impegnata. Accadde durante un dialogopubblico che avemmo a Tokio, nell’autunno del 2010; lasua risposta fu più rivelatrice che lusinghiera.
Disse che, quando aveva letto la traduzione giappone-se di Soldati di Salamina, aveva molto attirato la sua at-tenzione una scena, ricorrente nel romanzo, in cui ungiovane soldato repubblicano, aggrappato a un fucile,
balla u n pasodoble, una popolare composizione musi-cale spagnola. Disse che non sapeva cosa fosse un paso-doble e che lo domandò al figlio, Hiraki. Noi lettori di Oenon ignoriamo chi è suo figlio, perché forse l’opera delloscrittore giapponese non si comprende senza di lui: Hi-raki era stato un bambino nato con gravi carenze menta-li, tante che i medici avevano consigliato a Oe di lasciarlomorire; ma Oe non aveva dato loro retta, e adesso Hiraki,
Nell’immagine: Sylvia PalaciosWhitman (1941), Passing Through(1977), performance realizzataalla Sonnabend Gallery di NewYork (courtesy dell’artista,fotografia di Babette Mangolte)

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 46/48
46 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
Percorsi Controcopertina
Patrimonio italiano La cittadina altoatesina sorgesulla strada romana che unì per secoli i mondilatino e germanico. Qui giunse persino il culto
del dio Mitra. Con una vivacissima fioritura d’arteITALIA
AUSTRIA
Alto AdigeBolzano
Trento
VipitenoVipiteno
Nell’orecchio c’è Spirito
dal nostro inviato a Vipiteno (Bolzano) CARLO VULPIO
La strana Annunciazione di Vipiteno in odore di eresiaCosì Giotto ispirò tre fratelli (e c’è un Papa all’inferno)
N
on è certo frequente che affreschi a temareligioso, meravigliosi e suggestivi, ven-gano guardati con una certa diffidenza, al
punto da essere accusati di eresia, come èaccaduto ai dipinti della piccola chiesa diSanto Spirito, nel centro della altoatesina
Vipiteno, o meglio, della sudtirolese Ster-zing. La chiesa, completamente affrescata da Giovanni(Hans) di Brunico con i fratelli Erasmus e Cristoph agli ini-zi del XV secolo, è una delle più belle chiese gotiche dellaregione e i suoi affreschi si ispirano in maniera evidente aquelli che Giotto aveva dipinto nella Cappella degli Scrove-gni, a Padova.
I tre fratelli di Brunico e molti altri artisti sudtirolesi fu-rono letteralmente catturati dalla lezione di Giotto e ne fe-cero tesoro, dimostrandosene all’altezza. Ma a Sterzingparlavano (e parlano) tedesco, e tedesca è la massima me-dioevale secondo cui «l’aria delle città rende liberi». Unaconvinzione che qui aveva radici profonde ben da primache questo motto fosse coniato e che continuasse a carat-terizzare per sempre la vita delle popolazioni di questa re-gione.
L’«aria», i tre artisti di Brunico la respirano a pieni pol-moni, almeno quanto quella delle Alpi, e gli affreschi diSanto Spirito ne sono la prova. Ecco quindi la grande scenadell’ Annunciazione, in cui la libertà di espressione artisti-ca nella raffigurazione di uno dei grandi episodi biblicinon tiene conto della dottrina e si spinge non solo a mo-strare il concepimento di Maria per aurem, attraversol’orecchio, da parte dello Spirito Santo, una colomba, chele è vicino, ma fa vedere il Bambino non ancora nato —insomma, il feto — che porta sulle sue esili spalle una cro-ce e in volo procede dal Padre (rapprese ntato dal sole) ver-so la Madre. Una scena forse mai vista. Una troppo liberainterpretazione. Dunque, un’eresia. Per giunta, annidatain un affresco superlativo.
La singolare Annunciazione non è un guizzo isolato. Ba-
sta volgere lo sguardo alla parete opposta della chiesa edecco il Giudizio finale, un’altra scena grandiosa — incredi-
bilmente sfregiata dall’apertur a di u na finestra proprio
sulla figura di Cristo giudice — in cui ci sono i buoni e icattivi come in tutti i giudizi universali, con i primi che ri-sorgono, si rivestono ed entrano nella Gerusalemme cele-ste e gli altri che invece, stravolti rincagnati, vengono spin-ti tra le grinfie dei demoni dall’arcangelo Michele armatodella propria spada. La sorpresa — altra libertà, altra ere-sia — è che tra i malvagi ci sono preti, cardinali e anche unPapa, nudi come gli altri dannati, ma riconoscibili dai se-gni propri del loro stato, le mitrie e la tonsura.
La libertà degli artisti, senza dubbio, ma anche il terre-no fertile della crescente contestazione nei confronti diuna Chiesa troppo ricca, troppo sazia, troppo corrotta,troppo tutto. In cui i segnali di smottamento diventanoscosse telluriche che nel giro di qualche decenni o cambie-ranno il volto dell’Europa settentrionale, dove nel 1517, conle 95 Tesi affisse dal frate agostiniano Martin Lutero sulportone della chiesa di Wittemberg, trionferà la Riformaprotestante. E tuttavia, dieci anni più tardi e 700 chilome-tri più a sud, sarà proprio a Sterzing, cittadina di robusteradici cattoliche, che esploderà la rivolta degli anabattisti,movimento radicale ispirato alla Riforma e guidato da Mi-chail Gaismair, che considerava lo stesso Lutero un «mo-derato», se non proprio un «venduto» ai prìncipi tedeschi.
L’utopia di uguaglianza sociale ispirata al Vangelo pro-pugnata da Gaismair e dagli anabattisti annegò nel san-gue. Lui fu assassinato da alcuni sicari a Padova, dove si erarifugiato, mentre i suoi compagni che non furono massa-crati ripararono in Moravia. Non venne però spento il sen-timento di libertà, di autonomia, di autodeterminazionedei tirolesi, che è antico ed era già saldo nel XIII secolo,quando i «padri fondatori», conti svevi o forse bavaresi,
concentrano i propri sforzi sul Tirolo, regione strategicaper il controllo di ogni tipo di traffico sulla via del Brenne-ro. Nel XIII secolo, con Mainardo II, nasce anche Sterzing,
e prende forma quella che si può defini re un’entità statua-le moderna, che cancella il sistema feudale e d iviene subi-to invisa a nobili ed ecclesiastici, tanto che anche Mainar-do II, come il suo «riferimento» Federico II di Svevia, fal’abitudine alle ripetute scomuniche papali.
L’arte prodotta a Sterzing però continuerà a essere artereligiosa e per di più ispirata a figure e vicende che cele-
brano la carità nei confronti di pellegrini, malati, poveri,persone sole. Prima di tutto perché Sterzing è anche unadelle tappe del pellegrinaggio verso Santiago de Compo-stela e poi perché ha già maturato una forte tradizione«ospedaliera», intesa nel senso proprio del termine, diospitalità e accoglienza dei viandanti e dei bisognosi, pri-ma ancora che in senso sanitario. La chiesa di Santo Spiri-to, per esempio, costruita nel 1399, fa parte dello stessocorpo di fabbrica del nuovo ospedale costruito in città inseguito alle inondazioni del Rio Valler, che avevano com-promesso il vecchio ospedale. Mentre un altro ospedale,ancora più antico, del 1298, è quello annesso alla chiesetta— anch’essa dedicata al Santo Spirito — della Commendadell’Ordine Teutonico, il cui Gran Maestro, nel 1226, erastato nominato Principe dell’Impero proprio da FedericoII.
Questa seconda Santo Spirito, che cronologicamente èla prima, è stata poi dedicata a santa Elisabetta (patronadell’Ordine Teutonico) ed è una graziosa chiesa baroccaaffrescata a metà del Settecento da Matthäus Günther, incui spicca la «pittura illusionistica» della cupola, architet-ture dipinte che sembrano la continuazione dell’architet-tura reale. Ma è nella Santo Spirito affrescata da Hans e isuoi fratelli che si resta catturati. Come abbiamo già dettoper l’ Annunciazione e il Giudizio finale, anche le altre sce-ne della vita di Cristo — la Strage degli innocenti, l’ Adora-zione dei Magi, l’Orto degli ulivi, il Bacio di Giuda, la Fla-
Il coat è in double felt , il bra in pizzo, i pant in lanabonded e l’abito è cut out in jersey . La nuovamoda, pardon fashion, è servita. Ma capiranno lelettrici delle riviste di abbigliamento, anchequelle non troppo agguerrite, che di cappotto in
doppio feltro si tratta, di reggiseno in pizzo, dipantaloni in lana cotta e di vestito tagliato nel
jersey? E sarà così brutto scrivere didascalie inbell’italiano, idioma del Paese che in fatto dimoda non dovrebbe essere secondo a nessuno?
La lingua del doppio feltro
{Ultime modedi Isabella Bossi Fedrigotti

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 47/48
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 47
Una donna molto ricca, una gatta eun’eredità. Come va a finire? Che la ricconalascia tutto alla gatta Ofelia. E poi questa,d’incanto, diventa una bellissima ragazza. InOfelia (traduzione di Bruno Oddera, Elliot, pp.
192, 17,50), c’è tutto l’umorismo raffinatodi Florence Stevenson, la cui vita stessasembra un romanzo: nata a Los Angeles nel1922, visse una florida carriera di scrittrice, acui antepose solo l’amore infinito per i gatti.
Gatti e parole
{Viva Liala!di Roberta Scorranese
Una copertinadue artisti
La giungla della nostra vitaUna stratificazione dicolori ches’intersecano in unasequenza armonica,rivelando un disegnoa carboncino: palme,
vegetazione tropicale, un paesaggioesotico come metafora di un mondoarcaico in cui perdersi, per poi ritrovarsi edesorcizzare così ogni paura e conflittointeriore. L’opera, frammento di un videorielaborato appositamente per «laLettura», è l’ultimo lavoro della coppiad’arte (e nella vita) degli svedesi NathalieDjurberg e Hans Berg (Lysekil, 1978;
Rättvik, 1978), ormai autori affermati delgiovane panorama internazionale: Leoned’argento alla Biennale di Venezia, mostrealla Tate di Londra, al Pompidou di Parigi,dal 17 settembre alla Galleria Gió Marconi aMilano. Lei (a dispetto del suo voltodelicato) è nota per le sue fi gure diplastilina dense di mostri e incubi, messe i nscena con video surreali, cupi e grotteschi.E lui, da compositore e musicista, le ècomplice nel dare vita a una cornice sonora,ipnotica e avvolgente per animazioni einstallazioni, spesso trasgressive, masempre ricche di simbolismi che evocanocon potenza le angosce del nostropresente. Forse, ha davvero ragioneAdorno: «Il compito attuale dell’arte èintrodurre caos nell’ordine». (gianluigi colin)
Supplemento culturale del Corriere della Sera
del 13 settembre 2015 - Anno 5 - N. 37 (#198)
Direttore responsabile Luciano Fontana
Vicedirettore vicarioVicedirettori
Barbara StefanelliDaniele MancaAntonio Polito (Roma)Venanzio PostiglioneGiampaolo Tucci
Supplemento a curadella Redazione cultura Antonio Troiano
Pierenrico Ratto
Stefano BucciAntonio CariotiSerena DannaMarco Del CoronaCinzia FioriAlessia RastelliAnnachiara Sacchi
Cristina TagliettiArt director Gianluigi Colin
© 2015 RCS MediaGroup S.p.A. Divisione QuotidianiSede legale: via A. Rizzoli, 8 - MilanoRegistrazione Tribunale di Milano n. 505 del 13 ottobre 2011
REDAZIONE e TIPOGRAFIA:Via Solferino, 28 - 20121 Milano - Tel. 02-62821RCS MediaGroup S.p.A. Dir. Communication SolutionsVia A. Rizzoli, 8 - 20132 Milano - Tel. 02-25841www.rcscommunicationsolutions.it© COPYRIGHT RCS MediaGroup S.p.A. Divisione QuotidianiTutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo prodotto puòessere riprodotta con mezzi grafici, meccanici, elettronici o digitali.Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
gellazione, Gesù davanti a Pilato, Gesù che porta la croce,la Resurrezione — sono tutte di chiara marca giottesca esono state restaurate due volte, prima nel 1939 e poi nel
1989, dopo essere sopravvissute per caso persin o alla pestedel Seicento grazie a una provvidenziale copertura di cal-ce.
Non si è salvata invece la scena della Crocifissione, die-tro l’altare, che ha lasciato una grande nicchia vuota, riem-pita in qualche modo dal bellissimo Cristo crocifisso tar-dogotico, in legno, realizzato nella seconda metà del XVsecolo da Hans Harder. Il quale è anche l’autore del CristoPortacroce ligneo e dei busti di Gesù e dei dodici apostoliche si trovano nella grande chiesa gotica ai margini delcentro abitato, dedicata alla Madonna e meglio nota comeNostra Signora delle Paludi.
Questa chiesa è una Hallenkirche, cioè una «chiesa a sa-la», in cui la navata centrale e le due laterali hanno la stes-sa altezza, affinché la luce possa illuminarla in ogni parteallo stesso modo, sia per affermare un principio di ugua-glianza tra i fedeli, sia per esa ltare i colori delle volte affre-scate nel Seicento probabilmente da Josef Ritterle, il cuiGiudizio universale, scrive Alberto Perini in Vipiteno. Unastoria, un ritratto (edito dall’Associazione per la storia eper il museo di Vipiteno), «ricorda quello della CappellaSistina in Roma, poiché anche qui si agitano tumultuaria-mente corpi muscolosi ed atletici travolti dal cataclismadel dies irae».
Il capolavoro gotico di Nostra Signora però è l’altare li-gneo a portelle alto 12 metri (metà del XV secolo) di HansMultscher, tedesco di Ulm, il migliore artista del legno delsuo tempo. Per la verità, dell’altare di Multscher, nellachiesa di Nostra Signora, sono rimaste solo le cinque sta-tue ( Maria e quattro sante), mentre le altri parti — tra lequali i dipinti su tavole in legno di alburno ( Annunciazio-
ne, Salita al Calvario, Flagellazione, Dormitio Virginis) ele statue dei guardiani Giorgio e Floriano — si trovano nelMuseo Multscher, allestito in un’ala della Commenda del-
l’Ordine Teutonico, che nella storia di Sterzing/Vipitenoha avuto a lungo un ruolo di primo pian o. Infatti, attraver-so le vicende di quest’ordine religioso cavalleresco natodurante le Crociate, smembratosi in seguito alla Riforma(una parte diventò protestante, l’altra rimase cattolica) esoppresso due volte, prima da Napoleone e poi da Hitler,si possono comprendere meglio conflitti, rancori, turbo-lenze, incomprensioni, che ancora oggi condizionano la
vita delle popolazioni di questa regione e che, quando in-crociano la storia e l’arte, si traducono in domande fatali.Come questa: ma Sterzing una volta era effettivamente Vi-piteno?
La risposta è che non lo sappiamo. Forse sì. Perché disicuro una Vipitenum c’era, ma non si sa esattamente dovefosse. Sappiamo che l’imperatore Claudio, nella primametà del I secolo dopo Cristo, conquistò questi territori e liinglobò nella provincia Raetia, completando la via impe-riale Claudia Augusta, l’unica strada transalpina che attra-
verso il Brennero raggiungeva la città sveva di Augsburg(Augusta Vindelicum), mentre Settimio Severo, nel 201, sene prese cura, facendo riparare ponti e strade. Sappiamoanche che grazie a questa importantissima via di comuni-cazione arrivò fin qui persino il culto orientale del dio Mi-thra, testimoniato da una bellissima stele in bassorilievocustodita nel Museo archeologico di Bolzano, e che questaregione diventò ricca, colta, ospitale. E sappiamo, infine,che Sterzing/Vipiteno è uno dei borghi più belli d’Italia, odel Tirolo, o meglio ancora d’Europa, e che tra le sue opered’arte ne ha una da togliere il respiro: la Gola di Stanghe,un’opera d’arte naturale, l’unica al mondo in cui l’acquadelle cascate ha tagliato come burro chilometri di altissi-me pareti di marmo bianco. Un paradiso. O an che l’antica-mera dell’inferno. Dipende.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le immaginiQui sopra, la volta della chiesadi Santa Elisabetta a Vipiteno
affrescata da MatthäusGünther, esempio di «pitturaillusionistica» in cui learchitetture dipinte sembranola continuazionedell’architettura reale. In alto:la chiesa di Santa Elisabetta ela Commenda dell’OrdineTeutonico. Nella paginaaccanto: gli affreschi dellachiesa di Santo Spirito,sempre a Vipiteno, realizzatida Giovanni (Hans) di Brunicocon i fratelli Erasmus eCristoph agli inizi del XVsecolo. A sinistra, sopra: IlGiudizio finale , con san MicheleArcangelo che spinge idannati verso i demoni; sotto:un particolare del Giudiziofinale ; a destra, nella fotogrande: l’Annunciazione . La
scena mostra il concepimentodi Maria per aurem, attraversol’orecchio, da parte delloSpirito Santo rappresentatoda una colombae fa vedere il Bambino, nonancora nato che, portandosulle spalle una croce, procededal Padre (il sole) verso laMadre (servizio fotograficodi Lucia Casamassima
/Ag. Lara)
C O U R T E S Y G A L L E R I A G I Ó M A R C O N I / M I L A N O
I S A B E L A S H A P
E N Z L I E N

7/17/2019 LETTURA(2015_09_13)
http://slidepdf.com/reader/full/lettura20150913 48/48
48 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015