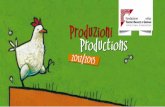Le produzioni sulle aree agricole e marginali
Transcript of Le produzioni sulle aree agricole e marginali
Le produzioni sulle aree agricole e marginali
L’evoluzione della Politica agricola comunitaria ha aperto scenari fino a qualche
anno fa impensabili per l’azienda agricola. All’originario imperativo “produrre di più” si sono
aggiunti i nuovi obiettivi “produrre meglio” e “produrre altro” in un mercato sempre più
globale dove nuove opportunità di reddito sono legate all’offerta di prodotti e di servizi di
elevata qualità, connessi al rispetto dei fondamentali “vincoli ambientali” che
caratterizzano i principi dello sviluppo sostenibile. Ecco quindi che le attività forestali e
agroforestali tornano ad avere spazio nelle aziende agricole.
I possibili interventi da realizzare nell’ambito delle aree marginali del territorio del
GAL MERIDAUNIA, possono essere cosi riassunti:
• arboreti da legno con impianti di “specie a legname di pregio”;
• impianti per la produzione di biomassa a fini energetici SRF (Short rotation
forestry);
• coltivazione di piante officinali;
• coltivazione di piccoli frutti;
• coltivazione di tartufi;
• produzione di funghi spontanei;
• allevamenti alternativi.
ARBORICOLTURA DA LEGNO CON IMPIANTI DI “LATIFOGLIE A LEGNAME DI PREGIO”
L'industria è sempre costretta a importare legname e l'abbandono dei terreni
agricoli è in costante aumento, in tale contesto l'arboricoltura da legno con latifoglie di
pregio può rappresentare un valido investimento, riducendo l'importazione di legname e
contribuendo a migliorare l'ambiente. Le latifoglie a legname pregiato utilizzate sono
molte: noce comune, ciliegio selvatico, acero montano, frassino maggiore, frassino
meridionale, sorbo domestico, ecc.., ma l'attenzione è incentrata soprattutto sul noce
comune per il maggiore valore del legname.
L'uso di piante idonee alle caratteristiche locali del clima e del terreno, l'attenta
progettazione delle consociazioni e dei sistemi d'impianto sono le premesse per la buona
riuscita degli impianti.
Nella scelta delle aree e delle specie da utilizzare, bisogna porre particolare
attenzione alle caratteristiche fisiche, alla profondità e alla stratificazione del terreno.
Questi parametri possono influire in modo determinante sulla crescita delle piante arboree.
I terreni argillosi e pesanti sono assai sfavorevoli soprattutto per la crescita delle specie
più esigenti (es. noce e ciliegio), mentre i suoli molto superficiali sono totalmente inadatti
all'arboricoltura da legno. La presenza di orizzonti sottosuperficiali più compatti e poco
permeabili (es. suola di lavorazione) può ostacolare la penetrazione delle radici e
determinare periodi di asfissia radicale anche in suoli non particolarmente argillosi. Se tali
difetti non possono essere eliminati o mitigati con opportune lavorazioni ed sistemazioni
pre-impianto, le aree devono essere scartate, o, al massimo, destinate alle specie meno
esigenti.
Gli impianti monospecifici sono oggetto di molte critiche perché richiedono alti
apporti di energia sussidiaria, sono sistemi instabili, in quanto, nel momento in cui
subiscono stress ambientali, diventano vulnerabili alle malattie, alla competizione, al
parassitismo e alla predazione. Per ridurre gli aspetti negativi della monocoltura si tende a
realizzare impianti plurispecifici o misti, caratterizzati dalla presenza sulla stessa superficie
di una specie "principale" che di solito è una specie a legname pregiato e una di
"accompagnamento", sia albero che arbusto, il cui scopo è quello di svolgere un'azione
benefica a vantaggio della principale. Questi benefici consistono nel: maggiore sviluppo in
altezza del fusto; contenimento della ramificazione; miglioramenti del suolo sia per apporti
di lettiera che per la fissazione biologica di Azoto che può ridurre al necessità di riduzione
delle concimazioni azotate; ottenimento di eventuali prodotti integrativi: frutti, miele, ecc.;
maggiori incrementi iniziali in diametro e altezza della specie principale rispetto agli
impianti monospecifici; maggiore stabilità biologica.
Riguardo alle potenzialità produttive degli impianti, per il noce comune, sono state
rilevate nell'Italia centrale produzioni unitarie, riferita al solo tronco da lavoro, comprese tra
25 e 50 m3 a 16 anni, tra 30 e 55 m3 a 20 anni e tra 35 e 60 m3 a 26 anni, pari a
incrementi medi annui di 1-3 m3. Il ciliegio è specie a rapido accrescimento, almeno in
fase giovanile: l'accrescimento è elevato fino a 20 anni in altezza e fino a 50 in diametro.
Sono stimati incrementi medi annui di 4-5 m3.
Oltre all'aspetto quantitativo occorre tener presente anche della qualità: il valore
degli assortimenti varia non solo in relazione alle dimensioni. Così, i fusti più apprezzati
non sono solo quelli, dritti, lunghi almeno 3 m, con diametro maggiore di 30 cm, ma anche
quelli senza nodi, danni meccanici, attacchi parassitari, rami laterali, innesti e fibra storta.
Il Piano di Sviluppo Rurale (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 114 del 30-
7-2001), prevede la realizzazione di impianti di arboreti da legno su terreni con buona
fertilità, sufficiente franco di coltivazione (almeno 100 cm) e con disponibilità irrigue. Questi
impianti sono da considerarsi colture legnose agrarie finalizzate alla produzione di
legname e come tali rientranti nella definizione di “arboricoltura da legno” di cui all’art. 2,
comma 5, del D. Lgs. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”.
Pertanto non sono considerati boschi e neppure soggetti ai vincoli che la legislazione pone
sui boschi.
Gli interventi previsti dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell’ambiente e in
particolare garantire l’integrità dei siti della Rete Natura 2000 (Direttiva 79/409/CEE -
Uccelli selvatici e Direttiva 92/43/CEE - Habitat).
Gli impianti dovranno essere effettuati con materiale di propagazione compatibile
con le condizioni pedoclimatiche dell’area interessata e secondo le prescrizioni della
normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali. Il materiale
di propagazione, appartenente a specie vegetali per le quali la normativa vigente lo
preveda, dovrà essere munito della certificazione relativa alla provenienza o all’identità (L.
269/1973 e s.m.i., D. Lgs. 386/2003) e, per le specie che lo richiedono, anche della
certificazione riferita allo stato fitosanitario (passaporto verde).
Gli impianti dovranno essere costituiti da popolamenti arborei di latifoglie, governati
ad alto fusto, con turno superiore a 20 anni. Al fine di consentire un adeguato sviluppo
delle specie di maggior pregio (principali) e di assicurare nel contempo un sufficiente
grado di naturalità, deve essere realizzata preferibilmente la consociazione di specie
accessorie associate a quelle principali. Le specie arboree principali, ovvero quelle che
raggiungeranno la fine del turno e forniranno la maggior parte del reddito, devono essere
in grado di produrre legname prevalentemente per segati e/o tranciatura.
La superficie minima dovrà essere di almeno 1 ettaro, con corpi di almeno 0,5 ettari.
La superficie minima su cui realizzare gli impianti deve calcolarsi al netto di eventuali tare
esistenti (es. strade, capezzagne, fabbricati, canali, boschi, siepi, filari ecc.). La superficie
dell’impianto deve essere omogenea e ravvicinata, cioè un qualsiasi e singolo corpo che
compone l’impianto, al netto di tare di qualsiasi tipo, deve trovarsi ad una distanza non
superiore ai 200 metri da almeno un altro corpo dell’impianto stesso. In ogni caso, l’area
oggetto di intervento deve presentare caratteristiche ecologiche, ambientali ed
economiche adatte all’impianto e all’accrescimento della piantagione.
La densità minima d'impianto dovrà essere di 400 piante/ettaro (specie arboree
principali).
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI BIOMASSA A FINI ENERG ETICI SRF (SHORT ROTATION FORESTRY)
Oggi la ricerca insaziabile di energia porta un rinnovato interesse verso il legno-
energia. Ecco quindi la coltivazione short rotation forestry (SRF), ossia impianti di colture
legnose a turno breve, un mix di coltura agronomica e forestale: si coltivano piante
legnose a rapido accrescimento (arboree o arbustive) destinate a fornire biomassa per la
produzione di energia elettrica e/o termica.
La realizzazione di un impianto SRF comporta la necessaria presenza di alcuni
fattori indispensabili per la realizzazione della filiera di produzione di biomassa per la
trasformazione in energia, in particolare, la domanda di mercato del prodotto finale.
Le coltivazioni legnose di biomassa sono impianti di specie forestali a rapido
accrescimento, per lo più pioppo, salice, eucalipto e robinia, con impianto ad elevata
densità (oltre 5000 piante per ettaro) con turni che vanno dai 2 ai 10-12 anni.
Nel territorio del GAL, occorre realizzare impianti a più alta sostenibilità ambientale,
con potenzialità produttive medio alte, le cui caratteristiche sono: impianto a struttura
iniziale a densità media (1500 piante/ha); composizione multispecifica, di specie con ritmi
di accrescimento differenziati; turni medi (4-12 anni); polifunzionalità degli impianti;
meccanizazione medio bassa. La funzione principale di questi impianti è quella di produrre
biomassa legnosa sotto forma di cippato, di legna in pezzi o di ambedue gli assortimenti.
Un esempio di ceduo a media rotazione che potrebbe essere realizzato:
• specie impiegate: frassino meridionale, olmo campestre e platano ibrido;
• turno per il platano e l’olmo: 5 anni, per il frassino meridionale: 6-7 anni;
• mescolanza delle specie impiegate per piccoli gruppi.
Il Piano di Sviluppo Rurale (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 114 del 30-
7-2001), prevede la realizzazione impianti di specie forestali a rapido accrescimento a fini
energetici. Questi impianti sono da considerarsi colture legnose agrarie finalizzate alla
produzione di biomassa e come tali rientranti nella definizione di “arboricoltura da legno” di
cui all’art. 2, comma 5, del D. Lgs. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore
forestale”. Pertanto non sono considerati boschi e neppure soggetti ai vincoli che la
legislazione pone sui boschi.
Gli interventi previsti dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell’ambiente e in
particolare garantire l’integrità dei siti della Rete Natura 2000 (Direttiva 79/409/CEE -
Uccelli selvatici e Direttiva 92/43/CEE - Habitat).
Gli impianti dovranno essere effettuati con materiale di propagazione compatibile
con le condizioni pedoclimatiche dell’area interessata e secondo le prescrizioni della
normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali. Il materiale
di propagazione, appartenente a specie vegetali per le quali la normativa vigente lo
preveda, dovrà essere munito della certificazione relativa alla provenienza o all’identità (L.
269/1973 e s.m.i., D. Lgs. 386/2003) e, per le specie che lo richiedono, anche della
certificazione riferita allo stato fitosanitario (passaporto verde).
Gli impianti dovranno essere costituiti da popolamenti arborei di latifoglie e/o
conifere, a rapido accrescimento e turno inferiore a 15 anni. Sono considerate specie a
rapido accrescimento, infatti, quelle che, nella stazione di impianto, giungono a maturità
con un turno inferiore a 15 anni.
La superficie minima dovrà essere di almeno 1 ettaro, con corpi di almeno 0,5 ettari.
La superficie minima su cui realizzare gli impianti deve calcolarsi al netto di eventuali tare
esistenti (es. strade, capezzagne, fabbricati, canali, boschi, siepi, filari ecc.). La superficie
dell’impianto deve essere omogenea e ravvicinata, cioè un qualsiasi e singolo corpo che
compone l’impianto, al netto di tare di qualsiasi tipo, deve trovarsi ad una distanza non
superiore ai 200 metri da almeno un altro corpo dell’impianto stesso. In ogni caso, l’area
oggetto di intervento deve presentare caratteristiche ecologiche, ambientali ed
economiche adatte all’impianto e all’accrescimento della piantagione. La densità minima
d'impianto dovrà essere di 400 piante/ettaro (specie arboree principali).
COLTIVAZIONE DI PIANTE OFFICINALI
Il consumo di piante medicinali ed aromatiche da parte dell’industria farmaceutica,
alimentare, liquoristica, cosmetica ed erboristica è in continuo aumento in tutto il mondo.
Nel nostro paese, mentre il settore della trasformazione e di quello della
commercializzazione dei prodotti finiti hanno fatto registrare negli ultimi anni un notevole
incremento (il consumo annuo di piante medicinali ed aromatiche coltivabili in Italia è
stimato in circa 100/120 milioni di euro, dati ASSOERBE), quello della coltivazione stenta
a svilupparsi e la superficie investita in Italia a piante officinali erbacee rimane modesta
(circa 1.800 ha). Ciò dipende dal fatto che la produzione Italiana di piante medicinali ed
aromatiche deve confrontarsi per qualità e prezzo con quella di altri Paesi, specialmente
dell'Europa dell’Est e di quelli in via di sviluppo, dai quali proviene circa il 70% delle erbe
consumate nel nostro paese. I maggiori produttori, in campo mondiale di piante medicinali
ed aromatiche coltivabili anche in Italia sono: Albania, Bulgaria, Croazia, Grecia,
Jugoslavia, Macedonia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia,
Ungheria, Egitto, Marocco, Tunisia, Cina, India, Pakistan, Argentina, Brasile, Cile,
Messico, Centro America, ecc. Il fatto che il 70% del fabbisogno nazionale di erbe venga
importato, porta a dedurre che in Italia ci dovrebbero essere buone possibilità di
incrementare le coltivazioni di piante medicinali ed aromatiche e numerosi produttori
agricoli vedono nelle coltivazioni di queste piante delle nuove opportunità che si augurano
più remunerative di quelle tradizionali. Prima di intraprendere questo tipo di attività è
tuttavia opportuno tenere conto di alcune condizioni di fattibilità.
A causa dell’elevato numero di specie officinali richieste dal mercato ed in
considerazione delle diverse situazioni pedoclimatiche ed aziendali si dovrà valutare caso
per caso quali siano le specie più adatte ad essere coltivate. Fra le specie che più si
adattano alle condizioni pedoclimatiche caratteristiche dei nostri boschi (e che in alcuni
casi vi crescono spontaneamente) ci sono:
Sambucus nigra L., Viola odorata L., Primula officinalis (L.) Hill., Galium odoratum
(L.) Scop, Glechoma hederacea L., Aegopodium podagraria L., Convallaria majalis L.,
Vinca maior L., Vinca minor L., Buxus sempervirens L., Hedera helix L.
Una volta definite le possibili piante coltivabili nell’azienda occorrerà valutarne le
possibilità di vendita e la remuneratività prendendo contatti con le ditte di
commercializzazione oppure con le industrie di trasformazione che possono acquistare le
piante essiccate oppure i prodotti semilavorati.
In breve, non si dovrà mai coltivare senza conoscere la possibile via di
commercializzazione ed i prezzi minimi che si possono realizzare oppure si dovrà
ipotizzare, oltre alla coltivazione, la trasformazione in azienda e la vendita in mercati di
nicchia, che, in realtà particolari, possono rivelarsi abbastanza remunerativi.
Sono da escludere terreni infestati da erbe perenni, troppo sassosi oppure troppo
argillosi, ma si scelgano i terreni migliori come quelli che si usano per le colture orticole. In
caso di terreni incolti si tenga presente che i migliori sono quelli che sono stati
precedentemente coltivati a prato stabile polifita.
Le attrezzature necessarie alla coltivazioni sono quelle che si usano normalmente
per una coltivazione orticola specializzata.
La coltivazione delle piante officinali richiede per lo più un elevato impiego di
manodopera, che fa lievitare i costi di produzione.
Se la manodopera impiegata fa parte dell'impresa coltivatrice (è il caso delle piccole
aziende famigliari) essa creerà un redddito da lavoro interno all'azienda, ma se si deve
ricorrere a manodopera esterna, essa contribuirà ad elevare i costi di produzione.
Per cui, nel programmare le coltivazioni officinali, la manodopera è uno degli
elementi fondamentali che può determinare le scelte di chi si accinge a coltivare.
L'azienda produttrice può avere diversi indirizzi:
- ottenere piantine da vendere sul mercato vivaistico ad altre aziende coltivatrici
- produrre erbe fresche da vendere sui mercati ortofrutticoli
- ottenere piante o loro parti aeree essiccate da destinare all'erboristeria oppure
alle industrie estrattive
- produrre radici, tuberi, rizomi essiccati
- ottenere olii essenziali
Le macchine necessarie alla produzione di qualsiasi gruppo di piante sopra
elencato, sono in dotazione alle comuni aziende orticole e cioè quelle che servono alla
preparazione del terreno (trattrice, aratro, erpice) all’esecuzione delle operazioni colturali
(seminatrici, trapiantatrici) ed al mantenimento delle colture (zappatrici, sarchiatrici
multiple, motocoltivatori per la lavorazione interfila) il cui numero e la cui potenza
dipenderà dall'indirizzo e della dimensione aziendale. Per produrre piantine da trapianto
(primo indirizzo) sono necessari:
- semenzaio a letto caldo, tunnel con copertura in film plastico oppure serre con le
principali attrezzature (irrigazione, riscaldamento, ecc.)
Per la produzione di erbe fresche si può fare riferimento a quelle attrezzature
largamente usate dalle aziende che producono per esempio basilico: seminatrici di
precisione per semina in cellette o contenitori alveolari, serre, ecc.
Per la produzione di erbe essiccate e di radici, che è il caso più frequente, oltre alla
attrezzature per la coltivazione, saranno necessarie le seguenti macchine:
- raccoglitrici dimensionate alla grandezza delle superfici coltivate
- essiccatoio (che è l'attrezzatura fondamentale)
- taglierina per tagliare le erbe o le radici prima o dopo la essiccazione
- selezionatrice per ottenere diversi tipi di assortimenti commerciali
- macchine di pressaggio del prodotto secco e di confezionamento in balle
- magazzini adeguati allo stoccaggio dalle piante medicinali e/o aromatiche
prodotte.
Per la produzione di olii essenziali (di menta, lavanda, timo, ecc.) è naturalmente
necessario un distillatore, che solitamente è un'attrezzatura molto costosa
Per la produzione di semi (anice, finocchio, cardo mariano, coriandolo, ecc.) è
fondamentale disporre della seguente attrezzatura:
- seminatrici di precisione con possibilità di semina da 13 a 70 cm
- trebbiatrici (possono essere adottate quelle usuali con modifiche a seconda dei
tipo di seme da produrre)
- aree di essiccazione
- magazzino
Come si può notare da quanto detto finora, la coltivazione delle piante officinali
richiede un investimento in macchinari più elevato rispetto alle colture tradizionali perché
rispetto a queste ultime necessitano di un grado di trasformazione più o meno spinto.
Un fattore che può contenere i costi di produzione è la disponibilità di manodopera
aziendale. La produzione agricola a basso costo di mano d'opera è tipica delle famiglie
coltivatrici. In caso contrario l’alto costo della mano d'opera salariata rende spesso
improponibile ogni tipo di coltivazione, a meno che il ricorso a quest’ultima non sia limitato
al massimo, grazie ad un’elevata tecnologia ed alla realizzazione di adeguate economie di
scala, il chè tuttavia comporta investimenti in macchinari molto elevati.
I macchinari per la raccolta e/o trasformazione delle piante officinali (separatrici
foglie/fusti, trance per taglio tisana ecc.) sono nella maggioranza dei casi di produzione
straniera e quindi molto costosi e non sempre facili da procurare. Una soluzione per
ovviare agli alti costi è quella di modificare o da soli o con l’aiuto di meccanici specializzati,
macchine agricole destinate ad altre piante o alla lavorazione di altri prodotti.
I prezzi ottenibili per le piante medicinali ed aromatiche coltivate sono sempre
correlati alla qualità del prodotto. Come scelta strategica e competitiva (superiore qualità
dei prodotti e quindi prezzi di vendita più remunerativi), è opportuno adottare tecniche di
coltivazione biologiche e/o biodinamiche. Tuttavia occorre tener conto che entrambe
comportano costi di produzione, nonché capacità tecniche di gestione delle colture e
dell’impresa più onerosi rispetto a quella convenzionale.
Le piante medicinali ed aromatiche per essere commerciabili devono inoltre
possedere i seguenti requisiti:
- residui tossici (diserbanti, pesticidi, ecc.) nei limiti di legge;
- assenza di impurezze e contaminanti;
- sufficiente essiccazione del prodotto;
- carica batterica nei limiti di legge;
- aflatossine nei limiti di legge;
- metalli pesanti nei limiti di legge;
- contenuto di principi attivi secondo farmacopea o monografie relative al prodotto.
Queste caratteristiche possono essere ottenute solo con un’alta specializzazione ed
adeguati macchinari di trasformazione ed ambienti di conservazione.
La resa agronomica è molto influenzata dalla specie coltivata e dal tipo di prodotto
che si vuol ottenere. Ad esempio un ettaro di camomilla fornisce in media 6 q di capoloni
essiccati, un ettaro di menta circa 70 kg di olio essenziale ed un ettaro di lino 10-15 q di
semi.
Nelle nostre zone dove la durata del periodo vegetativo è maggiore, la presenza
dell’irrigazione permette di aumentare la produzione di massa verde e quindi di eseguire
più tagli. Inoltre, grazie alle temperature più elevate, i costi dell’ essiccazione sono minori.
Relativamente ai prezzi, quelli praticati dai grossisti fanno riferimento al prezzo
praticato a livello internazionale e per tanto sono bassi (in media 1, 5 €/kg di prodotto
secco). Il prezzo poi, a causa delle dimensioni intrinseche del comparto, in relazione ai
quantitativi di prodotto commercializzato a livello mondiale, è soggetto a notevoli
oscillazioni cicliche collegate alla disponibilità dell’offerta.
Ogni iniziativa di coltivazione, non dovrà tenere conto dei prezzi momentanei,
specialmente se sono alti, ma dei prezzi medi avuti negli ultimi anni.
Lo sbocco commerciale di produzioni elevate potranno essere indifferentemente le
industrie farmaceutiche, alimentari, liquoristiche, cosmetiche ed erboristiche Occorre
tuttavia tener conto che mentre l’offerta delle officinali è piuttosto polverizzata, il
commercio delle medesime è in mano a pochi grossisti, concentrati nel nord Italia. Nella
maggior parte dei casi le partite trattate, a questi livelli, sono decisamente consistenti. In
caso di grosse produzioni, per potere avere la certezza del collocamento del prodotto
ottenuto, prima di iniziare a coltivare, è necessario concludere un contratto di vendita con i
potenziali acquirenti.
Da parte dell’industria tuttavia, una programmazione nel lungo periodo è oltremodo
difficile, verificandosi spesso variazioni notevoli per prezzo, quantità e qualità da un
raccolto all’altro. Qualora si intenda avvalersi di questo canale commerciale è
indispensabile assicurarsi preliminarmente con adeguati contratti di coltivazione, che
prevedano il ritiro del prodotto, e (come già anticipato) ipotizzare grossi investimenti sia
per quanto riguarda le superfici che si intendono destinare alla coltivazione di piante
officinali, sia per quanto riguarda l’aspetto finanziario collegato (adeguamento aziendale
con attrezzature specifiche). In questo caso è consigliabile produrre piante medicinali ed
aromatiche di consumo consolidato.
Le maggiori richieste di informazioni sulle possibilità di coltivazione di piante
medicinali piante medicinali ed aromatiche provengono però da aziende agricole situate in
zone collinari e montane che dispongono di piccole superfici di terreno.
Risulta particolarmente difficile per un produttore agricolo, che intenda diversificare
la propria produzione sperimentando la coltivazione di piante officinali, proporsi come
possibile fornitore dei grossisti e le coltivazioni con bassi volumi rischiano di non trovare
acquirenti, indipendentemente dal prezzo e gli unici sbocchi commerciali di queste
produzioni possono essere i laboratori cosmetico/erboristici.
Un’altra strada possibile è la creazione di consorzi o cooperative che possono
coltivare piante officinali da affiancate ad altre culture tradizionali. Per le aziende di piccole
dimensioni, singole od associate in cooperative, è opportuno cercare di valorizzare il
prodotto occupandosi direttamente dell’intera filiera produttiva, trasformando e vendendo
direttamente la materia prima lavorata. Ciò è più facile se si ha a disposizione un’azienda
agrituristica, oppure se si opera in zone turisticamente sviluppate. La presenza del turismo
aumenta moltissimo le possibilità di vendere il prodotto attraverso spacci di prodotti tipici
locali o presso gli alberghi, oppure direttamente.
Per le famiglie coltivatrici proprietarie di piccole aziende di collina montagna poste
in luoghi lontani dall’inquinamento, un’altra possibilità oltre a quella della coltivazione è
quella della raccolta spontanea. E’ questa un'attività che può essere fatta sia a tempo
pieno, oppure nel tempo libero. In questo caso, non ci sono problemi di investimenti e di
alta specializzazione, come richiesto dalle coltivazioni, ma solo la conoscenza delle specie
da raccogliere, del loro tempo balsamico e del processo ottimale per il loro essiccamento.
Essendo le quantità giornaliere raccolte molto basse, si potranno essiccare le
piante medicinali ed aromatiche avvalendosi di telai posti in locali preesistenti, senza
l’investimento in costose attrezzature.
Le piante medicinali ed aromatiche spontanee più importanti da raccogliere sono:
Iperico, Tiglio, Ononide, Santoreggia, Timo, Fumaria, Ortica, Equiseto, Achillea, Ginepro,
Assenzio, Ruta.
Occorre, tuttavia, tenere conto che in mancanza di una legge quadro di riordino del
settore, il Ministero della Salute sta emanando delle circolari che adeguano la nostra
legislazione a quella europea. Questo “adeguamento” preoccupa non poco i piccoli
coltivatori e/o trasformatori perché esige una qualificazione del prodotto (analisi) i cui costi
non sono assolutamente sostenibili da parte di piccole aziende o piccoli consorzi. Inoltre
molti compratori richiedono già che il produttore fornisca la documentazione che
garantisca l’adozione delle G.A.P. (Good Agricultural Practices) e delle H.A.C.C.P.
(Hazard Analisis Critical Control Point) nelle varie fasi produttive.
Occorre, infine, sottolineare che per vendere anche semplicemente una tisana,
occorre poter disporre del supporto di un’erborista. La legislazione attuale prevede infatti
che qualsiasi formulazione erboristica messa in commercio sia garantita e certificata nella
sua composizione da questa figura professionale.
COLTIVAZIONE DI PICCOLI FRUTTI
I frutti di bosco, detti anche piccoli frutti, sono delle colture che richiedono un
elevato fabbisogno di manodopera, una buona disponibilità di acqua e un basso
investimento in termini di superficie e quindi particolarmente adatti alle piccole e medie
aziende a conduzione familiare
La coltivazione dei piccoli frutti rappresenta un’interessante opportunità per
integrare il reddito e diversificare le produzioni delle aziende collinari e montane.
Queste colture hanno una spiccata resistenza naturale nei confronti di patogeni, di
conseguenza si prestano bene a sistemi di produzione integrata o biologica e possono
rappresentare una fonte di reddito interessante per i terreni marginali.
Le principali specie di frutti minori coltivate in Italia sono il lampone (Rubus
idaesum), il mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) e il mirtillo rosso (Vaccinium vitis idaea), la
mora di rovo (Rubus fruticosus), l’uva ursina (Arctostaphylos uva-ursi) e la fragola
(Fragaria vesca).
Tutte queste specie sono caratterizzate da un’elevata resistenza al freddo, ma
soffrono la mancanza d’acqua, fattore che in alcuni casi può diventare limitante per la loro
diffusione nelle aree meridionali della nostra penisola.
Anche se le informazioni disponibili sulle quantità e i valori della produzione sono
carenti, si può affermare che questi prodotti possono rappresentare nicchie di mercato che
alimentano delle micro-filiere particolarmente importanti per promuovere politiche di
tipicità, origine e qualità dei prodotti.
La raccolta dei frutti minori avviene durante i mesi estivi e deve essere
programmata adeguatamente attraverso una scelta varietale che consenta di ricoprire le
esigenze di mercato soprattutto in controstagione (aprile-maggio e ottobre-novembre),
quando cioè si riescono a spuntare elevati prezzi.
Moltissimi sono gli esempi e i risultati: di notevole importanza quelli della
Garfagnana conseguenti all’attività svolta dall’ASFD. Piantine di fragoline selvatiche
derivanti dal bosco vengono trapiantati su terreni di montagna irrigui, ben lavorati e
fertilizzati con concimi organici e quindi coltivate. Le coltivazioni danno prodotti di qualità
non inferiore a quelli spontanei. Produzioni di oltre 50 quintali ad ettaro con una redditività
molto elevata. Dati economici parlano di fragoleti di circa mezzo ettaro che rendono oltre
20.000€ all’anno. Impianti produttivi vengono realizzati anche con altre specie del
sottobosco, come il lampone, partendo più spesso da materiale con caratteristiche
superiori a quelle del selvatico. Con questo sistema si può arrivare a produzioni che
oscillano fra gli 80 e i 120 quintali per ettaro. Un ettaro di lamponeto può rendere anche
30.000€ all’anno.
D'altra parte, però, i piccoli frutti non concedono tante alternative: o ci si associa in
cooperative od in altre forme associative, o si soccombe alla realtà di un mercato sempre
più esigente e competitivo.
La disponibilità di prodotto fresco sul mercato trova riscontro in un largo consenso
tra i consumatori e soprattutto nei laboratori di gelaterie e pasticcerie, anche perché
queste ultime utilizzano prodotto conservato. La facile deperibilità del prodotto obbliga una
rapida collocazione dello stesso, fatto che richiede una organizzazione di vendita molto
dinamica e flessibile.
L’utilizzo prevalente dei piccoli frutti è dato dal consumo allo stato fresco: questo
tipo di utilizzazione consente la migliore valorizzazione commerciale del prodotto. La
presenza di picchi produttivi comporta la considerazione di destinazioni alternative quali
dolci confezionati, sciroppi, marmellate e preparati per yogurt. Tali ulteriori opportunità
possono essere sfruttate da piccole aziende di trasformazione che, apprezzato il prodotto,
possono iniziare, con interesse e inventiva, la produzione di dolci confezionati, sciroppi,
marmellate e preparati per yogurt a base di frutti di bosco.
Il lampone è un arbusto che può raggiungere i 2,5 metri di altezza. Si mette a
dimora in novembre, in terreno sciolto, ma tendenzialmente umido e fertile; non cresce
bene nei terreni alcaline siccitosi. Al momento della preparazione del terreno, è
consigliabile distribuire un buon quantitativo di letame maturo; successivamente si ricorre
ai concimi minerali, che devono essere distribuiti ogni anno, nel periodo primaverile. In
novembre si staccano i polloni radicati, cercando di non rovinare le radici, e si mettono
direttamente a dimora; in seguito si tagliano all’altezza di 25 centimetri dal livello del
terreno. Se questa operazione è stata effettuata in primavera, è consigliabile evitare che la
pianta produca frutti nel primo anno, altrimenti potrebbe indebolirsi notevolmente: in
questo caso si asportano i frutti appena cominciano a formarsi. Alla fine del primo anno di
vita delle piante, si eliminano tutti i fusti deboli. I frutti si raccolgono quando sono
completamente maturi e sono utilizzati freschi o usati nella preparazione di dolci, gelati,
sciroppi, succhi, marmellate, caramelle, liquori. Il lampone può avere un impiego anche
farmacologico, in quanto ha azione rinfrescante e diuretica.
La mora di rovo è un arbusto da frutto, spontaneo in Italia, alto 50-150 centimetri;
cresce bene nei terreni freschi e ben drenati, al sole o in posizioni parzialmente
ombreggiate. Dato che la fioritura non avviene all’inizio della primavera, ma più tardi, in
genere non si verifica il problema delle gelate primaverili. Si mette a dimora in autunno e
subito si tagliano i fusti all’altezza di 25-30 centimetri dal livello del terreno. La mora si
coltiva come arbusto prostrato oppure munito di sostegni e si moltiplica facilmente per
propaggine apicale, in quanto radica facilmente all’estremità dei rami. Questi ultimi
vengono interrati in agosto-settembre e staccati dalla pianta madre nella primavera
successiva; si mettono direttamente a dimora o si piantano in vivaio, dove si coltivano fino
all’autunno. La produzione dei frutti inizia nel corso dell’annata seguente. Dopo la raccolta,
si asportano i rami che hanno prodotto i frutti. Questi ultimi si raccolgono quando sono
diventati neri e hanno sapore dolce e vengono consumati direttamente o destinati alla
produzione di marmellate, sciroppi, succhi e gelati.
Il mirtillo, sia rosso sia nero, è un arbusto semilegnoso che raggiunge il mezzo
metro d’altezza e cresce bene nei terreni torbosi non calcarei. Si mette a dimora in
autunno o all’inizio della primavera, al sole o in ombra parziale. In settembre si possono
eseguire propaggini, che vengono staccate dalla pianta madre dopo 1-2 anni. In ottobre o
in febbraio-marzo si dividono le piante e si mettono direttamente a dimora. In luglio si
prelevano talee lunghe 5-8 centimetri e, dopo averle fatte radicare in un miscuglio di torba
e sabbia, si invasano in piccoli contenitori riempiti con miscugli di torba, sabbia grossolana
e terriccio da giardino non calcareo e si tengono in letto freddo fino al mese di ottobre,
quando si trapiantano in vivaio, dove si coltivano per 2-3 anni. I frutti maturi del mirtillo
nero, dal sapore dolce e aromatico, si possono consumare crudi o cotti e vengono
impiegati nella preparazione di succhi, marmellate, gelatine e per aromatizzare grappe e
liquori digestivi. I frutti maturi del mirtillo rosso, dal sapore acidulo-amarognolo, vengono
impiegati nella preparazione di marmellate, gelatine, grappe e liquori casalinghi.
L’uva ursina è un arbusto a fusti prostrati. .Si mette a dimora in settembre-ottobre o
in marzo-aprile in terreno umido, torboso, al sole o in ombra parziale. Si moltiplica per
propaggini, interrando i lunghi rami a marzo; questi vengono separati dalla pianta madre
dopo 1-2 anni, quando hanno radicato bene. Si effettuano anche le talee, prelevando
germogli laterali lunghi 5-8 centimetri, in luglio-agosto; si depongono in un miscuglio di
torba, terriccio privo i calcare e sabbia grossolana; i vasi si interrano all’aperto; in
settembre-ottobre, le piante giovani possono essere messe definitivamente a dimora.
La fragola è una pianta orticola molto diffusa, coltivata in molte zone d’Italia per
ottenere i frutti; si adatta a condizioni ambientali molto diverse e può essere coltivata
anche in zone collinari e montane, fino ai 1000 metri di altezza. Non ha particolari
esigenze pedologiche, anche se sono da sconsigliare i terreni calcarei; resiste bene al
freddo, ma teme le gelate tardive. È una pianta che cresce bene all’ombra, quindi si presta
bene a essere coltivata nel sottobosco. La coltura delle fragole può essere effettuata per
un periodo variabile da 3 a 5 anni sul medesimo terreno. La messa a dimora può essere
effettuata a una distanza di 30 centimetri tra loro e in file distanti 30 centimetri in
settembre-ottobre o in marzo-aprile. La moltiplicazione si effettua per via vegetativa,
sfruttando la caratteristica delle fragole di produrre nuove piantine in corrispondenza dei
nodi degli stoloni. Quando queste sono ben sviluppate, si staccano e si mettono
direttamente a dimora. I frutti della fragola selvatica, ricchi di zuccheri e vitamine, sono
molto più profumati di quelli ottenuti dalle grosse fragole coltivate e si utilizzano per
profumare e decorare gelati, macedonie e torte di frutta. Le foglie si possono utilizzare in
gradevoli tisane primaverili.
COLTIVAZIONE DI TARTUFI
La tartuficoltura può essere considerata un’attività agronomico-forestale piuttosto
recente se paragonata a coltivazioni quali la viticoltura o l’olivicoltura che si praticano da
tempi biblici.
I fattori da tenere sotto controllo per arrivare al risultato finale vale a dire una
produzione di tartufi economicamente valida e costante nel tempo sono molteplici e non
tutti ancora perfettamente noti. Sicuramente rimane molto da fare nel settore della ricerca
e della sperimentazione ma, ne vale la pena, in quanto la tartuficoltura permette di
produrre un bene di elevato valore economico, la cui domanda è in continua crescita sui
mercati mondiali e la cui produzione ha un impatto positivo sull’ambiente in quanto non
può prescindere dal rimboschimento, con tutti i benefici ambientali e paesaggistici che
esso comporta.
In Italia sono presenti allo stato spontaneo, numerose specie di tartufo, di queste
solo sette sono ammesse al commercio, esse sono: il tartufo nero pregiato (Tuber
melanosporum Vittad), il tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), il tartufo nero estivo
(Tuber aestivum Vittad.) il tartufo uncinato (Tuber uncinatum Chat.), il tartufo brumale
(Tuber brumale Vittad.), il tartufo nero moscato (Tuber brumale Vittad. forma moschatum
Ferry), il tartufo nero di Bagnoli (Tuber mesentericum Vittad.), il tartufo nero liscio (Tuber
mascrosporum Vittad.) e il tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vittad.).
La specie più largamente coltivata e che ha dato i migliori successi produttivi è il
tartufo nero pregiato; è stata tentata la coltivazione del tartufo bianco ma con esiti alquanto
deludenti; buoni risultati si sono avuti con il tartufo bianchetto e con il tartufo estivo.
La coltivazione dei tartufi in Italia è incominciata verso la metà degli anni ottanta del
secolo scorso, in questo arco di tempo sono stati registrati risultati estremamente diversi:
da buone produzioni a completi fallimenti.
Sulla scorta delle esperienze fatte, si può affermare che una tartuficoltura razionale
ed economicamente valida debba tenere nella giusta considerazione i seguenti aspetti:
1 - Idoneità del sito alla coltivazione dei tartufi
I tartufi hanno esigenze pedologiche e climatiche molto precise e specifiche per
ciascuna specie. Prima di intraprenderne la coltivazione, bisogna valutare se il terreno
scelto è idoneo ed eventualmente, a quale specie. I terreni estremamente compatti o con
pH acido vanno comunque scartati, quelli che hanno altre caratteristiche vanno
attentamente analizzati. E’ indispensabile un’indagine pedologica in cui vengano analizzati
la tessitura, la struttura, il pH, la presenza di carbonato di calcio totale e di quello libero
nella soluzione circolante. E’ necessaria anche un’analisi stazionale che prenda in
considerazione l’altitudine, l’esposizione, la pendenza e un esame della vegetazione che
metta in evidenza le specie forestali presenti nei boschi limitrofi e il loro sviluppo allo stato
adulto.
2 - Scelta della giusta combinazione pianta – tartufo
Stabilita la specie di tartufo più indicata ad essere coltivata nella tipologia di suolo a
disposizione, bisogna scegliere la specie forestale simbionte in base alle caratteristiche
climatiche e vegetazionali della stazione. Il tartufo nero di Norcia ad esempio ha dato
ottimi risultati produttivi in simbiosi con il leccio però, questa specie forestale non è adatta
alle quote elevate. E’ preferibile realizzare impianti con due o tre essenze forestali per
avere una maggiore variabilità fonte di garanzia verso gli eventuali stress climatici o
patologici.
3 - Fornitura delle piante
Le piante micorrizate sono prodotte da vivai specializzati dislocati soprattutto nel
Centro - Nord Italia. Generalmente la qualità delle piante prodotte in Italia è buona ma, è
sempre opportuno richiedere piante certificate. La certificazione della qualità delle piante
viene effettuata da strutture pubbliche (Università e altri enti di ricerca) sulla base di un
protocollo abbastanza rigido, essa non è obbligatoria in quanto i vivaisti possono fornire
un’autocertificazione, la maggior parte dei vivai italiani comunque, richiede la
certificazione alle strutture preposte. Il prezzo medio di una pianta micorrizata oscilla dai
6,5 euro ai 10,5 euro soprattutto in base alla specie di tartufo simbionte, (le piante
micorrizate col tartufo nero pregiato costano in media uno o due euro in più rispetto a
quelle micorrizate con altre specie), e al fatto se sono certificate o autocertificate (la
certificazione incide per circa 0,5 euro). E’ bene prenotare le piante con un certo anticipo
in quanto, negli ultimi anni, si sta verificando una vera corsa alla piantagione di tartufaie e
pertanto i vivai migliori ne rimangono presto sforniti.
4 - Lavorazioni pre impianto
Tutti gli interventi agronomici devono essere decisi in base alla tipologia di suolo e
alla combinazione pianta tartufo prescelta. In generale le operazioni pre impianto sono:
Decespugliamento
La vegetazione legnosa, sia arbustiva che arborea, deve essere eliminata per
facilitare le lavorazioni, per avere maggiore spazio di piantagione, ma, soprattutto, perché
alcune specie potrebbero essere già micorrizate con funghi presenti nel terreno e quindi
rappresentare una fonte di inoculo di funghi competitori. Prima di intervenire sulla
vegetazione arborea e/o arbustiva, è buona norma verificare la legislazione vigente.
Spietramento
Nel caso di presenza di grossi massi, sarebbe opportuno provvedere al loro
allontanamento, compatibilmente con i costi che questa operazione comporta. In alcuni
impianti, i sassi sono stati macinati sul posto e sparsi sul terreno per sfruttare il loro effetto
pacciamante ma, è una operazione non consigliabile in quanto troppo onerosa.
Lavorazione del terreno
La lavorazione principale deve essere decisa in base al tipo di suolo e alle colture
precedenti l’impianto. In generale la profondità dell’aratura non dovrebbe superare i 30 -
40 cm, profondità maggiori potrebbero portare in superficie orizzonti sterili o troppo
argillosi inoltre, verrebbe alterato l’assetto della flora microbica del suolo. In generale, per
terreni mediamente profondi si consiglia una rippatura incrociata in modo da favorire la
circolazione dell’aria e dell’acqua senza rovesciamento del suolo, seguita da un’aratura
piuttosto superficiale e un successivo affinamento delle zolle. Sarebbe opportuno eseguire
i lavori prima dell’estate in modo che, i probabili propaguli di funghi competitori presenti
naturalmente nel terreno, vengano esposti il più possibile all’aria e inattivati dalle elevate
temperature e dalla carenza idrica estiva.
Sesto d’impianto
Il sesto di impianto deve essere deciso in base alla specie forestale simbionte, allo
sviluppo probabile che la pianta avrà da adulta, alla specie di tartufo e all’esposizione del
terreno. In pratica, si deve riuscire a prevedere l’ombreggiamento operato dalle chiome
delle piante adulte considerando che: il tartufo nero tollera male ombreggiamenti superiori
al 60%, il tartufo estivo tollera ombreggiamenti maggiori, il tartufo bianco predilige un
ombreggiamento del 100%. E’ buona norma adottare sesti larghi piuttosto che stretti:
numerose tartufaie realizzate con la combinazione carpino nero - tartufo nero pregiato, in
stazioni favorevoli allo sviluppo della specie forestale, dopo 10 - 15 anni risultano troppo
ombreggiate. In questi casi bisogna intervenire con le potature che sono abbastanza
onerose o con il diradamento, una scelta molto difficile quando la maggior parte delle
piante sono in produzione.
Piantagione
L’epoca più idonea per la piantagione è quella autunno - vernina se le temperature
non sono troppo basse, se il terreno non è occupato dalla neve per lunghi periodi, ecc.,
oppure la primavera ponendo attenzione ai ritorni di freddo. Qualche giorno prima della
messa a dimora è bene sospendere l’irrigazione delle piantine in vaso, in modo che il pane
di terra sia asciutto e quindi la sua estrazione facilitata.
Irrigazione
Deve essere prevista l’irrigazione di soccorso alle giovani piantine in modo da
favorire il loro attecchimento. Una pianta ben micorrizata è più resistente alla siccità ma, la
fase di affrancamento è molto delicata, uno stress idrico prolungato può compromettere
oltre alla pianta, le micorrize.
Verifica della produzione
La verifica della produzione si incomincia intorno al quarto -quinto anno, dopo
questo lasso di tempi infatti, se gli impianti sono stati realizzati e condotti razionalmente, è
possibile raccogliere i primi tartufi. Per tutte le specie, ad esclusione del tartufo bianco,
produzioni interessanti incominciano ad esserci, in media, dal decimo anno in poi. In caso
di assenza di produzione, si può verificare la permanenza delle micorrize sugli apparati
radicali mediante l’analisi di campioni di radici. Sono analisi che possono essere effettuate
solo in pochi laboratori specializzati e sono abbastanza costose (30 - 60 euro a
campione).
Truffe e raggiri
Da almeno un decennio operano alcune strutture che hanno truffato molti
imprenditori agricoli in tutta Italia. La loro tecnica consiste nel presentarsi come
professionisti esperti del settore, nel dichiarare che le piante micorrizate da essi proposte,
sono eccezionali in quanto prodotte con metodologie innovative in collaborazione con
strutture scientifiche particolarmente note, di volta in volta, italiane o francesi; nel garantire
l’entrata in produzione delle loro piante micorrizate già al terzo anno dall’impianto;
nell’assicurare una produzione di tartufo da 1 a 3 chili per ciascuna pianta; nel rendersi
disponibili a ritirare essi stessi il tartufo prodotto a prezzo di mercato. Nei primi tre anni
forniscono assistenza tecnica con uno o due sopralluoghi sull’impianto e consigliano una
mistura liquida contenente sostanze che favorirebbero la produzione dei tartufi. Le piante
micorrizate vengono vendute a un prezzo che oscilla dai 60 - 120 euro, i sopralluoghi
vengono effettuati dietro pagamento e il costo della pozione è di parecchie centinaia di
euro a litro. Purtoppo le persone truffate sono centinaia e distribuite in tutta Italia
A scanso di equivoci si precisa che:
1 - non esistono piante micorrizate italiane o straniere in grado di produrre un chilo
di tartufo dopo tre anni;
2 - nessuno è in grado di garantire l’entrata in produzione di una pianta micorrizata
e prevedere la quantità di tartufo prodotto;
3 - le strutture di ricerca pubbliche italiane non collaborano con i vivai per la
produzione delle piante micorrizate, su richiesta dei vivaisti e mediante apposite
convenzioni, effettuano il controllo della qualità delle piante e rilasciano un certificato.
4 - Non esistono, attualmente, misture miracolose che possano favorire la
fruttificazione dei tartufi.
Un’altra truffa meno frequente è quella d i vendere come micorrizate, essenze quali
l’olivo, il rosmarino o altre piante che non contraggono la simbiosi micorrizica con le specie
del genere Tuber.
Risultati produttivi delle tartufaie realizzate con piante micorrizate tartufo nero
pregiato (con particolare riferimento all’esperienza delle regioni dell’Italia Centrale)
Nelle zone di collina e montagna che presentano caratteristiche pedoclimatiche
idonee a diverse specie di tartufi neri (Tuber aestivum Vittad., Tuber brumale Vittad.,
Tuber mesentericum Vittad.), è stata privilegiata la coltivazione di Tuber melanosporum
perché più pregiato. Nel primo decennio di coltivazione dei tartufi, la tendenza purtroppo,
è stata quella di dare importanza soprattutto alla micorrizazione della pianta simbionte,
senza tenere nella giusta considerazione i caratteri pedoclimatici del sito di impianto,
nell’errata convinzione che piante ben micorrizate avrebbero comunque prodotto tartufi.
Ovviamente queste prime piantagioni hanno fornito risultati produttivi diversificati e poco
soddisfacenti: accanto a piantagioni produttive se ne registrano altre improduttive
realizzate in ambienti non idonei, oppure con piante simbionti non ben micorrizate o
coltivate in maniera irrazionale.
Gli impianti di tartufo nero pregiato realizzate negli ambienti idonei, utilizzando la
specie di pianta simbionte adatta al sito e adottando opportune pratiche colturali di
impianto e post-impianto, stanno fornendo produzioni soddisfacenti ed in alcuni casi
eccezionali (da 20 - 30 kg/ha a oltre 100 kg/ha).
Risultati produttivi delle tartufaie realizzate con piante micorrizate da tartufo bianco.
Gli impianti di tartufo bianco sono stati realizzati soltanto fino al 1992-93;
successivamente le micorrize che, su basi morfologiche, si ritenevano di tartufo bianco
non sono state confermate come tali dall’analisi molecolare e ciò ha determinato un blocco
della produzione delle piante micorrizate. Nelle ultime due stagioni produttive, due
tartufaie realizzate nel 1985-87 e situate in due località distanti tra di loro, hanno iniziato a
produrre ottimi carpofori di tartufo bianco. Per cui riteniamo che sia possibile coltivare con
successo anche questa specie, debbano però, essere continuati e approfonditi gli studi
sull’ecologia, sulle tecniche di micorrizazione e di coltivazione, fortunatamente ci sono vari
gruppi di ricercatori, prevalentemente italiani che stanno affrontando le varie tematiche
ancora da chiarire per riuscire a coltivare questo prezioso tartufo.
Risultati produttivi delle tartufaie realizzate con piante micorrizate da tartufi minori:
tartufo nero estivo o scorzone e tartufo bianchetto o marzuolo.
Negli ambienti ritenuti non idonei alle due specie pregiate di tartufo, sono state
realizzate tartufaie utilizzando i così detti “tartufi minori” e cioè Tuber aestivum Vittad. e
Tuber borchii Vittad. In alcune piantagioni di Tuber melanosporum si è verificata la
sostituzione delle micorrize del tartufo nero con quelle di Tuber aestivum. In particolare, in
una tartufaia situata nel comune di Spoleto, una parcella di 5000 mq di carpino nero
realizzata con piante micorrizate da Tuber melanosporum, impiantata nel 1984, ha fornito
nelle ultime stagioni produttive buoni quantitativi di tartufi estivi (25-70 kg). Impianti
realizzati con piante micorrizate da Tuber aestivum in siti idonei, hanno dimostrato una
precoce entrata in produzione (quarto - quinto anno dall’impianto) e una produzione
piuttosto elevata ( 30 - 50 kg/ha).
Tuber borchii (bianchetto) è notoriamente una specie a larga diffusione e
apparentemente molto adattabile alle condizioni pedoclimatiche più diverse. Esso,
comunque, mostra una forte dipendenza dalle conifere: in moltissimi rimboschimenti a
Pinus nigra Arnold si raccolgono discreti quantitativi di carpofori di questa specie. Ricerche
sull’ecologia del bianchetto hanno rilevato una larga distribuzione e la capacità di
colonizzare anche i terreni sub-acidi. I migliori risultati produttivi verificati in tartufaie
presenti in Umbria, Lazio e Campania, sono stati ottenuti in terreni con tessitura franco-
sabbiosa o franco-sabbiosa-argillosa, quindi suoli assolutamente non compatti,
caratterizzati da bassi valori di densità apparente, con calcare in basse percentuali e con
pH che può variare dalla lieve acidità a leggermente alcalino. Anche in questo caso le
produzioni sono state relativamente precoci e quantitativamente significative.
PRODUZIONE DI FUNGHI SPONTANEI
La domanda commerciale di funghi, nel 1999, è stata di 70.000 tonnellate. Per
soddisfare questa domanda sono importate massicce quantità di funghi dai paesi dell’Est
europeo e da altri continenti.
Le specie fungine più richieste dal mercato, allo stato fresco, secco e conservato,
sono quasi tutte ectomicoriziche e quasi nessuna di loro può essere coltivata. La
coltivazione dei funghi ectomicorrizici, infatti, è stata realizzata con relativo successo per le
specie pregiate del genere Tuber (tartufi). Per tutte le altre specie ci sono grosse difficoltà
per la preparazione delle piante micorrizate.
La presenza dei funghi spontanei è strettamente legata alla vegetazione forestale
specialmente a quella tipica dei nostri boschi naturali. Oltre alle specie forestali che
caratterizzano il bosco, le produzioni fungine dipendono molto dai vari gradi di densità del
bosco: il bosco ideale per la produzione di funghi è quello ricco di piccoli spazi privi di
vegetazione forestale.
I funghi per arrivare alla fase di fruttificazione necessitano di calore solare che
scaldi il terreno e di acqua di pioggia che favorisca il potenziale di umidità del suolo e,
proprio nelle radure, questo fenomeno si esprime nella sua forma migliore. E’ proprio
ispirandosi alla scarsa densità del bosco e alla presenza di zone prive di vegetazione al
suo interno che sono stati fatti dei tentativi di trattamento selvicolturale studiati
appositamente per arrivare ad un aumento della produzione di funghi. Uno degli interventi
più comuni è l’irrigazione sopra le chiome degli alberi con nebulizzatori nelle zone dove
abitualmente nascono i funghi. L’acqua distribuita in periodi prestabiliti viene ceduta
lentamente al suolo, contribuisce a favorire i processi di fermentazione agendo
direttamente sui miceli con conseguente anticipo della fruttificazione e con produzioni di
tutto rispetto. Altri tentativi importanti sono stati fatti con interventi selvicolturali.
Diradamenti intensi con riduzione della copertura anche del 30-40% hanno favorito la
produzione di funghi.
Effettuare interventi in bosco in grado di aumentare la produzione di funghi può
essere utile per gli operatori agricoli che risiedono nelle aree collinari e montane, spesso
marginali per l’agricoltura. In tali zone la raccolta e la conservazione dei funghi epigei
commestibili, o la loro valorizzazione all’interno di un’azienda agrituristica, possono
rappresentare una risorsa economica integrativa.
ALLEVAMENTI ALTERNATIVI Lo sviluppo economico e sociale che si è avuto in Italia negli ultimi decenni ha
determinato
profonde trasformazioni nell’agricoltura, che hanno portato a modificare il paesaggio
e l’utilizzazione del territorio. In particolare si è assistito ad una concentrazione dell’attività
agricola nelle zone più fertili, cioè nelle zone di pianura e pedocollinari, dove è stato
possibile impiegare tecniche colturali adatte all’incremento delle produzioni e al
miglioramento delle condizioni di lavoro dell’uomo, mentre l’agricoltura di collina e di
montagna è andata marginalizzandosi.
Si sono differenziate quindi due agricolture: una caratterizzata da livelli produttivi
elevati con largo ricorso ai mezzi tecnici moderni, localizzata nelle zone largamente
antropizzate; l’altra, a bassa produttività, basata principalmente sull’utilizzo delle risorse
naturali presenti nelle zone a scarsa antropizzazione, che man mano sono state più o
meno marcatamente abbandonate e ricolonizzate al bosco.
Alla fine degli anni ’70, si è tentato di recuperare alla produttività queste terre
incolte, soprattutto laddove non sussistevano sufficienti condizioni di destinazione delle
stesse ad attività agricole o zootecniche di tipo tradizionale.
Le vie di utilizzazione di queste aree, stimabili in 15 milioni di ettari, sono state
soprattutto quella forestale e quella faunistica, peraltro non in contrasto tra loro e, almeno
in parte, sovrapponibili.
Una maggiore utilizzazione faunistica del territorio, realizzabile con minimi interventi
strutturali e infrastrutturali, ha potuto infatti aumentare le potenzialità di numerose aziende
agricole sotto l’aspetto dell’integrazione dei redditi, e, contemporaneamente, contribuire
alla ricostruzione dell’equilibrio ecologico e al recupero economico attraverso la
produzione di carne e, forse più proficuamente, attraverso lo sviluppo turistico o turistico-
venatorio.
UTILIZZAZIONE FAUNISTICA
La possibilità di allevare selvatici si è presentata come strategia alternativa nella
diversificazione produttiva delle imprese. Nelle aree marginali è stato un fatto
estremamente importante, da non sottovalutare in quanto ha rappresentato una fonte di
reddito e di occupazione, così come da tempo avveniva in altri Paesi dell’Europa e del
Mondo, che avevano avvertito assai prima dell’Italia la portata del problema ed avevano
operato in tal senso.
E’ fuori dubbio che l’animale selvatico si è rivelato un buon utilizzatore delle risorse
naturali, in quanto dotato di grande capacità di adattamento all’ambiente, di spiccata
resistenza alle malattie e di elevata possibilità di sopravvivenza anche in condizioni difficili.
Peraltro, la reintroduzione di selvatici nelle zone ad essi destinabili, ha costituito anche un
fattore di riequilibrio ecologico, oltre che una fonte di proteine animali di elevato pregio.
Gli allevamenti di ungulati selvatici a scopo alimentare sono stati resi possibili in
Italia dalla legge nazionale 968/77 sulla protezione della fauna. I primi allevamenti sono
sorti agli inizi degli anni ’80 con la emanazione delle leggi regionali. E’ necessario ottenere
autorizzazioni per l’esercizio di questa attività, in quanto gli animali in libertà appartengono
allo Stato e la detenzione senza autorizzazione comporta ipotesi di appropriazione di beni
statali con sanzioni di tipo amministrativo e penale.
L’allevamento a scopo alimentare si è configurato quindi come attività zootecnica
(art. 19 L968/77) e si è differenziato, perciò, in maniera sostanziale dalle tipologie di
allevamenti previste dalla legge come strumenti della gestione faunistica e venatoria del
territorio (centri di produzione di selvaggina, recinti di caccia in aziende faunistico-
venatorie). Per questo motivo essi sono sottoposti a vincoli di estensione spaziale minima,
di quantità massima di territorio impiegabile, di autorizzazione e conduzione che ne
rendono meno generalizzabile la realizzazione.
Ogni allevamento viene attuato in un ambiente confinato e, necessariamente, più o
meno artificiale, nel quale gli animali sono sottratti all’azione selettiva dell’ambiente e in
parte anche alle normali interazioni sociali. Oltre al rischio di consanguineità, i soggetti
prodotti in cattività sono per lo più inadatti a sopravvivere e riprodursi con successo in
libertà. Gli allevatori tendono ad utilizzare, per la produzione della carne, gli esemplari più
prolifici e più grossi, che si rivelano invece molto meno adatti per il ripopolamento.
E’ necessario, pertanto, orientare l’allevamento verso un tipo o l’altro di produzione,
perché “materia prima” e criteri di gestione sono completamente diversi.
ALLEVAMENTO DEGLI UNGULATI SELVATICI
Nell’ultimo censimento dei primi anni ’90, in Italia è stata accertata la presenza di
circa 970 allevamenti di ungulati selvatici, per complessivi 28.600 capi, con una media di
circa 30 unità per allevamento. Le prospettive sono per un trend positivo.
Le specie più allevate sono: cinghiali (14.100), daini (9.900), mufloni (2.100), cervi
(1.600) e caprioli (850) in numerosi allevamenti privati (~910), con un numero medio
ridotto di capi (~20), e pubblici (~60), con in media circa 180 capi. Questi allevamenti non
risultano distribuiti uniformemente sul territorio nazionale. Al primo posto per numero di
capi allevati si trova la Toscana (~8.900), seguita da Umbria (~3.900), Piemonte (~3.300)
e Lazio (~2.600); consistenze minori sono state rilevate nelle altre regioni (in media 650
capi).
Si può osservare, pertanto, che la concentrazione maggiore di animali è presente
nell’Appennino centrale, dove si vanno qualificando anche le attività indotte, quali
soprattutto la ristorazione e l’attività venatoria, che possono contribuire alla valorizzazione
del prodotto.
I problemi con cui debbono confrontarsi gli allevatori sono prevalentemente di tre
tipi: legale, finanziario e commerciale.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’ottenimento dell’autorizzazione
all’allevamento risulta abbastanza facile, anche se alcune regioni tendono a limitare il
numero di concessioni per evitare di sottrarre troppo territorio alla caccia.
La legislazione sanitaria è quella che crea i problemi più grossi, in quanto la
commercializzazione della carne dei selvatici allevati non può essere ancora effettuata
nelle macellerie accanto a quella degli animali domestici (a meno che si ricorra a
confezioni sotto vuoto o in atmosfera controllata). Inoltre viene favorita la macellazione nei
mattatoi pubblici, con riduzione delle autorizzazioni a livello aziendale.
Il D.P.R. 30.12.1992, n. 559 “Regolamento di attuazione della direttiva 91/495/CEE
concernente la produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di
allevamento” (G.U. n. 28 del 4.2.1993), fissa i requisiti igienico-sanitari per la produzione e
la commercializzazione delle carni di coniglio e di selvaggina e stabilisce cosa si intende
per “selvaggina in allevamento”.
Il D.P.R. 17.10.1996, n. 607, “Regolamento recante norme per l’attuazione della
direttiva
92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione
di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni” (G.U. n. 280 del 29.11.1996),
stabilisce i requisiti sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione, preparazione e
commercializzazione di selvaggina cacciata, definendo la “selvaggina cacciata”,
sostanzialmente differente dalla selvaggina allevata per autonomia di ricovero e di
approvvigionamento, anche se confinata in un territorio chiuso.
Così i mammiferi biungulati (daini, cervi, mufloni) possono essere macellati in
impianti autorizzati per grossi animali (bovini, equini, suini, ovini e caprini) ai sensi del
D.L.vo 286/94, in quanto i requisiti di questi mattatoi ben si prestano a far fronte alle
esigenze igienico-sanitarie derivanti dalla macellazione di specie, che con i grossi animali
hanno molto in comune. Analogamente quaglie, piccioni, fagiani possono essere macellati
in mattatoi riconosciuti ai sensi del D.P.R. 503/82 per volatili da cortile (polli, oche, anatre,
ecc.).
Relativamente all’aspetto finanziario, l’impianto di un allevamento completamente
funzionale necessita di investimenti di somme elevate per le recinzioni e per le altre
strutture (trappola di cattura, mangiatoie, abbeveratoi, ecc.).
L’aspetto più critico, con rischio di compromissione della redditività delle aziende, è
quello commerciale, legato soprattutto ai costi molto elevati della carne prodotta da un
numero limitato di animali in allevamenti privati, sui quali incidono fortemente le spese di
macellazione, lavorazione, trasporto, visite sanitarie e ammortamento delle strutture. A
questo si deve aggiungere la concorrenza della carne di provenienza venatoria da altri
Paesi (sia fresca che congelata) e la commercializzazione di animali da vita sotto costo da
parte degli enti pubblici.
Allevamento dei cervidi
L’allevamento dei cervidi e del muflone è riconducibile a tre modelli fondamentali,
semi-intensivo, semi-estensivo e sfruttamento estensivo (gestione faunistica)
Allevamento semi-intensivo
Generalmente adottato per Cervo e Daino, secondo moduli riconducibili ad una
stabulazione libera “ampia”, semplificata rispetto a quella caratteristica degli animali
domestici.
L’allevamento semi- intensivo, finalizzato prevalentemente alla produzione di carne,
prevede una scelta iniziale di soggetti provenienti di preferenza da allevamenti analoghi,
che, naturalmente, non sono adatti al ripopolamento.
In questa tipologia gli animali (densità superiore a 10 q PV/ha) sono alloggiati in
recinti generalmente intercomunicanti, per una utilizzazione a rotazione, e collegati con un
impianto di cattura. Per la recinzione si usa rete metallica, alta circa 2 m leggermente
interrata e sormontata da 2-4 ordini di filo spinato. I sostegni possono essere realizzati con
pali di legno o metallo posti ogni 5-7 m. Ogni recinto deve essere provvisto di abbeveratoi,
mangiatoie a rastrelliera e per concentrati; sono necessari anche ricoveri per la protezione
dai venti dominanti. Un elemento indispensabile è la trappola di cattura, piccolo recinto in
contatto con tutti i paddok dell’allevamento, in rapporto con uno stretto corridoio che
permette il passaggio di un solo animale alla volta. Essa è comunicante con una struttura
in metallo per l’immobilizzazione (crush), munita di finestre laterali e di una bilancia a
bascula, per i controlli ponderali.
Le risorse naturali all’interno dei recinti spesso non sono sufficienti a coprire i
fabbisogni degli animali e quindi si deve provvedere all’integrazione o alla
somministrazione completa della razione ricorrendo ad alimenti prodotti in azienda o del
commercio; per la completa soddisfazione delle loro esigenze nutritive è necessario
considerare l’elevato dispendio energetico, non sempre quantificabile, per il movimento,
per la termoregolazione e per i frequenti stati di stress.
Allevamento semi-estensivo
Presuppone ampie superfici e basso carico di animali (1¸5 q PV/ha). La superficie
deve essere suddivisa in recinti, ognuno dei quali di dimensioni intorno ai 2-3 ha. Gran
parte dell’alimentazione è assunta direttamente dagli animali, che utilizzano le produzioni
vegetali spontanee; tuttavia durante i periodi difficili sono previste integrazioni. I costi per
le recinzioni sono più elevati, dato il maggior sviluppo delle superfici, mentre sono più
bassi i costi di gestione. Anche in questo caso deve essere previsto un impianto di cattura
del tipo precedentemente descritto. Le condizioni di vita degli animali si avvicinano di più
alla situazione naturale, quindi questo tipo di allevamento è più idoneo per la produzione di
soggetti da destinare alla vita in libertà (allevamenti a scopo di ripopolamento, centri
pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica).
Gestione estensiva
Lo scopo principale è quello venatorio. La densità di animali prevista per unità di
superficie è molto bassa. Le spese di investimento, per la realizzazione di quelli che
vengono definiti recinti venatori e che vanno da un minimo di 300 ha in su, sono limitate
alle recinzioni esterne, che possono essere in gran parte sostituite da delimitazioni
naturali. Sono comunque opportuni punti di foraggiamento, di abbeverata, nonché punti di
insoglio e strutture strategiche per le osservazioni; devono inoltre essere previsti punti per
la cattura e i trattamenti sanitari. Il carico deve essere accuratamente controllato e
mantenuto intorno al valore massimo sostenibile all’ambiente, per evitare danni alle
coperture vegetali, onde un’evoluzione negativa delle fitocenosi, e carenze nutrizionali agli
animali; questo presuppone una buona conoscenza dell’offerta pabulare, nei diversi
periodi dell’anno, ed altrettanto buona conoscenza dei fabbisogni alimentari egli animali.
Quindi è corretto calcolare il numero massimo di capi allevabili in funzione dei periodi di
minima offerta. Tutti questi dati concorrono alla predisposizione del così detto “piano di
assestamento”, che prevede un numero adeguato di animali appartenenti alle varie classi
di età di una determinata specie, al fine di conservare le popolazioni senza arrecare danni
alla copertura vegetale. Ad equilibrio raggiunto si può programmare un “piano di
abbattimento selettivo”, cioè definire, nell’ambito di ciascuna specie, il numero e la
categoria di soggetti da abbattere (o vendere) in modo da mantenere la popolazione ai
livelli e nella struttura prevista dal piano di assestamento. Rientrano in questa tipologia di
gestione le aziende faunistico-venatorie.
Allevamento del cinghiale
Per il cinghiale sono previsti sistemi di allevamento intensivi, con attrezzature e
impianti del tutto simili a quelli del suino domestico, e sistemi più o meno estensivi.
Nel primo caso si fa ricorso a vere e proprie stalle in muratura, con box, provvisti di
recinti esterni da utilizzare anche per l’insoglio, separati per i verri, le scrofe e i cinghialetti
in accrescimento; può essere utile un reparto “maternità”, costituito da gabbie provviste di
vie di fuga per i suinetti, nei primi giorni di vita, al fine di evitare i rischi di schiacciamento.
Per quanto riguarda l’alimentazione vengono generalmente impiegati i prodotti del
commercio di norma utilizzati nell'allevamento suino; è comunque sempre opportuna una
integrazione con ghiande e castagne.
I sistemi estensivi e semiestensivi prevedono uno o più recinti, con ampie radure e
zone boscate, delimitati da rete con altezza fuori terra di 140-150 cm, interrata per 30-40
cm, e un impianto di cattura, costituito per lo più da un piccolo recinto, ovale o circolare,
delimitato da una robusta palizzata alta un paio di metri con chiusura a saracinesca
azionata dallo stesso animale. La densità degli animali può essere molto diversa in
funzione della quantità e della qualità dell’alimentazione fornita artificialmente; un capo
ogni due ettari si può considerare il valore ottimale per limitare i danni alla copertura
vegetale, per contenere l’alimentazione artificiale e per mantenere in buona salute gli
animali. Si consiglia comunque di non superare i due capi adulti per ettaro, anche nei casi
in cui si faccia ampio ricorso all’alimentazione “esterna”.
ALLEVAMENTO DELL’AVIFAUNA SELVATICA E DELLA LEPRE
L’allevamento dell’avifauna e della lepre può essere ricondotto a due forme, semi-
estensiva ed intensiva, che hanno però indirizzi e finalità non molto diversi fra loro, in
quanto ambedue destinano la loro produzione al ripopolamento e all’esercizio venatorio.
L’allevamento allo stato naturale (semi-estensivo) è quello in cui le risorse
alimentari spontanee vengono integrate con la somministrazione di mangimi nei periodi
critici dell’anno e con la predisposizione di “colture a perdere”. Possono rientrare in questa
tipologia di gestione le zone di ripopolamento e cattura, le aziende faunistico-venatorie ed
alcuni centri di riproduzione della selvaggina. Più diffuso è l’allevamento intensivo, del
quale vengono di seguito descritte le tecniche più utilizzate per diverse specie.
Allevamento dell’avifauna selvatica
Per questo tipo di allevamento l’ideale sarebbe l’utilizzazione di riproduttori
autoctoni di elevato pregio genetico, al contrario di quanto viene finora attuato attraverso
l’importazione di soggetti, prevalentemente dai paesi dell’Est europeo, con risultati
insoddisfacenti e notevoli danni per la fauna locale. In quest’ottica è preferibile eliminare
gli allevamenti di tipo industriale e far prevalere quelli di piccola e media dimensione,
tenendo conto delle capacità faunistiche della zona. La diminuzione del numero di capi
allevati comporta un aumento dei costi, ma una migliore gestione igienico-sanitaria e
l’ottenimento di animali di maggior pregio, grazie alla conservazione delle caratteristiche di
selvaticità e rusticità.
L’allevamento può essere iniziato in due diversi modi: acquistando uova o
utilizzando riproduttori adulti. Nel primo caso, rispetto al secondo, si ha una riduzione dei
costi, ma un allungamento dei tempi di entrata in produzione (circa un anno). I volatili
vengono allevati in voliere, dette parchetti, poste in luoghi tranquilli e soleggiati, su terreni
permeabili. Allo stato naturale fagiano e quaglia sono poligami, quindi anche in cattività è
necessario rispettare questo stato. Nel caso del fagiano si ricorre più comunemente
all’allevamento in "famiglie", cioè un maschio con 5-7 femmine; in alcuni casi si può optare
per quello in "colonie", in cui 6-7 maschi vengono allevati in grandi recinti con circa 40-45
femmine. La presenza di più maschi determina competizione e quindi una maggiore
attività di quelli più vigorosi; in questa situazione, però, è difficile individuare i riproduttori
poco attivi per procedere alla loro eliminazione.
L’allevamento della quaglia (1 maschio/5-7 femmine) viene effettuato generalmente
al chiuso. La starna e la pernice, sia in libertà che in allevamento, sono monogame, quindi
ogni coppia deve disporre di un proprio parchetto. Poiché in cattività la scelta dei partner
non avviene per simpatia, come in natura, è necessario formare le coppie con debito
anticipo, entro la metà di gennaio nelle regioni a clima mite ed entro la metà di febbraio
nelle regioni a clima freddo.
Generalmente la femmina di fagiano depone in media 50-60 uova a stagione (inizio
aprile-inizio luglio); la starna e la pernice da 20 a 80 uova (fine aprile- fine luglio); la
quaglia produce in media un uovo al giorno per tutto l’anno.
Le uova raccolte, prima di essere incubate, vengono conservate (massimo una
settimana) in luoghi freschi, fino al raggiungimento di un numero sufficiente da giustificare
l’avvio dell’incubatrice. Essa deve essere scelta in funzione del numero di femmine
presenti e delle uova deposte e sistemata in locale apposito (T ambiente intorno ai 16-20
°C). All’interno dell’incubatrice (T media: 37,5 °C ; umidità: 70% - 80%) le uova vengono
rivoltate periodicamente, a mano o in modo automatico, e, sempre periodicamente, si
esegue la speratura, per eliminare le uova non fecondate o con embrione morto. La durata
dell’incubazione è di circa 16 giorni per la quaglia, 24 per il fagiano, per la pernice e per la
starna.
In tutte le specie avicole, i riproduttori restano in produzione per no n più di tre anni,
dopo di che vengono messi in libertà a fine inverno. Al termine della stagione di
riproduzione viene effettuata una cernita dei soggetti più prolifici, che vengono utilizzati per
la rimonta. E’ necessaria l’immissione, ogni 2-3 anni, di alcuni maschi acquistati presso
altri allevamenti per ridurre al minimo i rischi di consanguineità.
Dopo la schiusa i pulcini vengono affidati a madri artificiali (generalmente lampade
a raggi infrarossi del tipo a campana), disposte nelle pulcinaie (~5 m2), locali caldi e ben
aerati, provvisti di abbeveratoi e mangiatoie. La temperatura iniziale di 38-39 °C viene
diminuita gradualmente dopo il quarto giorno per arrivare alla temperatura ambiente verso
il 14° giorno di vita. Trascorse 2-3 settimane, gli allievi sono trasferiti nelle voliere di
transizione, preferibilmente sistemate in luoghi riparati dai venti e ben soleggiati, dove
possono tentare i primi voli e abituarsi all’ambiente aperto.
Da 30 giorni fino a circa 60-90 giorni di età (momento più opportuno per il lancio) gli
animali sostano in voliere di allevamento, dove dispongono ad libitum, oltre che dei
consueti mangimi bilanciati, anche di granaglie e verdure fresche, in modo da abituarsi
all’alimentazione naturale.
Allevamento della lepre
La maggior parte dei tentativi compiuti per allevare le lepri in recinti a terra sono
falliti per l’insorgere, entro breve tempo, di vari tipi di epidemie, i cui agenti patogeni
permangono nel terreno anche per anni, rendendo, di fatto, impossibile un reale controllo
sanitario. Inoltre, le elevate densità, necessarie per rendere economicamente valido
l'allevamento, possono indurre negli animali vere e proprie sindromi da stress.
E' più usuale, pertanto, adottare l’allevamento in gabbia per i riproduttori. Le gabbie,
sollevate da terra per consentire la più completa pulizia e disinfezione, sono di maggiori
dimensioni rispetto a quelle dei conigli; mangiatoie, abbeveratoi, rastrelliere debbono
essere accessibili dall’esterno per non arrecare disturbo agli animali.
I nati per coppia sono in media 8-10 all’anno, con mortalità neonatale molto elevata
(intorno al 50%). I leprotti, tolti alle madri dopo 20-30 giorni dal parto, vengono alloggiati in
gabbie sistemate in zone protette dal vento e sollevate da terra; quelli destinati ai
ripopolamenti vengono trasferiti in recinti a terra, provvisti di buona copertura erbacea e di
un numero sufficiente di ripari, per favorire il loro adattamento alla vita libera. Per
l’alimentazione si ricorre prevalentemente all’uso di mangimi integrati, in minor misura a
quello di alimenti freschi, quali erba, foglie, ortaggi, frutta, ecc..