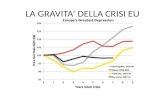Le nuove barriere alla coesione economica e sociale in Europa · che viene definita la convergenza,...
Transcript of Le nuove barriere alla coesione economica e sociale in Europa · che viene definita la convergenza,...
1
Le nuove barriere alla coesione economica e sociale in Europa
Intervento di Luciano Monti
Docente di Politiche dell’Unione Europea – LUISS Guido Carli
VII Ciclo di Seminari Europei e Tavole Rotonde “Dal Manifesto di Ventotene al Fiscal Compact”
Università della Calabria, Rende (CS), mercoledì 20 gennaio 2016
Desidero fare alcune brevissime considerazioni sull’attuale stato del processo di convergenza europea
per poi porre l’attenzione su quelli che ritengo essere i maggiori ostacoli a una sua piena realizzazione
nell’ambito dell’Unione Europea. Intendo iniziare con un esame dello stato odierno di integrazione delle
regioni europee, prendendo atto dell’interruzione del processo di convergenza, per poi concentrarmi sul
tema principale del mio intervento, enucleando quelle che reputo le principali barriere che si oppongono
ad uno sviluppo che, oltre ad essere sostenibile, deve anche necessariamente essere inclusivo.
Negli intendimenti originari, l’integrazione economica sarebbe stata raggiunta grazie alla rimozione degli
ostacoli alla libera circolazione nel mercato unico. In altri termini, la liberalizzazione economica avrebbe
condotto anche ad un diffuso benessere sociale. Successivamente, ci si è resi tuttavia conto che i problemi
di ritardo di sviluppo e le crisi di alcune delle aree della Comunità europea non si sarebbero risolti, ma
anzi aggravati, in un mercato aperto alla concorrenza e dunque soggetto a shock territoriali e a pressioni
esogene sempre più forti.
A fianco delle azioni dette di etero-correzione delle forze ostacolanti, della libera circolazione di merci,
persone e servizi, hanno dunque preso il via i primi strumenti di etero-compensazione, rivolti cioè a
sostenere economicamente programmi di investimento indirizzati a ridurre le cause strutturali del ritardo
accumulato dalle aree o dalle fasce di popolazione in difficoltà. Questo nuovo approccio ha dato vita a
quella che è stata definita la politica di coesione economica e sociale e ai suoi principali strumenti: i fondi
strutturali o, usando la terminologia introdotta nella programmazione comunitaria 2014-2020, i fondi SIE
(fondi strutturali e di investimento europei).
Ferma è dunque la convinzione che lo sviluppo armonioso della Comunità, riducendo le disparità tra le
differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite, fosse un obiettivo al quale l’Unione Europea dovesse
mirare in senso globale, uniformando quindi i redditi imponibili, le strutture economiche e sociali, i
sistemi di welfare e le relazioni industriali a elevati standard, tali da assicurare un benessere diffuso ai
cittadini europei.
Per contro, l’abbandono delle valute nazionali, il massiccio allargamento ai paesi dell’ex blocco comunista
e a parte dell’area balcanica, nonché il sempre più rigoroso controllo della spesa pubblica e del deficit dei
bilanci nazionali, hanno provocato e provocano non pochi disagi sia alle regioni maggiormente in
2
difficoltà, bisognose di politiche redistributive, sia ai governi impossibilitati ad attuare politiche di
sostegno o di protezione autonome. Le prime rese vane dai vincoli di bilancio imposti e dalla necessità di
fronteggiare la crisi mediante ulteriori tagli alle spese degli enti locali, e le seconde non coerenti con la
concorrenza e il regime degli aiuti di Stato (trasferiti alla competenza esclusiva della Commissione UE).
L’allargamento ad Est, inoltre, ha scavato un ulteriore solco in tema di divario territoriale. Con la tornata
di adesioni degli inizi dell’attuale secolo, l’Europa si è ritrovata con quasi cinquecento milioni di abitanti,
ma con un Pil aumentato di soltanto il 5%.
La fase recessiva avviatasi nel primo decennio di questo secolo ha aperto un ulteriore solco, questa volta
non tanto sulla linea Est-Ovest, quanto su quella Nord-Sud, con numerosi paesi dell’area mediterranea
chiamati a fronteggiare vere e proprie emergenze sociali, generate dal crollo della domanda interna, lo
smantellamento di una consistente componente del tessuto produttivo e le restrizioni al credito.
Da decenni si dibatte dunque sulla strategia volta a ridurre le principali vecchie e nuove cause che si
frappongono alla convergenza verso una piena integrazione. Questa cause vengono definite cause
strutturali di ritardo di sviluppo o ostacoli alla crescita di primo livello. Queste ultime rallentano quella
che viene definita la convergenza, cioè una crescita delle aree in ritardo di sviluppo maggiore rispetto alla
media comunitaria e tale da recuperare il gap iniziale. Cause che spesso, se non rimosse, possono non
solo precludere la crescita prevista, ma addirittura rallentarla a livelli inferiori di quella della media
comunitaria e accrescere la fragilità di un territorio in presenza di turbolenze generate da fattori
macroeconomici globali.
In tali ipotesi si assiste a un aumento del divario tra la regione colpita e la media nazionale di riferimento.
Tale fenomeno è detto di deriva o divergenza e contribuisce nel tempo ad aumentare le disparità fra le
diverse regioni.
La deriva non misura il livello di arretratezza di una determinata regione, ma il suo negativo scostamento
dalla media marginale di riferimento a livello nazionale o a livello europeo. In sostanza, si assiste a un
fenomeno di deriva anche nell’ipotesi di crescita dei principali indicatori (Pil e tasso di occupazione) se
tale crescita risulta essere inferiore in un dato periodo a quella della media del paese di appartenenza.
I dati Eurostat del 2013, che fotografano la ricchezza generata nelle 272 regioni dell’Unione Europea, non
lasciano dubbi in merito all’inefficacia della politica regionale europea adottata e segnano la profondità
della ferita inferta dalla recessione che ha colpito e colpisce molte aree dell’Europa.
A prescindere dall’abisso che intercorre tra la regione bulgara più povera dell’Europa, con 9.400 euro/PPS
(potere di acquisto standard) annui pro capite (pari a meno del 35% del Pil pro capite della media degli
europei), e la regione di Londra, con 86.400 euro/PPS (cioè quasi dieci volte la citata regione bulgara),
oltre la metà delle regioni italiane si trova al di sotto della suddetta media europea.
3
L’Italia arretra su tutti i fronti e, mentre prima della crisi alcune regioni italiane del Nord entravano nella
top ten delle regioni maggiormente sviluppate, ora per ritrovare una regione nostrana bisogna scendere
al ventunesimo posto (provincia di Bolzano, con 39.000 euro/PPS), mentre la Lombardia (35.700
euro/PPS) è scesa al trentesimo posto.
Il divario regionale nel nostro paese è tuttavia ampio e le regioni “più ricche” possono contare su un Pil
pro capite più che doppio rispetto a quello dei cittadini delle regioni meridionali. È vero che in termini
assoluti tale divario (21.200 euro/PPS, cioè la differenza tra il reddito nella regione più ricca e il reddito
nella regione più povera) è inferiore a quello registrabile in Germania (29.600 euro/PPS), ma quest’ultimo
interseca livelli di reddito ben differenti. I divari interni in Italia sono ben superiori a quelli di Grecia,
Spagna e (se escludiamo Parigi) anche della Francia.
Tra i fanalini di coda, tutti oltre la 220^ posizione, Calabria (con 15.100 euro/PPS, pari al 57% della media
europea) Puglia, Sicilia, Basilicata e Campania (queste ultime due al 69% della media europea).
Come noto, il Parlamento europeo, con la risoluzione 2013/2008 INI del 3 febbraio 2014, prendeva atto
di come la crisi economica avesse provocato una inversione nel processo di convergenza, ponendo così
fine a un lungo periodo in cui le disparità tra regioni europee – in termini sia di Pil pro capite sia di tassi
di disoccupazione – continuavano ad assottigliarsi. Fra il 2000 e il 2008 le disuguaglianze a livello regionale
in termini di Pil pro capite erano, infatti, costantemente diminuite, fino ad arrestarsi nel 2009. La forbice
della disuguaglianza tra regioni europee ha però ripreso ad allargarsi nei due anni successivi. Per contro,
le risorse pubbliche sia a livello degli Stati membri sia dell’UE sono diventate più limitate. In più, la crisi
del debito sovrano in diversi Stati membri ha spinto molte autorità nazionali ad attuare le necessarie
riforme strutturali, tagliando talora la quota di cofinanziamento dei Fondi strutturali e del Fondo di
coesione.
Il contestuale ridimensionamento dei piani di investimento pubblico nei vari comparti dell’economia ha
conseguentemente contribuito a rendere più “leggera” la politica regionale europea, orfana del sostegno
di misure nazionali di etero-compensazione (sacrificate, come appena ricordato, per rispettare i patti di
stabilità e non rifinanziate per ridurre il sempre maggiore debito pubblico).
Come rimarcato nella Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale curata dalla
Commissione europea nel 2014, tra il 2008 e il 2013 gli investimenti pubblici in tutta l’UE sono diminuiti
del 20%; in Grecia, Spagna e Irlanda il calo ha sfiorato il 60%.
I risultati di questo stato di cose stanno sotto gli occhi di tutti e l’effetto deriva si è fatto sentire non solo
sulla caduta dei Pil delle regioni con le economie più fragili, ma anche sulle fasce di popolazione e sulle
generazioni più a rischio. Si tratta di dati tristemente noti, che non risparmiano neppure i giovani con
laurea. È a questo punto opportuno affrontare anche l’altro aspetto del divario, dunque, quello che
colpisce alcune fasce di età.
4
Le rilevazioni dell’International Labour Organization (ILO) rese note all’inizio del 2013 confermano che a
esser maggiormente colpiti sono stati i giovani dei paesi più sviluppati. Mentre nel decennio 1998-2008
il tasso di disoccupazione giovanile era sceso del 12%, nel corso della crisi (dati 2008-2012) lo stesso è
risalito di 4,8 punti percentuali. Questo è semplicemente il dato aggregato, vedremo come in alcuni paesi
l’ascesa del tasso sia ben più significativa.
In controtendenza, invece, i paesi del Sud-Est asiatico e pacifico, che nello stesso periodo registrano un
calo della disoccupazione giovanile di 1,4 punti percentuali. I giovani beneficiano della globalizzazione,
ma non quelli europei.
La persistenza di alti tassi di disoccupazione giovanile, per gli analisti dell’ILO, sta modificando
radicalmente l’attitudine al lavoro delle nuove generazioni occidentali. Tale prolungata crisi del mercato
del lavoro, osservano, spinge la corrente generazione dei giovani ad essere meno selettiva nella tipologia
di offerta di lavoro da accettare, accontentandosi spesso di lavori precari, a tempo parziale, sottopagati
o sottodimensionati rispetto alle competenze acquisite.
Questo elemento non è da sottovalutare, in quanto la diversa attitudine, che conduce ad accettare anche
posizioni lavorative non in linea con le proprie competenze e aspirazioni, nel medio-lungo periodo
contribuisce a ridurre il tasso di competitività delle imprese che non sfruttano appieno il potenziale delle
loro risorse umane. Ciò avviene per la costante dissipazione di conoscenze acquisite dai giovani, che,
accettando di lavorare in funzioni sottodimensionate, finiscono per perdere le competenze originarie.
I paesi che alla fine del 2014 registravano la percentuale di giovani disoccupati più elevata erano tutti
quelli mediterranei, in testa Spagna (con oltre il 53%) e Grecia (con oltre il 50%), seguite da Croazia (con
oltre il 45%) e Italia (con oltre il 43%).
Un rapporto di Eurofound del 2013 (la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita
e di lavoro e organismo dell'Unione Europea), basato su dati Eurostat, mette inoltre l’accento
sull’incremento dei giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), cioè coloro che non
frequentano un percorso scolastico, un corso di formazione professionale né risultano occupati in Europa
dall’inizio della crisi.
Nel 2008 i NEET tra i 15 e i 24 anni erano l’11%, mentre quelli tra i 25 e i 29 anni erano il 17%. Tali
percentuali sono salite nel 2011 rispettivamente al 13% e al 20%, per un totale complessivo di ben 14
milioni di giovani. L’incremento maggiore si è registrato in Spagna, Italia, Irlanda e Bulgaria.
Se si mettono in relazione il livello educativo e lo status di NEET si nota come, prendendo sempre in
esame il paese più colpito, cioè l’Italia, la metà di questi ultimi presenta un livello d’istruzione che nella
classificazione ISCED (International Standard Classification of Education) va da 0 a 2, ossia dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado (in passato scuola media inferiore). Un’altra ampia
fetta di NEET, pari a quasi il 45%, è nella fascia educativa 3-4 (scuola secondaria di secondo grado e post-
5
secondaria). Invece, i NEET con istruzione terziaria (laurea triennale, laurea magistrale e dottorato di
ricerca), corrispondenti alla categoria 5-6 della classificazione ISCED, sono meno del 5%.
Questo fenomeno è da ricondurre alla originaria concentrazione delle risorse nei bacini di impiego
maggiormente colpiti dalla recessione, che assorbono tradizionalmente manodopera meno qualificata
(settore delle costruzioni e manifatturiero non tecnologico); meno, a mio avviso, alla minore flessibilità
delle risorse con bassi livelli di scolarità.
La persistenza di un alto numero di NEET riduce, dunque, il capitale umano delle giovani generazioni.
Riprendendo una frase del premio Nobel per l’Economia Krugman: “vanno in fumo i programmi finalizzati
a garantire il futuro”.
Questo divario si ripercuote ovviamente anche sulla ricchezza in capo ai soggetti interessati e introduce
l’altro profilo del divario, quello generazionale, e il conseguente fenomeno detto del trascinamento della
ricchezza. In un recente lavoro del Servizio Studi di Banca d’Italia (del 2012, a cura di D’Alessio), dal titolo
emblematico Ricchezza e diseguaglianza in Italia, si nota come il rapporto (tra ricchezza e Pil, nds) sia
comunque all’incirca raddoppiato (un po’ meno, se si esclude il debito pubblico), segnalando che il nostro
paese ha in questi cinquant’anni “incrementato la propria ricchezza più di quanto abbia incrementato la
produzione”. Questo indicatore testimonia la crescente rilevanza delle condizioni patrimoniali rispetto a
quelle reddituali con evidenti impatti negativi sullo sviluppo e sull’uguaglianza sociale. “La ricchezza che
ci proviene dal passato è infatti oggi più rilevante di ieri in rapporto a quella che è possibile procurarsi
giorno dopo giorno con l’attività lavorativa e di impresa”.
La popolazione dei baby boomer (i nati tra il 1946 e i primi anni Sessanta, secondo la classificazione di
Howe e Strauss) invecchia e porta con sé la sua ricchezza, a danno della produttività del paese. In altre
parole, si sta affermando il principio che “chi ha avuto ha avuto e chi non ha mai avuto mai avrà”. Una
sorta di proiezione del passato per la quale se non sei stato non potrai essere: quasi una chiusura
autarchica di una generazione che ha saputo sfruttare al meglio (e secondo taluni anche troppo) una
congiuntura favorevole.
Il consolidamento e “trascinamento” della ricchezza, che permette agli attuali over 64 anni di registrare
una ricchezza familiare netta 1,5 volte superiore a quella degli omologhi ultrasessantenni della fine degli
anni Ottanta, spiegano innanzitutto l’attuale tensione sociale tra coloro che hanno incrementato il
proprio patrimonio e stanno per ritirarsi dal mondo del lavoro e coloro che devono costruirsi il loro
avvenire partendo da un reddito sempre più difficile da conseguire e senza sicurezza sociale.
Il menzionato fenomeno del trascinamento della ricchezza chiarisce a livello macroeconomico il motivo
per cui i fondamentali di un paese come l’Italia continuino a essere solidi, ma anche la causa della perdita
di competitività del sistema paese e relativa offerta delle imprese nel mercato globalizzato. Spiega anche
perché la domanda interna, soprattutto di beni durevoli, continui a rimanere molto bassa.
6
I fondamentali sono solidi perché la ricchezza media pro capite rimane elevata e anche la propensione al
risparmio, grazie, come detto, alla concentrazione delle risorse in capo agli over 64 anni. La competitività
invece si abbassa a causa del mancato turnover nelle aziende e dell’assenza di forze giovani in grado di
assicurare quella spinta innovativa di cui le imprese sempre hanno bisogno. La domanda interna è bassa
perché i giovani, che avrebbero una maggior propensione al consumo di beni durevoli (la casa in primis),
non hanno le risorse economiche per acquistarli.
Il problema del trascinamento e della concentrazione della ricchezza non è però solo economico, ma
anche sociale, con l’emergere di sempre più forti diseguaglianze. In Italia, i dieci individui più ricchi
posseggono una quantità di ricchezza che è all’incirca equivalente a quella dei tre milioni di italiani più
poveri. La disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza è dunque più pronunciata di quella sul
reddito.
Una prima considerazione, quindi, è che la generazione europea dei baby boomer ha preferito
consolidare la propria ricchezza nel breve periodo piuttosto che porre le basi per una ricchezza futura,
generata da una politica industriale che mantenesse alto il livello di competitività dell’offerta aggregata
e un sistema previdenziale maggiormente in linea con le attuali dinamiche demografiche. Se a questi fatti
si aggiunge, per quanto concerne l’Italia, anche il lungo periodo di iperinflazione degli anni Settanta, si
può concludere affermando che non solo la generazione dei baby boomer ha ipotecato il futuro (degli
altri), ma ha anche bruciato la ricchezza delle generazioni precedenti (la cosiddetta generazione silent,
cioè i nati prima della fine della seconda guerra mondiale), molti dei quali oggi possono contare su
pensioni inferiori al minimo necessario per la sussistenza.
In sostanza, quella generazione che si è fatta artefice dell’accelerazione del processo di integrazione
europea, avrebbe di fatto cancellato un presente, minando le basi per un futuro di speranza. Ora si
introducono i vincoli di bilancio, ora si impone l’austerità, ora si parla di economia sostenibile, ora si
modificano i sistemi previdenziali, ora si cambiano le regole.
Se si considerano gli individui con i redditi più bassi, quelli cioè con maggiori rischi di precipitare nella
spirale della povertà o addirittura nella grave deprivazione materiale, ancora una volta si può rilevare
come siano le fasce più giovani a essere le maggiormente esposte, cioè la fascia di età compresa tra 0 e
17 anni e quella compresa tra i 18 e i 24 anni.
In conclusione, tutti questi dati confermano l’esistenza di una profonda frattura intergenerazionale in
Italia, analogamente ad altri paesi con un alto indice di disuguaglianza come il Regno Unito, gli Stati Uniti
d’America e il Giappone.
Superfluo dire che generalmente le criticità rilevabili a livello territoriale coincidono in larga parte con
quelle a livello generazionale. Sono a rischio le giovani generazioni proprio nelle regioni in ritardo di
sviluppo e alla deriva dal processo di convergenza europea.
7
Fatte queste considerazioni, gli ostacoli, o meglio, i muri che si frappongono alla strada per una corretta,
virtuosa e piena integrazione non sono solo economici e sociali. Se, infatti, da un lato una elevata
disuguaglianza intergenerazionale comporta uno stato di disagio e una maggiore fragilità delle
generazioni più colpite dalle crisi e dai periodi di recessione, dall’altro lato mina la sostenibilità della
crescita nel suo complesso.
Non è solo rilevante il denunciato gap e tra due o più generazioni, ma anche la deprivazione dello stock
di capitale umano, qualora, come nel nostro caso, a risultare pregiudicate siano le generazioni più giovani
e quelle a venire; colpiti non solo i Millennials, ma anche i loro figli. Dunque, se è vero che con
l’introduzione del mercato unico sono state abbattute molte delle barriere citate nei paragrafi
precedenti, sussistono ancora altre barriere che potremmo definire culturali ed etiche.
È il problema della mobilità sociale. Gli studi sulla mobilità sociale sono stati condotti seguendo
prevalentemente due approcci: quello sociologico e quello economico. Il primo correla la posizione
sociale raggiunta con l’occupazione svolta e tende dunque a rilevare la cosiddetta mobilità sociale. Il
secondo identifica invece la posizione sociale mediante indicatori di reddito.
Gli studiosi hanno così classificato le principali occupazioni in cinque categorie: i dirigenti e i
professionisti; gli imprenditori; i colletti bianchi; i colletti blu; gli artigiani e i commercianti. Rilevando le
occupazioni di padri e figli è individuato così il grado di mobilità sociale di una determinata società.
Un altro metodo utilizzato per verificare quella che viene anche definita la riproduzione delle
disuguaglianze è stato quello di analizzare i rispettivi (tra padre e figlio) livelli di istruzione, ritenendo
quest’ultima lo strumento più efficace per garantire la mobilità sociale e ridurre la persistenza interge-
nerazionale delle disuguaglianze nei redditi e negli status socioeconomici.
Infine, seguendo un approccio socio-psicologico, sono stati presi in esame le motivazioni/opportunità che
spesso conducono i figli a intraprendere la carriera dei padri. Non si tratterebbe in questo caso di sola
trasmissione di capitale (si pensi all’azionariato di una impresa), ma anche il trasferimento di capitale
umano e di relazioni sociali. Un fenomeno, quello della mobilità, o meglio della immobilità sociale che,
con qualsiasi approccio lo si voglia studiare, mostra sempre il suo lato oscuro, cioè quello della
ineguaglianza generazionale. Le analisi compiute mettono in luce come tale fenomeno sia
particolarmente intenso in Italia. In particolare, il reddito da lavoro avrebbe pochissima mobilità sociale
e il nostro paese è secondo in questo solo agli Stati Uniti.
A voler mettere in relazione tale fenomeno con l’indicatore di Gini (l’indicatore che misura il grado di
disuguaglianza in seno a una società), ci si rende conto di come vi sia una diretta relazione tra i due
aspetti: tanto minore sarà la mobilità sociale tanto maggiore sarà l’ineguaglianza.
È questa la più convincente risposta a coloro che difendono i loro privilegi maturati negli anni, sostenendo
di rappresentare, grazie a tali risorse, quell’efficace ammortizzatore sociale per le giovani generazioni.
8
L’esito delle ricerche sulla mobilità generazionale, infatti, dimostra come l’aiutare i propri figli o nipoti
spesso determina maggiore disuguaglianza e non benessere diffuso, perché ad affermarsi saranno coloro
che contano su un determinato patrimonio familiare (economico e relazionale) e non i più meritevoli e
capaci. Ciò a danno della competitività del sistema paese e in ultima istanza della collettività.
Un secondo ostacolo è di natura finanziaria. Le misure lanciate dalla BCE volte a generare maggiore
liquidità nel sistema creditizio e a rilanciare le esportazioni dei prodotti delle imprese europee si devono
confrontare anche con le peculiarità di ciascun paese, la struttura delle sue imprese e il sistema creditizio
locale. Per quanto concerne l’Italia, colpita da una recessione che ha minato non solo il tessuto
economico, ma anche quello sociale, la questione è capire se e quanto il quantitative easing possa avere
effetti positivi sulle categorie più colpite dalla recessione: le famiglie giovani e le micro e piccole imprese.
Per quanto concerne le imprese, il rapporto della BCE sulle condizioni di credito nell’ultimo quadrimestre
del 2014 segnala un calo delle restrizioni al credito, generato in particolar modo da una riduzione dei
costi di accantonamento per rischi, in particolare sui bilanci delle banche in Italia e Francia. Tale riduzione
viene attribuita alla maggiore liquidità dei sistemi bancari e dunque, se questa analisi fosse confermata,
il quantitative easing dovrebbe ulteriormente spingere al ribasso tali costi e quindi generare un ulteriore
allentamento delle condizioni di credito alle imprese; allentamento che potrebbe fare ripartire la
domanda di credito a sostegno di nuovi investimenti. Rimane, tuttavia, il fatto che questa analisi è basata
sulla media delle imprese italiane e non sulla mediana e quindi non tiene conto della grande maggioranza
delle micro e piccole imprese che continuano a soffrire del credit crunch e che probabilmente non
potranno godere degli attesi benefici sulle esportazioni di prodotti italiani extra UE, in quanto non in
grado di internazionalizzarsi. Si deve infatti ricordare che di 425.000 imprese manifatturiere italiane,
soltanto 88.000 si dichiarano esportatrici, ma poco più della metà lo fa regolarmente e di queste solo una
piccola parte sono micro imprese.
Inoltre, la spinta valutaria potrà esplicare i suoi effetti nei settori più competitivi del sistema paese, dove
negli anni scorsi si sono già registrati incrementi più significativi delle esportazioni, come il settore delle
bevande, alimentari, farmaceutica e metallurgia, mentre rischia di essere ininfluente nei settori più
penalizzati, come il settore del mobile e dell’abbigliamento.
Una attenzione particolare va data inoltre alle difficoltà di accesso al credito da parte degli under 35 anni.
Analizzando la quota delle famiglie con mutui per caratteristiche del capofamiglia, si nota come, in
particolare nel Nord-Ovest del paese, vi sia stato un calo dal 2005 al 2009 di oltre il 10% dei nuclei familiari
under 35 anni titolari di mutuo. Variazioni negative si evidenziano anche nel Centro Italia, mentre in
leggera controtendenza sarebbe solo il Sud, dove però gli impegni sono molto più bassi. Questi dati
trovano conferma anche nella qualità delle abitazioni e in quella che viene definita la “carriera abitativa”;
ancora una volta la fascia più colpita dal disagio abitativo è quella tra i 18 e i 24 anni.
9
Analoghe indicazioni emergono dall’esame dell’incidenza del servizio al debito rispetto al reddito, in
quanto sono gli under 35 a essere molto prossimi alla soglia di insostenibilità del 30%. Le maggiori
variazioni nel quinquennio in esame si registrano proprio nella fascia di età più giovane, con incrementi
della percentuale di indebitamento del 7,6% al Centro e del 5,2% nel Mezzogiorno.
Afferente alla carriera abitativa è anche la bolla immobiliare che ha preceduto la fase recessiva.
Interessanti spunti emergono dalle ricerche condotte a partire dal 2005 da Equalsoc (Economic Change,
Quality of Life and Social Cohesion), un network di ricercatori attivi sul versante della coesione sociale,
finanziato con fondi comunitari nell’ambito del VI Programma quadro europeo di ricerca e sviluppo. I
risultati sono stati raccolti in un rapporto pubblicato e presentato nell’ottobre del 2009. Tra questi merita
un accenno l’esame della trasmissione per successione o donazione o acquisto delle abitazioni.
Partendo dalla constatazione che le abitazioni sono la componente principale della ricchezza delle
famiglie italiane, si è osservato che l’accesso alla casa di proprietà può avvenire in vari modi: mediante
un acquisto di una unità abitativa subito dopo aver lasciato la famiglia di origine o dopo un primo periodo
di affitto, oppure subentrando nella proprietà a un genitore mediante donazione o eredità.
A parte queste due ultime e scontate ipotesi, i ricercatori rilevano come anche le altre scelte sarebbero
influenzate dalla provenienza familiare e dal reddito di quest’ultima. In ogni caso, dunque, l’accesso alla
proprietà di unità abitative sarebbe influenzato dal ruolo sociale della famiglia di origine; una vera e
propria carriera abitativa come sopra ricordato.
Si tratta di valutazioni che oggi più che mai divengono rilevanti, stanti le grandi difficoltà da parte dei
giovani ad accedere all’acquisto di una nuova abitazione, in considerazione sia della restrizione del
credito per i lavoratori precari sopra richiamata, sia del prezzo delle abitazioni, che non ha accompagnato
la discesa del Pil e dei redditi mediani. Soprattutto per quanto concerne il nostro paese, è possibile parlare
di due Italie, quella dei proprietari di casa e quella di coloro che sono in affitto o stanno ancora
provvedendo al servizio al debito contratto con il mutuo immobiliare, in maggioranza giovani.
A questo fenomeno si aggiunga anche il fatto che normalmente il venditore dell’unità abitativa è un
individuo maturo, mentre l’acquirente è una giovane coppia. In tale ipotesi, in considerazione del
ricordato boom dei prezzi delle abitazioni registrato sino a ridosso della recessione, si sarebbe assistito a
un ulteriore trasferimento intergenerazionale di ricchezza dalla giovane generazione a quella più matura.
La prima avrebbe acquistato casa a prezzi elevati e ora si ritroverebbe con un asset di ricchezza nella
migliore delle ipotesi depauperato e nella peggiore minacciato dal passaggio in contenzioso del mutuo
contratto.
Il fenomeno è diffuso. Un esempio drammatico relativo al mercato immobiliare ce lo fornisce il caso
dell’Inghilterra. Analizzando i dati disponibili per il 2009, si rileva come i proprietari di casa under 35 anni
avrebbero una ricchezza immobiliare lorda di 350 miliardi di sterline, gravata però da mutui ancora da
10
rimborsare per 280 miliardi di sterline e dunque una ricchezza netta di “soli” 70 miliardi di sterline.
Immaginando che dall’avvento della crisi i prezzi delle unità abitative siano scesi del 20%, in questo
momento i giovani inglesi proprietari di casa sarebbero pressoché nullatenenti e rischiano, con l’andare
degli anni, di avere una ricchezza negativa, cioè un deficit.
Un altro nuovo ostacolo consiste il quello che viene definito il digital divide. La maggior parte dei paesi
travolti dall’ondata innovatrice della digitalizzazione non è stata in grado di comprendere la portata del
fenomeno, limitandosi al rimodellamento delle proprie strutture produttive in linea con i nuovi standard
proposti. Questo è sicuramente il caso dell’Italia che, sebbene fino al 1999 fosse in linea con la media
europea degli investimenti nel settore, a partire dai primi anni Duemila si è ritrovata indietro a causa
della sua incapacità di comprendere la rivoluzione in atto. L’avvento dell’era digitale ha paradossalmente
generato una ulteriore marginalizzazione di questi territori già periferici. Molta dell’attuale economia
poggia sulle piattaforme abilitanti a banda larga, in grado di annullare le distanze e di rendere possibili
attività, occupazioni e trasferimenti di conoscenza sino a pochi anni fa semplicemente inconcepibili.
Tuttavia, la stessa piattaforma, base e fondamento dell’economia della conoscenza e della fruizione dei
servizi primari (dalla sanità all’istruzione telematiche), se non estesa a tutti i cittadini, diviene essa stessa
fattore di esclusione.
Così i piani digitali per l’introduzione della banda ultralarga rischiano di spingere nell’ulteriore baratro
della deriva le aree che non possono contare neppure sulla connessione di base. Quello che è stato
definito il digital divide assume in Italia proporzioni rilevanti se si pensa che nelle regioni del Centro-Nord
tra il 65% e il 75% delle famiglie accedono regolarmente a internet da casa, mentre nelle regioni del
Mezzogiorno non si raggiunge il 63%, con tassi superiori solo a quelli registrati nelle più arretrate regioni
di Romania, Bulgaria e Portogallo (Eurostat 2013).
Anche in questo caso, inutile dirlo, le regioni in ritardo di sviluppo presentano spesso significativi livelli di
arretratezza delle infrastrutture immateriali. Se si prende ad esempio la provincia di Cosenza, a una buona
dotazione stradale e ferroviaria (superiore alla media nazionale) non fa riscontro la dotazione di reti per
le telecomunicazioni (60% della media nazionale e della media delle altre province del Mezzogiorno)
(Atlante della competitività delle province e delle regioni 2012). Le sofferenze bancarie a Cosenza (cioè il
rapporto tra sofferenze e impieghi) posiziona inoltre tale città sopra la media della Calabria e la media
del Mezzogiorno (Atlante della competitività delle province e delle regioni 2014).
Il ritardo non ha riguardato semplicemente il settore pubblico, che non ha adeguato in tempi ragionevoli
le normative e non è stato in grado di comunicare con i nuovi strumenti, ma anche il settore privato, che
nella maggior parte dei casi non ha avuto la prontezza di introdurre all’interno del proprio modello di
business innovazione e tecnologia. Questo deficit è riscontrabile soprattutto in molte PMI che faticano a
11
mantenere competitività, anche a causa del divario digitale che le mette in una situazione di netto
svantaggio rispetto ai concorrenti presenti sul mercato nazionale e non.
Secondo le stime di Confindustria Digitale, l’83% delle piccole e medie imprese fallite nel 2013 non aveva
un sito internet, dato che mette chiaramente in luce quale sia il livello medio di arretratezza delle imprese
italiane e quanto il fattore di ritardo digitale possa influire sul gap della competitività. Se ne può allora
dedurre che il ritardo infrastrutturale sopra menzionato ha un pesante effetto sulla competitività del
sistema paese, soprattutto in una realtà come quella italiana, connotata da una massiccia presenza di
microimprese.
Infine, un ulteriore ostacolo che contribuisce ad acuire quello che è stato definito il generational divide è
sicuramente l’esistenza di forti reti di incolumità (safety nets). In L’europa è un’avventura, Bauman
scriveva: «La società moderna, avendo rimosso il fitto tessuto di comunità e corporazioni che un tempo
definivano le regole di protezione e vigilavano sulla loro applicazione, per rimpiazzare tale rete con
l’obbligo individuale dell’auto assistenza e dell’autosoccorso, è stata costruita sulle sabbie mobili della
contingenza: l’insicurezza e il timore di un pericolo diffuso sono endemici in tale società. Come per ogni
altra trasformazione moderna, anche in questo caso l’Europa ha avuto un ruolo di battistrada. Essa ha
dovuto anche affrontare per prima le conseguenze impreviste, e perlopiù insane, del cambiamento».
Quindi il crollo di queste reti protettive e del senso di sicurezza che le stesse assicuravano, se da un lato
apre grandi spazi di libertà a coloro che sanno cogliere le opportunità di globalizzazione, dall’altro genera
in molti individui, cioè la maggioranza, la sensazione che tali spazi siano inaccessibili. La conseguenza è
un diffuso senso di impotenza e il timore di essere inadeguati.
Questa non è la sola conseguenza sociologica dell’affermarsi di tale incertezza. Un ulteriore effetto è
l’assunzione, da parte di coloro che si sono conquistati tale sicurezza (i baby boomer), di pratiche difensive
delle loro prerogative. In altre parole, si sta assistendo all’arroccamento di una generazione, la prima
colpita da questa ondata di insicurezza, a danno delle successive. Queste ultime, nate già in un clima di
incertezza, danno a tale condizione un valore minore, e sono, per così dire naturalmente assuefatte.
Questo fenomeno potrebbe spiegare la altrimenti incomprensibile inazione dei giovani alla situazione di
divario generazionale venutasi a creare e la scarsa propensione a immaginare un futuro per sè e per gli
altri.
Voglio concludere con un ostacolo tutto italiano: il costo dei lacci e lacciuoli. La stima dell’impatto
economico degli adempimenti fiscali sulle imprese italiane ha come punto di partenza l’analisi, condotta
in una ricerca della Fondazione Bruno Visentini alla quale ho partecipato, della complessità e della
frequenza degli adempimenti stessi relativi a ciascun tributo. L’assunto di base è che il tempo per evadere
gli adempimenti impiegato dalle risorse interne alla azienda, ai suoi vari livelli, da quello esecutivo a
quello dirigenziale, è stato sottratto ad altre attività. In sostanza, quindi, la valorizzazione di queste risorse
12
permette di determinare una sorta di “tributo occulto” gravante sulla competitività delle aziende italiane,
in particolare quelle piccole e medie, oggetto di questa indagine. Non sono state prese in considerazione
le eventuali spese per gli spostamenti, copie o altre spese vive sostenute per effettuare l’adempimento.
I dati presi come riferimento sono relativi ai costi medi orari per il personale dipendente da imprese
dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti, relativi all’anno 2013, e sono forniti
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei
Rapporti di Lavoro - Divisione IV. Non sono dunque stati presi in considerazione nel computo gli aumenti
contrattuali per il periodo 2013-2015 disposti dal citato CCNL.
Il risultato conduce a stimare un costo interno medio per azienda (CIM) di 15.156 euro annui.
L’approfondimento, mediante la somministrazione dei formulari alle figure chiave ha, inoltre, permesso
di modulare meglio la quantità e la complessità dell’adempimento in ragione della dimensione aziendale.
A tal fine, considerata la media pro capite del costo per gli adempimenti campionati, si è proceduto a
verificare lo scostamento delle singole classi da tale media, riparametrando poi l’intero costo del paniere
degli adempimenti. Fatto 100 la media dei costi interni dichiarati dai rappresentanti aziendali, si è
attribuito un punteggio di 39,7 alle micro imprese, 112,1 alle piccole imprese e 148,2 alle medie imprese,
da applicare al CIM soprarichiamato, determinando così il costo interno medio per classe di azienda (CIC).
Quest’ultima attribuzione ha in sostanza confermato l’analisi effettuata sugli adempimenti, e cioè che
con l’aumento della dimensione aziendale aumenta anche il tempo e la complessità richiesta per svolgere
i singoli adempimenti. In questa sede, naturalmente, si è voluto rilevare il costo dell’adempimento in
valore assoluto e non in percentuale sui ricavi aziendali. Probabilmente quest’ultima analisi condurrebbe
ad una conclusione differente e di segno opposto. Questo parametro è stato dunque utilizzato per
attribuire il “tributo occulto” all’universo delle imprese italiane rilevato per le rispettive classi
dimensionali.
Il passo finale è stato quello di applicare i CIC alla base dati Istat disponibili, ricavandone i relativi valori
assoluti. L’universo di PMI considerate è stato quindi di 4.233.822 micro imprese, 191.430 piccole
imprese e 22.039 medie imprese. Per le prime è stato stimato un costo interno di 6.012,90 euro, per le
seconde un costo di 16.991,97 euro e per le ultime 22.463,12 euro.
Proiettando questi costi sull’universo delle aziende Italia si realizza che i costi annui stimati per il 2011
ammontavano a circa 29,1 miliardi di euro, di cui 25,4 gravanti sulle micro imprese.
Una “zavorra” non di poco conto se si paragonano queste cifre a quelle che le imprese sostengono per
sostenere gli investimenti fissi.
Nel 2011 i lacci e lacciuoli rappresentavano il 9,31% degli investimenti fissi lordi, mentre nel 2013 la
percentuale era salita a 10,83%. In altre parole questo significa che oltre un decimo della capacità di
13
investimento delle aziende è trattenuta dagli oneri per gli adempimenti fiscali. Le stesse somme, se
parametrate al Pil, evidenziano una incidenza nel 2011 dell’1,84%, salita nel 2013 all’1,87%.
L’unico modo per superare tutti questi ostacoli è partire da una ridiscussione dei diritti acquisiti da una
generazione e da ciò che ne è stata l’espressione, che in chiave solidaristica permetta di sostenere nuove
e robuste politiche di sostegno all’economia, al lavoro e agli interventi in campo sociale, perché, come
afferma il dettato costituzionale dell’uguaglianza sostanziale: “È compito dello Stato rimuovere gli
ostacoli che di fatto limitano l'eguaglianza e impedisce agli individui di sviluppare pienamente la loro
personalità sul piano economico, sociale e culturale”.