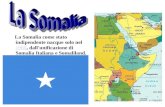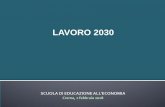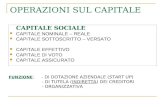Lavoro e capitale in Somalia
-
Upload
alberto-allegrini -
Category
Documents
-
view
215 -
download
2
Transcript of Lavoro e capitale in Somalia
Lavoro e capitale in SomaliaAuthor(s): ALBERTO ALLEGRINISource: Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africae l’Oriente, Anno 8, No. 6 (Giugno 1953), pp. 175-176Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO)Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40756158 .
Accessed: 14/06/2014 12:42
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extendaccess to Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sat, 14 Jun 2014 12:42:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
AFFRICA 175
Lavoro e capitale in Somalia di ALBERTO ALLEGRINI
Rifacciamoci un momento al 1* Convegno Economico Africano che si tenne a Milano un anno fa.
Concludendo i suoi lavori esso raccomandò, per quanto concerne la Somalia, che vengano assicurate fonti adeguate di credito a medio e lungo termine, sia mediante Tinter- vento di organi internazionali nel quadro della collabo- razione economica auspicata nei principii sanciti dalla Car- ta delle N. U. (e in particolare delle previdenze proget- tate per l'assistenza delle aree depresse: punto IV Truman), sia con l'emissione di prestiti da parte della stessa Ammi- nistrazione fiduciaria, adeguatamente garantiti, onde faci- litarne il collocamento entro e fuori il Territorio della Somalia; che si provveda ad una progredita regolamenta- zione dei rapporti di lavoro ai fini di un duraturo incre- mento produttivo nel quadro e nei limiti dello Statuto del Territorio e degli impegni internazionali; che siano adottati tutti i provvedimenti di natura valutaria^ fiscale, economica, tecnica, organizzativa, atti ad incremenatre lo sviluppo degli scambi commerciali, con particolare riguar- do al settore dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e delle telecomunicazioni.
Gregorio Consiglio, in una nota di commento a quello importante Convegno, insisti sul «bisogno di capitali, sen- za i quali è impossibile qual sia si avvaloramento; di una organizzazione burocratica agile, che faciliti gli scambi e le iniziative nuove; di una grande assistenza tecnica e sopratutto di fiducia ».
Non è a dire che lo Stato-tutore non abbia fatto molto, da parte sua, sia per l'organizzazione amministrativa del Territorio, sia per il progresso politico e culturale delle popolazioni, sia per l'incremento agricolo e commerciale del Territorio. Ha anche istituito una speciale moneta a pieno titolo, addossandosene il rischio, oltre all'onere del cambio della precedente valuta East-Africa e delle rinun- zie previste dall'accordo finanziario con la Gran Bretagna. L'Italia ha, invero, il privilegio di sperimentare in So- malia un singolare Trusteeship: privilegio unico, non es- sendo l'OJV.U. riuscita ad imperlo alle altre Nazioni. E di questa tutela, non retribuita, ma onerosa, vigilata da pres- so da un Consiglio Consultivo, deve dar conto ogni anno all'Assemblea delle N. U.
Ma noi l'abbiamo accettata perche, al di là di ogni calcolo, sentiamo di avere una missione da compiere, da continuare, in un territorio a noi caro per lunga abnega- zione; e lasciamo alla diplomazia di coprire la realtà con drappeggi di frasi fidenziane e di dar quietanza dei torti che, per disavventure storiche, sia costretta a subire.
Mentre questa onerosa tutela è a tempo determinato e dovrà portare in dieci anni la Somalia all'autogoverno, il Ministro laburista delle Colonie inglesi, citando le parole del suo collega laburista Creech Jones, ha così fissato l'obiettivo centrale della politica coloniale (britannica) :
«Esso consiste - ha detto - nel guidare i territori coloniali verso l'autogoverno responsabile in seno al Com- monwealth... in condizioni che assicurino alla popolazione un buon livello di vita e la libertà da qualsiasi aggres- sione... Ma ciò che noi abbiamo creato qui, in Gran Bre- tagna, in 800 anni e in una società civile, non può essere costruito in 80 anni in una società per gran parte anal- fabeta > (1).
E il ministro delle Colonie, conservatore, Oliver Lyt- telton, ha commentato : « Ciò che egli intendeva dire è che non basta concedere l'autogoverno, il quale non signi- fica sempre buon governo. E' nostro dovere far sì che, allorquando i popoli coloniali giungono a governarsi da se essi si governino bene».
Ma veniamo ai fatti economici della Somalia, quali risul- tano dalle relazioni antiche e recenti, riservandoci di riesa- minarli alla luce del Rapporto AFIS del 1952, quando verra reso pubblico.
Il Governatore Giacomo De Martino scrisse nel 1910 una relazione al ministro Bertolini (stampata poi nel 1912) su la « grande Somalia >, che, allora, la nostra Colonia aveva,
senza l'Oltre Giuba, una superficie di 357 mila chilometri quadrati contro i circa 287 mila dell'Italia. E, a proposito del lavoro, faceva queste considerazioni:
«II problema del lavoro, nella sua forma e nelle sue manifestazioni, non si può dissociare dallo studio della natura stessa delle genti nelle quali si vogliono destare operosità nuove».
«Il sòmalo, figlio delle sue sterminate lande boscose, ha preso- dagli spazi senza fine, dalla vita nomade unifor- me, senza che un'ora si dissimili dall'altra, dalla mancanza di stimoli e di bisogni, quell'abito comune a tutte le popo- lazioni dell'Asia e dell'Africa, di sovrana indifferenza e passività, che nulla commuove od agita; ma, bello e aitan- te nella persona, di mente svegliata, vivace e mobile nelle impressioni, facile a persuadere e a condurre, buono e mite nelle tendenze, è suscettibile di un lento e graduale pro- gresso morale e materiale. Costringerlo con la forza o con la violenza sarebbe turbare profondamente la sua stessa natura, renderlo riluttante, incapace d'intendere ciò che si vuole da lui. E ciò sanno gl'inglesi, i quali rispettano i somali, a differenza delle altre razze che tengono sotto il duro regime della correzione corporale».
«Nella Somalia sono infinite le diversità secondo le varie razze o gl'incroci, la vita nomade o stabile, il con- tatto vicino o lontano con altre genti ed altre civiltà, l'in- fluenza più o meno sensibile della religione islamica, co- me differenze sostanziali esistono tra liberi e liberti«. ».
Il problema del lavoro, dunque, si connette intrinseca- mente allo studio di un regime che tenga conto della varia natura di queste popolazioni, delle condizioni morali e delle attitudini diverse, delle relazioni diverse esistenti tra liberi e liberti, delle popolazioni dedite all'agricoltura o alla pastorizia o tenute a sistema misto, delle organizzazio* ni collettive più o meno omogenee e compatte, della ge- rarchia esistente nei vari ordini sociali.
E Ton. De Martino approfondiva Tesarne del problema con questa considerazione:
«Svolgendosi la società indigena verso forme diverse, tendendo la servitù domestica a scomparire, rallentandosi i legami che stringono liberi e liberti, nascendo negli indi- vidui, per forza naturale di cose, bisogni nuovi e nuovi derideri di lucro, crescendo la richiesta della mano d'opera per le opere di Stato e per quelle dei privati, una tutela e un regime del lavoro s'impongono, sia per la prestazio- ne d'opera collettiva, sia per quella individuale, sia nei
rapporti interni della società indigena, sia verso la società nuova, dominatrice del territorio. Ma ne quella tutela ne <rael regime si possono costituire senza che sorgano lega- mi riconosciuti dallo Stato con legali sanzioni tanto pel lavoratori quanto pei conduttori di opere pubbliche e pri- vate». ., _
Egli mirava perciò a rendere attraente il ., lavoro com- piuto per obbedienza passiva o per soggezione alla col- lettività. m , -,
Intendeva a tal fine educare i giovani al m , lavoro, perche
-,
l'educazione ne produce l'abito; e proponeva l'insegna- mento pratico della nostra lingua, l'insegnamento del la- voro agricolo e industriale che, più che l'insegnamento delle lettere, è strumento efficace di civiltà.
Com'è noto, un attraente sistema di compartecipazione fu istituito dalla S.A.I.S. nel 1920, cioè prima della Con- venzione di Ginevra, nel villaggio «Duca degli Abruzzi». Abolito il contingentamento per cabila, l'indigeno veniva assunto con libero contratto per un anno e reso compar- tecipe a una parte della produzione aziendale.
Rimase, peraltro, ferma l'eccezione, per la mano d ope- ra proveniente dal di fuori, al principio « salario eguale a lavoro di valore eguale» proclamato dalla Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Ma il lavoro non è che un elemento della produzione: occorrono anche i capitali, cioè gli strumenti, quelli sopra tutto che fanno piovere l'acqua quando si vuole, per di- fendere la zootecnia e l'agricoltura dalle terribili siccità.
Senonchè, invece dell'acqua, piovono in Somalia i prin- cipii democratici e vi generano un'imponente fioritura di
(1) Ufficio Stampa e Informazione britannico: Notizia- rio coloniale, aprile 53.
(2) A. Allegrini: Diruto e legislazione coloniale (Spe- rotto, Vicenza, 1943).
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sat, 14 Jun 2014 12:42:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
176 AFFRICA
Consigli. I francesi, che di democrazia se ne intendono, chia- mano questi Consigli i Beni oui oui (quelli dei sì). Ma noi facciamo ogni sforzo per sostituire, possibilmente, secondo le direttive dell'ONU, la rappresentanza territoriale a quella tribale, formando i Consigli di Residenza e quello Terri- toriale in base alla forza proporzionale dei partiti politici - dice il Rapporto AFIS 1951. Anzi, è intenzione del Go- verno italiano di riformare questo Consiglio, con la crea- zione di una o parecchi Comitati, che assumeranno gra- dualmente le funzioni di Commissioni parlamentari ed an- che l'attribuzione, a titolo di esperimento, della direzione dei dibattiti ai consiglieri indigeni (3).
Ma, oltre a queste concrete manifestazioni di intendi- menti democratici, il nostro Governo ha data prove per- spicue di abnegazione verso l'ideale della indipendenza somala. Nel campo dell'istruzione ci awiamo versa l'insegna- mento superiore richiesto dall'ONU, per gli indigeni. In quanto al lavoro, però, la relazione 1951 ha dovuto ripe- tere le considerazioni di un tempo, e cioè:
a) non si può contare su di un lavoro individuale assiduo e regolare da parte di una popolazione che da cen- tinaia o migliaia di anni è abituato a un lavara collettivo e discontinuo sotto la direzione di capi di gruppi sociali; lavoro assiduo e regolare che, del resto, non sembra con- sentito dalla debole costituzione fisica di malti somali e dal clima;
b) l'insufficienza dei lavoratori agricoli si è accentuata con la coltura, in compartecipazione«, del cotone e del se- samo, malgrado Faumento dei salari.
e) per le imprese meccanizzate mancano i lavoratori specializzati, che l'Amministrazione si adopera a formare mediante un piano quinquennale d'istruzione;
d) la nuova legislazione del lavoro è ostacolata dalle condizioni particolari del Territorio e dalla insufficiente organizzazione di attività economiche.
Tuttavia l'Amministrazione fiduciaria, in seguito alla missione Gavin dell'Organizzazione Internazionale del La- voro, ha disposto l'invio di un funzionario a Ginevra per stabilire le basi della futura legislazione del lavoro, e ha deciso di aderire alla Convenzione 65 su le sanzioni pe- nali (pei lavoratori indigeni) e all'altra, che porta il n. 85, su l'ispezione del lavora. E, secondo la relazione Gavin* l'Amministrazione ha creata, altre all'Ispettorato centrale del lavoro, altri sei Uffici d'ispezione pressa i Commissa- riati regionali e un Ufffcio del lavoro presso ciascuna delle principali Residenze: Uffici che hanno il compita di pro- teggere ed assistere i lavoratori, di vigilare su la regolare esecuzione dei contratti e le condizioni d'uso della mano d'opera, non che su l'osservanza della relativa legislazione. Insomma, l'Amministrazione s'ispira ai principii enunciati nella Dichiarazione di Filadélfia del 1944.
#
Nulla, dunque, il nostra Governo ha trascurato e trascura per dare ai somali ordinamenti ed istituti modernissimi, atti a farli progredire verso la progettata indipendenza. Ma è ormai evidente per tutti che gl'indigeni o sono indifferenti a tali riforme, o non le comprendono, o sono incapaci di assimilarle in breve per la contrastante forza d'inerzia del- le abitudini secolari. Ci vogliono altro che dieci anni!
Ciò ha potuta constatare la Missione di visita delle N. U. compiuta nel 1951.
Essa ha potuto accertare che in Somalia non manca al- cuna libertà, nel senso più democratico della parala; man- cano solo i mezzi per valorizzare le due risorse del Ter- ritorio: la pastorizia e l'agricoltura, questa in misura mi- nare, sebbene, con adeguati impianti d'irrigazione, ci sia da estendere di malta quella forma di agricoltura indu- striale orientata verso la produzione della canna da zuc- chero, la banana, il cotone, le arachidi e una certa quan- tità di frutti tropicali, previa formazione, s'intende, di una mano d'opera specializzata, che per ora manca.
La pastorizia è più importante perche costituisce anche l'esportazione tradizionale del Paese.
Ma, a parte l'onere finanziario dello Stato amministrato- re, chi fornirà i capitali indispensabili?
C'è stata, come è noto, la missione Gavin del 1951, che in 15 giorni ha visitato i distretti agrìcoli e gli stabi- limenti industriali; è pure stata in Somalia una missione
(3) Su la costituzione e i poteri di questo Consiglio Territoriale, vedasi P. Franca in « Affrica >, n. 1-1953.
geologica dell'ECA, incaricata di studiare le risorse idriche del sottosuolo; Mogadiscio ha ricevuta anche il Sig. Filip- po Soupault, incaricato dall'UNESCO di raccogliere dati sui sistemi d'informazione e sui mezzi di diffusione esi- stenti nel Territorio; poco dopo giungeva in Somalia e vi rimaneva due mesi, estendendo le sue indagini dalla Mi- giurtinia all'Oltre Giuba, la Missione d'assistenza tecnica delle N. U., incaricata di studiare le condizioni locali e le possibilità di sviluppo del Territorio; infine si è avuta la Missione di Visita delle N. U„ che ha, infatti, visitato scuole, ospedali, prigioni, circoli di cultura, imprese indu- striali ed agricole, ha assistito alle sedute del Consiglio territoriale, dei Consigli di Residenza e municipali, ha ri- cevuto petizioni e reclami.«
E' da sperare che da queste visite e dalle loro inda- gini scaturisca l'assistenza concreta, l'aiuto, cioè, necessa- rio a metter su la zona depressa.
Ma intanto non è presumibile che notevoli capitali di privati italiani si avventurino verso quel territorio prov- visoriamente da noi amministrato, se esiste il rischio che il futuro riservi loro, come è accaduto altrove, soltanto il danno. Il Rapporta 1951, infatti, afferma di non poter pre- cisare l'importo di tali investimenti, considera come inve- stimento di capitali italiani in Somalia il super-reddito rea- lizzato in Italia dalla vendita delle banane, in confronto di altri mercati, nonché l'importazione nel Territorio, fran- co divisa, di macchine ed attrezzi agricoli e industriali, senza contropartita.
E tuttavia - si legge nel rapporta - lo sviluppo della industria è strettamente legato alla messa in opera d'im- portanti capitali, poiché bisogna ammodernare e ingrandire quasi tutte le installazioni esistenti, adattandole ai bisogni reali del Territorio e alle necessità della concorrenza inter- nazionale... L'Amministrazione favorisce la costituzione di società industriali con la partecipazione di capitale indige- no; ma non è possibile concepire un programma più vasto senza l'apporta di capitali esteri.
Bisogna anche ricordare che la stessa Amministrazione da ad ogni nuova impresa il suo appoggia, nel modo più conveniente a ciascuna, senza parlare dell'esenzione totale dei diritti d'importazione per tutte le macchine e le instal- lazioni necessarie allo sviluppo delle industrie esistenti e nuove, oltre all'esenzione totale da ogni imposta sul reddito per un periodo di dieci anni. Tutto ciò è sottratto al Bilan- cio della Somalia, che l'Amministrazione è costretta a sov- venzionare a carico del Bilancio dello Stato.
A ragione, quindi, l'Amministrazione fiduciaria ha messo in rilievo eia contraddizione fondamentale esistente tra la necessità, da una parte, d'introdurre nel territorio capitali considerevoli e un gran numero di tecnici, per dare al Paese la struttura che esige la vita d'uno Stato moderno, e, d'altra parte, la preoccupazione legittima e giustificata di gravar troppo d'impegni insopportabili il Bilancio di un Territorio di così deboli risorse ».
Ecco perche le provvidenze sono state più larghe in campo politico che in quello economico; e si sono invocati sin dall'inizio gli aiuti dell'ECA e la collaborazione del- f UNESCO, nonché il concorso di organizzazioni finanziarie internazionali o una forma di garanzia del capitale per un periodo assai più lungo di quello fissato dall'accordo di tutela.
Per quanto riguarda il lavoro, diamo atto della delibe- razione presa d'inviare in Somalia una Commissione di esperti italo-americani per l'assistenza tecnica ed economica italiana. Ma, quanta agli aiuti, poco confortanti sono le con- siderazioni fatte da Pompeo M. Gorini, già segretario gene- rale dell'Amministrazione fiduciaria, sul rapporto dell'ECA in merito ai 5 progetti d'assistenza nei settori zootecnico, idrico e della meccanizzazione dell'agricoltura (4).
Somalia do ceti... L'esperimento di questo Trusteeship af- fidata all'Italia è il solo non mutilato dei doveri fondamen- tali elencati nello Statuto conseguente alle «Dichiarazioni buí Territori non autonomi». Se l'Italia fallisse, per difet- ta di aiuti indispensabili, all'esercizio del difficile mandato la colpa non sarebbe sua: e bisognerebbe dichiarare il falli- mento dell'istituto concepito con tanto fervore di ideali de- mocratici e d'umanità.
(4) «Affrica», n. 12-1952.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sat, 14 Jun 2014 12:42:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions











![Atlante geopolitico della Somalia contemporanea - CORE · ³socialismo scientifico […]». G. Carbone, L’Africa. Gli stati, la politica, i conflitti, Bologna, Il Mulino, 2012,](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5c67dbfa09d3f28e058c77a2/atlante-geopolitico-della-somalia-contemporanea-core-socialismo-scientifico.jpg)