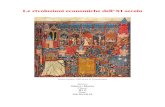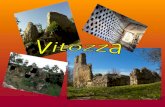L'artigianato nell'Egitto antico: Atti dell'XI Convegno Nazionale di Egittologia e Papirologia...
-
Upload
caterina-moro -
Category
Documents
-
view
221 -
download
6
Transcript of L'artigianato nell'Egitto antico: Atti dell'XI Convegno Nazionale di Egittologia e Papirologia...
I "bambini seminati": connotati osiriani di una leggenda ebraicaAuthor(s): Caterina MoroSource: Aegyptus, Anno 87, L'artigianato nell'Egitto antico: Atti dell'XI Convegno Nazionale diEgittologia e Papirologia Chianciano Terme, 11-13 gennaio 2007 (2007), pp. 347-368Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro CuoreStable URL: http://www.jstor.org/stable/41217493 .
Accessed: 15/06/2014 08:26
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore is collaborating with JSTOR todigitize, preserve and extend access to Aegyptus.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
«Aegyptus» 87 (2007), pp. 347-368
I "bambini seminati": connotati osiriani di una leggenda ebraica
co
I ed U S
I i
1 ví
fu в !>
Nella storia del pensiero occidentale è noto l'interesse suscitato dalle storie dell'infanzia e della giovinezza di Mosè, specie nella forma mediata dalle fonti esterne alla Bibbia ebraica (1). Riusciamo a intuire che questo Mosè «istruito in tutta la sapienza degli egiziani» (Atti 7,22) dovette essere una figura apologetica cara a un ambiente giudaico d'Egitto attento sia alla cultura greca sia a quella indigena (2). Tuttavia questo ambiente attende ancora di essere studiato approfondita- mente, intanto nel suo sviluppo diacronico (prima che alla cultura greca, infatti, gli ebrei sono stati esposti alla cultura mesopotamica e persiana), ma soprattutto nel suo effettivo legame con la cultura egiziana di Bassa Epoca. L'interesse per "Mosè l'Egizio" comincia già nell'antichità in una serie di fonti pagane, cristiane e giudaiche, alcune più antiche, come quelle bibliche e quelle degli storici di lingua greca, altre più recenti come quella che analizzeremo in questa sede. Tali fonti testimoniano l'esistenza di un vasto complesso di tradizioni narrative su Mosè, che non vanno ritenute tutte espansioni o interpretazioni del racconto biblico, come spesso si legge: al contrario, è più probabile che furono gli autori
(1) Alcune tappe della fortuna di questa "figura della memoria" sono commentate nel celebre volume di J. Assmann, Mosè l'egizio. Decifrazione di una traccia di memoria, Milano 2000 (trad. it. di Ezio Bacchetta di Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur, München 1998).
(2) La testimonianza più suggestiva di questo ambiente resta la storia di Mosè narrata nei frammenti dello storico giudeo-ellenistico Artapano (II a.C.?), in cui Mosè è presentato come fondatore di istituzioni civili e religiose egiziane, compreso il culto del toro Api e dell'ibis (testo e traduzione in L. Bombelli, I frammenti degli storici giudaico-ellenistici, Genova 1986, pp. 127-149, vd. anche pp. 42-48; CR. Holladay, Fragments from Hellenistic Jewish Authors I, Atlanta 1983, pp. 189-243); vd. anche il contributo che apparirà nel web negli Atti del IV Incontro Orientalisti (Pavia, 19-21 aprile 2007), dal titolo Lo storico Artapano e il passato multietnico. Su Artapano e le Cronache di Mosè vedi oltre (nota 5).
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
348 CATERINA MORO
biblici ad operare, a loro tempo, una selezione tra le tradizioni a loro disposizione (3).
Il testo
La storia in analisi è tratta da un breve midraš (commentario) in ebraico detto Cronache di Mosè nostro maestro (4), dove costituisce il prologo alla storia della nascita e dell'infanzia di Mosè. Il testo somiglia piuttosto da vicino alle "rinarrazioni" bibliche di epoca ellenistico-romana (5), come le Antichità Giudaiche di Giuseppe Flavio о il Libro delle antichità bibliche (6), perché la versione biblica della vicenda passa spesso in secondo piano (7). Rankin lo ha datato attorno al II d.C. per l'assenza di riferimenti al
(3) Sul rapporto tra il complesso delle tradizioni antiche e la letteratura biblica si veda la ricerca
compiuta sulla storia di Mosè (e di Abramo) nella Bibbia e nelle fonti greche di epoca ellenistica in G. Garbini, Storia e ideologia dell'Israele antico, Brescia 1986, pp. 183-207; Id., Mito e storia nella Bibbia (Studi Biblici, 137), Brescia 2003, pp. 87-109; С. Moro, Mosè fondatore di Gerusalemme, che uscirà negli atti del convegno Città pagana - città cristiana: tradizioni di fondazione (Roma, 2-3
luglio 2007). Ovviamente non tutte le tradizioni su Mosè sono altrettanto antiche, e anche quelle antiche si presentano secondo gli influssi culturali e le intenzioni degli autori delle fonti.
(4) D brano tradotto in questo contributo è tratto da A. Jelljnek, Bet ha-Midrash, П, Jerusalem 19674, pp. 1-2 (il testo completo delle Cronache di Mosè occupa le pp. 1-11); ho tenuto conto delle traduzioni di L. Gaster (The Chronicles ofJerahmeel, London 1899, pp. 106-108), che traduce un manoscritto miscellaneo del XTV sec., e di O.S. Rankin (Jewish Religious Polemic of Early and Later Centuries, Edinburgh 1956, pp. 26-28; il testo completo è tradotto alle pp. 25-46), che traduce il testo delle Cronache di Mosè edito da Gilbert Gaulmyn a Parigi nel 1629.
(5) Gaster (op. cit., pp. Lxxxvn-xc) ipotizza che l'autore delle Cronache di Mosè si sia
ispirato a un testo di Artapano più completo di quello che è giunto fino a noi, ma le divergenze sulla storia della conquista dell'Etiopia (per es. gli ibis di Artapano e delle Antichità Giudaiche di Giuseppe Flavio sono diventati cicogne, mancano molti dettagli di colore più egiziano, come la costruzione del tempio di pietra) a mio parere sono troppe.
(6) Testo tramandato sotto il nome di Filone Alessandrino, fu scritto in ebraico о aramaico attorno al I sec. d.C, ci è pervenuto in versione latina (si veda G. Aranda Perez, Nuove narrazioni della storia biblica, in Id., F. García Martínez, M. Pérez Fernández, La letteratura giudaica intertestamentaria (Introduzione allo studio della Bibbia, 9), Brescia 1998, pp. 297-303; testo e traduzione in H. Jacobson, A Commentary on Pseudo-Philo's Liber Antìquitatum Biblicarum with Latin Text and English Translations, 2 voll., Leiden 1996).
(7) In questo contributo non tenterò un'analisi filologica approfondita о una ricostruzione
dell'originale. A tal scopo ho preso in esame solo tre versioni varianti della storia e non le versioni che sembrano dipendere direttamente dalle Cronache di Mosè, ovvero quella del Libro del Giusto
(vd. Rankin, op. cit., pp. 22-23) e quella del midraš medievale Šemoth (Esodo) Rabba.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
I "BAMBINI SEMINATI": CONNOTATI OSIRIANI DI UNA LEGGENDA EBRAICA 349
cristianesimo e la presenza di alcuni temi polemici analoghi a quelli trattati dagli autori giudeo-ellenistici del I secolo d.C. (8).
«Nell'anno 130 della discesa dei figli d'Israele in Egitto, sessanta anni dopo la morte di Giuseppe, sognò il faraone un sogno, ed ecco nel sogno un vecchio stava in piedi di fronte a lui, e aveva nella sua mano una bilancia, ed egli metteva tutte le generazioni d'Egitto (9), uomini donne e bambini, su di un piatto della bilancia, e poneva sul secondo piatto un agnello (10), e l'agnello pesava più di tutti gli uomini d'Egitto. Ed egli si spaventò, e meditava nel suo cuore con grande meraviglia e si interrogava su questa grande visione. E si svegliò il faraone ed ecco era un sogno: e convocò tutti i sapienti d'Egitto e tutti i suoi maghi, e il faraone narrò loro il suo sogno. E il popolo ebbe molta paura del sogno, finché giunse uno dei principi di fronte al re e disse "Questo sogno significa una grande sciagura per l'Egitto e terrore" E il re gli disse "Cosa significa?" ed egli rispose "Un bambino nato ai figli d'Israele che devasterà tutto l'Egitto. Ed ora, mio signore re, ti consiglierò un buon consiglio: che tu ordini che ogni figlio che nasca tra i
(8) Si veda l'introduzione di Rankin, op. cit., pp. 3-23. Per esempio la lunga narrazione delle dieci piaghe fa corrispondere a ognuna di esse un peccato degli egiziani punito, come in Sapienza 11,1-20 (p. 13); l'affermazione del faraone di essere un dio rimanderebbe alle analoghe pretese di divinità dell'imperatore Caligola (per le quali si confronti Filone Ales- sandrino, Legano ad Gaiwn 44, Eusebio Storia Ecclesiastica П,6; Rankin, op. cit., pp. 16-19). Quest'ultimo tema del midras è tra quelli che meritano di essere ulteriormente investigati anche alla luce delle tradizioni egiziane.
(9) Essere messi su una bilancia nei testi onirocritici egiziani è un presagio negativo (probabilmente perché rimanda alla psicostasia nell'aldilà). Nel Libro dei sogni di Copenha- gen (pap. Carlsberg ХШ b. 2,1) si legge «Se siede (in sogno) su una bilancia, farà una cattiva fine» (traduzione di E. Bresciani, Letteratura e poesia dell'antico Egitto, Torino3 1999, p. 720). L'idea di un giudizio mediante pesatura sembra presente anche nell'ebraismo: per es. in Proverbi 24,12 («Colui che pesa i cuori sa, e renderà a ciascuno secondo le sue opere»; si veda С Moro, Ascolta la mia parola. Analisi testuale di Proverbi 22, 17 - 24, 22, Studi semitici n.s., 17, Roma 2002, pp. 268-271). Nell'apocrifo detto Testamento di Abramo (B 13,1-3) Abele è presentato in una visione celeste come un angelo con una bilancia in mano, che giudica i trapassati. Nei libri profetici è inoltre assai frequente l'immagine di YHWH che intenta un processo (ryb) contro le nazioni: la pesatura dell'Egitto sarebbe quindi un giudizio sfavorevole di Dio nei suoi confronti e a favore di Israele, nella figura del suo liberatore (simboleggiato dall'agnello che riscatterà i primogeniti ebrei durante la notte di Pasqua).
(10) II termine usato (talyah) è un prestito dall'aramaico talya' , che può voler dire sia "agnello" sia "ragazzo" (cf. la traduzione puer di Gualmyn; Rankin, op. cit., p. 26 nota 1). Nel Targum Ps. Jonathan si specifica (in forma lacunosa nel manoscritto, vedi Le Dèaut, Targum du Pentateuque, П, Paris 1979, p. 16 nota 11) «un agnello figlio (di una pecora)». Tuttavia nel testo delle Cronache tale precisazione manca, e comunque l'interpretazione successiva del sogno fa capire che l'agnello doveva simboleggiare un ragazzo.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
350 CATERINA MORO
figli d'Israele (11) lo uccidano, e forse non si avvererà questo sogno (12)." E fu buona la cosa agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi servitori. E il faraone convocò le levatrici ebree ecc.[cf. Esodo 1,18] (13). E videro le levatrici che esse [= le donne ebree] erano vitali, simili ad animali (14), e non avevano bisogno di levatrici. E diede ordine il faraone a tutto il suo popolo ecc. [cf. 2,22]. E avvenne che quando appresero i figli d'Israele queste cose che aveva ordinato il faraone, (cioè) di gettare i figli nel Nilo, alcuni del popolo si separarono dalle loro mogli, e alcuni altri invece ri- masero con esse per mettere al mondo figli, ed esse (15) abbandonarono i loro figli sulla superficie del campo, e avvenne quanto era stato giurato ai loro padri, di rendere la loro discendenza come la polvere del suolo [cf. Genesi 13,16]. (Dio) mandò loro i suoi angeli per lavarli, per ungerli e per fasciarli [cf. Ezechiele 16,4] (16), e per porre due pietre levigate: da una succhiavano latte, dalla seconda mangiavano miele (17). E fece crescere i loro capelli fino alle loro ginocchia perché si coprissero con essi, e per adornarli e coccolarli nella Sua misericordia per loro. E avvenne che
(11) II testo ebraico di Esodo 1,22 parla di «ogni bambino che nascerà», quindi non solo di quelli degli ebrei. L'aggiunta "agli ebrei" compare nella versione dei LXX, nel Pentateuco Samaritano e nei targumim, ma il Talmud (B. Sotah 12a) difende il testo ebraico tradizionale dicendo che il faraone «decretò così anche per il suo popolo». Nel suo commentario a Esodo 1 ,22, Rashi di Troyes (1040- 1 105) spiega che al faraone era stata annunciata dagli astrologhi la nascita di un liberatore degli ebrei, ma non la nazionalità di costui (traduzione del passo in SJ. Sierra, Rashi di Troyes. Commento all'Esodo, Genova 1988, p. 9). L'ambiguità del presagio corrisponde all'identità ambigua di Mosè, che era ebreo ed egiziano al tempo stesso.
(12) II motivo dato in Esodo 1 ,9-10 è differente: gli ebrei sono visti come possibili nemici in guerra, о meglio come alleati dei nemici dell'Egitto. Questa motivazione sembra un'allusione al secondo racconto di Manetone, in cui i lebbrosi guidati da Mosè diventano alleati degli Hyksos (Giuseppe Flavio, Contro Apione, 1.227-266, spec. 241-243; traduzione italiana in L. Troiani, Commento storico al Contro Apione di Giuseppe Flavio, Pisa 1977, pp. 243-248).
(13) Tutte le indicazioni di versetti biblici sono date qui nella stessa forma, assai stringata, del testo ebraico, senza gli ampliamenti presenti nelle altre traduzioni.
(14) Nel testo massoretico di Esodo 1,19 le donne ebree sono dennite hayoth vive, vitali", ma è un hapax ed è lecito sospettare che il termine sia stato semplicemente inventato per eufemismo al posto di hayyoth «(come) animali» (da hayyah) che renderebbe più logica l'affermazione delle levatrici (le madri animali partoriscono da sole). La possibile sfumatura offensiva non doveva preoccupare l'autore biblico (in 1 ,7 usa per gli ebrei il verbo 'brulicare'), ma sicuramente preoccupò il traduttore greco, che non mette nessun equivalente di questa parola. L' interpretazione «come animali» è presente anche nel Talmud (B. Sotah lib. vedi sotto).
(15) II brusco cambio di soggetto fa pensare all'omissione di una parte del racconto. Nel Talmud (vedi oltre) le donne vanno a cercare i loro mariti sul luogo di lavoro per unirsi a loro e generare figli.
(16) Unica altra attestazione del verbo. (17) II testo di Gaulmyn chiama le due pietre «la manna di chi succhia latte e la manna di
chi mangia miele» (Rankin, op. cit., p. 27 nota 4).
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
I "BAMBINI SEMINATI": CONNOTATI OSIRIANI DI UNA LEGGENDA EBRAICA 35 1
avendo compassione di loro cercò di moltiplicarli sulla faccia di tutta la terra, ordinò al mondo terreno di accoglierli e custodirli finché non fossero cresciuti, eccetera. Poi la terra si aprì e li vomitò e fiorirono come l'erba del campo [cfr. Salmo 72, 16]. E tornarono ciascuno da suo padre e alla sua tribù e rimasero con loro. E ancora fecero delle capanne sulla superficie della terra, e li nascosero lì (18), e gli egiziani ararono sulle loro schiene ma non poterono danneggiarli, come ciò che è scritto "gli aratori ararono ecc." [Salmo 129,3] (19)»
Questa storia dei "bambini seminati" è narrata estesamente anche dal Tal- mud Babilonese (20), nella lunga digressione sulla cattività d'Egitto inserita nel trattato Sotah, che precisa anche che i bambini erano frutto di rapporti coniugali avvenuti nelle stesse campagne tra le donne ebree e i loro mariti al lavoro. Altre due versioni della storia sono riportate dal Targum Ps-Jonathan (cap. 15) (21) e dai Capitoli di Rabbi Eliezer (43,3) (22), due testi la cui redazione finale non è più antica del VII- VOI secolo d.C, dove però i bambini non sono inghiottiti dalla terra. Un breve schema (fig. 1) può aiutare a comprendere differenze e analogie tra le quattro versioni della storia prese in esame.
Nel Targum Pseudo-Jonathan la storia è narrata da brevi note che espan- dono la traduzione aramaica dei corrispondenti versetti biblici. Si osserverà che l'elemento iniziale della storia, ovvero la predizione della nascita di un liberatore degli ebrei che causa la strage dei figli maschi, nel Talmud e nei Capitoli di R. Eliezer è collocata in una posizione anomala (parti in neretto dello schema): per la seconda fonte si tratta di un ulteriore capitolo di storie
(18) Più avanti (p. 3, 1. 20 del testo di Jellinek) si afferma che Dio avrebbe fatto lo stesso per Mosè: «e la sua balia lo chiamò Abi Soco perché Dio lo nascose sotto il suo capanno (swkw) dall'odio degli egiziani» (vedi anche Gaster, op. cit., p. 110). La frase potrebbe riferirsi ai tre mesi in cui fu nascosto dalla madre. Nel Talmud si parla di un baldacchino nuziale posto nell'arca dove era esposto (B. Sotah 12b).
(19) Stessa citazione nel Talmud, B. Sotah lib. (20) II Talmud, di cui esistono due redazioni, una palestinese e una babilonese, è composto
dalla Mišnah (la raccolta di legge orale che fu messa per iscritto dal П secolo a.C. al II d.C, in ebraico) e dalla Ghemara ("completamento", in aramaico). La storia che ci interessa è parte della Ghemara e quindi si può datare attorno al V-VI secolo d.C.
(21) II Targum Pseudo- Jonathan, una traduzione aramaica del Pentateuco caratterizzata da numerose aggiunte narrative, è Tunica delle fonti in esame che riporti il sogno del faraone. Traduzione in R. Le Deaut, op. cit., p. 17; M. Mäher, The Bible in Aramaic. Targum Pseudo- Jonathan: Exodus, Edinburgh 1994, p. 203; testo in E.G. Clarke et aa., Targum Pseudo- Jo- nathan of the Pentateuch: Text and Concordance, Hoboken 1984, p. 84.
(22) Traduzione in M. Perez Fernández, Los Capítulos de Rabbi Eliezer, Valencia 1984, p. 298.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
352 CATERINA MORO
Talmud B.Sota Tar gum P s. -Jonathan Cronache di Mosè Capitoli di R. Eliezer
(12b, cf. B.Sanh.lOlh) ~~
I maghi predicono la Predizione della nascita ;. Diiancia ¡
} gn° Sogno della bilancia nascita del ragazzo che di Mosè Diiancia salyerà ̂̂ (4ад (12b) Separazione degli (2,1) Separazione degli Separazione degli israeliti dalle mogli israeliti dalle mogli israeliti dalle mogli (lib) Ricerca dei mariti in Alcuni mariti rimangono campagna e preparazione -
co„iemogli al rapporto coniugale (43,3) I bambini gettati
Parto in campagna e (15,2) Parto in campagna e Parto in campagna e nel Nilo riaffiorano in abbandono abbandono abbandono superfice e sono portati
da Dio nel deserto.
Cura da parte di Dio e degli (15'2) Cura da parte di Cura da P**6 di Dio e Cura da parte di Dio
an eli imi 1 li ) *^° e de^* ̂ S^ (miele e degli angeli (latte e (miele, variante miele e olio) miele latte, eolio)
Crescita dei capelli
La terra inghiotte i bambini - La terra inghiotte i bambini
Sui bambini sepolti sono costruite capanne
I bambini rispuntano e tah ] ̂ ambini e ̂ no 'ornano ancora lattanti
come ^^ rispuntano e Sconoscono del
Dio Mar
al I tornano bambini
alle rispuntano
loro case e tah e ̂ no ancora lattanti tomano
^^ ^ rispuntano
^ case e
passaggio del Mar
cresciuti d Passagg10 del Mar cresciuti Rosso (non S1 dlce se Rosso (Esodo 15) sono cresciuti)
Fig. 1 - Le quattro versioni della storia
sulla schiavitù d'Egitto, posto alla fine. Nel Talmud viene spostato anche un altro precedente, ovvero la separazione tra mariti e mogli. Questo mi induce a credere che le Cronache di Mosè discendano recta via da un archetipo perlomeno anteriore al VI secolo d.C, cui gli altri testi si sono ispirati, e che preservino quindi la forma о perlomeno la struttura originale della storia.
Anche una serie di brevi allusioni a questa storia in altri testi rende plausibile la datazione proposta da Rankin. In Sapienza 10,21, un testo del I sec. d.C. (23), si dice che Dio per essere lodato dopo il passaggio del Mar
(23) Per una panoramica degli studi su Sapienza si veda D. Winston, Un secolo di ricerca sul libro della Sapienza, in G. Bellia, A. Passaro (edd.), // libro della Sapienza. Tradizione, redazione, teologia, Roma 2004, pp. 13-31.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
I "BAMBINI SEMINATI": CONNOTATI OSIRIANI DI UNA LEGGENDA EBRAICA 353
Rosso «aveva sciolto la lingua degli infanti»: nel Talmud, nei Capitoli e nel Targum questi bambini sono infatti coloro che dicono la frase «è il mio Dio e lo voglio lodare» (Es. 15,2), perché essendo stati curati da Dio lo riconoscono (24). Un'altra allusione potrebbe essere contenuta nella prima lettera di Pietro (1 Petri 2,2.4): «come bambini appena nati bramate il puro latte spirituale, per crescere con esso verso la salvezza (....) Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa presso Dio. . .(ecc.)». La vicinanza delle due affermazioni fa pensare che dalla pietra esca latte, come nella nostra storia (25). Discendendo nel tempo un'allusione alla storia sembra presente in Aboth de R. Natan (A 33) (26): le due "muraglie" in cui si divide il mare in Esodo 15,8 versano olio e miele nella bocca dei lattanti (cf. Deut. 32,13). In un capitolo variante di Berešit Rabba (commentario a Genesi redatto nel V sec. d.C. ca.) si narra che 600.000 bambini, generati in una sola notte dalle donne ebree, furono gettati nel fiume ma si salvarono (97,3).
Nel complesso della tradizione ebraica sulla schiavitù d'Egitto la storia dei «bambini seminati» si inserisce in un gruppo di storie in cui si narra la fine tragica o, al contrario, il salvataggio miracoloso di bambini appena nati. Queste storie si collegano alla strage dei bambini ebrei annunciata in Esodo 1,22 e alla vicenda della salvezza di Mosè, ma al contempo sono espressione di un dramma costantemente rinnovato nella storia ebraica, il coinvolgimento dei bambini nelle sconfitte e nelle persecuzioni, che adom- bra lo spettro dell'estinzione del popolo. In una di queste storie, narrata nel Targum Pseudo-Jonathan (27) e nei Capitoli di R. Eliezer (48,7) (28), una donna ebrea incinta abortisce il suo feto nello stampo dei mattoni. Questo mattone, simbolo delle sofferenze del popolo d'Israele, viene raccolto da Dio e trasformato nella base del suo trono. Nello stesso Targum si narra
(24) P. Enns, Exodus Retold (HSM 57), Atlanta 1997, pp. 88-95; il problema, come rile- vato dall'A., è che al passaggio del Маг Rosso i 'bambini', se coetanei di Mosè, non potevano essere più tali, ma il dato coincide con l'annotazione nel Targum Ps.- Jonathan a Esodo 15,2 (sono lattanti al seno delle madri).
{io) L allusione alle «pietre vive» cne eaincano «1 edincio spirituale» (v. Ъ) ta inoltre pensare che Г A. stia seguendo il filo dei racconti legati all'Esodo (i bambini usati al posto dei mattoni, vedi oltre).
(26) Testo datato attorno al III-IV secolo, incluso nel Talmud. (27) Targum Ps.-Jonathan a Ex. 24,10 (testo in E.G. Clarke et Aa., Targum Pseudo-
Jonathan of the Pentateuch, pp. 96 s.; traduz. M. Maher, Targum Pseudo- Jonathan: Exodus, pp. 231 ss.).
(28) M. Perez Fernandez, op. cit., p. 339.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
354 CATERINA MORO
che il faraone di cui si parla in Esodo 2,23 morì di lebbra, e che tentò di guarire bagnandosi nel sangue di bambini ebrei (29). Risale invece al commentario medievale di Esodo (Shemoth Rabbď) e al commento al Talmud di Rashi di Troyes, anche se ce n'è già un accenno nella Miinah (Sanh. 101 b.), la storia secondo la quale gli egiziani, per mancanza di mattoni, usarono i neonati ebrei inglobandoli nel muro. Mosè chiede a Dio di poterli salvare ma questi gli risponde che sarebbero stati malvagi: l'unico salvato, Micha, diviene idolatra {Giudici 17 s.) e fonte di sciagure rituali (gli è attribuita la costruzione del vitello d'oro). Queste storie di bambini sembrano disporsi in un sistema in cui ogni storia rimanda all'altra, in positivo о in negativo. Il versante negativo ha la funzione di presentare una situazione estrema e disperata di annullamento della continuità delle generazioni (la soppressione dei neonati, che assume la forma dell'aborto nella storia del bambino-mattone), mentre il versante positivo di queste storie presenta la salvezza, appunto miracolosa, di questa stessa continui- tà. La storia dei "bambini seminati" appare essere la più complessa storia di salvezza miracolosa di questa serie, affollata com'è di una quantità di elementi simbolici e narrativi, alcuni dei quali cercheremo di esporre e decifrare in questa sede.
I bambini seminati e l'eroe esposto
L'esposizione - Come abbiamo visto, nelle tradizioni ebraiche questi bambini rappresentano una sorta di popolo ideale che riconosce YHWH al passaggio del Mar Rosso. Essi sono abbandonati in campagna e quin- di apparentemente destinati a morire, come in quello schema narrativo {tale type) che possiamo definire dell'eroe esposto alla nascita", e di cui abbiamo numerosi esempi nella letteratura antica (Sargon di Akkad, Ciro, lo stesso Mosè, Romolo e Remo, Perseo...) (30). Pur nella grande
(29) Plinio riporta una notizia simile sulla cura della lebbra {Storia Naturale 26.1.5). (30) Si veda il materiale raccolto da B. Lewis, The Sargon Legend: A Study of the Akka-
dian Text and the Tale of the Hero Who Was Exposed at Birth (American School of Oriental Research. Dissertation Series, 4), Cambridge MA 1980, tenendo conto delle critiche al metodo di questo autore esposte da J.G. Westenholz nella sua recensione in «JNES» 43 (1984), pp. 73-79. Le tradizioni leggendarie su Sargon emergono in epoca paleo-babilonese in due opere in sumerico, la Leggenda sumerica di Sargon (tavoletta 3N T296, vd. oltre) e la Lista reale
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
I "BAMBINI SEMINATI": CONNOTATI OSIRIANI DI UNA LEGGENDA EBRAICA 355
varietà di motivi e di ambiti culturali in cui questo schema narrativo si presenta, possiamo dire che il suo significato fondamentale è di fondare miticamente, tramite il racconto della loro nascita, la natura e il carattere di personaggi del passato (re, eroi о divinità) per opera dei quali la realtà di una cultura ha preso forma, sottolineando come la loro vita e la loro vicenda di ascesa (e di sventura, come nel caso di Edipo) fosse segnata fin dall'inizio dal volere degli dèi. Per evidenziare ed esplicitare questo volere degli dèi talvolta, come nella nostra storia, la storia prende le mosse da un presagio che indica nel bambino il futuro erede o soppiantatore del monarca in carica, e a causa di questo presagio egli viene esposto. Come l'"eroe esposto alla nascita" questi bambini sono oggetto di cure particolari da parte della divinità, che permette e decreta la loro sopravvivenza: nelle Cronache di Mosè, nel Talmud e nel Targum Ps-Jonathan sono fasciati e nutriti dagli angeli, in una variante delle Cronache di Mosè tradotta da Gaster sono nutriti dagli animali (31).
La latenza - La fase di nascondimento a un antagonista che vuole ucci- derlo è parte integrante di molte versioni della storia dell'eroe esposto: nella forma più tipica, l'eroe è adottato da una famiglia umile (32). Nella storia di Mosè il nascondimento è di segno inverso (figlio di schiavi oppressi,
sumerica (T. Jacobsen, The Sumerian King List, Chicago 1939, p. Ill, vi.30-36), entrambe mutile nelle parti in cui ci dovevano essere notizie sulla nascita del personaggio (non sappiamo quindi se già vi comparisse l'esposizione e l'adozione). In entrambi i testi Sargon è presentato come coppiere del re Urzababa, e nella Lista reale sumerica si dice che suo padre (naturale о adottivo) era un giardiniere. Il testo su cui si incentra l'analisi di Lewis è la Leggenda della nascita di Sargon, una composizione pseudo-autobiografica datata dall' A. a poco prima del 705 a.C, cioè nell'ultimo periodo di regno del re assiro Sargon П (721-705) {The Sargon Legend. . . , cit., pp. 97-106; si vedano tuttavia le obiezioni di Westenholz, art. cit.). La vicenda narrata nella prima colonna di questo testo è quella formalmente più vicina alla storia della nascita di Mosè narrata in Esodo 2: figlio di una sacerdotessa enetu e di un padre ignoto, Sargon è posto nel fiume in un baule (quppu, termine parzialmente ricostruito) di canne sigillato con bitume. Ripescato e adottato dal giardiniere Aqqi, giunge al trono per il favore della dea IStar e com- pie imprese memorabili. Nell'analisi che segue il significato generale attribuito allo schema narrativo dell '"eroe esposto" e ai suoi vari elementi rispecchia, ove non altrimenti indicato, l'opinione di chi scrive.
(31) Gaster, op. cit., p. 108. (32) L'adozione da parte di una famiglia umile compare in quasi tutte le storie dell'eroe
esposto, a prescindere dalla presenza о no di un antagonista nella storia. Nella Leggenda della nascita di Sargon accadica il protagonista è adottato da un giardiniere, ma non ha un antago- nista cui nascondersi.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
356 CATERINA MORO
viene cresciuto al sicuro nel palazzo reale), ma la funzione è la stessa. I bambini coetanei di Mosè sono nascosti dalla terra fino a crescere, il che equivale о ad attendere la fine della persecuzione (su questo punto il testo non è chiaro) о a perdere la qualità di bambini che li esponeva a questa. A mio parere la latenza è una fase importante della storia dell'eroe esposto, funzionale a rassicurare gli ascoltatori sulla continuità della regalità, voluta e garantita dagli dèi, a dispetto della fragilità della continuità fisica dei monarchi (che possono essere sterili, o i loro figli morire...). Il senso di questo elemento del racconto è che l'erede, anche quando sembra mancare, è semplicemente invisibile ai profani, ma non agli dèi che provvedono alla sua sopravvivenza e alla sua 'riapparizione' (33). Spesso egli è uno straniero dal ruolo provvidenziale, che la storia mette sotto la protezione degli dèi del Paese conquistato, come appunto Sargon di Akkad rispetto ai Sumeri (34), о il persiano Ciro rispetto ai Babilonesi. Come l'erede esposto è un celebre re del passato, il cui esito glorioso è noto agli ascoltatori, i bambini seminati sono per gli ascoltatori ebrei il «popolo di sacerdoti» che riceverà la Legge sul Sinai e stringerà un patto con YHWH {Esodo 19 e 24), sono cioè personaggi della Bibbia ebraica destinati a una funzione tipicamente regale. Questa concezione che vede il popolo d'Israele protagonista diretto del patto di alleanza con YHWH, al posto del re (per il quale cf. il rito descritto in 2 Re 23,3), centrale in tutto il Pentateuco, dovette prendere forma dopo l'Esilio e dopo la fine della monarchia di Giuda con la morte del'ultimo erede, Zorobabele (35).
(33) In questo senso la storia può essere stata la controparte mitica di un evento che spesso deve essere accaduto nella realtà, ovvero l'ascesa al trono di un sedicente "erede regale" che si vuole sopravvissuto alla strage (o all'estinzione naturale) della sua famiglia: in 2 Re 9-11, ad esempio, si narra una storia simile per il re loas.
(34) Nella Leggenda sumerica di Sargon (trascrizione e traduzione inglese in J.S. Cooper, W. Heimpel, The Sumerian Sargon Legend, «JAOS» 103, 1983, pp. 67-82) si spiega in dettaglio come Sargon giunga al potere perché prediletto della dea manna (Istar nella Leggenda della nascita di Sargon accadica) e perché così hanno decretato gli dèi, che hanno deciso di sottrarre il trono al re Urzababa, di cui Sargon è coppiere.
(35) Si veda ad es. G. Garbini, Mito e storia ..., cit., pp. 101-103; Рн. R. Davies, The Place of Deuteronomy in the Development ofJudean Society and Religion, in Recenti tendenze nella ricostruzione della storia antica d'Israele (Roma, 6-7 marzo 2003), Roma 2005, pp. 139-155. Sul ruolo di Zorobabele nel ritorno dall'esilio babilonese e la sua probabile fine vd. G. Garbini, II ritorno dall'esilio babilonese (Studi Biblici, 129), Brescia 2001, pp. 145- 172; Id., La lancia del re. Indagini su ebr. seiet, in P.G. Borbone et Aa. (edd.), Loquentes linguis. Studi linguistici e orientali in onore di Fabrizio A. Pennacchietti, Wiesbaden 2006, pp. 301-305, spec. pp. 304 s..
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
I "BAMBINI SEMINATI": CONNOTATI OSIRIANI DI UNA LEGGENDA EBRAICA 357
La vegetazione - bdi storia presenta, però, un dato estraneo alla storia dell'eroe esposto (36). I bambini sono descritti come dei vegetali: sono, infatti, inghiottiti dalla terra per rispuntarne vivi dopo un certo tempo «come l'erba del campo». L'aspetto vegetale dei bambini è ancora più sottolineato nelle versione delle Cronache di Mosè, in cui prima di essere sepolti si coprono di lunghi capelli, paragonabili a germogli d'erba о di cereali (37) - la parola usata per 'capelli', secar, in ebraico postbiblico indica anche lo 'stelo', ed è quasi omofona di quella per 'orzo', secora о secur. Questo particolare della storia mi ha condotto al rito detto parpi- sà, di cui sono venuta a conoscenza tramite il libro di Chiara Peri sulla concezione della morte nella religione di Canaan (38). Il rito è descritto nel commentario di Rashi di Troyes al Talmud (B.Shabb. 81b): due о tre settimane prima di Roš-hašanna (il Capodanno ebraico) si facevano canestri di foglie di palma e si riempivano di terra, uno per ogni bambino о bambina della casa, seminandovi fagioli egiziani о altri legumi. Alla vigilia di Roš-hašanna ogni bambino prendeva il suo cesto, lo faceva roteare sulla testa sette volte dicendo: «Questo per questo, questo invece di me, questo è il mio sostituto», e poi lo gettava nel fiume. Il nome di questo rito era forse già conosciuto ai tempi di R. Abaye (280-338 d.C). L'idea sottesa a questa pratica sembra essere simile a quella di un sacrifi- cio espiatorio о di sostituzione, in cui il vaso vegetante di foglie di palma rappresenta il bambino (per il rito degli adulti, detto kapparoth, si usa un gallo). Poiché Dio nei giorni tra Roš-hašanna e Yom Kippur decide chi deve vivere о morire nel corso dell'anno, il sacrificio di sostituzione serve a stornare la mortalità infantile, connessa non con una minaccia mitica (la strage dei coetanei di Mosè) ma con il tempo di crisi legato
(36) О quasi estraneo: in alcune storie di esposizione compare un recipiente tratto da un tronco d'albero, in cui il bambino viene esposto (per es. nel Liber Antiquitatum Biblicarum 9,12 Mosè è posto in un'arca di corteccia di pino: Jacobson, op. cit., p. 15). Un collegamento tra queste storie e le peregrinazioni del cadavere di Osiride in Plutarco è stata ipotizzata da N.M. Holladay, The Floating Chest, «J. Hell. St.» 69 (1949), pp. 39-47.
(37) Jellinek, op. cit., p. 2, 1. 2 s.. (38) // regno del nemico (Studi biblici, 140), Brescia 2003, p. 164. Il nome del rito secondo
J.Z. Lauterbach (Tashlik, «HUCA» 11 (1936), pp. 207-340, spec. pp. 277-279, da cui sono tratte le notizie sul rito che seguono) deriva dal latino propitio; nel dizionario di M. Jastrow (A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, col. 1236b) la parola è interpretata come composto significante "fiore di palma".
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
358 CATERINA MORO
al passaggio dell'anno (39). Proprio l'esistenza di questo rito (ancorché di attestazione tardiva), e la sua connessione con il passaggio dell'anno e con la continuità delle generazioni mi ha incoraggiata a istituire una comparazione tra il racconto dei bambini seminati e il rito osiriano delle figurine germogliano di Khentimenti, che conosciamo in dettaglio dai testi di Dendera che descrivono i riti che si svolgono nel mese di Khojak (40). La figura di Osiride detta Khentimenti, fatta di sabbia e orzo impastati e posta in due stampi a forma di mummia, viene innaffiata e coperta con dei giunchi (che sono rinnovati tutti i giorni, e quelli vecchi sono sep- pelliti come cose sacre) perché non secchi, e infine, dodici giorni dopo, viene avvolta in bende che uniscono, avvolgendole, le due parti. Dopo un anno di permanenza nel santuario e dopo il confezionamento della forma dell'anno in corso, la forma dell'anno precedente viene messa per sette giorni sui rami di un sicomoro (corrispondenti ai sette mesi di gestazione di Osiride), e poi seppellita. L'immagine vegetale della rina- scita di Osiride era impiegata anche nelle liturgie funerarie: nelle tombe del Nuovo Regno si trovano i "letti di Osiride" (grani disposti su una tela a forma di Osiride) e figurine mummiformi, munite di fori, con lo stesso scopo (41). Le analogie che mi sembra di vedere tra questo rito e la storia dei bambini seminati ci offrono, in attesa di definire un rapporto di dipendenza, una possibilità di comparazione (42). Come nel rito del- F Osiride germogliante, nella storia dei bambini seminati (e nel rito di parpisà) non è la vitalità della vegetazione a essere in causa, ma questa vitalità, espressa dalla germinazione, significa e attua per l'individuo la
(39) In realtà nella Bibbia ebraica vi è un nesso tra storia di Mosè e passaggio dell'anno, ovvero la prima piaga (l'acqua mutata in sangue, Esodo 7,14-24) che corrisponde ad alcune descrizioni della piena date dagli autori classici (vedi B. Soyez, Byblos et la fête des Adonies, Leiden 1977, p. 58) ed è connessa esplicitamente con l'inondazione del Nilo da Artapano (in Eusebio, Praeparatio Evangelica. IX, 27. 28).
(40) Edizione, traduzione e commento dei testi in È. Chassinat, Le Mystère ď Osiris au mois de Khoiak, 2 voll., Le Caire 1966 e 1968 (la traduzione continuativa è in II, pp. 809-823).
(41) Vedi Р. КоЕмотн, Osiris et les arbres, Liège 1994, 12, 15-18, e il contributo di E.M. Ciampini in questo stesso volume.
(42) Nei Capitoli di Rabbi Eliezer i bambini curati da Dio nel deserto (ma non sepolti) sono gli stessi gettati nel fiume dagli egiziani (nelle Cronache di Mosè questa storia è narrata come doppione di quella dei bambini seminati nel campo). Questo dettaglio sembra avvicinare maggiormente i bambini a Osiride (che in una versione del mito fu annegato dal rivale Seth), ma potrebbe essere una semplice fusione del dato biblico con la storia.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
I "BAMBINI SEMINATI": CONNOTATI OSIRIANI DI UNA LEGGENDA EBRAICA 359
rinascita о la salvezza dalla morte, e per il popolo, inteso come protago- nista regale della relazione col suo Dio, la continuità delle generazioni, dopo l'apparente latenza del seme-bambino nascosto sotto terra (43). A ciò si aggiunga che la comparazione con alcune pratiche del folklore egiziano, in cui il bambino di pochi giorni viene scosso in un cesto (che serve da crivello) assieme a grano e gioielli, ha indotto S.H. Aufrère a pensare che nel rito di Khojak la rinascita di Osiride fosse connessa con una reiterazione dei riti della prima infanzia (44).
Il problema storico: rapporto con la storia di Mosè
Oltre agli elementi che appartengono al patrimonio comune del tale type dell'eroe esposto, ci riconducono dai "bambini seminati" alla storia di Mosè alcuni particolari che emergono sporadicamente nella tradizione. Già nella Bibbia ebraica {Esodo 2,3) il recipiente dove Mosè viene esposto è chiamato tevah, termine per il quale è stata chiamata in causa un'etimologia egiziana (da dblt "cassa, sarcofago", copto taibé) (45). Come i bambini seminati, secondo le Cronache, Mosè fu nascosto da Dio «sotto la sua capanna» (46), dove per capanna possiamo intendere una copertura di rami intrecciati non dissimile da quella usata per coprire la cassa germogliarne nei riti di Khojak (47), e nei Ca- pitoli di Rabbi Eliezer (48,39) è nascosto sotto terra, in una camera sottostante la casa. La sua stessa permanenza tra i giunchi della riva del fiume (che per Giubilei, un testo parabiblico del П sec. a.C, si prolunga per sette giorni) (48)
(43) Un'immagine simile compare nel vangelo di Giovanni (12,24). (44) Le hiéroglyphe du crible à grain et la métaphore désignant le nouveau-né dans V Egypte
ancienne, in N. Grimal et. Aa. (éds.), Hommages à Fayza Haikal, Le Caire 2003, pp. 17-27. (45) Wb. 5, 561. (46) II particolare riguardante i bambini è presente solo nel testo edito da Jellinek e in
quello tradotto da Rankin, non in quello tradotto da Gaster. Su Mosè vd. sopra, nota 17. In Amos 9,1 1 si parla di una «capanna di David» (sukkat Dawid) come di un importante attributo del re Messia, che Dio restaurerà (Garbini, Mito e storia . . ., cit., pp. 171-174 ): cf. la struttura tornata alla luce presso la porta di Teli Dan, centro religioso del regno d'Israele, interpretata come base di un baldacchino, che poteva accogliere il re in trono о la divinità (I. Oggiano, Dal terreno al divino. Archeologia del culto nella Palestina del primo millennio ', Roma 2005, p. 89).
(47) Vd. per es. nel testo di Dendera libro II § 3, § 5 (Chassinat, op. cit., p. 811). (48) Giubilei 47 ,4 (E Corriente, A. Pinero, Libro de los Jubileos, in A. Diez Macho (ed.)
Apócrifos del Antiguo Testamento II, Madrid 1983, p. 183).
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
360 CATERINA MORO
richiama la permanenza della figura di Khentimentì tra i rami di sicomoro prima della sepoltura (49). In questa fase della ricerca mi risulta difficile formulare un'ipotesi unitaria sull'origine ultima della storia dei bambini seminati e sui modi storici dell'appropriazione del tema osiriano da parte della tradizione ebraica. Nell'ultima parte di questa relazione esporrò un ventaglio di possibili collegamenti e percorsi all'interno del materiale finora analizzato.
La successione regale
Al di là della possibile presenza di questi temi osiriani, la storia di esposizione di Mosè narrata nella Bibbia appare ben inserita nel filone delle analoghe storie mesopotamiche (50), e difficilmente si può dubitare della derivazione da queste. Ma poiché il più probabile luogo di elaborazione della storia dell'infanzia di Mosè fu l'Egitto (51), resta da scoprire per quali vie questo genere di storia giunse alle orecchie degli ebrei d'Egitto, e perché fu ritenuto degno di rappresentare l'eccellenza della figura di Mosè. Una spiegazione possibile è che tale storia fosse entrata a far parte dell'ideologia regale persiana, come dimostra l'adozione di questo schema narrativo nel racconto dell'ascesa di Ciro (52). Ricordiamo che nell'ideo-
(49) Si veda il testo di Deriderà, libro V § 49 (Chassinat, op. cit., p. 819). (50) Oltre a Sargon, esistono due storie mesopotamiche di esposizione narrate da Ctesia
di Cnido, quella della regina Semiramide (in Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, II, 4; trad, it. G. (Gordiano, M. Zorat, Biblioteca Storica: libri I-VIII, Milano 1998, pp. 232 s.), e quella di Ghilgamos (Gilgames, in Eliano, La natura degli animali, 12, 21).
(51)1 nomi geografici e di persona contenuti nei primi due libri dell'Esodo presuppongono una conoscenza dell'Egitto di epoca saitica (si veda D. B. Redford, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, Princeton 1992, pp. 408-422). Alcuni storici, pur accettando le argomentazioni di Redford, hanno voluto porre l'origine di questa storia nel regno di Giuda al tempo di Giosia (VII sec. a.C; I. Finkelstein, N.A. Silberman, Le tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e mito, Roma 2002, pp. 61-84, spec. pp. 82-84), quando lo stato di guerra con l'Egitto rendeva sì plausibile la nascita di una tradizione ostile a questa nazione, ma non favoriva certo la conoscenza della geografia о dei nomi di persona. È più probabile che l'Egitto di Esodo 1-2 rispecchi quello che conobbero i primi ebrei che vi si insediarono tra gli ultimi re indigeni e il dominio persiano (sui primi insediamenti degli ebrei in Egitto vd. R. Contini, / documenti aramaici dell* Egitto persiano e tolemaico, «Rivista Biblica Italiana» 34, 1986, pp. 73-109).
(52) Tale ipotesi, che merita ulteriori verifiche, mi è stata suggerita nel corso di un colloquio con il prof. Giovanni Garbini (C. Perrot, Les récits d'enfance dans la haggada antérieure au Ile siècle de notre ère, «Recherches de Sciences Religieuses» 55, 1967, pp. 481-518, spec. p.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
I "BAMBINI SEMINATI": CONNOTATI OSIRIANI DI UNA LEGGENDA EBRAICA 36 1
logia biblica la regalità di Mosè rappresenta la regalità della Legge come strumento di mediazione col divino (53). La presenza di elementi osiriani nella storia dell'infanzia di Mosè potrebbe essere frutto di una interpre- tazione giudeo-egiziana della sua storia, analoga ma differente da quella operata da Artapano (54). La vicenda di Osiride e Horus è, infatti, il mito di successione per eccellenza nella religione egiziana, e la rigenerazione vegetale del rito dell 'Osiride germogliante è una delle espressioni costanti, come è spiegato da Ciampini (55), di questo teologumeno. Possiamo dire quindi che sul piano narrativo la vicenda di Osiride è l'equivalente fun- zionale di quello che per il mondo mesopotamico (e in parte greco) (56) è la storia dell'eroe esposto. Anche la storia di rigenerazione dei bambini seminati costituirebbe una riformulazione narrativa del rito dell 'Osiride germogliante come storia di successione, inserita nella narrazione biblica e nell'ideologia del "popolo regale". Lo conferma anche un elemento della storia estraneo ai riti di Khojak ma di chiaro sapore osiriano: la ricerca (dopo una separazione forzata) e la 'preparazione' dei padri (che sono lavati,
507, ipotizzava un'influenza della tradizione riguardante Ciro, limitata però a quelle che giudica tradizioni aggadiche posteriori alla Bibbia). Delle due storie dell'ascesa provvidenziale di Ciro risalenti al V secolo a.C. (giova ricordarlo, poco più di un secolo dopo la sua morte) una ha l'espo- sizione (Erodoto, Storie 1, 107-121), e l'altra no (Ctesia Di Cnido, di poco posteriore, trasmessaci da Nicola di Damasco, FrGrH90 F66, F. Lenfant, Ctésias de Crude. La Perse. Linde. Autres fragments, Paris 2004, pp. 93-95). Ricordiamo che Mosè ha anch'egli una storia di ascesa senza esposizione, quella dello storico giudeo-ellenistico Artapano. La storia di Ciro in Ctesia (sulla quale si veda R. Drews, Sargon, Cyrus and Mesopotamian Folk History, «JNES» 33, 1974, pp. 387-393) ha numerosi punti di contatto con la Leggenda sumerica di Sargon (uno per tutti, il ruolo di coppiere del re per l'eroe). Per l'appropriazione della figura di Ciro nella Bibbia ebraica, cf. Isaia 40 ss. (secondo G. Garbini, Storia e ideologia. .., cit., pp. 134-138, questi capitoli sono stati scritti al tempo di Dario).
(53) Nella vicenda di Mosè come paradigma della Legge, la vicenda dell'eroe esposto è molto importante: anche la Legge è stata 'nascosta' (dalla Conquista al suo ritrovamento nel Tempio secondo 2 Re 22). Per la regalità di Mosè nell'esegesi successiva, si veda per es. Ezechiele Tragico, Exagoge, vv. 68-89 (in una visione notturna Mosè riceve scettro e corona da Dio, che lo invita a sedersi sul suo trono); Filone Alessandrino, Vita Mosis, passim, spec. 11,3; Clemente Alessandrino, Stromati I/24/158-162.
(54) Vd. sopra, nota 2. In Artapano Mosè è presentato come un erede regale a tutti gli effetti.
(55) E.M. Ciampini, Rigenerazione e trasmissione del potere: la statua di Khentimenti nel rituale di Khoiak e i precedenti di una tradizione dell* Egitto tardo, in questo stesso volume, pp. 257-287.
(56) Si veda l'analisi del mito eroico come mito di intronizzazione in D. Sabatucci, // mito il rito e la storia, Roma 1978, pp. 296-302.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
362 CATERINA MORO
unti d'olio e rivestiti) da parte delle loro mogli, prima del concepimento di questi bambini, così come sono narrate nel Talmud (B. Sotah lib).
Il prematuro
Accanto alla connessione con la successione regale, questi elementi della tradizione possono rimandare anche a una diversa rappresentazio- ne dell'infanzia di Mosè legata all'idea di una sua natura eccezionale, ai confini tra umanità e divinità, che emerge spesso nella documenta- zione antica (57). Come per Osiride (58) e Horus nella religione egi- ziana, la tradizione ebraica conosce molte gestazioni di sette mesi per i personaggi biblici (59). Tuttavia nelle Cronache di Mosè (60) e nel
(57) Per uno sguardo d'insieme sul tema vd. W.A. Meeks, Moses as God and King, in J. Neu- sner (ed.), Religions in Antiquity. Essays in Memory of ЕЯ. Goodenough (Studies in the History of Religions, 14), Leiden 1968, pp. 354-37 1 . Per la Bibbia ebraica si veda Esodo 4, 1 6 e 7, 1 , in cui Mosè è detto 'Dio', e la trasformazione di cui si parla in Esodo 30,29-35. Per quanto riguarda le tradizioni giudeo-egiziane, ricordiamo lo storico Artapano, per il quale Mosè fu ritenuto un dio dai sacerdoti egiziani per i benefici resi allo Stato (Eusebio, Praeparatio Evangelica, IX, 27, 6) e la visione del trono in Ezechiele Tragico (vd. nota 53), in cui Mosè viene fatto sedere sul trono di Dio, assumendo la funzione di suo reggente e plenipotenziario (P. W. Van Der Horst, Moses ' Throne Vision in Ezekìel the Dramatist, «Journal of Jewish Studies» 34, 1983, pp. 21-29; Id., The Interpretation of the Bible by the Minor Hellenistic Jewish Authors, in Id., Essays on the Jewish World of Early Christianity, Nov. Test, et Orb. Ant, 14, Göttingen 1999, pp. 187-219, spec. pp. 190-192). Secondo gli autori del Nuovo Testamento (vd. soprattutto la trasfigurazione, Matteo 17,1-13 e paralleli) e altre fonti coeve (Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche, IV.326, cf. Ш.96; Filone Alessandrino, Quaest. In Ex., П.29), Mosè sarebbe asceso al cielo come Enoch ed Elia, e nella tradizione ebraica samaritana il Messia atteso ha i tratti del «profeta come Mosè», sulla base di Deuteronomio 18 (tracce di questa concezione si sono trovate anche nei testi di Qumran, si veda F. Dexinger, Reflections on the Relationship between Qumran and Samaritan Messianology, in J.H. Charlesworth et Aa. (eds.) Qumran-Messianism. Studies on the Messianic Expectations in the Dead Sea Scrolls, Tübingen 1998, pp. 83-99). Anche nei Vangeli sono frequenti le analogie tra le vicende e le azioni di Mosè e quelle di Gesù (si pensi solo alla strage di bambini perpetrata da Erode in Matteo 2, in cui i magi hanno la stessa funzione delle predizioni fatte al faraone).
(58) Nel testo di Dendera (vd. nota 48) i sette giorni in cui la figura di Khentimenti sta tra i rami di sicomoro corrispondono ai sette mesi di gestazione.
(59) Si veda P.W. van der Horst, Seven Months Children in Jewish and Christian Lite- rature from Antiquity, «Eph. Theol. Lov.» 54 (1978), pp. 346-360 (ristampato in Id., Essays ..., cit., pp. 233-247).
(60) Vedi Rankin, op. cit., p. 28: «And it came about that after six month she conceived and bore a son»; cf. Gaster, op. cit., p. 109; nel testo edito da Jellinek, op. cit., p. 21, 1. 24, si parla di tre mesi, probabilmente per facile confusione tra waw (6) e ghimel (3).
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
I "BAMBINI SEMINATI": CONNOTATI OSIRIANI DI UNA LEGGENDA EBRAICA 363
Targum Pseudo- Jonathan (a Esodo 2,2) Mosè viene partorito sei mesi dopo il concepimento, ovvero a un'età di gestazione in cui le nozioni degli antichi ritenevano impossibile la sopravvivenza (61). Questa tra- dizione doveva già esistere al tempo degli affreschi della sinagoga di Dura Europos (III secolo d.C), dove all'atto del ritrovamento da parte della figlia del faraone il volto di Mosè è rappresentato senza tratti, (gli occhi che si vedono nella figura sono esito di restauro) (fig. 2). In ambiente egiziano, questa natura incompleta è attribuita nel De Iside et Osiride di Plutarco (§ 19) al dio Arpocrate, figlio postumo della coppia divina. A prima vista, la tradizione si presta a essere liquidata come un espediente esegetico per spiegare perché e come Mosè potè essere nascosto dalla madre per non più di tre mesi {Esodo 2,2) (62). Tuttavia io preferisco attribuire a questo dato una funzione religiosa più profonda (63): la tradizione ebraica attribuisce a Mosè proprio la persistenza delle conoscenze fetali (soprattutto la Torah) (64), e inoltre questo tratto eccezionale lo connette con il primo uomo, che secondo il commentario Berešit Rabba fu creato golem, 'informe' (65). Ad ogni modo alla luce di questa tradizione, le cure a lui riservate, prima e durante l'esposizione, si possono connettere a quelle dovute a un pre- maturo, e la tevah che lo contiene nel racconto biblico, la capanna che eventualmente lo copre, о la stanza sotterranea che lo accoglie durante i tre mesi di nascondimento, possono essere viste come surrogati del grembo materno, ai quali può essere affidato il completamento della gestazione. Lo stesso può dirsi della terra che accoglie e nasconde i «bambini seminati», giacché nella stessa Bibbia ebraica il mondo sot-
(61) Per es. Filone, De Opif. Mundi, 124; Leg. Alleg. 1,9; BereSit Rabba 14,2 (per van der Horst, Seven Month's Children..., cit., pp. 237-239, la teoria secondo cui i bambini di otto mesi non sono vitali, contrariamente a quelli di sette, è di origine greca).
(62) L'espediente sarebbe analogo alla soluzione del Liber Antiquitatum Biblicarum (9,5. 12; il padre di Mosè suggerisce alle donne di nascondere lo stato di gravidanza per tre mesi, come poi fece sua moglie) о a quella del Talmud (B. Sotah 12a, la madre era già incinta di tre mesi quando ringiovanì miracolosamente, e gli egiziani contarono da allora i mesi di gravidanza).
(63) Anche van der Horst, Seven Month's Children..., cit., pp. 347 s. (= pp. 234 s.), ri- tiene la tradizione su Mosè prematuro sia la più antica rispetto agli altri personaggi biblici cui questo tratto è attribuito, ma ritiene che la sua origine vada ricercata nella natura miracolosa del concepimento di Mosè.
(64) Talmud, B.Nidda 30b (il feto impara tutta la Torah nel grembo materno, per poi dimenticarla alla nascita).
(65) Berešit Rabba 8,1, in riferimento al termine golem in Salmo 139,16.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
364 CATERINA MORO
Fig. 2 - Ritrovamento di Mosè. Affresco dalla sinagoga di Dura Europos (da E.R. Goodenough, Jewish Symbols in the Graeco-Roman Periody XI: Symbolism
in the Dura Synagogue. Illustrations, New York 1964, pl. IX)
terraneo è equiparato al grembo materno: si veda per es. Salmo 139,15 («quando venivo intessuto nelle profondità della terra») e Giobbe 1,21 («nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò là»). Sa- remmo quindi vicini all'identificazione nel rito egiziano tra la cassa germogliante e Nut, madre di Osiride. Questi elementi della storia di Mosè potrebbero in conclusione costituire i resti di una concezione religiosa che legava il personaggio biblico, о una qualche figura divina in lui confluita, alla tutela dei nati e dei feti in gestazione, in definiti- va alla buona riuscita della procreazione umana. La figura divina cui viene fatto di pensare è il dio egiziano Bes, protettore delle nascite, che aveva i tratti del prematuro (66), e che conobbe un considerevole successo in tutta l'area mediterranea (67). Tuttavia non restano tracce
(66) D. Meeks, Le nom du dieu Bès et ses implications mythologiques, in U. Luft (ed.), The Intellectual Heritage of Egypt (Studia Aegyptiaca, 14), Budapest 1992, pp. 423-436. Il nome Bes non è attestato per la divinità in questione prima della XXI dinastia, ma l'immagine del dio compare nel Medio Regno, e bs con il significato di "prematuro^compare già nei Testi delle Piramidi.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
I "BAMBINI SEMINATI": CONNOTATI OSIRIANI DI UNA LEGGENDA EBRAICA 365
di questa concezione nella tradizione giudaica, nemmeno in quella magica, dove Mosè è invocato sempre non per la sua storia di salvezza miracolosa, ma per la sua conoscenza dei nomi divini, rivelatagli sul Sinai (cf. Esodo 3,14 e 6,2), che nella tradizione magica non sono solo YHWH (o «Io Sono») bensì tutta una serie di nomi segreti efficaci per ogni tipo di magia, che nella tarda antichità saranno oggetto della compilazione in ebraico detta Spada di Mosè (68). Allo stato attuale delle nostre conoscenze, la natura divina di Mosè, come quella regale, resta legata prevalentemente all'idea che egli abbia ricevuto la Legge e che in qualche modo la incarni, sia sul piano narrativo che nella sfera soprannaturale raggiunta dopo la sua morte: l'eventuale assunzione di elementi religiosi arcaici nella rappresentazione tradizionale di Mosè non contraddice a mio parere la natura relativamente recente di tale rappresentazione (69).
Il problema dei giardini di Adone
Una considerazione analoga deve farci da guida e indurci alla cautela qualora volessimo cercare tracce di un'origine più remota dei temi presenti
(67) II dio Bes è uno dei soggetti più rappresentati negli amuleti e nei sigilli dell' VOI secolo in Palestina (I. Oggiano, op. cit., p. 135). Molte discussioni ha suscitato la presenza di due figure besoidi s'ňpithos Ada Kuntillet Ajrud (IX- Vili sec. a.C), che porta iscritta anche una benedizione «per YHWH di Samaria e la sua Arerà» (vd. C. Uehljnger, Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestina and the Search for Yahweh 's Cult Image, in K. van der Toorn (ed.), The Image and the Book. Iconic cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and in the Ancient Near East, Leuven 1997, pp. 97-155, spec. pp. 142-146; P. Merlo, La dea Asratum - Atiratu - Mera, Roma 1998, pp. 204-205, e la bibliografia ivi citata): sembra difficile che tale raffigurazione sia in diretto rapporto col testo, ovvero che rappresenti le due divinità ivi nominate, ma ad ogni modo è testimonianza della compresenza di culto di Bes e culto di YHWH e Asera nel sito.
(68) M. Gaster, The Sword of Moses, in Id., Studies and Text in Folklore, New York 197 1 , I, pp. 288-337; П, pp. 69-103.
(69) D problema della sopravvivenza di notizie e concezioni pre-esiliche nella Bibbia ebraica è al centro della contesa tra storici "massimalisti" e "minimalisti" (si veda un breve sunto della questione, con notizie bibliografiche, in C. Moro, La Bibbia ebraica tra contesto orientale ed esegesi antica: un bilancio didattico e metodologico, «Annali di Storia dell'Esegesi» 23/2, 2006, pp. 529-536). Per rappresentazione relativamente recente intendo coeva о di poco precedente al formarsi delle opere poi confluite nei libri da Esodo a Giosuè (le notizie su Mosè di epoca pre-esilica non lo collegano alla Legge: la prima fonte databile che collega Mosè alla Legge è lo storico greco Ecateo di Abdera, nel IV sec. a.G; si veda Garbini, Mito e storia ..., cit., pp. 87-109, spec. p. 95, pp. 103 s.).
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
366 CATERINA MORO
nella storia dei "bambini seminati": come già detto, nella storia in nostro possesso la natura regale di questi bambini è strettamente legata a una conce- zione religiosa post-esilica (70). Tuttavia non è da escludere che in tale storia possano conservarsi elementi dell'ideologia regale arcaica d'Israele, di cui noi sappiamo poco per la condanna indiscriminata che i re, e soprattutto il loro ruolo religioso, hanno subito nella storiografia biblica e nei profeti. In parti- colare resta problematico il rapporto tra la storia in esame, il rito di parpisà, e le notizie di fonte classica sui cosiddetti giardini di Adone: in particolare, i cesti del parpisà sono stati messi in collegamento con i giardini di Adone da M. Delchor (71). La pratica di far germogliare dei semi in piccoli vasi, poi posti a seccare al sole, è ben conosciuta nel culto greco di Adone, ma si ignora se fosse praticata in oriente (72): nel De Dea Sira 6-9 dello Ps.-Luciano (П sec. d.C), che descrive le feste di Adone a Biblo, non se ne fa parola (73). È possibile che per gli israeliti esistesse un mito arcaico di nascita о rinascita "vegetale" del re, identificato con una figura divina che muore e risorge come Baal о Melkart, о comunque collegato con le realtà sotterranee (74)? Nella Bibbia ebraica non è infrequente l'uso di metafore vegetali per descrivere il
(70) Vd. sopra, nota 35. (lì) Le problème des jardins d'Adonis dans Isaïe 17, 9-11 a la lumière de la civilisation
syro-phénicienne, «Syria» 55 (1978), pp. 371-394, spec. 376 s. (ma, secondo ГА. stesso, il rito è troppo tardivo per dare lumi sul passo biblico in questione). L'ipotesi di Delchor è respinta da S. Ribichini, Adonis. Aspetti «orientali» di un mito greco, Roma 1981, pp. 94-98.
(72) Ribichini, ibidem, ipotizza, però, che i giardini del culto greco possano essere una reinterpretazione di realtà religiose orientali, probabilmente dei veri e propri giardini con funzione cultuale (pp. 98-107).
(73) Sulle Adonie di Biblo vd. Soyez, op. cit. In tali feste al periodo di lutto seguiva la proclamazione che il dio «continuava a vivere» dopo la morte. È probabile che tale culto prose- guisse quello reso a un dio poliade fenicio, analogo a Melkart di Tiro e a Esmun di Sidone, del quale Adon ("Signore") fosse non il nome ma un attributo (S. Ribichini, Adonis, in K. van der TooRN et Aa., eds., Dictionary of Deities and Demons in the Bible, Leiden 1995, coll. 12-17, spec. col. 14; P. Xella, Da Baal di Ugarit agli dei fenici. Una questione di vita о di morte, in Id., ed., Quando un dio muore. Morti e assenze divine nelle antichi tradizioni mediterranee, Verona 2001, pp. 73-114, spec. pp. 84 s.).
(74) Sugli dei che muoiono e risorgono nel pantheon renicio, e la loro connessione con la regalità, si veda Xella, art. cit.. Nell'area siro-palestinese esiste una tradizione di culto dei sovrani defunti ambientato nel "giardino": il più antico documento in proposito viene da Ebla (III mill. a.C; vd. Ribichini, Adonis. Aspetti ..., cit., pp. 104-106, e i testi ivi citati; С Grottanelli, Da Myrrha alla mirra: Adonis e il profumo dei re siriani, in «Adonis. Relazioni del colloquio di Roma 22-23 maggio 1981» (Collezione di Studi Fenici, 18), Roma 1984, pp. 35-60, spec. pp. 36 s.).
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
I "BAMBINI SEMINATI": CONNOTATI OSIRIANI DI UNA LEGGENDA EBRAICA 367
futuro re Messia, come nel celebre esempio di Isaia 11,1.10 (75). Secondo i commentatori nella Bibbia ebraica ci sarebbero inoltre due menzioni (o allusioni) ai giardini di Adone nei testi profetici, Isaia 17,9-11 (76) e Isaia 15 (77). Tuttavia nelle fonti in nostro possesso i giardini di Adone hanno costantemente un significato opposto a quello dell'Osiride germogliante, sono considerati un simbolo di morte e di caducità, opposto all'agricol- tura utile incarnata da Demetra (78). Si aggiunga che nelle stesse feste di Adone a Biblo e ad Alessandria si sono riconosciuti elementi di influenza egiziana rispetto alle adonie ateniesi (79). Ora, le allusioni che si ritiene di individuare nei testi profetici della Bibbia ebraica rimandano alla stessa interpretazione negativa del rito data nel mondo greco, incentrate come sono non sulla nascita dei germogli ma sulT inaridimento degli stessi come segno di morte e di lutto (80): la coincidenza è sospetta e indurrebbe a datare queste allusioni, se tali sono, al periodo ellenistico (81). Allo stato attuale della documentazione, il significato di rinascita e continuità gene- razionale del rito osiriano risulta assai più vicino sia alla funzione del rito del parpisà che al ruolo della leggenda dei "bambini seminati" all'interno
(75) Nel v. 1 il futuro re Messia è detto hòter "ramo" e nèser "germoglio, pollone", nel v. 10 sòres "radice"; si veda anche Zacearía 6,9-15, in cui un personaggio su cui è posta una corona è chiamato semah "germoglio" (si veda Garbini, // ritorno ..., cit., p. 151; cf. anche 3,8-10; Geremia 23,5; 33,15).
(76) Si veda l'art, cit. di M. Delchor, che riporta i nomi di molti commentatori dello stesso parere.
(77) C. Bonnet, Echos d un rituel de type adonidien dans I oracle contre Moab d Isaïe (Isaïe 15), «St. Ep. Ling.» 4 (1987), pp. 101-119; la sequenza di paralleli tra il testo biblico e alcuni elementi delle Adonie di Biblo è senza dubbio impressionante, ma resta il fatto che il rito al centro dell'ipotesi dell 'A., cioè i giardini di Adone, proprio a Biblo non è documentato.
(78) Platone, Fedro 267B ; si veda M. Détienne, Les Jardins d'Adonis. La mythologie des aromates en Grèce, Paris 1972, pp. 191-205; B. Servais-Soyez, Lits ď Osiris et jardins d'Adonis. Une questione de vie, ou de mort, in A. Theodorides et Aa. (éds.), Vie et survie dans les civilisations orientales (Acta Or. Belg., 3), Leuven 1983, pp. 219-226; Koemoth, op. cit., pp. 48-51 (l'A. porta l'esempio della lattuga, da lui discusso alle pp. 39-41, che ha significato inverso nei due riti, e ipotizza che nel contesto orientale originario i giardini di Adone potes- sero avere un significato positivo, analogo all'Osiride germogliante, senza poter citare alcuna testimonianza in tal senso).
(79) B. Soyez, op. cit., passim; Ribichdnti, Adonis. Aspetti ..., cit., pp. 176-181. (80) Delchor, op. cit., pp. 391-394; Bonnet, op. cit., p. 110. (81) La stessa obiezione e valida per 1 analogia che Delchor (op. cit., pp. 377-378) vede
in un passo del poema ugaritico di Baal, nel quale (nell' interpretazione dell'A.) El si pone in testa delle piante disseccate in segno di lutto.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
368 CATERINA MORO
del ciclo narrativo su Mosè (82). Merita approfondimenti futuri la ricerca di tracce di un contatto più remoto di quello qui proposto tra il rito osiriano e la religione d'Israele.
Roma Caterina Moro
(82) Una conferma indiretta a quanto qui affermato è il nesso con il rito cattolico dei cosiddetti "Sepolcri", ovvero l'esposizione dell'Eucarestia tra giovedì e venerdì santo, che merita di essere ulteriormente indagato. Il grano che adorna i 'Sepolcri' è "grano bianco" per- ché fatto germogliare in luogo buio. Questo elemento ci riporta, più che ai Giardini di Adone, all'idea egiziana del germogliare di Osiride nell'Aldilà, quindi non all'idea di lutto ma di vita che continua, pur in uno stato di temporanea latenza - stato sottolineato nel triduo pasquale dall'assenza di riti sacrificali nel venerdì e sabato santo.
This content downloaded from 185.44.78.129 on Sun, 15 Jun 2014 08:26:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions