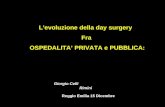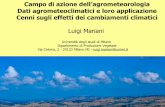L'accordo di synoikia fra Orcomeno ed Euaimon (IPArk 15)
Click here to load reader
Transcript of L'accordo di synoikia fra Orcomeno ed Euaimon (IPArk 15)

Miszellen
L'accordo di synoikia fra Orcomeno ed Euaimon (IPArk 15)*)
Il volume è un primo passo verso l'attuazione di un progetto scientifico di decisiva importanza per l'avvenire della giusgrecistica, un progetto delineato una quindicina d'anni fa dal compianto H. J . Wolff, il massimo fautore della rinascita di questo set-tore degli studi antichistici nel secondo dopoguerra. Wolff auspicava la redazione di un repertorio delle iscrizioni giuridiche greche, da cui avrebbero dovuto scaturire rac-colte tematiche ("Sachcorpora") divise per regioni. Le IPArk costituiscono la prima di tali raccolte tematiche. Essa è dedicata a una regione relativamente marginale del mondo greco, che però annovera un certo numero di iscrizioni rilevanti per la conos-cenza del diritto greco nel suo complesso. Il volume in esame è importante anche per-ché costituisce un riuscito esempio di lavoro interdisciplinare : esso è infatti il risultato della felice collaborazione fra uno storico del diritto e un epigrafista. A p. XIII della prefazione leggiamo in che modo si sono divisi il lavoro : la lettura, la traduzione e le annotazioni di carattere storico si devono a H. Taeuber, il commento giuridico a G. Thür ; nei rari casi in cui le loro opinioni non conicidono, si trova fra parentesi la seg-nalazione (Th. o Taeu.). In ogni caso entrambi i collaboratori si assumono la respons-abilità del volume nel suo complesso.
Il volume consta di una "Prefazione" ("Vorwort"), una bibliografia (aggiornata al 1992), 53 iscrizioni (testo greco con apparato critico e bibliografia specifica, tradu-zione munita di copiose note illustrative, commento storico-giuridico), indice delle parole greche, indice delle cose notevoli e l i fotografie.
Per conoscere i criteri con cui è stato impostato il lavoro, è necessario leggere innanzi tutto la sintetica esposizione del metodo e dei risultati che leggiamo nel "Vor-wort". Là dove il contenuto dell'iscrizione lo permette, il commento segue una griglia espositiva articolata in tre gangli principali : 1) organizzazione dell'organo giudicante, caratteristiche delle procedure adottate, posizione delle parti in causa ; 2) svolgimento della procedura: atti introduttivi, fase istruttoria e dibattimentale, procedure probato-rie, sentenza; 3) eventuali sanzioni irrogate (p. XI)
A questo proposito gli aa. ritengono opportuno aggiungere subito un'avvertenza: anche se il criterio di selezione dei documenti contenuti nella raccolta intende privi-legiare i testi che meglio contribuiscono alla nostra conoscenza del processo greco, non c 'è nessun testo che non implichi anche questioni di diritto sostanziale. Nel caso dell'Arcadia, comunque, il numero di iscrizioni di rilevanza giuridica è così ridotto da
*) A proposito di G e r h a r d T h ü r / H a n s T a e u b e r , Prozeßrechtliche Inschriften der griechischen Poleis : Arkadien (= S B Öst. Ak. Wiss., ph.-h. Kl. 607), Verl. Öst. Ak. Wiss., Wien 1994, XXIV, 363 S„ 11 Taf.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 9/19/13 1:04 PM

A. Maffi, Synoikia fra Orcomeno ed Euaimon 395
consigliare una selezione basata su criteri piuttosto estensivi, fermo restando che in altri casi, come ad esempio l'Attica, la selezione di testi di interesse prettamente pro-cessualistico potrebbe richiedere l'applicazione di criteri molto più restrittivi. La pro-grammata elasticità di questi criteri può lasciare forse insoddisfatti su un piano teorico, ma è ampiamente giustificata dalla necessità di raggiungere un risultato che in questo volume si rivela comunque utile e positivo.
La necessità di tenere conto del contesto più ampio, in cui le iscrizioni vanno stu-diate e comprese, ha indotto gli aa. a pubblicare i testi nella loro stesura integrale (salvo eccezioni, come il n. 35). Tuttavia questioni storiche e questioni giuridiche di ordine non strettamente processualistico sono state per lo più trattate nelle note alla tradu-zione ; in qualche caso si è ritenuto opportuno premettere al commento vero e proprio una "Vorbemerkung" (v. per es. il η. 15). In ogni caso queste annotazioni, per così dire marginali respetto allo scopo primario che la raccolta si propone, soddisfano piena-mente le esigenze di inquadramento storico e contribuiscono ad una migliore com-prensione del commento strettamente processualistico. IPArk si pone dunque come una tappa fondamentale verso la futura elaborazione di una sintesi delle nostre conos-cenze sul processo greco. Si tratta d'altronde di un obiettivo che lo stesso Thür ha presentato nelle sue linee generali in un importante articolo del 19871)·
Fra i documenti presentati2) vi sono alcuni testi celebri : i depositi bancari di Xout-hias (n. 1) ; il contratto di appalto relativo agli edifici sacri di Tegea (n. 3) ; la legge che regola il rientro degli esuli a Tegea nel 324 a. C. (n. 5) ; il giudizio di Mantinea (n. 8), alla cui interpretazione Thür ha già fornito contributi fondamentali, qui ripresi e aggi-ornati ; il trattato di assistenza giudiziaria fra Stinfalo e una città vicina, per lungo tempo identificata con Aigeira, che ora si rivela essere Sicione sotto il nome di De-metriade, assunto in onore di Demetrio Poliorcete (n. 17). Grazie al paziente studio della stele, condotto da Taeuber, è stato così possible non solo identificare esattamente le città contraenti ma anche datare con buona approssimazione l'epigrafe, dato che Sicione si chiamò Demetriade solo per un breve periodo di tempo (probabilmente fra il 303 e il 300 a. C.) ; e per di più vengono anche pubblicate per la prima volta le rr. 102-130 e 187-200 dell'iscrizione. Il trattato fra Stinfalo e Demetriade, che occupa più di cento pagine del volume, si pone dunque come il testo più affascinante e più approfonditamente studiato della raccolta. Poiché mi riprometto di pubblicare altrove un'analisi critica dell'interpretazione che gli aa. ne propongono, prenderò qui in con-siderazione un altro testo di grande interesse per la conoscenza dei rapporti fra le poleis: l'accordo di synoikia fra Orcomeno d'Arcadia e la piccola città di Euaimon (n. 15) (360-350 a. C.), a cui gli aa. dedicano un commento piuttosto ampio (p. 130-152).
L'interesse di questa epigrafe non risiede tanto nell'opportunità di accrescere le nostre conoscenze su queste due oscure città, quanto nella possibilità di confrontare i dati forniti dall'iscrizione con i contenuti tipici degli accordi di synoikia.
') G. T h ü r , Neuere Untersuchungen zum Prozeßrecht der griechischen Poleis, For-men des Urteils, Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages, Frankfurt a. M. 1987, p. 467-484.
2) Qualche perplessità iniziale suscita nel lettore l'ordine in cui le iscrizioni si suc-cedono, e che non mi pare venga illustrato nel Vorwort. In realtà le iscrizioni sono ripartite per zone geografiche, e soltanto all'interno di queste sono poste in ordine cronologico.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 9/19/13 1:04 PM

396 Miszellen
Riporto qui la traduzione dell'iscrizione proposta dagli aa. (IPArk, pp. 131-134).
„Göttin! Gutes Glück! (§1) Synoikia (soll sein) den Euaimniern mit den Orcho-meniern unter völliger Gleichheit der Rechte. (§ 2) Die Kulthandlungen sollen dort immer, wie es üblich ist, monatlich vollzogen werden. - (§ 3) (Sinngemäß etwa: Die Euaimnier sollen Grundstücke im Tempelland erhalten;) die früheren Einwohner (dieses Gebiets) sollen Anteil am Tempelland erhalten, so wie es beide (Poleis) be-schlossen haben. (§ 4) Wenn ein Grundstück der (Siedler) unter Chairiadas im Tem-pelland umstritten ist, sollen die Heraier die Diadikasia (darüber) sowie alle Prozesse entscheiden, die das Vorverfahren durchlaufen haben ; Entsendungen (von Prozessen) sollen drei Jahre hindurch stattfinden gemäß der Anordnung der Arkader. (§ 5) Die öffentlichen Schulden sollen beide (Poleis) gemeinsam tragen. Urkundenaufzeich-nungen (darüber) sollen sie abfassen und hinterlegen, wo immer es beide beschließen. (§ 6) Den (Siedlern) unter Chairiadas sollen sie selbst bezüglich der Schulden, die diese bei der Göttin haben, nach Beratung eine Frist für die Rückzahlung setzen. (§ 7) Und ebenso (soll man verfahren) bezüglich der Pachtzahlung für das Land, das Mna-siteles verpachtet hat. (§ 8) Wenn jemand eine Fremde geheiratet hat, sollen die Kin-der und die Frauen Orchomenier sein. (§ 9) Alle Schwurzeremonien (sollen) künftig immer unverändert (in Gebrauch bleiben) ; man soll niemanden (davon) ausschließen, aber auch nicht zwingen. (§ 10) Diejenigen Prozesse, welche fremde (Richter) ent-schieden haben, sowohl in Euaimon als auch in Orchomenos, - das Vermögen (in) jeder der beiden (Städte?). Die (Vertreter) der Euaimnier leisteten folgenden Eid: Ich werde die Synoikia mit den Orchomeniern gemäß den Vereinbarungen getreulich hal-ten, bei Zeus Ares, bei Athena Areia und bei Enyalios Ares, und ich werde niemals wegziehen von den Orchomeniern, bei Zeus Ares, bei Athena Areia und bei Enyalios Ares. Und dem, der wahr schwört, soll es wohl ergehen; der, der falsch schwört, soll samt seinem Geschlecht zugrunde gehen. Die Orchomenier leisteten folgenden Eid: Ich werde die Synoikia mit den Euaimniern gemäß den Vereinbarungen getreulich hal-ten, bei Zeus Ares, bei Athena Area und bei Euyalios Ares, und ich werde niemals die Euaimnier vertreiben, bei Zeus Ares, bei Athena Area und bei Enyalios Ares. Und dem, der wahr schwört, soll es wohl ergehen ; der der falsch schwört, solll samt seinem Geschlecht zugrundegehen. Aristanor, Onomantos, Laeas, Saokles - oder wenn er ab-wesend ist, soll (die Sache) wieder vor Gericht gebracht werden (?)".
Riporto ora il brano con cui gli aa. tracciano le linee fondamentali dell'interpreta-zione da essi proposta : „Die Inschrift regelt somit in den zusammenhängenden §§ 3 -7 und vielleicht in § 10 (als Nachtrag) die Rechtsbeziehungen, die sich zwischen dem Heiligtum der Göttin (Z. 34) und den beiden neu vereinigten Poleis ergeben : Neu-verpachtung von Tempelland im Rahmen einer Gesamtrevision und hieraus ent-stehende Prozesse, frühere Schulden beider Poleis (beim Heiligtum?), Darlehen aus dem Tempelschatz als Startkapital für die neue Pächter, Stundung älterer Pachtschul-den beim Heiligtum und schließlich die Rechtskraft von (in derartigen Streitigkeiten?) bereits entschiedenen Prozessen. Unmittelbar sakralen Charakter, etwa wegen be-stimmter, an einzelne Familien gebundener Kulte, kann man den Epigamievorschrif-ten (§ 8) zusprechen ; bei den Eidesformalien (§9 ...) und dem Fortbestehen der Kulte (§ 2) liegt das auf der Hand" (p. 142-143).
Il pregio di questa interpretazione consiste indubbiamente nell'ispirazione unitaria che riscontra nel testo: l'elemento unificatore è il tempio, che fa da cerniera fra le due comunità; tutto l'accordo si impernia sulla regolamentazione dei rapporti con il tem-pio. Qui vorrei proporre un'altra chiave di lettura unitaria, alternativa a quella proposta dagli aa.
Prima di tutto ritengo che il testo debba essere considerato come l'atto conclusivo di una complessa trattativa, che si è probabilmente già tradotta in precedenti atti for-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 9/19/13 1:04 PM

A. Maffi , Synoikia fra Orcomeno ed Euaimon 397
mali3). Aggiungo che il risultato scaturito dalla trattativa sembra imprimere una svolta e una soluzione nuova e definitiva a questioni che costituivano in apparenza quello che potremmo definire un contenzioso aperto. Questa volontà di sistemare questioni aperte emerge secondo me in modo evidente nei §§ 3 , 6 , 7 , 8 ,10 . Si tratta dunque: a) di com-prendere quali siano le questioni che vengono risolte nel l 'ambito della convenzione di synoikia ( e che riguardano la popolazione di entrambe le città, o almeno buona parte di essa) ; b) di ricostruire la cronologia relativa alle situazioni passate, presenti e future, a cui l 'accordo fa riferimento.
Espongo subito qual 'è il mio punto di vista riguardo a entrambe le questioni. Come ha ben osservato Moggi, nel suo commento all 'iscrizione4), la convenzione presenta alcuni aspetti del tutto anomali rispetto al normale contenuto di un accordo sinecistico, come, ad esempio, "la sopravvivenza di Euaimon e l 'assegnazione di terre agli Euaimnì nel territorio di Orcomeno" (p. 285).
Secondo me il carattere anomalo di molte clausole del testo si spiega con il fatto che nell 'accordo complessivo fra le due città confluiscono in realtà due operazioni diverse, entrambe attuate sotto l 'egida di Orcomeno : la prima è l 'a t to che sanziona il ritorno di esuli nella loro patria Euaimon ; la seconda è la vera e propria synoikia f ra le due città, che assume però l 'aspetto di un' incorporazione degli abitanti di Euaimon nella cittadi-nanza di Orcomeno. Le condizioni in base a cui deve aver luogo la seconda operazione, cioè la synoikia, non sono esplicitamente formulate nel testo dell 'epigrafe. Io ritengo infatti che nessuna delle clausole che leggiamo abbia un carattere programmatico con-cernente i futuri rapporti fra le due cittadinanze (se non in quanto conseguenza di una decisione riguardante il passato o il presente). Tutte le clausole riguardano invece le condizioni in base a cui si ristabilirà l 'unità della comunità degli abitanti di Euaimon nell 'ambito della nuova cittadinanza di Orcomeno. Dunque tutte le clausole che non menzionano il nome di una delle due comunità, o di entrambe, devono intendersi rife-rite agli Euaimnioi. D'al t ronde ciò è implicitamente ammesso, sia pure con riferimento a singole clausole, dagli stessi aa. Ad es. il § 9, come vedremo, viene riferito dagli aa. alla libertà di scegliere la formula del giuramento da parte degli Euaimnioi.
Espongo gli elementi che mi inducono a proporre l ' interpretazione testé enunciata. Prima di tutto osservo che, dopo il § 2 e fino al § 10, non c ' è più alcun riferimento es-plicito alla parte a cui le clausole dovrebbero applicarsi : si parla di "entrambe le parti", ma senza ulteriori specificazioni. Un riferimento indiretto a un soggetto collettivo in-determinato è dato per due volte dall 'espressione οίεπί Xaiqiáóai (§ 4 e § 6) : secondo l ' interpretazione dominante, che risale a Plassart, si tratterebbe di un magistrato epo-nimo di Orcomeno, e precisamente del magistrato attraverso cui si identifica l 'anno in corso all 'atto della conclusione dell 'accordo fra le due comunità. In realtà non c ' è nes-sun elemento esplicito a favore di questa identificazione. Poiché entrambe le clausole, in cui si trova il riferimento a Chairiadas, secondo gli aa. riguardano i "Siedler" pro-venienti da Euaimon "unter Chairiadas" (da identificare con un magistrato di Orco-meno), ci si aspetterebbe che essi venissero indicati con il lore etnico, gli Euaimnioi, come avviene alle rr. 2 - 3 e 5 4 - 5 5 . In ogni caso i §§ 4 e 6 non contengono regole re-
3) Una traccia, riconosciuta dallo stesso Thür, si ha nella formula κατάπερ εόοξε άμψοτέροις delle rr. 13-15 .
) M. M o g g i , I sinecismi interstatali greci, I. Dalle origini al 338 a. C., Pisa 1967, n. 43.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 9/19/13 1:04 PM

398 Miszellen
ciprocamente valide e applicabili sia agli abitanti di Euaimon che a quelli di Orco-meno, come dovrebbe accadere in un accordo di synoikia.
A me sembra dunque più probabile che i §§ 4 e 6 si riferiscano a questioni interne agli Euaimnioi, e che Chairiadas sia un magistrato eponimo, o comunque un cittadino, di Euaimon. Si tratta dunque di disposizioni destinate a regolare i rapporti tra le due fazioni di Euaimon, che vengono recepite nel quadro di quello che appare formalmente come un accordo fra Euaimon e Orcomeno.
Se si prova ad estendere anche alle altre clausole il criterio di interpretazione dei §§ 4 e 6, il passo ulteriore sarà quello di riconoscere nel ripetuto ricorso al termine αμφότεροι, che ricorre più di una volta (una volta nel § 3, due volte nel § 5), un riferi-mento non alle due città contraenti (Orcomeno ed Euaimon), ma ai due gruppi prota-gonisti della stasis all'interno della comunità degli Euaimnioi. Il presupposto da cui parto è infatti che a Euaimon vi sia stata in passato una stasis, a seguito della quale la fazione soccombente aveva dovuto abbandonare la città. Poco tempo prima di con-cludere la synoikia tra Euaimon e Orcomeno è stato raggiunto un accordo tra le due fazioni sotto l'egida di Orcomeno (che aveva probabilmente appoggiato la fazione a suo tempo vittoriosa) : in seguito a tale accordo la fazione soccombente ha potuto rientrare in patria. All'accordo tra le due fazioni si sovrappone ora l'incorporazione della riunificata comunità di Euaimon nelle cittadinanza di Orcomeno ; ma il testo stesso dell'iscrizione, che si presenta formalmente come un trattato fra le due città, appare destinato soprattutto a confermare (e probabilmente a perfezionare) numerosi aspetti dell'accordo tra le fazioni di Euaimon.
Nel senso dell'interpretazione da me proposta mi pare deponga il diverso compor-tamento a cui si vincolano mediante il giuramento finale i cittadini di Euaimon e quelli di Orcomeno: i primi si obbligano pronunciando le parole ονδ' άνισταίμαν ("ich werde niemals wegziehen von den Orchomeniern"); i secondi giurano ούό' έξελαν-νοια ("ich werde niemals die Euaimnier vertreiben"). Questa singolare disparità negli obblighi assunti dalle parti contraenti è stata interpretata da Piccirilli nel senso rispet-tivamente di "allontanarsi e cacciare dalla synoikia"5) ; si tratterebbe quindi di obblighi da intendere in senso giuridico e non fisico, dato che in apparenza i due nuclei urbani sono destinati a permanere entrambi. Gli aa., che sembrano invece propendere per un effettivo trasferimento ad Orcomeno degli Euaimnioi (p. 142), non prendono posi-zione su questo punto. In ogni caso anche gli aa. concordano con la dottrina dominante nell'affermare che la synoikia fra le due comunità avviene solo apparentemente su un piano di parità (a cui sembrerebbe alludere la formula corrente επί τοις ϊσοις και τοις όμοίοις del § 1) ; in realtà Orcomeno ingloba Euaimon (anche gli aa. parlano di "Ein-gliederung": p. 135).
Ma se le cose stanno così, cioè se il trattato manifesta un intento "imperialistico" da parte di Orcomeno (forse con l'intento di controbilanciare l'espansione di Mega-lopoli6), per quale motivo gli Orcomenii dovrebbero giurare di "non scacciare" gli Euaimnioi ? In questa prospettiva scacciare gli Euaimnioi significherebbe da parte di Orcomeno rinunciare all'accrescimento di potere conseguito.
5) L. P icc i r i l l i , Gli arbitrati interstatali greci, I, Dalle origini al 338 a. C., Pisa 1973, p. 201.
6) L'ipotesi, che risale a Plassart, è ritenuta ancora la più probabile da parte degli aa. (p. 139)
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 9/19/13 1:04 PM

A. Maffi, Synoikia fra Orcomeno ed Euaimon 399
Mi pare dunque più convincente interpretare l'obbligo assunto dagli Orcomenii alla luce dell'ipotesi sopra formulata. Ritengo cioè che in sostanza gli Orcomenii si im-pegnino a recepire pienamente l'accordo di pacificazione tra le fazioni di Euaimon, obbligandosi a non espellere i membri della fazione avversa a quella da essi stessi appoggiata. A loro volta gli Euaimnioi si impegnano non tanto a non abbandonare la synoikia, cosa che difficilmente potrebbero fare per vie legali, quanto a non sollevarsi contro gli Orcomenii, rinfocolando la stasis.
Che vi sia stato un accordo tra due fazioni di Euaimon mi pare attestato anche dal § 3. Qui si conferma che i "precedenti abitanti" (τός δε προτέρος Ινοίκος) hanno diritto alla porzione di terra che è stata stabilita da un documento ufficiale (εόοξε) concordato dalle due parti (άμφοτέροις). I precedenti abitanti sono, secondo me, i proprietari di terra che, dopo essere stati scacciati e aver quindi perso le loro proprietà, sono ritor-nati in città rientrando in possesso dei loro immobili, come è comunemente stabilito da questo genere di accordi7). La terra a cui si riferisce questa clausola è indicata con il termine τομώf) (resta oscuro perché non si parli del recupero delle case).
Il § 4 stabilisce la competenza degli Erei per le controversie fra gli attuali posses-sori e quelli dell'epoca di Chairiadas. Io ritengo che il riferimento a Chairiadas sia il dato cronologico mediante il quale si identifica la fazione perdente degli Euaimnioi : potrebbe indicare l'anno in cui suoi membri sono stati scacciati. Probabilmente la com-petenza degli Erei non era prevista dall'accordo (che abbiamo presupposto) tra le due fazioni, ed è stata quindi imposta dalle autorità di Orcomeno. Mi sembra strano, altri-menti, che in un accordo di synoikia anomalo come questo, la città predominante accetti a priori di rinunciare alla competenza dei propri tribunali.
Come spiegare nel contesto della mia interpretazione le δίκαι προδεδικασμίναι ? Se pensiamo che la competenza degli Erei sia una novità introdotta dal trattato di synoi-kia, possiamo supporre che fossero già state intentate delle azioni per il recupero dei terreni in base all'accordo tra le due fazioni di Euaimon, ma che queste azioni non fos-sero andate oltre la fase istruttoria. In questo quadro mi sembrerebbe plausibile l'in-terpretazione, proposta da Thür, del termine προδεδικασμίναι nel senso di azioni che non hanno superato la fase istruttoria9). Mi sembra invece meno verosimile il senso che Thür attribuisce a questi processi nel contesto della intepretazione globale dell'epi-grafe proposta dagli aa. : egli ritiene infatti che i processi relativi ad eventuali future controversie fondiarie prevedano un'istruttoria da condurre in loco e una fase decisio-nale che si svolgerebbe ad Erea. Ora, a parte il fatto che il participio perfetto
7) La notevole mole di argomenti e di paralleli (p. 144-148), con cui Thür cerca di dimostrare che si tratta di una revisione dei titoli di possesso della terra del tempio, non mi ha convinto.
8) Gli aa. ritengono che questo termine non indichi genericamente una zona suddi-visa in lotti, ma sia equivalente a τέμενος (Tempelland). Anche accettando questo sig-nificato, è singolare che l'iscrizione non fornisca elementi per una identificazione più precisa. A questo proposito sono possibili due ipotesi. O il τέμενος apparteneva al san-tuario di Artemide Mesopolitis, in prossimità del quale è stata trovata l'epigrafe; oppure il τέμενος si trovavo sul confine dei territori delle due città. In entrambi i casi non occorrevano dati più precisi per l'identificazione. Naturalmente lo stesso pro-blema sussiste anche se assumiamo rομάς nel senso laico di territorio diviso in lotti.
9) In alternativa si potrebbe pensare a una disposizione che consenta la revisione di tutte le sentenze in materia di controversie territoriali intervenute durante il periodo di esilio della fazione soccombente e riguardanti i terreni della rομάς che devono essere loro restituiti.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 9/19/13 1:04 PM

400 Miszellen
προόεόικασμίναι sembra riferirsi soltanto al passato, mi sembra una soluzione troppo macchinosa e sostanzialmente ispirata all'interpretazione, da parte dello stesso Thür, di una clausola apparentemente analoga contenuta nel trattato tra Stinfalo e Deme-triade (si veda un esplicito riferimento a p. 150). Istituire una simile analogia, al di là della questione specifica, apre un problema di vasta portata (che però non è possibile discutere qui) : esistono delle "Denkformen" peculiari alla cultura giuridica arcadica, che la differenziano da quella di altre regioni ?
Le rr. 22-25 sono ricomprese dagli aa. nel § 4. A ben guardare, però, le rr. 22-25 sono collegate alle rr. 25-28 da un και (integrato ma sicuro). Se osserviamo il resto dell'iscrizione, constatiamo che le altre due uniche proposizioni collegate con un και (cioè le rr. 32-37 e le rr. 37-40) sono sicuramente connesse logicamente dalla pres-crizione che chiude la seconda, cioè κά ταντά. Se ora ritorniamo alle rr. 22-28, con-statiamo che la traduzione degli aa. non tiene conto del και (come non ne tengono conto le traduzioni di Piccirilli e di Moggi). A questo punto vediamo come sono state interpretate le due proposizioni in cui si articolano le rr. 22-28.
Le πομπαί di cui si parla nella prima proposizione sono state messe in relazione dagli aa. con le δίκαι προόεόικασμίναι. Piccirilli e Moggi pensano a missioni di giu-dici erei ad Orcomeno10) ; gli aa. ritengono invece che si alluda all'invio ad Erea della documentazione scritta relativa alle risultanze dell'istruttoria condotta in loco.
Un punto particolarmente oscuro nell'interpretazione di questa frase è il ruolo svolto dalle decisioni degli Arcadi. Secondo gli aa. "den Auftrag zur Entsendung der Prozesse nach Heraia soll das zuständige Organ des Arkaderbundes erteilen" (p. 135). E a p. 149 si aggiunge che l'invio di più cause, a intervalli stabiliti dal koinon arca-dico, consentiva di risparmiare sui costi. Mi chiedo: se si fosse trattato solo di rispar-miare, c'era bisogno di scomodare gli organi federali (con un inevitabile appesanti-mento e ritardo dei processi) ? Non bastava una decisione delle autorità locali ? Mi sembra quindi più verosimile che le deliberazioni degli Arcadi riguardino le modalità secondo cui devono aver luogo le πομπαί·. qualunque cosa siano le πομπαί, esse de-vono conformarsi alle regole stabilite (una volta per tutte) dai decreti del koinon. La mia impressione è che le πομπαί siano degli adempimenti di carattere sacrale (proces-sioni?), che dovranno compiersi per tre anni fuori dall'ambito cittadino visto il riferimento ai decreti federali.
Se poi è vero che il και della r. 25 collega strettamente la proposizione relativa alle πομπαί a quella seguente, ritengo che anche i debiti pubblici (tà χρήα τα όαμόσια), di cui si parla nel § 5, così come le spese per lo svolgimento delle πομπαί, dovranno es-sere sopportati in comune dai due gruppi (άμφοτέρος), cioè dalle due fazioni riunifi-cate degli Euaimnioi. La fazione rientrante dovrà dunque accollarsi la quota dei debiti pubblici della città, anche se contratti durante la loro assenza. Certo, interpretando così questa clausola, il trattato non disporrebbe nulla sui rapporti fra cittadini di Euaimon e cittadini di Orcomeno dopo l'entrata in vigore dell'accordo di synoikia (diversa-mente da quanto accade in altri accordi analoghi, citt. dagli aa. a p. 136 n. 11). D'altra parte mi pare difficile interpretare le rr. 25-31 come un riferimento alla messa in co-mune dei debiti pubblici di Euaimon e di Orcomeno. Se è vero, infatti, che gli Orco-
l0) Riporto qui la traduzione di Moggi (sostanzialmente analoga a quella di Picci-rilli) : "Missioni (di giudici) avranno luogo per tre anni, secondo la decisione degli Arcadi" (p. 275).
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 9/19/13 1:04 PM

A. Maffi, Synoikia fra Orcomeno ed Euaimon 401
menii intendevano rendere appetibile ("schmackhaft": p. 139) per gli Euaimnioi la synoikia, imporre a questi ultimi di contribuire al pagamento dei propri debiti sarebbe stato controproducente, a meno che i debiti pubblici degli Orcomenii, in rapporto al numero dei cittadini, fossero stati inferiori a quelli degli Euaimnioi.
Secondo gli aa. la clausola successiva (rr. 28 -31) si spiega con il fatto che il muta-mento intervenuto nella parte debitrice rende necessario redigere nuovi contratti con i creditori. Perciò traducono: "Urkundenaufzeichnungen (darüber) sollen sie abfassen und hinterlegen, wo immer es beide beschließen". Conformemente all'opinione che propongo, io ritengo invece che si tratti di rendere pubblico il contenuto definitivo dell'accordo tra le due fazioni così come sanzionato dal trattato con Orcomeno; e poiché l'affissione deve avvenire a Euaimon, saranno i rappresentanti delle due fazioni a decidere dove è opportuno esporlo. Se si trattasse di rendere pubblica la novazione dei debiti pubblici, come ritengono gli aa., lo si farebbe nei luoghi deputati a rendere noti i documenti pubblici in entrambe le città : che bisogno ci sarebbe per questo adem-pimento di carattere meramente amministrativo di uno specifico accordo (a cui allude Υ άμφοτέροις di r. 31) ?
Passiamo così al § 6 (rr. 32 ss.). Ritorna qui il gruppo identificato mediante il rife-rimento a Chairiadas: si tratta di debiti verso la divinità; dunque, a quanto sembra, di un prestito. Anche in questo caso ritengo che la clausola si riferisca al passato. La fazione soccombente, prima di essere scacciata, aveva contratto un prestito con il tem-pio, che nel frattempo era probabilmente scaduto (o era molto vicino alla scadenza). Date le circostanze, il gruppo degli esuli, da poco rientrato in patria, non era in grado di rispettare la scadenza. Perciò si stabilisce che l'insieme degli Euaimnioi approvi una dilazione di pagamento.
Un criterio di interpretazione analogo si applica, secondo me, alle terre date in affìtto da Mnasitele (§ 7). Non credo che si tratti di affitto delle terre del tempio (non conosco alcun parallelo in cui per alludere a un tale affitto si faccia riferimento solo al nome del sacerdote). Se vale l'analogia desumibile dal κά ταύτα, si potrebbe trattare di un membro influente della fazione soccombente, che, al momento della fuga, aveva dato in affitto un cospicuo numero di terreni. Durante tutto il periodo in cui Mnasitele è stato assente gli affittuari non hanno pagato gli affitti. Al suo ritorno si è dunque ac-cumulato un arretrato così notevole da costringere gli esponenti delle due fazioni a far rientrare la questione nell'accordo che pone fine alla stasis.
Se dunque colleghiamo i §§ 6 e 7 agli accordi tra le due fazioni degli Euaimnioi, possiamo supporre che si tratti di eccezioni al principio che i debiti pubblici di Euai-mon saranno pagati solidalmente dai membri delle due fazioni riunificate. Per questo si è ritenuto opportuno inserirli in questo punto dell'accordo.
La clausola successiva (§ 8: rr. 40-43) , secondo gli aa., va intesa nel senso che il trattato recepisce le convenzioni vigenti ad Euaimon in materia di epigamia. E' sot-tinteso che la clausola non è formulata in termini di reciprocità perché sono gli Euaim-nioi ad essere assorbiti nella cittadinanza di Orcomeno.
Ma nel testo troviamo di nuovo un perfetto (γεγάμηκέ) : dunque non si tratta, se-condo me, di una regola che proietta nel futuro la situazione attuale, cioè che recepisce nel nuovo ordinamento le convenzioni di epigamia vigenti a Euaimon (d'altronde gli aa., così come Piccirilli e Moggi, traducono con un verbo riferito al passato: "gehei-ratet hat"). Ma nello stesso tempo il riferimento al passato non può essere inteso nel senso che Orcomeno voglia sindacare la validità dei matrimoni contratti a Euaimon in
2 6 Zei tschr i f t für Rechtsgesch ich te . CXV. R o m . Abt. Brought to you by | Heinrich Heine Universität Düsseldorf
Authenticated | 134.99.128.41Download Date | 9/19/13 1:04 PM

402 Miszellen
base alle regole ivi vigenti in materia di epigamia. Dobbiamo infatti pensare che tutti i rapporti giuridici stretti da Euaimon vengano recepiti in blocco da Orcomeno. Per-ché proprio in tema di epigamia dovrebbe essere sentita come necessaria un 'esplicita recezione?
In alternativa si potrebbe pensare che questa clausola si proponga di legittimare i matrimoni contratti con una straniera da un cittadino di Euaimon al di fuori delle norme in materia di epigamia. Se così fosse, potremmo dire che si tratta di una misura tendente a rendere "appetibile" per gli Euaimnioi l'incorporazione. In tal modo, nelle aspettative degli Orcomeni, gli Euaimnioi che hanno stretto un'unione illegale con una straniera sarebbero indotti ad appoggiare la synoikia dalla speranza di poter legalizzare la loro unione. Ma un simile punto di vista non sembra plausibile.
Io penso perciò che si tratti ancora una volta di sanare una situazione irregolare de-terminatasi nel passato con riferimento a Euaimon. I matrimoni contratti all'estero dagli esuli di Euaimon vengono riconosciuti in base all'accordo di synoikia indipen-dentemente dalla loro conformità alle convenzioni di epigamia vigenti a Euaimon e nella stessa Orcomeno. Nel futuro, però, si applicheranno le regole in materia vigenti a Orcomeno.
Passiamo ora al § 9. La proposta, formulata anni fa da Taeuber, di intendere δρκια nel senso di "beschworene Verträge" viene qui respinta da Thür con argomenti con-vincenti (p. 137). Thür propone a sua volta (riprendendo un'opinione già espressa in dottrina, per es. da Moggi, p. 281) di collegare direttamente il § 9 al § 2: nel quadro di una complessiva "Kultusfreiheit" concessa agli Euaimnioi, questi avrebbero diritto an-che in futuro di impegnarsi con un giuramento conforme alle loro formule tradizionali.
A me pare che, se riferita genericamente ad eventuali futuri giuramenti che l'intero corpo cittadino potrebbe essere chiamato a pronunciare, questa interpretazione appaia inverosimile. Dovremmo infatti immaginarci dei trattati internazionali in cui, a fronte di un unico giuramento dei cittadini della controparte, troveremmo due giuramenti di-stinti, prestati rispettivamente da ciascuna componente della cittadinanza di Orco-meno. Non solo; ma, per di più, questa opinione è smentita dal testo stesso del trat-tato, dove la formula del giuramento, pronunciato tanto dagli Euaimnioi quanto dagli Orcomenii, è identica.
E ancora ; che cosa significa la precisazione : nessuno sia escluso e nessuno sia cos-tretto (a giurare) ? Se si trattasse di una precisazione destinata a valere nel futuro per la componente della cittadinanza originaria di Euaimon, il privilegio di non essere costretto a giurare darebbe luoga a una conseguenza simile a quella su cui Thür basa la sua critica all'interpretazione di Taeuber. Si potrebbe anche intendere la precisa-zione nel senso che nessun cittadino originario di Euaimon possa essere costretto a pronunciare un giuramento utilizzando la formula degli Orcomenii ; ma, poiché ab-biamo visto che non è verosimile l'uso di due formule diverse da parte dei cittadini della stessa città, occorrerebbe ammettere che un cittadino possa rifiutarsi di giurare. D'altra parte non si vede per quale motivo e in quali circostanze si potrebbe pre-sentare l'altra eventualità prevista dalla clausola, cioè che un cittadino originario di Euaimon venga escluso dal giuramento pur essendo disposto a servirsi della formula degli Orcomenii.
Un'ultima osservazione: Thür ritiene che il § 9 dovrebbe essere collocato imme-diatamente prima delle formule dei giuramenti; perciò ne desume che il § 10 sia "re-daktionell als Zusatz zu betrachten" (p. 137). Il rilievo è convincente; ma costringe a
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 9/19/13 1:04 PM

A. Maffi, Synoikia fra Orcomeno ed Euaimon 4 0 3
supporre un'incoerenza della redazione che può essere evitata intendendo il § 9 in modo diverso.
A me pare che tutte le difficoltà fin qui rilevate scompaiano se riferiamo anche il § 9 alla stasis di Euaimon. La formula del giuramento che vincola i cittadini di Euaimon sarà d'ora in poi la stessa per tutti. Si tratta dunque di una conferma solenne della ri-conciliazione avvenuta: nessuno potrà essere escluso dai giuramenti, conformi alla tradizione, che la cittadinanza riunificata di Euaimon potrà essere ancora chiamata a prestare per ratificare gli accordi attraverso cui si va attuando la riconciliazione tra le fazioni. Nello stesso tempo nessuno potrà essere costretto a prestare simili giuramenti : ciò significa che l'adesione alla riconciliazione è libera. Possiamo ad esempio im-maginare che non tutti i membri di una famiglia esiliata o fuggita intendano aderire all'accordo di riconciliazione: in questo caso la mancata adesione di un membro della famiglia non avrà conseguenze negative per gli altri.
Quanto all'ultima clausola parzialmente leggibile (§ 10) prima delle formule dei giuramenti, non è facile da inserire nel contesto del trattato, se si vuole adottare una chiave di lettura unitaria")· Un dato certo è che, anche in questo caso, la clausola si riferisce a un'attività giudicatrice svolta nel passato da giudici stranieri ad Euaimon. L'andamento della r. 50 sembra rendere inevitabile il riferimento speculare anche all'attività dei giudici stranieri ad Orcomeno. Thür si spinge fino a collegare a quel che precede anche le parole con cui inizia la stele C, intendendo : "[Die Prozesse] ... sol-len endgültig entschieden sein und die Vollstreckung in das Vermögen (λάχος) soll in jeder der beiden Städte gestattet sein" (p. 138). E' possibile; però mi chiedo: che bisogno c'era di affermare un principio che avrebbe dovuto risultare pacifico?
In ogni caso questa sembra essere l'unica clausola del trattato in cui viene espres-samente sancita la condizione di reciprocità fra ciò che è accaduto a Euaimon e ciò che è accaduto a Orcomeno. Tutto il resto, come si è visto, sembra occuparsi esclusiva-mente di sistemare la situazione a Euaimon in vista della synoikia con Orcomeno.
Milano A l b e r t o M a f f i
") Può essere interessante notare che si tratta di una delle clausole che M o g g i ri-tiene non interpretabili : p. 281.
26* Brought to you by | Heinrich Heine Universität Düsseldorf
Authenticated | 134.99.128.41Download Date | 9/19/13 1:04 PM