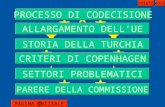La resistenza al fascismo in ItaliaLa seconda finì con l’imporsi, sia pure con lentezza,...
Transcript of La resistenza al fascismo in ItaliaLa seconda finì con l’imporsi, sia pure con lentezza,...

La resistenza al fascismo in Italiadi Guido Quazza
Storiografia e politica, storiografia e interdi- sciplinarità
Il fascismo e la Resistenza armata sono stati in molti paesi al centro del dibattito storiografico del dopoguerra, ma forse in nessun altro luogo come in Italia. Le spiegazioni non sono molto difficili. Esse risiedono in due elementi. Il primo è il fatto che la lotta frontale tra fascismo ed antifascismo è stata in Italia la più antica, la più lunga — dal 1919-20 al 1943-45 —, la più diffusa, e ha coinvolto intensamente e drammaticamente l’uomo intero, nella pienezza della dimensione pubblica e di quella privata. Lo studio di quella lotta non ha potuto perciò a lungo sottrarsi allo sforzo di delineare una storia “totale”, delle strutture, dell’intelligenza, della paura e insieme della speranza.
Il secondo elemento è stato il peso particolarmente forte e costante dell’intreccio tra i condizionamenti politici e la crescita scientifica della storiografia italiana. I primi non potevano mancare in tempi di ricostruzione dell’economia e della cultura del paese in un nuovo clima politico. La seconda finì con l’imporsi, sia pure con lentezza, attraverso un allargamento dei propri orizzonti che si avvalse, dopo l’isolamento culturale fascista, anche delle metodologie e delle problematiche più avanzate proposte dalle grandi scuole francesi e anglosassoni.
A questo intreccio, nei suoi incontri e scontri e nelle sue scansioni cronologiche,
“Italia contemporanea”, marzo 1986,162
intendo guardare affinché l’analisi, purtroppo in questa sede fortemente sommaria, si presenti il più possibile aperta e al tempo stesso articolata. Primo e secondo elemento, infatti, sono entrambi necessari a tentare quella che è, secondo la nota espressione di Pietro Gobetti, una vera e propria “autobiografia della nazione” e, aggiungo, l’esame di coscienza degli italiani, la pietra di paragone fra l’Italia di prima e l’Italia di poi.
L’uso della violenza
Diventa sempre più difficile, anche agli storici più vicini a una rivalutazione del fascismo, negare che il rapporto dell’Italia fascista con l’Italia liberale — il prima — sia ideologicamente nella “cultura della crisi” ma politica- mente nella “paura del rosso”. Lo smarrimento della fede nel progresso, camminando di pari passo con la graduale perdita di egemonia mondiale dell’Europa, si collega col timore che dopo l’occupazione delle fabbriche nell’estate 1920 convince il grande capitale e i più alti dirigenti dello Stato a puntare su un “esercito privato” a servizio d’una “controrivoluzione” capace di aggiogare le masse operaie e bracciantili a un potere centralizzato e autoritario, mirante, sulla base di precedenti impostisi durante il conflitto, a un duro controllo dei movimenti sociali dentro e fuori l’azienda. Il “partito unico della borghesia” usato a questo fine è quello fondato

8 Guido Quazza
il 23 marzo 1919 a Milano da Mussolini, perché si presenta come pronto a usare la più dura e spregiudicata violenza contro le persone che guidano i “rossi” , in nome di una filosofia della crisi che nel suo eterogeneo empirismo sembra idonea a catturare i soggetti sociali più diversi. L’avallo dello Stato, dalla monarchia all’esercito, dalla polizia alla magistratura, offre le armi necessarie per “spedizioni punitive”, mentre l’alta burocrazia si prepara a garantire l’obbedienza con l’apparato della violenza legale in tutto il tessuto delle sue articolazioni esecutive, dal centro alla periferia.
Da ciò la prima, fondamentale constatazione: il fascismo giunge al potere non attraverso un consenso di maggioranza o almeno di larghi strati. Poche migliaia di voti nelle elezioni generali del 1919, meno del 7% in quelle del 1921, una minoranza nell’Italia del Nord ancora nel 1924, quand’è già padrone di tutti gli strumenti coercitivi. In quest’ultimo anno, l’opposizione di Giacomo Matteotti viene stroncata con l’assassinio, quella dell’Aventino con gli inganni e le minacce, complice la viltà del sovrano. Il discorso del 3 gennaio 1925 e lo scioglimento dei partiti non fascisti nel 1926 sono la prova del nove dell’assenza di un sufficiente consenso, del carattere dittatoriale del nuovo regime politico.
Non basta ciò, tuttavia, per caratterizzare la questione, vivacissimamente discussa in Italia negli ultimi vent’anni. Si deve tener presente, come ragione logica di metodo interpretativo, che si può parlare di consenso solo se esso implica l’adesione attiva. Assente o largamente insufficiente prima della conquista totale del potere — che è sempre la fase determinante per poter distinguere i regimi di libertà da quelli di oppressione —, il consenso viene, e sia pure con un sistema complesso di propaganda, estorto dopo. Dall’opportunistico mere in servitium della “palude”, quella parte cioè di popolazione che è mossa da paura dei controlli e da spe
ranza di successi personali e di carriera, l’adesione si allarga costantemente sotto il segno del trasformismo, marchio costante della vita pubblica italiana dal connubio di Cavour del 1852 alla mediazione e corruzione di Depretis e di Giolitti, metodo mai superato di cooptazione nei ceti dirigenti di persone e gruppi disposti ad obbedire alle forze vincitrici del Risorgimento.
La percentuale dei nuovi capi è, in ogni settore della società e dello Stato, assai piccola rispetto al periodo pre 1922. Due fortunate barzellette colgono incisivamente già nel 1925-1926 il nocciolo della questione del rapporto tra il Regime e il prima. Una, circolante nei ceti più popolari, interpreta la sigla del distintivo del partito nazionale fascista (Pnf), che era d’obbligo tenere all’occhiello, come: “per necessità familiari” . La seconda, inventata dal filosofo Giuseppe Tarozzi, suona: ”Un italiano per essere perfetto deve essere intelligente, onesto, fascista. Ma potrà, poiché nessun uomo è perfetto, avere al massimo due di queste doti; se sarà intelligente e fascista, non sarà onesto; se onesto e fascista, non sarà intelligente; se intelligente e onesto, non sarà fascista” .
Le migliaia di sommosse o assalti ai municipi e ai negozi, in testa le donne, del 1930- 1932 non sembrano davvero un documento di consenso, né sono credibili le immagini di propaganda prodotte dai giornali “Luce”, dai documentari filmici, dalle pellicole cinematografiche di quegli anni, oppure le canzoni e gli slogan che la neonata radio divulga sotto precisi ordini di Roma. Contro le prime apparenze, anche i negoziati tra Pio XI e Mussolini sfociati nella “Conciliazione” del 1929 sono più il risultato d’un accordo tra potenze sul do ut des che il preludio ad un vero consenso fra regime e cattolici. Lo dimostrano non soltanto gli scontri tra le organizzazioni fasciste e quelle ecclesiastiche, ma anche i dissensi, raramente espressi a luce piena ma ampiamente diffusi nell’interno del mondo cattolico, nel quale non sono pochi

La resistenza al fascismo in Italia 9
coloro che si raccolgono nelle sedi religiose per prepararsi a un’alternativa di coscienza ispirata agli insegnamenti del Vangelo anziché alle direttive del potere vaticano.
Dopo le “spedizioni punitive” delle squad ra le , dopo attenta azione repressiva della polizia e della magistratura — eccezionale, ordinaria e del lavoro —, ancora negli anni trenta la sottomissione non è consolidata. Certo non è facile, a chi non ricordi personalmente il clima del tempo, documentarsi con l’eloquenza delle cifre. È bene tuttavia non dimenticare che, se la storiografia antifascista del 1945-1965 esagerò nel considerare il popolo italiano come attivo, sia pure in forme clandestine, nel fronteggiare la dittatura, ancor più oggi nuclei di storici non solo di destra ma moderati, affiancati da scrittori di sinistra, sbagliano nel presentare il secondo decennio come “anni del consenso”. Anche qui dovrebbe essere necessario ricordare che per storici non di parte il primo dovere — elementare metodologicamente — è di non fermarsi alla rappresentazione di sé che dà il Regime, e di utilizzare tutte le fonti, da qualsiasi parte vengano, per confrontarle e, vagliate con dubbio metodico, ricomporle in un quadro costruito onestamente. Da esse si ricava senz’ombra di dubbio che, in un regime nel quale il controllo repressivo è attentissimo, non la speranza, ma la paura domina i più. Gli attivi (i gerarchi di vario grado e i militanti medi e bassi) non superano i 150.000, tanti quanti gli antifascisti perseguitati (dei quali oltre 5.000 ricevettero condanne per 25.000 anni di carcere, 10.000 furono confinati). Mentre quasi un milione di operai e contadini e migliaia di intellettuali, studenti, funzionari emigrarono, i più per sottrarsi già nei primi anni alle violenze inferte alle loro persone, ai parenti, alle case. Di contro, ben 130.000, proprio negli anni proclamati come gli “anni del consenso” , all’indomani della guerra etiopica, si iscrissero in Francia alla Cgt, l’organizzazione sindacale guidata dai comunisti, e non pochi di essi furono di
retto veicolo di antifascismo, venendo in Italia durante le ferie, e portandovi notizie degli aumenti salariali, della settimana di 40 ore, dei 15 giorni feriali per anno, ottenuti in un paese colpito dagli anatemi della propaganda di Roma. Per non parlare della crescente defezione del clero dopo l’alleanza del 1936 con la Germania nazista e — spinta decisiva — dopo le leggi razziali del 1938.
Il fuoco, del resto, veniva tenuto acceso dagli strati intellettuali rimasti fedeli a Benedetto Croce; fra gli operai costituivano un richiamo, di là dal malcontento per la riduzione dei salari (il 20% effettivo nel ventennio), le azioni coraggiose dei giellisti e degli anarchici e la presenza di comunisti nelle fabbriche; fra i contadini destavano diffidenza il “ruralismo” troppo scopertamente truffaldino del Regime e le costose e inefficienti bonifiche. Più in generale, mentre il duce proclamava, con la conquista dell’Abissinia, il ritorno dell’Impero, “dopo 19 secoli”, sui “colli fatali” di Roma, la presenza di oltre 4.000 volontari antifascisti italiani di varia fede politica in Spagna contro Franco non era ignota. E della vittoria a Guadalajara ottenuta nel marzo 1937 da questi volontari appartenenti alle brigate internazionali parlarono non solo i reduci delle formazioni mandate dall’Italia a battersi per il fascismo spagnolo, ma lo stesso Mussolini, colpito dalla perdita di prestigio che quella presenza e quella battaglia gli arrecarono. Dagli intellettuali esuli in Occidente, i “fuoriusciti”, come li chiamava la propaganda fascista, i Salve- mini, gli Sforza, i Ferrari, gli Sturzo, da quelli andati a Mosca, giungevano messaggi clandestini ma sempre più conosciuti e ascoltati.
Non occorre, in ogni modo, sopravvalutare l’antifascismo del ventennio per aver ragione deHe esagerazioni riguardanti il consenso al regime. Basta prendere in attento esame gli echi quotidiani della propaganda fascista all’interno — come si viene facendo sempre più con indagini circoscritte e perciò

10 Guido Quazza
più documentate — per cogliere la natura retorica del consenso parlante e la sostanziale ostilità di quello silenzioso. È vero che la grande industria sta con Mussolini fino al 1942, per la preferenza che la politica di intervento nell’economia assegna ai grandi gruppi siderurgici, meccanici, elettrici e ai complessi bancari, ma il processo di concentrazione monopolistica scontenta la media e la piccola industria, come apertamente si vedrà durante la guerra.
L’autarchia e il rapporto più stretto con il Reich non tardano a inoculare dubbi anche dentro il “blocco sociale” sostenitore di Mussolini. Il volume pubblicato dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione su Operai e contadini nella crisi del ’43, l’unico finora largamente documentato, offre basi robuste alla critica della tesi che considera largo il consenso nel ventennio. E l’opera di Luisa Passerini su Torino operaia e il fascismo colpisce ancora di più perché coglie nel rapporto fra gli stereotipi dell’antica cultura popolare e le affermazioni stretta- mente politiche il varco d’una ostilità o almeno estraneità che Nuto Revelli individuò anni fa nei contadini o montanari attraverso le “storie di vita” de II mondo dei vinti. Anche l’uso dei metodi più raffinati delle scienze umane qualitative si unisce a quello dei metodi delle scienze sociali quantitative per mostrare i vuoti profondi e le incrinature superficiali di un consenso che sarà così debole da portare i soldati ad essere ancora più ostili alla seconda guerra mondiale che non alla prima, e gli stessi fascisti a dileguarsi come neve al sole nel luglio 1943.
Continuità e rottura, unità della Resistenza
Profondamente legata alla vicenda politica della Repubblica italiana nata nel 1946, ma — come dicevo — strettamente intrecciata allo sviluppo delle influenze metodologiche e problematiche straniere, la storiografia con-
temporaneistica italiana non tardò a rendersi conto, di fronte agli eccessi di svalutazione e di sopravvalutazione del consenso al Regime, della necessità imprescindibile di porsi il problema del nesso fra continuità e rottura nella storia italiana, cioè, nello specifico, tra la storia del fascismo e dell’antifascismo clandestino e partigiano col prima e col poi. Di là dal merito di quegli storici che si assunsero il carico scientifico ed etico-politico di affrontare il dibattito in questa prospettiva, il nodo divenne subito stringente. Dalla parte opposta si tentò di minimizzare, o svilire, la centralità del nesso sviandone il significato. Si disse che il nesso era proposto come dilemma schematico e che ognuno dei due termini era presentato come un assoluto, una chiave rigida di interpretazione. Ma la falsificazione urtava contro testi precisi, che consideravano i due termini come “tendenziali” , come linee orientative sulle quali impostare una discussione che, presa da un corno oppure dall’altro, avrebbe dato risultati di maggior vigore scientifico e di ben diversa efficacia politica. Si puntò con forza sulla distinzione tra storiografia e politica, ma con altrettanta attenzione sulle reciproche influenze, per osservare come le sinistre (in primis il Pei) cercassero, esagerando il grado di rottura della guerra partigiana e l’ampiezza di rinnovamento del suo esito, di dimostrare come colpa non perdonabile del centro e della destra moderata (in primis della De) l’avere cacciato le sinistre dal governo nel maggio 1947 e non più accettato il loro ritorno, infrangendo la base stessa della “Repubblica nata dalla Resistenza” . L’accusa, prima lanciata da socialisti e comunisti, poi, con l’alleanza fra Psi e De nel primo governo del Centro-sinistra sorto nel 1963, dai soli secondi, favorì l’estendersi dall’altra parte di una linea di difesa che, puntando sull’ “unità indifferenziata” dei resistenti, colpiva ad un tempo sia la natura di classe della guerriglia, sia il grado di rottura con l’Italia di prima, da Cavour a Mussolini.

La resistenza al fascismo in Italia 11
Negli anni sessanta, dunque, la storiografia sul fascismo e sulla Resistenza toccò il limite massimo di sudditanza all’ottica politico-istituzionale e la spinta più forte a uscirne in più larghi campi. Nei quindici anni fra il 1945 e il 1960 erano state le storie generali a rivelare più scopertamente il legame col partito o con la fazione: sia quelle sulla guerriglia, dal Battaglia al Bendiscioli, dal Valiani al Carli Ballola, sia quelle sul ventennio, anche la pur ricchissima sintesi del Salvatorelli e del Mira. Durante lo stesso periodo, antidoto soltanto parziale erano stati i numerosi scritti memorialistici, spesso caldi di fede e di passione. Così, non soltanto fra gli studiosi, ma anche fra i cittadini, si era acuito il contrasto fra la capacità della storiografia di afferrare l’ampiezza del tema e le esigenze che stavano emergendo dalla società italiana.
Cinematografia, letteratura, poesia, arti figurative avevano intuito meglio il fondo umano — la “cultura” , la “mentalità” — sul quale s’erano scontrati i due principali contendenti del conflitto. La storiografia aveva limitato la sua attenzione ai pensieri e alle azioni di essi, considerando di fatto — e contro le proprie proclamazioni pubbliche, dunque come retorica — il “popolo” come oggetto e non soggetto di storia.
La chiave “continuità-rottura” finiva con l’aprire molte più porte che non quella dell’“unità della Resistenza”. Riesplodeva, a fianco d’una formula che nella sostanza guardava — da sinistra come da destra — alla Resistenza quale pura “guerra di liberazione nazionale”, l’attenzione ai contrasti di classe e alla guerriglia in quanto sede di sforzi di “rivoluzione sociale” . Irrompeva la polemica sulla Resistenza tradita o incompiuta.
Il destino della storiografia di essere messa al muro delle sue specifiche responsabilità scientifiche e morali dalle differenze e contrapposizioni della politica era reso ancor più manifesto dal fiorire in quegli anni di almeno tre grandi speranze: la “nuova frontiera” di
Kennedy, la Chiesa rinnovata dal Concilio Vaticano II di Giovanni XXIII, la “rivoluzione culturale” di Mao Tze-tung. E dal muoversi di sempre più larghe masse su quello ch’era il terreno più esemplare di verifica nell’azione di quelle speranze: la lotta di liberazione del Vietnam. Né si può dimenticare il costituirsi spontaneo, contro le mene pro-fa- sciste del presidente del Consiglio Tambroni nel 1960, d’una coalizione tra i vecchi antifascisti del ventennio e della guerra partigiana e i nuovi antifascisti giovani-operai, e via via il pullulare di proposte che si collocavano alla sinistra del Pei per esplodere nel 1967-1968 col movimento studentesco e nel 1969 con 1’ “autunno caldo” nelle fabbriche. Da ciò il rendersi incandescente, perché pietra di paragone dei conflitti generali, del contrasto tra antifascismo e fascismo in tutte le sedi: da quelle della politica contingente a quelle dei programmi generali di conservazione o di mutamento dell’economia e della società, agli orientamenti ideologici come premesse necessarie delle specificazioni culturali. Speranze e movimenti “dal basso”, inoltre, si innestavano nel vero spartiacque della storia sociale italiana, che non era stato né il ventennio né la lotta armata, ma la grande migrazione di popoli — 10, 12 milioni di persone — che durante il boom dell’economia del paese (1958-1963) si era spostato e si stava spostando dal Sud al Nord, dalla campagna alla città. Ancora una volta, ma per una strada diversa, il “pubblico”, la realtà collettiva d’ogni giorno, premeva sulla storiografia perché estendesse i suoi territori e i suoi strumenti di lavoro.
Neutralità e scelta
Quali diventarono, sul nostro tema, i punti del contendere?
L’unità antifascista e resistenziale venne usata come merce da vendere a prezzo più o meno alto a seconda che si venisse estenden

12 Guido Quazza
do la pressione di massa o si inasprisse la risposta dei gruppi conservatori e apertamente di destra e fascisti. La sequela delle “stragi” compiute dal terrorismo nero dal 1969 in poi fu il termometro della febbre conflittuale nel politico e nel sociale. La formula “unità della Resistenza” venne tirata dal Pei verso il “compromesso storico”, prima (1973) come tesi enunciata dal segretario comunista Berlinguer, poi (1976-1978) come prassi applicata sotto la guida del democristiano An- dreotti.
Quella storiografia che a sinistra era libera di sudditanze a partiti lo individuò come strumento di “mistificazione” perché presentava il suo precedente — l’unità della Resistenza — come accordo sicuro acquisito una volta per tutte e non come risultato da raggiungere attraverso una ricerca continua, impedendo in tal modo una spiegazione storica dell’esaurimento della carica innovatrice della Liberazione.
I fautori della continuità si divisero essi pure in due schiere. Chi, come i rivalutatori del fascismo, si mise a sostenere la “obbiettività” di una posizione che si collocava come neutrale tra i “demonizzatori” (parola che diventerà negli anni seguenti di gran moda in Italia) e i fascisti tout court. Una tesi — dicevano — necessaria per ricostituire l’unità degli italiani, per dimenticare un’età di feroci contrasti, un’età — ecco la formula — di “guerra civile” .
Chi, come coloro che avevano visto con dubbio non solo metodico l’insistenza convergente da destra e da sinistra sulla Resistenza quale unità e rottura, si apprestò a respingere anche la formula, di Giorgio Amendola, della “rivoluzione antifascista” , pur riconoscendo nella lotta contro il fascismo la base morale e culturale della Repubblica italiana. Costoro si avvalsero dell’esperienza metodologica e problematica fatta dalla storiografia francese e anglosassone negli studi di storia moderna per propugnare la necessità che quest’esperienza venisse estesa alla
storiografia sull’età contemporanea e, nello specifico, sul fascismo e sulla lotta contro di esso. Era questione di non annegare passato e presente nella hegeliana notte in cui tutte le vacche sono nere. Era questione di non affondare nella palude della neutralità. Era questione di avere il coraggio di rischiare una interpretazione, cioè di scegliere secondo la “verità” scientifica e, inseparabilmente, secondo una visione del mondo che si autode- nunciasse come coscienza etico-civile espressa da quella “verità” .
Fu dagli Istituti storici della Resistenza che si sviluppò l’azione più larga, lo sforzo coerente non d’uno o pochi ma di molti per rendere più aggiornata la ricerca storiografica e attraverso l’aggiornamento portarla a farsi più idonea a liberare lo studio e la conoscenza del grande conflitto del 1919-1920 in atto in Italia dalle secche dell’ideologismo e dagli schematismi inevitabilmente nascenti da una visione puramente politico-istituzionale del passato. Più adeguata, dunque, anche alla coscienza delle avanguardie militanti e non lontana dall’opinione del cittadino medio. Soprattutto, più autonoma dai condizionamenti di breve periodo, più solida nel guardare a continuità e rottura, cioè alle permanenze e ai mutamenti, i quali sono propri d’ogni orizzonte non “presentista” ma di “lunga durata” . Era anche la via per ripristinare la diversità di idee e, con essa, la chiarezza, diciamo pure l’onestà intellettuale delle ottiche interpretative. L’obbiettività non nasce — si disse e si scrisse allora — dalla neutralità ma dalla franchezza con la quale si denuncia il proprio angolo visuale senza manipolare le fonti disponibili. Chi ha più filo, come interprete, fa più tela. E il lettore rimane libero di giudicare, non catturato dalle proclamazioni di una neutralità che non può — e perciò non deve — esistere.
Subito emersero dilemmi interni al nesso continuità-rottura e funzionali alle scelte che riguardavano — come continuano a riguardare, in tutte le articolazioni necessarie ad at-

La resistenza al fascismo in Italia 13
tivare semplicistiche contrapposizioni — questo nesso. Cerco di indicarli nell’ordine che mi pare più logico per l’analisi del tema.
Spontaneità e organizzazione, lotta nazionale e lotta di classe
Nei primi anni dopo la Liberazione la “spontaneità” era stata assunta a carattere principale della scelta della lotta armata special- mente da storici o dirigenti del Partito d’A- zione (Calamandrei, Galante Garrone, Foa) preoccupati dei tentativi del Partito comunista di monopolizzare il merito d’aver affermato e guidato il passaggio allo scontro totale. Negli anni sessanta, proprio per le grandi battaglie di massa che ho già ricordato come segnate dal crisma dell’antifascismo, furono invece studiosi cattolici (con particolare lucidità Sergio Cotta) a sostenere che la Resistenza era stata in realtà una cosa diversa dall’antifascismo dei partiti nel ventennio. Mentre questo secondo rispecchiava differenze dell’Italia liberale ormai vecchie, elitarie, unicamente politiche, e tornava alla ribalta nel 1943 come isolato dalla società italiana quale era venuta mutandosi sotto il fascismo, la prima rispecchiava un moto spontaneo di massa, una “adesione socialmente indifferenziata”, non di classe, nella quale erano presenti tanto la “borghesia industriale” quanto gli “strati più umili”, l’una e gli altri mossi da spinte “materiali” .
Più tardi, al tempo del compromesso storico, Cotta sarà ancora più esplicito, parlando di “movimento popolare arditamente innovatore ma largamente unitario e non ideologicamente rivoluzionario, che indica il cammino da riprendere nel ritrovato accordo delle forze politiche che allora vi parteciparono”. Unità che prima è vista come nascente dalla spontaneità, perché si vuole strappare ai comunisti il credito di guida della Resistenza. Poi, mutati i tempi politici ed estesasi
la contestazione mossa alla Repubblica dai “neri” e dagli ultrarossi, perché soltanto su un terreno di parità di meriti era possibile ricostituire un minimo comun denominatore sul quale formare un governo di “unità nazionale”, come significativamente fu chiamato nel 1976-1978.
Riferimento polemico principale restavano le tesi “organizzativistiche” proprie della tradizione settaria e dell’anima stalinista del Pei. Non più le formule di “Secondo Risorgimento” — patrocinate per la Resistenza da Togliatti fin dal 1945 — e di “movimento patriottico di unità popolare” — proclamate da Longo nel libro, del 1947, intitolato Un popolo alla macchia. Ma quelle di Secchia sulla classe operaia come “avanguardia organizzata” della guerra partigiana: formule cresciute con la rottura del governo di unità nazionale nel maggio 1947, con l’attentato a Togliatti nel luglio 1948, con la reazione antioperaia degli anni 1948-1955.
La questione spontaneità-organizzazione rimase, dunque, per tutto il quarantennio dopo il 1945 come spia più o meno esplicita del contendere intorno al tema, più scoperto e scottante politicamente, dell’“unità della Resistenza”. Per la De — lo scrisse con chiarezza Ernesto Ragionieri — fu un mezzo tattico per garantirsi quale erede della continuità dello Stato; per il Pei — fu detto da chi scrive e da altri — la via strategica da percorrere per legittimarsi come partito nazionale, dopo i lunghi anni delle scomuniche fasciste e cattoliche, e poi come partito cofondatore della Repubblica e interno al suo sistema istituzionale. Più a sinistra, dentro il Pei stesso (Secchia) e fuori (nei cosiddetti gruppi extraparlamentari), l’atteggiamento ufficiale, di Togliatti e poi di Berlinguer, fu bollato, dal 1968 in poi, di rinuncia a portare fino in fondo la istanza rivoluzionaria operaia quale si era espressa con grande forza negli scioperi, da quello del marzo 1943, ancora in regime mussoliniano, a quello “insurrezionale” del 18 aprile 1945.

14 Guido Quazza
Spontaneità e organizzazione rimangono anche oggi, a mio parere (e si veda l’acuta sintesi di Giovanni De Luna), i due termini-chiave per l’interpretazione del significato politico della guerra partigiana e del suo rapporto con il periodo fascista.
Già negli anni del divampare più acceso di questa discussione, gli anni sessanta, da parte di storici degli Istituti della Resistenza si era sottolineato il fatto che la stragrande maggioranza dei partigiani era costituita da giovani: (80-85%, e fra essi il 56,3 erano nati tra il 1920 e il 1925, il 40,8% tra il 1910 e il 1919, oppure — e questi senza obblighi di servizio imposti dalla Rsi — nel 1926-1927). Essi dunque nella quasi totalità non potevano aver militato nell’antifascismo clandestino se non, ma alcuni soltanto, nel periodo della guerra. Altre sollecitazioni, non politico-partitiche, ma esistenziali (morali, psicologiche, “materiali”), li avevano spinti a ribellarsi al fascismo, prima in forme per lo più passive (non combattere, criticare, “mugugnare”), poi, di fronte al crollo totale dello Stato l’8 settembre 1943, con 1’“andare in montagna” e prendere le armi. La scelta di questa strada, essa stessa minoritaria (fra i relativamente numerosi ex militari “sbandati” dei giorni dopo l’armistizio, solo nove o diecimila rimasero nella “bande” a fine dicembre 1943), era stata prepolitica. Uno scatto morale, l’intuizione personale che occorresse recuperare l’identità risorgimentale del paese combattendo contro il nazifascismo, un atto di responsabilità e di assunzione di rischio per la grande maggioranza di giovani “ribelli” appartenenti al ceto medio (studenti, intellettuali in fieri in prima uscita, impiegati, lavoratori indipendenti). Un’avanguardia peraltro ridotta rispetto a coloro che avevano nel ventennio assistito all’imporsi e al dominare del “duce”. L’antifascismo politico non spinse direttamente i più fra questi, ma poi cercò via via di organizzarli e in parte (in parte soltanto) riuscì a influenzarli, senza mai riuscire, durante i venti mesi dello scon
tro frontale, a soggiogarli. Al naufragio dello Stato e della sua “autorità” sia morale sia coercitiva s’era aggiunta l’ambiguità della chiesa cattolica, divisa tra il desiderio del papa di dar vita a una sorta di fascismo senza Mussolini, o a un regime militare, e la passione cristiana del clero vicino al “popolo di Dio”.
Al campo della spontaneità, ma con azione d’efficacia crescente, appartiene anche l’adesione dei ceti “popolari” . Antifascismo esistenziale, dunque in primo luogo spontaneo, fu infatti quello operaio e, dove si manifestò, quello contadino. Non c’è dubbio, anche se la tesi esclusivista dell’organizzazione non è ancora morta, che gli operai poterono, fin dal 1942-1943, riacquistare una loro forza e cementarla, entro certi limiti, con l’avvio a classe, cioè a forza, per ragioni “materiali” e non propriamente politiche, relativamente omogenea, sia perché generalmente dequalificata dal tipo di lavoro e portata verso salari e categorie più ravvicinate, sia perché l’economia bellica imponeva che si tenesse conto delle loro richieste di vita, special- mente salariali e alimentari. Dopo l’8 settembre, la Rsi fu in gran parte il braccio armato volto a favorire le domande di mano d’opera avanzate dal Terzo Reich, e spesso i nazisti tedeschi si arresero ad una certa comprensione fino a che riuscirono a ottenere, complice parte degli industriali, un certo grado di produzione effettiva. Poi, quando gli scioperi del novembre-dicembre 1943 e quello, il più grande dell’Europa occupata, del marzo 1944, mostrarono che gli operai erano in prima linea nella resistenza di fatto, si aprì la fase delle vere e proprie deportazioni di lavoratori in Germania, oltre quella della Todt. La primazia operaia (i partigiani armati crebbero di numero, fino a 30-35.000, solo dopo i bandi di richiamo emanati dalla Rsi in primavera) nel combattere i fascisti e i nazisti con le proprie armi tradizionali (scioperi, renitenze, sabotaggi, ecc.) venne via via meno, ma un forte contenuto di classe, anche questo esistenziale più che politico, rimase. Il

La resistenza al fascismo in Italia 15
Pei era presente con suoi uomini, la sostanza dell’opposizione operaia era dentro il “movimento”, e dentro il movimento doveva porsi l’avanguardia comunista per poter agire. Soltanto più tardi — come rilevò Claudio Dellavalle — il Pei riuscirà a collegare più strettamente le rivendicazioni economiche agli obbiettivi politici e, con l’insieme della sua azione,a conquistarsi la maggioranza effettiva dei loro consensi. Come nel marzo 1943, fino alla primavera dell’anno seguente la spinta maggiore alla resistenza fu d’origine operaia, ma in quanto il cemento dell’omogeneità era più naturalmente evidente e forte, come cemento di classe, nella fabbrica anziché nella società.
Ciò, dunque, mantiene un certo carattere di precedenza alla spontaneità rispetto all’organizzazione. Ciò, tuttavia, non deve diminuire l’importanza di questa come presenza orientativa nel terreno ancor vergine della preparazione ideologico-politica. E ancora: la storia del rapporto fra i due termini non è di contrapposizione, salvo eccezioni non frequentissime. È storia di intreccio quotidiano, e di dialettica reale, che si conserverà anche dopo la Liberazione.
Storia d’intreccio anche perché, nell’Italia occupata dai tedeschi, il rapporto tra spontaneità e organizzazione è ogni giorno influenzato da quello che in anni ormai non vicini tentai di definire antifascismo dei fascisti. In primo luogo, antifascismo di quegli industriali e banchieri che nel 1920-1922 e poi fino almeno all’autunno del 1942 furono i principali promotori, affiancatori e profittatori del fascismo.
Ai primi dell’autunno 1943 in alcune zone essi non esitavano ad appoggiare l’andare in montagna di giovani “sbandati” preoccupati di sfuggire alla chiamata dell’appena nata Rsi e alla minaccia di fucilazione come “disertori” : essi speravano in una vicina fine della guerra e contavano di farsene uno strumento per la “salvaguardia delle aziende” . Il prolungarsi del conflitto e la durezza del suo
quotidiano svolgersi li portò presto a non prendere posizione, a farsi consapevolmente neutrali, finanziando gli uni e gli altri in lotta, sia per mantenere le commesse belliche da parte fascista e nazista, sia per prepararsi titoli di salvezza nel caso previsto di vittoria degli Alleati e con essi dei partigiani. La differenza o, assai più spesso, l’ostilità nei confronti dei “rossi” , si tradusse in una sostanziale estraneazione dalla lotta armata, perché questa procurava difficoltà e veri e propri pericoli per l’incolumità delle strutture produttive e interruzioni di lavoro e quindi riduzioni di profitti, oltre alle conseguenze mortali per le persone quali nascevano dalle rappresaglie contro i colpi di mano e le imboscate dei partigiani. Era 1’“attesismo”, adottato come “linea politica definitiva”, in alcuni giunto fino a vedere la Rsi, scrive Luigi Canapini, come “ punto di riferimento per tutti quei ceti sociali che, pur non aderendo al fascismo repubblicano, volevano sottrarsi ad ogni scelta ed evitare, con la difesa delle tradizionali istituzioni che quel governo preservava, ogni deciso sbocco innovatore della crisi” .
Per queste vie, ma non solo per queste, l’antifascismo dei fascisti operò molto negativamente anche nel campo della politica generale. In primo luogo, nei rapporti col governo del Sud e con gli Alleati.
L’iniziativa monarchica, gli Alleati e il peso del Mezzogiorno
Qui sta il nodo più gravido di conseguenze sia sull’efficacia militare della Resistenza, sia sulla capacità di questa di lasciare una sua eredità di mutamento. Continuità e rottura vi giocano la loro partita decisiva.
Anche su questi aspetti non sono mancate, in sede di interpretazione storiografica, implicazioni conseguenti alla politica contingente.
Nelle tesi di storici comunisti (specialmente di Carlo Pinzani) si è giunti fino a ridurre

16 Guido Quazza
l’importanza, per la caduta del fascismo, degli scioperi del marzo 1943, per meglio poter dimostrare che il re e Badoglio, con l’arresto di Mussolini il 25 luglio, con l’armistizio e con la fuga del 9 settembre nella zona alleata, sferrarono un colpo non solo grave ma irreparabile contro l’iniziativa dei partiti antifascisti, e specialmente delle sinistre. Secondo questa tesi, la difesa che gli Inglesi fecero del re e di Badoglio fu dovuta all’avere costoro mantenuto strettamente in pugno la figura di garanti dell’esecuzione dell’armistizio e di difensori della continuità dello Stato italiano. Continuità ch’era considerata essenziale soprattutto da Churchill, scettico, anzi timoroso nei confronti di ogni movimento dal basso, tanto più se guidato da quegli antifascisti del ventennio ch’egli aveva sempre considerato — come Vittorio Emanuele III — dei révenants. Re e Badoglio, a detta di Pinzani, perseguivano lucidamente una “strategia di conservazione istituzionale e sociale della corona e del comando supremo tendente a promuovere l’uscita dal conflitto senza scosse istituzionali” e a inserire il “paese nella sfera di influenza occidentale” .
Da altri si è tentato, inoltre, di ridurre le distanze tra Sud e Nord nel tempo della Resistenza. Alcuni studiosi, come il comunista Rosario Villari, hanno sottolineato che nel Mezzogiorno l’antico blocco agrario era entrato in crisi dagli anni trenta e trovava negli anni della guerra, dopo lo sbarco degli Alleati in Sicilia in particolare, fenomeni di potenzialità disgregatrice quali le occupazioni di terre da parte contadina. Senza sminuire l’importanza di questi fatti, non sembra tuttavia ancora possibile, né è prevedibile lo sia in futuro, sopravvalutare i fermenti operai in Napoli e le insorgenze contadine in tutto il Sud. Né sottovalutare la forza ritardatrice e inquinatrice esercitata dal fatto che per molti mesi — e ancor prima dello sbarco in Sicilia — i canali di informazione degli Alleati sono gli italo-americani già succubi della propaganda ufficiale dell’Italia fascista, cioè la
mafia italo-americana, e il Vaticano al proprio vertice tendente a un fascismo senza Mussolini. Le incertezze degli Usa, durate a lungo, finiscono col coniugare i conflitti tra militari e civili e tra i vari centri di potere americano con le paure della mobilitazione operaia del Nord e le sollecitazioni delle forze sociali dominanti al Sud, indebolendo le prime intenzioni riformatrici.
Sono fatti che incideranno, soprattutto dopo la Liberazione dell’Alta Italia, dal punto di vista del mutamento sociale, non c’è dubbio. Ma per l’esito politico-istituzionale immediato — quello che contò decisivamente nell’impianto del nuovo potere in Italia dopo la fine della lotta armata — l’effetto fu molto scarso. Lo provano la nascita, quasi ovunque, di Cln che, mentre nel Nord erano l’organo politico dirigente la lotta, nel Sud erano formati da opportunisti ed ex-fascisti. Ciò tolse base specifica innovativa al Cln centrale di Roma, rendendolo ben diverso da quello che il 16 ottobre 1943 aveva espresso con un duro ordine del giorno la volontà di sostituirsi alla monarchia come “governo straordinario dotato di tutti i poteri costituzionali dello Stato” . Ciò rese inefficace il convegno dei Cln meridionali tenutosi a Bari il 28 e 29 gennaio 1944, la cui azione finì presto con l’arenarsi sulla richiesta, in sé debole, dell’abdicazione del vecchio re. Mancava l’impegno nella lotta conosciuto di fronte alla dura alleanza tra fascisti e occupanti nazisti dal Nord e da una parte del Centro, e la conseguenza non potè essere se non quella di rendere più forti la monarchia e il governo Badoglio e le tendenze restauratrici del governo militare alleato. La presto mancata epurazione del personale fascista negli apparati dello Stato (questori e prefetti del Regime, per esempio, restavano in gran parte ai loro posti), la fiacchezza, o per meglio dire inesistenza, dei rapporti con la Resistenza (che il re temeva come aperta sconfessione di fatto della sua ventennale collaborazione col fascismo), la timidezza con la quale si dichia

La resistenza al fascismo in Italia 17
rò guerra alla Germania il 13 ottobre 1943 e si fecero proposte di affiancamento di un esercito italiano a quelli alleati (del resto la risposta alla chiamata di leva fece addirittura nascere un vasto “Movimento non si parte” e gli angloamericani non consentirono più di54.000 armati), il riconoscimento tacito delle posizioni tradizionali di potere economico e spesso l’uso in incarichi-chiave di esponenti di questo: ecco i punti principali che preparano il condizionamento negativo che, sia pure con minor pesantezza di quanto la storiografia abbia detto nei primi vent’anni dopo l’aprile 1945, ha agito non solo sul rapporto fra Nord e Sud ma anche sulla genesi della Repubblica italiana.
La tesi secondo la quale fin dal 1943 l’iniziativa politica del re e di Badoglio indebolì le chances di cambiamento ha senza dubbio una parte di verità, ma nella sua perentorietà è troppo chiaramente legata al desiderio di ridurre — soprattutto per il Pei — la responsabilità di chi non perseguì con forza l’ob- biettivo stesso del cambiamento. Si è voluto mostrare che, già nel momento in cui nasce, la Resistenza è per merito degli avversari privata delle capacità di diventare lo stimolo a una vera e propria rottura. Resta vero, ad ogni buon conto, che molte “precondizioni” dell’indebolirsi di questo stimolo furono dentro l’antifascismo. Così le dimissioni di Bonomi, il 24 marzo 1944, da presidente del Cln centrale, con conseguente crisi di questo. Così, e più, la “svolta di Salerno” operata pochi giorni dopo da Togliatti proveniente da Mosca, presto seguita dalla politica del “partito nuovo” e della “democrazia progressiva”: oggi le opinioni su di essa sono forse meno divise che nove anni fa. L’eloquenza dei documenti diplomatici, i mutamenti politici, l’ovvio buon senso, se attenuano il bisogno di attribuirla ad un perentorio comando di Stalin, rendono sempre più difficile negare che soltanto entro una situazione nella quale la svolta convergeva con fini congrui alla politica mondiale dell’Urss
(fini, in ogni caso, che gli stessi comunisti riconoscono), potè aprirsi quello che al Pei ed ai suoi storici appare un disegno originale, “italiano”, del proprio capo. E resta il fatto che da esso parte il processo di riconoscimento sostanziale, con l’avallo a Badoglio come primo ministro, della continuità dello Stato. La liberazione di Roma, il 4 giugno 1944, non altera il cammino, sebbene il decreto emanato il 25 giugno dal governo presieduto da Ivanoe Bonomi impegni, sulla base delle deliberazioni della conferenza interalleata di Mosca dell’ottobre 1943, a convocare la Costituente. Il problema istituzionale è bensì riconosciuto come esistente, ma lo si rinvia a guerra finita. E intanto la legislazione fascista sopravvive (salvo quella riguardante il Tribunale speciale), l’epurazione viene impostata anche da Bonomi in modo destinato a rimanere inefficace, e anche nel “patto di Roma” (la fondazione del sindacato unico nel giugno 1944) non mancano elementi di continuità. Per questa via le istituzioni tradizionali riprendono forza, i poteri visibili e invisibili del vecchio “sistema” si rassodano, gli Alleati, prima dubbiosi — specialmente gli americani — sull’opportunità di una difesa dell’esistente, a poco a poco si convincono della necessità di stringere i freni rispetto ad ogni passo liberalizzatore. Pesa sempre più forte sia il timore della crescente vivacità mostrata dai soggetti sociali innovatori sia il sospetto di possibili influenze sovietiche.
Soltanto il 25 agosto, e con grande prudenza, il governo romano delega il Clnai “a dirigere la guerra dei patrioti contro i tedeschi e i fascisti” , e le trattative iniziate dopo la decisione, il 9 giugno, di formare nel Centro-Nord un comando unico di quello che viene chiamato ufficialmente il Corpo Volontari della Libertà (Cvl) giungono faticosamente all’inizio di novembre a imporre ad esso un comandante moderato (il generale Raffaele Cadorna, figlio del generalissimo della prima guerra mondiale) incaricato di frenare l’esercito della guerriglia. I protocol

18 Guido Quazza
li di Roma del 7 dicembre vincolano poi i partigiani a obbedire alle direttive alleate e a disarmarsi al termine della guerra, mentre il 25 dello stesso mese una dichiarazione congiunta tra il Clnai e il ministero affossa il “terzo governo indipendente” , cioè il governo di fatto espresso nel Nord dalla Resistenza armata. Così, mentre Kesselring conduce la più terribile offensiva su tutto l’arco alpino contro i partigiani e Alexander li invita col suo “proclama” del 13 novembre 1944 a sospendere le operazioni, si arriva nello stesso mese, durante la crisi ministeriale, al disconoscimento di fatto delbautorità del Cln nel formare il governo. Ancora una volta non basta che lo storico guardi all’atteggiamento rigido degli Alleati. Deve misurare il peso della divisione delle sinistre (solo il Pei partecipa al nuovo ministero Bonomi). E ciò significa la fine sostanziale delle possibilità per il massimo organo politico degli antifascisti di porsi come novità alternativa al vecchio vertice dello Stato.
Di qui, con tutta chiarezza, i gravi limiti che all’“eredità” resistenziale pose il binomio Mezzogiorno-Alleati, nel quale la presenza del secondo termine non è da sola preponderante. Si tratta d’un intreccio di spinte e controspinte, che la stessa storiografia la quale ha lavorato per ridurre il peso del primo termine ha, con le nuove ricerche documentarie a Washington e a Londra, rivelato operanti nel senso di una prevalenza conservatrice. Le nuove energie emergenti dalla società meridionale non poterono, cioè, controbattere l’influenza di quelle tradizionali, rafforzate dalla presenza in loco della monarchia, e ne venne un grande, se non decisivo, stimolo alla vittoria nazionale della continuità rispetto alla rottura.
Già allora uno dei più acuti militanti politici, Vittorio Foa, l’aveva visto, e in un suo saggio fondamentale del 1947 lo aveva confermato, con una lucidità che il tempo non ha appannato. Non, dunque, le manovre regie intorno all’8 settembre, ma tutto il peso
combinato delle forze economiche, sociali e politiche conservatrici del Sud e degli interessi e pregiudizi inglesi, nonché delle iniziative di inserimento nel governo dei comunisti — dall’interno, dunque, degli innovatori — minarono l’idoneità della Resistenza a portare i propri ideali al successo.
Comunità contadina e partigiani
Sulla bilancia sembrano pesare in senso inverso per quasi tutto il 1944 gli elementi di forza costituiti nel Centro e nel Nord dagli operai prima, dai partigiani e dalle popolazioni poi. Ma anche dentro di essi si vanno inserendo germi di corrosione.
Ho già accennato al contegno ambiguo degli industriali e dei banchieri e, più latamente, di quell’antifascismo che ho definito “dei fascisti” . Aggiungo subito che, via via che la guerra sembra svelare un esito determinato, cioè la sconfitta dell’Asse, molti industriali e banchieri allacciano o ritessono trame dirette col potere economico privato negli Usa e in Gran Bretagna, a precostituire una collocazione postbellica nel grande mercato occidentale: gli esempi offerti dalla storiografia sono negli ultimi anni numerosi. Il nodo dell’antifascismo dei fascisti, tuttavia, non è solo qui. Il mutamento delle condizioni di lavoro dalla primavera in poi tarpa le ali alla spinta contestativa e per certi versi virtualmente rivoluzionaria degli operai, costretti dalle vicende dell’economia di guerra e dal rastrellamento tedesco di mano d’opera a rinunciare all’arma dello sciopero. I movimenti dei braccianti sono imponenti nell’estate in alcune regioni del Centro e le occupazioni di terre nel Sud, ma, mentre non possono avere la potenza incisiva della massa d’urto esistente nelle fabbriche, provocano negli agrari e nei piccoli e medi proprietari paure che si riveleranno più tardi non favorevoli al nuovo. Tra città e campagna si torna, con l’accrescimento numerico dei partigiani e il raf

La resistenza al fascismo in Italia 19
forzamento della loro azione militare, a giocare una partita storica che nel presente di allora favorisce forse la spinta a cambiare ma al tempo stesso prepara le condizioni di un futuro freno.
È il problema contadini e Resistenza, certamente fondamentale per la collocazione della Resistenza dentro la storia d’Italia del prima e del dopo e ciò nonostante in gran parte da affrontare con prospettive e strumenti nuovi.
Le fasi della ricerca storiografica sono state in proposito diverse. Esse, pur avendo risentito delle contingenze politiche, sono state percorse soprattutto dai grandi cambiamenti sociali che già ho ricordato, quelli iniziati sul finire degli anni Cinquanta e sviluppatisi soprattutto nel decennio Sessanta. Prima di essi la storiografia antifascista non aveva nutrito dubbi sull’asserzione che la maggioranza delle popolazioni rurali, già diffidente verso il ruralismo di Mussolini e tendente a restare il più possibile estranea a una chiara professione di fascismo, avesse parteggiato per i “ribelli” .
Non pochi documenti di commissari o comandanti e memoriali di combattenti avevano però via via rivelato diffidenza e anche ostilità da parte di molti contadini, restii a fornire i viveri, a nascondere i braccati, a tener duro di fronte ai rastrellatoti, soprattutto là dove prevalevano i piccoli proprietari. Le pagine entusiastiche di Salvemini e di Battaglia sul coinvolgimento dei contadini in una politica “collettiva” come fatto nuovo nella storia italiana erano state, è vero, controbilanciate dal richiamo di Valiani ai profitti del mercato nero, mentre Legnani rilevava che i partiti antifascisti non avevano mostrato di tener presenti e capire a fondo i problemi delle campagne.
Soltanto di recente, però, la storiografia, diversamente dai partiti rimasti quasi sordi alla “modernizzazione” del paese, ha fatto, specialmente ad opera degli Istituti che studiano il movimento italiano di liberazione
dal fascismo, un primo passo innanzi. Ha cominciato a negare validità a una considerazione unitaria del mondo delle campagne, diverso secondo ragioni geografiche, diverso secondo ragioni sociali. Condizioni strutturali e di coltura dei terreni, non solo in relazione all’altitudine, e condizioni di figura sociale (braccianti, mezzadri, affittuari, piccoli o medi proprietari, ecc.) impongono a chi non voglia essere generico e quindi impreciso di studiare le singole realtà locali separata- mente e poi comparativamente. Ecco un compito importante, e molto assorbente, per gli storici. Questo convincimento metodologico apre di per sé la strada a un uso più sistematico e più aggiornato delle scienze sociali quantitative e a un intreccio di quest’uso con l’adozione di strumenti antropologici. Con la penetrazione, circa dieci anni fa, delle suggestioni inglesi di storia orale, si aprì un confronto fra il 1943-1945 nella sua realtà sincrona e i decenni, anzi i secoli passati nella loro dimensione diacronica: un confronto basato sulla convinzione che i mutamenti nella vita contadina sono di lungo o lunghissimo periodo e che quindi vanno sottratti a osservazioni contingenti. Di qui non solo la raccolta delle testimonianze, soprattutto nella forma delle “storie di vita”, ma la pratica più larga delle scienze umane qualitative, e in primis dell’antropologia culturale, della storia delle tradizioni popolari, del folclore, oltre che una rilettura dei testi letterari, visivi, figurativi, variamente musicali.
Io credo — e alcuni recenti convegni degli Istituti storici della Resistenza hanno camminato su questa linea — che si debba fare strada l’idea che l’antifascismo e la Resistenza siano da riesaminare alla luce di interpretazioni del proprio passato, della propria lunga storia collettiva fornite, per così dire, dalla “gente”, da molti: ognuno collabora, con la sua personale e individuale memoria, a costruire tante storie quanti punti di vista, offrendo così allo storico professionale un materiale il cui interesse non sta nell’esattezza

20 Guido Quazza
di singoli dati ma nella diretta partecipazione umana al ricordo d’un passato vissuto collettivamente, nell’immagine di sé dentro il proprio mondo che a distanza di anni si dipinge.
Tutto ciò non deve, tuttavia, andare per proprio conto, dimenticando la complessità degli intrecci e dei piani. In primo luogo, deve essere collocato in un riesame — in Italia ancora raro — della storia della comunità contadina, in quanto sistema politico-amministrativo locale, sede di una cultura millena- ristica, di atteggiamenti di chiusura a difesa verso l’esterno — sia esso potere centrale o invasore — contemporaneamente di un disputare anche molto duro per l’egomonia interna e di un contrapporsi alla città ma al tempo stesso un farsene oggetto di gelosia e di invidia. La vecchia regolamentazione della comunità, tutta a pro’ dei locali e tutta contro i forastieri, è il punto di partenza, in un paese come l’Italia che nel 1945 aveva ancora il 49% di mano d’opera agricola, per capire il rapporto tra popolazioni locali e partigiani armati. Diverso è l’atteggiamento quando questi ultimi sono figli della propria terra, diverso quando sono esterni. Il senso di “appartenenza” gioca come convergenza e come repulsione: si tratta di misurare i singoli specifici casi. La “cultura” della guerriglia, ben nota alle vecchie tradizioni contadine di ribellione, di riots come nel Seicento e Settecento improvvisi e violenti, ha un suo bilancio di dare e avere nella misura in cui le bande armate partigiane contraccambiano le proprie requisizioni con la difesa contro le razzie e le distruzioni e violenze fasciste e na- ziste. Si preferisce chi è dei nost, ma non senza prezzo.
Invece, di fronte alla città, e a quella parte di essa che è sfollata nel villaggio, i contadini sono ancora fortemente diffidenti: il mercato nero è l’arma con la quale si vendicano di quello che considerano un vassallaggio millenario. Nel 1943-1945 la campagna ha la sua rivincita, di dignità, anzi, in certi casi, di prestigio, di ricchezza, di potere — i tre parame
tri della superiorità. Dall’altra parte, il rifugiarsi dei cittadini presso di loro non è sentito solo come un fatto di protezione fisica dalla guerra (soprattutto bombardamenti, coprifuoco), né di facilitazione alimentare, ma anche, più o meno consapevolmente, come ritorno alla primazia della famiglia patriarcale, della vicinìa, del contesto e concerto della “frazione”, più in generale, della natura.
La ripresa, in Italia, degli studi sulla storia della famiglia nell’età moderna consentirà — io credo — altri sviluppi importanti su questo aspetto della guerra di liberazione. Più in generale, sarà possibile intendere meglio i confini fra il rapporto umano e quello politico e sociale. Absalom descrisse con attenzione anni fa il contegno fiero di contadini che salvarono migliaia di prigionieri alleati e non vollero compensi a guerra finita. Chi ha vissuto l’esperienza della guerriglia sa che la generosità dei valligiani e dei lavoratori dei campi nel dare cibo, nel nascondere, nel praticare l’omertà contro le spie e contro i ra- strellatori era un fatto individuale, non collettivamente organizzato, un fatto privato, anche se diffuso, non pubblico, per usare due termini oggi di moda. In Italia, poi, nel quadro familiare-comunitario, il clero basso, i parroci, le suore, quando furono, e non pochi, a fianco dei partigiani, lo furono non come “parte” segnata da connotati ideologici o politici, ma come singole persone. Lo furono non soltanto come ministri del cristianesimo, ma anche, e forse più, come intellettuali organici del mondo rurale, come gestori spirituali e rituali dei momenti cruciali della vita (battesimo, matrimonio) e della morte (funerali). L’acquisizione delle fonti ecclesiastiche (diari dei preti, libri parrocchiali) ha confermato largamente quanto resta nel ricordo dei protagonisti della lotta, e lo seppero i fascisti e i nazisti che spesso dovettero cedere al soccorso e alla mediazione di questi modesti profeti o confessori di uomini soggetti da sempre alla subalternità di fronte al potere locale e centrale.

La resistenza al fascismo in Italia 21
Da queste osservazioni si dovrà comunque partire anche per capire ciò che è stato finora difficile intendere, cioè la supremazia della De e dei moderati, dopo, in zone (per esempio il Cuneese, il Friuli) dove la Resistenza ebbe altro segno politico e culturale, al centro del quale era pure una rigorosa volontà di usare pienamente la violenza quando reputata necessaria. Non affrontato se non per cenni, questo è un altro tema per collocare l’Italia partigiana nel corso della storia dal fascismo alla repubblica.
Dall’attesismo alla banda, dalla banda alla zona libera
I.’ultimo punto che consente di cogliere la Resistenza in se stessa, nei suoi particolari caratteri, ma, come dicevo, anche nei suoi effetti, come prodotto — ancora una volta —- del prima e produttrice del poi, è quello della lotta armata nel suo nascere, nel suo corso, nel suo finale insurrezionale e, contemporaneamente, nel suo farsi governo (le “zone libere”).
Come già ricordato, nelle prime settimane dopo l’8 settembre 1943 vanno in “montagna” militari sbandati, alcuni per scelta morale, altri con consapevolezza politica ma senza esperienze militari, per esempio Galimberti, Livio Bianco, i più perché timorosi d’essere braccati dalla Rsi nella fase di costruzione dei suoi apparati repressivi o, in alcune zone, dalle truppe naziste diventate di fatto non più alleate ma occupanti. In parte tendono a rimanere il meno possibile, anche perché non mancano industriali che pensano, come ho detto sopra, di servirsene per il momento, previsto come drammatico, del cambio di potere al termine, che si crede vicino, del conflitto. I comunisti e i giellisti ritengono necessario preparare un tipo di lotta non limitato a nuclei di esperti sabotatori, come vorrebbero gli Alleati (importante in questo senso quanto Me Caffery disse a Cer-
tenago in Svizzera il 3 novembre 1943 a Parri e a Valiani), ma esteso a una vera e propria “guerra di popolo”. Non si trattava tanto dell’esperienza spagnola del 1936-1939, o, più lontano nel tempo, dei ricordi garibaldini e mazziniani. Si trattava della lucida consapevolezza che operando, partigiani e fascisti, entrambi a casa propria, soltanto la scelta degli italiani da quale parte stare avrebbe deciso le sorti del paese. Sono settimane, qualche mese (fino al freddissimo inverno 1943- 1944), nei quali la popolazione è più lontana da quelle bande armate che si collocano sulle alture alpine, appenniniche, collinari. Essa è pronta a dar rifugio, abiti, cibo, e soccorso di varia natura, non a prender posizione per i “ribelli”, in una combinazione di generosità umana e di attesismo, qualche volta alimentata in loco dalla parola cristiana del prete. Su questo, ormai, la storiografia (che vi ha lavorato per molto tempo quasi esclusivamente) è giunta a un largo accordo. D’accordo, inoltre, che via via (e specialmente dopo la costituzione, nel gennaio 1944, del Cln dell’Alta Italia) l’azione armata è venuta crescendo e assumendo diffusione ed efficacia sempre maggiori, sia per il radicarsi delle bande nel territorio, sia per l’addestrarsi dei combattenti alla guerriglia e alle sue norme peculiari.
Superata in partecipazione, efficacia e intensità, come già ho detto, dalla lotta operaia fino alla primavera del 1944, l’azione armata dei partigiani giunge al suo culmine nell’estate 1944, quando tocca là piena arti- colazione di territorio e di formazione, cioè il nodo fondamentale della sua origine e natura autonoma (e, anche, autonomistica). Ormai restano ancora bande dette “autonome” perché libere da espliciti condizionamenti di partito (molte, però, sono di fatto monarchi- che-moderate), ma la parte maggiore è aggregata sotto segni di partito (40-50% sono formazioni Garibaldi, controllate in sostanza dal Pei; 30% Giustizia e Libertà, ispirate al PdA; molto meno le socialiste Matteotti e le democristiane Fiamme Verdi).

22 Guido Quazza
Ciò significa che è giunta ad imporsi largamente la convinzione che la Resistenza sia, comunque, un movimento con tratti non solo militari ma politici e che si debba puntare anche sulla massima maturazione di questi ultimi (s’intende, con i loro diversi colori) nei singoli combattenti. Di là dall’istituzione, già ricordata, del comando unico del Corpo Volontari della Libertà, rimasto in gran parte sulla carta, la scelta politica fu la strada sia per intensificare le operazioni militari, rimaste all’autonoma decisione delle bande, sia per passare gradualmente dallo scatto morale alla consapevolezza dei fini generali. Con l’allargarsi numerico e il rafforzarsi delle formazioni locali si venne configurando con maggiore pienezza quella che anni fa chiamai la banda come “microcosmo di democrazia diretta”, della quale occorrerebbe riuscire a fissare meglio i modi di nascita e di sviluppo, le procedure di decisione, le vie di esecuzione e di controllo. Al centro della ricerca dovrebbe essere la maturazione d’una spontaneità non più, per così dire, spontaneistica ma fatta di iniziativa e di solidarietà combinate con lo sforzo di istruzione da parte dei più colti (le lezioni, i volantini, i giornali, i libri) e di educazione da parte dei veci o combattenti più esperti, spesso coordinata e posta su carta scritta dal commissario politico, con “tagli” diversi a seconda del colore della banda, e oggi documentabile con materiali (vedi ad es. gli studi di F. Omodeo Zorini) seri e non di rado assai belli.
Non si ebbe se non in casi rari una sovrapposizione politica coattiva alla composizione sociale delle bande. I dati statistici su questa sono molto scarsi. Si può tuttavia dire che sui 70-80 mila partigiani dell’estate, i quali raggiungeranno i 120-130 mila alla vigilia della Liberazione, il grosso è dovunque di contadini e di operai (con molte variazioni percentuali); per il resto, studenti e impiegati. Si avrà un buon contributo alla conoscenza del nesso spontaneità-organizzazione e del rapporto partigiani-popolazioni quando si
raggiungerà una conoscenza quantitativa sufficiente di questo dato.
Anche dal dato sociale e da quello culturale dipende, nell’estate-autunno 1944, la sorte delle “zone libere”, delle cosiddette repubbliche partigiane nate in Liguria, nell’Ossola, nel Monferrato, nell’Oltrepò pavese, a Mon- tefiorino, in Carnia e Friuli, e durate da tre settimane a tre mesi. Queste sono state abbastanza studiate e i risultati hanno avuto le necessarie comparazioni. Una partecipazione diretta ancora legata a schemi di gerarchia economico-sociale, salvo eccezioni (ma anche la più avanzata, in Carnia, dà il voto ai capifamiglia, come nei vecchi comuni medievali e nelle recenti latterie sociali), una legislazione aperta nei problemi di contatto umano ma timida sulle questioni di fondo, a partire da quelle fiscali. L’incerto sistema di relazioni fra il potere armato e le giunte elette diede scarso respiro politico alle zone libere, ma specialmente il tempo breve e il perdurare della minaccia nemica. Nell’insieme, però, mentre il costituirle fu un forte rischio militare (e talvolta portò a esiti tragici), l’impegno politico fu di grande valore per il “morale” delle popolazioni. Se i primi passi verso l’autogoverno rivelarono una complessiva incapacità di trasferirvi i moduli democratici della banda partigiana, l’esempio fu di per sé subito, e restò dopo la loro fine, mobilitante.
La fine dei Cln e il ritorno dello Stato
Se fu causa di limiti nelle zone libere, direttamente o indirettamente dominate dai partigiani, la debolezza dei Cln fu anche all’origine dell’assenza di una guida “giacobina” al movimento di liberazione in generale. Le ragioni sono chiare: rappresentanze di partito, nei Comitati, non sempre complete né autentiche; clandestinità e dunque difficoltà di fornire una propria immagine autorevole alla popolazione; distanza troppo

La resistenza al fascismo in Italia 23
grande dal vivere quotidiano della gente e da quello dei combattenti; equivalenza all’interno fra i partiti presenti e difficoltà a decidere nel caso di non unanimità. Per queste ragioni non trovò vera attenzione l’importante decisione, presa fra l’agosto e l’ottobre 1944, dopo vivaci discussioni, di portare dentro i comitati la rappresentanza degli “organismi di massa”, specialmente i Gruppi di difesa della donna e il Fronte della gioventù. Non migliore efficacia, salvo casi non numerosi, ebbero i Cln periferici, in particolare quelli aziendali, i quali per altro erano intesi dai partiti come destinati a sostituire, anzi a mutare, i comitati di agitazione, vera espressione — questi — della forza rivendicativa degli operai nelle fabbriche. Pochi, poi, i Cln di cascina, di banca, d’ufficio, di categoria.
Ma la causa più grave di debolezza dei Cln non fu interna, bensì esterna. Fu la politica di partito. Politica dapprima istintiva, di affermazione di sé, spesso anche faziosa nelle forme. Politica in seguito voluta come linea precisa. Già la discussione aperta il 20 novembre 1944 da una lettera del Partito d’azione che rivendicava ai Cln il compito di essere le cellule del nuovo Stato, gli strumenti della “rivoluzione democratica”, mostrò, a cavallo fra il 1944 e il 1945, che la loro sorte era di soccombere agli accordi di partito. Le tesi ormai vincenti al Sud si sovrapposero a quelle dei combattenti nel Centro e nel Nord senza lasciarle sviluppare con convinzione sufficiente. Togliatti ribadiva con insistenza la formula dell’alleanza dei tre partiti di massa. Dalla liberazione, il 4 giugno 1944, di Roma, avevano fatto — lo dicevo sopra — passi da gigante i tiepidi o nemici dei Cln. Era prevedibile che l’insediamento, all’indomani della liberazione dell’Italia occupata dai nazifascisti, di un governo presieduto dal capo “morale” della Resistenza armata, Ferruccio Parri, non sarebbe stato seguito da una duratura vittoria del “vento del Nord”. Gli organi tradizionali — dalla luogotenenza alle prefetture,. dalla magistratura e dall’esercito
alle questure e ai carabinieri, dalle varie istanze amministrative ai sindacati — tornavano a poco a poco favoriti dall’arrendevolezza delle sinistre, in particolare dei comunisti, convinte che bastasse “stare” nel governo. Il totale fallimento dell’epurazione, sancito già nel 1945 dalla faziosità antipartigiana delle sentenze e poi dall’amnistia del 1946, fece sì che la decisione del governo De Gasperi, insediatosi nel dicembre 1945, di ripristinare i prefetti e questori di carriera e di facilitare il ritorno dei tecnici e dei dirigenti nelle aziende fosse accolto senza grandi reazioni.
Perciò si può dire che l’ultimo successo dei Cln, condiviso con le formazioni armate, fu l’insurrezione. Coronamento, dunque, salvo che a Roma, della guerra partigiana e dell’attività legislativa dei comitati, particolarmente viva — ancora dopo la vittoria militare — in Toscana. L’Italia del Nord fu trovata dagli Alleati già liberata e, prima che essi bloccassero tutto, ci fu un periodo, spesso di pochi giorni, di vero regime autonomo in libertà. Poi, favoriti dalla obbiettiva difficoltà di ricostruire strutture produttive e mercati di compravendita e di lavoro, l’antifascismo dei fascisti alleati con la monarchia e con gli angloamericani vinse la battaglia decisiva.
L’importanza dell’insurrezione non è stata ancora studiata a sufficienza. All’interno della Resistenza si dovette fronteggiare l’insistenza dei partiti del Sud per non farla o attenuarla. E si dovettero subire la missione Me- dici-Tornaquinci del 26-29 marzo 1945, il perentorio invito a Parri e a Cadorna a recarsi il 27 marzo a Caserta, il radiomessaggio del generale Clark il 10 aprile. Il Clnai affidava il comitato insurrezionale a uomini di sinistra, Valiani, Pertini e Sereni, ma doveva tener conto di queste pressioni di Roma e degli Alleati, tutte chiaramente volte a impedire che l’insurrezione fosse popolare, anzi che si facesse: l’attesismo era indicato come legge per il timore che il forte intervento di classe del movimento di liberazione italiano pre

24 Guido Quazza
valesse su quello “nazionale” . Quando le intenzioni e i piani per l’insurrezione saranno adeguatamente conosciuti nelle articolazioni locali, molto di più si potrà dire.
Ciò che sembra difficile contestare è il valore militare della Resistenza conclusasi con l’insurrezione. Essa era stata capace di tenere costantemente bloccate ben 14 divisioni tedesche e fasciste e di dimezzare la produzione industriale; la grande parte del territorio della Rsi era stata liberata prima dell’arrivo delle truppe angloamericane: “il contributo partigiano alla vittoria alleata in Italia — si legge in un rapporto della Special Force — fu assai notevole e sorpassò di gran lunga le più ottimistiche previsioni. Con la forza delle armi essi aiutarono a spezzare la potenza e il morale di un nemico di gran lunga superiore ad essi per numero. Senza queste vittorie partigiane non vi sarebbe stata in Italia una vittoria alleata così rapida, così schiacciante e così poco dispendiosa” . Anche il bilancio dei caduti non era disprezzabile. Sotto il segno della scelta, dell’iniziativa, della responsabilità, della sfida erano morti 45.000 partigiani, 10.000 civili, 32.000 deportati, 30.000 combattenti all’estero dopo l’8 settembre 1943, 26.000 a fianco degli Alleati; e 21.000 erano i mutilati. Dai dati conosciuti e dalle nuove ricerche emerge certamente come segno, come fonte e come esito della vicenda la contraddizione, ma pure e perciò l’utilità del rapporto tra spontaneità e organizzazione per misurare quello fra continuità e rottura.
In breve: alPinterno delle forze italiane, la Resistenza resta un grande momento come tentativo e come realtà, in sé stessa, di rottura. Resta come rottura l’aver salvato l’identità e l’unità nazionale, cancellando il peggio e il più della degenerazione fascista rispetto all’eredità risorgimentale. Ingiusto non ricordare che solo la lotta partigiana consentì di avere i titoli per salvare Trieste, per limitare a piccole zone il passaggio alla Francia di terre italiane. E che solo essa salvò il paese da
una divisione quale quella subita dalla Germania. Non trascurabile, anche, la ripresa dell’autonomismo in forme aggiornate, di reale crescita dell’autogoverno. Per certi versi — qui sono gli storici comunisti a insistere più degli altri — la rinascita dei partiti dopo il loro annientamento da parte fascista: ma qui si apre la discussione ancora in atto. A me, come ad altri, sembra anche alla luce di quarant’anni di logoramento della “forma-partito” , che Ragionieri pecchi di ottimismo nel definirli “l’unica forma di associazione veramente autonoma delle classi sociali” e per questo l’unico potere alternativo alla continuità dello Stato. Il tasso di continuità in essi esistente va ben al di là della loro misura quantitativa, del loro apparire come partiti di massa: occorre non dimenticare che anche il partito fascista fu un partito di massa. Questa definizione può coprire, dunque, contenuti molto diversi!
All’esterno degli atteggiamenti italiani, non pare dubbio che l’avvicinarsi degli Usa, sotto la presidenza Truman, alla diffidenza propria della Gran Bretagna, timorosa di possibili sviluppi di rivoluzione o, meglio, di contestazione dal basso, fu decisivo per l’abbandono dei disegni di new deal in Italia e per l’avvio alla individuazione della De come il partito più sicuro su cui appoggiare gli sforzi per mantenere il paese come alleato e la chiesa come il garante ideologico di un blocco politico e sociale anticomunista.
Per il resto, il nocciolo della politica di ri- costruzione fu il frutto di convergenze dall’interno e dall’esterno provenienti dalle forze del grande capitale.
I primi segni della ricerca d’inserimento della produzione italiana nel mercato occidentale e le connesse esigenze di ripristino delle condizioni del sistema capitalistico, presto raggiunti dai contrasti fra Usa e Urss, già alleati e nel 1946 in cammino verso la guerra fredda, consolideranno in Italia nel 1947, con la rottura del governo unitario, e nel 1948, con la grande vittoria elettorale del

La resistenza al fascismo in Italia 25
la De, la restaurazione sostanziale dell’apparato produttivo e di quello statale.
Nettamente positivo, e risultato congiunto della lotta partigiana e dell’interesse degli Alleati occidentali, il bilancio politico-istituzionale. Cioè, il ripristino d’un assetto fondato su libere elezioni, e la libera scelta della repubblica. Merito italiano, sia pure indebolito dalla eccessiva prevalenza dei moderati, la stesura d’una Costituzione abbastanza avanzata nelle sue formulazioni programmatiche, sebbene timida nella parte prescrittiva. Il coinvolgimento diretto nel rischioso impegno quotidiano del mondo contadino, che nella prima guerra mondiale aveva visto catturati dallo Stato i suoi figli per essa mandati a soffrire e a morire lontano dalla famiglia, trovò una parte — i braccianti — toccata notevolmente dal desiderio di novità, rimasto anche fra gli occupanti di terre al Sud, ma un’altra — i piccoli proprietari — forse ancora volta al ritorno del passato come proprietà esclusiva e come vecchi stereotipi culturali. Gli operai delle grandi città a lungo restii ad accettare le parole di prudenza mescolate a speranze di rivoluzione — la “doppiezza” delle parole d’ordine “unità nazionale” e “democrazia progressiva” intese come “rivoluzione” — del principale loro partito, ma frenati definitivamente nei giorni dell’attentato a Togliatti tre anni dopo, il 14 luglio 1948. I dirigenti e i tecnici aziendali presto riassorbiti nella forma mentis produttivistica e nella disciplina padronale. Gli intellettuali, o liberi di far opinione
ma esposti all’attacco dei partiti, o a questi subalterni e in pericolo di perdere il sale specifico della propria “professione” o funzione critica. La “grande speranza” subito delusa dalla permanenza dell’apparato dello Stato dei vecchi funzionari cresciuti nel clima di prepotenza e corruzione del fascismo.
Il tempo del coinvolgimento nella lotta era stato troppo breve. L’Italia della “ricostruzione” restava più agricola che industriale. Solo a cavallo degli anni sessanta, come già ho ricordato, si avrà quella grande svolta nella società che porterà verso la “modernizzazione” . Ancor oggi, tuttavia, a quarantanni dalla fine del conflitto, la continuità col passato incide fortemente sugli apparati dello Stato, sulla legislazione, sui modi di comando effettivo nelle fabbriche, sulle gerarchie di potere nell’economia. Le difese contro il tentativo in corso di cambiare la coinè ideale che è al fondamento della Repubblica, cercando di confondere antifascismo e fascismo di ieri sotto subdole formule — contro la “guerra civile” , per la concordia nazionale — non sono così forti come dovrebbero. La “neutralità”, mascherata dall’“obbiettività” , è il pericolo nascente dall’affievolimento dello spirito di scelta e di sfida della resistenza al fascismo. Il rigore scientifico della storiografia è forse l’arma principale per sostenere l’impulso morale necessario a non lasciar passare quel tentativo.
Guido Quazza










![integrazione ed allargamento 2012 [modalità compatibilità] · La firma del Trattato di Roma The European Union Trattato di Maastricht •Nasce l’Unione europea •Costruzione](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5c69dc8909d3f25e418b8f58/integrazione-ed-allargamento-2012-modalita-compatibilita-la-firma-del-trattato.jpg)