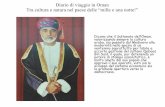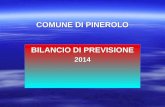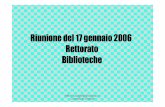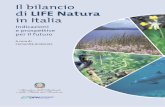Le Scienze Economiche Attività economica e natura del problema economico
LA NATURA ECONOMICA DEL BILANCIO … 1. Introduzione 1 2. La natura economica del bilancio...
Transcript of LA NATURA ECONOMICA DEL BILANCIO … 1. Introduzione 1 2. La natura economica del bilancio...
Università degli Studi Dipartimento didi Brescia Economia Aziendale
Dicembre 2007
Paper numero 72
Mario NICOLIELLO
LA NATURA ECONOMICADEL BILANCIO D’ESERCIZIO
NELLA DISCIPLINA GIURIDICADEGLI ANNI 1942, 1974, 1991, 2003
Università degli Studi di BresciaDipartimento di Economia AziendaleContrada Santa Chiara, 50 - 25122 Bresciatel. 030.2988.551-552-553-554 - fax 030.295814e-mail: [email protected]
AR
TI G
RA
FIC
HE
AP
OLL
ON
IO
LA NATURA ECONOMICA
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA DISCIPLINA GIURIDICA
DEGLI ANNI 1942, 1974, 1991, 2003
di Mario NICOLIELLO
Dottorando di ricerca in Economia Aziendale Università degli Studi di Brescia
Indice
1. Introduzione ............................................................................................... 1
2. La natura economica del bilancio d’esercizio............................................ 5
2.1. I presupposti per la redazione nel sistema del reddito ...................... 5
2.2. Grandezze, metodi e strumenti della contabilità generale................. 7
2.3. Dalla contabilità generale al bilancio d’esercizio........................... 10
2.4. Il bilancio nelle sue forme giuridiche............................................... 14
3. Il Codice civile del 1942 e la mini-riforma del 1974............................... 15
3.1. Introduzione...................................................................................... 15
3.2. La novella codicistica del 1942........................................................ 17
3.3. La mini-riforma del 1974 ................................................................. 22
4. La IV direttiva Cee e il Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 .......... 25
5. La riforma del diritto societario del 2003 e l’introduzione dei principî contabili internazionali............................................................................. 30
5.1. Il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 ................................... 30
5.2. I principî contabili internazionali .................................................... 33
6. Considerazioni conclusive ....................................................................... 38
Bibliografia .................................................................................................. 42
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
1. Introduzione
Il bilancio d’esercizio1 è il modello che misura e valuta l’economicità2 della gestione con riferimento ad un periodo di tempo definito, convenzionalmente di durata annuale come statuito, ormai da molti decenni, dalle normative civilistiche3.
Tale modello raccoglie il sistema di valori d’azienda in sintesi costruite sull’assemblamento – secondo processi noti in letteratura4 – di i) quantità economiche, ii) valori stimati, iii) valori congetturati.
1 “Non si può trattare del bilancio senza premettere alcuni chiarimenti sui molteplici
significati, spesso confusi e controversi, le più volte convenzionali, che si usano attribuire con maggiore o minore esattezza alla parola bilancio. (…) Il significato originario della parola bilancio deve senza dubbio ricercarsi nel procedimento di saldo dei conti, connesso con quello di chiusura dei conti stesso. Col passare del tempo l’espressione bilancio ha finito per assorbire, in relazione alla funzione dimostrativa assunta dal saldo, il significato assai più largo di procedimento di valutazione del saldo, e quindi di determinazione del risultato. Ed ecco quindi che nella parola bilancio si fa manifesto il duplice significato: di contenuto strettamente contabile di saldo dei conti per quanto si riferisce alla sua derivazione dal procedimento formale di chiusura dei conti; di contenuto tecnico-amministrativo per quanto si riferisce alle complesse operazioni di studio, in forza delle quali i risultati contabili esposti per bilancio si piegano alle esigenze dimostrative e si conducono ad essere espressione, la più corretta possibile, dei risultati di un complesso di operazioni modificative di un fondo di valori precedentemente determinati”. A. Ceccherelli, Il linguaggio dei bilanci: formazione e interpretazione dei bilanci commerciali, quarta ediz., Le Monnier, Firenze 1947.
2 Col termine economicità si intende la capacità dell’impresa di remunerare congruamente e soddisfare i portatori di interessi istituzionali e gli altri interlocutori sociali, svolgendosi in condizioni di autosufficienza economica quando quest’ultima condizione è prescelta dal soggetto economico dell’impresa stessa. AA.VV., Il bilancio di esercizio d’impresa, Giuffrè, Milano 2000, p. 4. Per approfondimenti sul concetto di economicità si rimanda a G. Airoldi-G. Brunetti-V. Coda, Corso di economia aziendale, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 161 e segg.
3 L’obbligo di redazione annuale del bilancio discende dall’art. 2364 del Codice che da un lato stabilisce come l’assemblea ordinaria debba essere convocata almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, dall’altro dispone come fra i compiti dell’assemblea ci sia anche l’approvazione del bilancio.
4 Sul punto si vedano G. Zappa, Il Reddito d’impresa, Giuffrè, Milano 1950; P. Onida, Il bilancio d’esercizio nelle imprese, Giuffrè, Milano 1951; P. Onida, La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d’azienda, Giuffrè, Milano 1970; P. Onida, Economia d’azienda, Utet, Torino 1971; A. Provasoli, Il bilancio d’esercizio destinato a pubblicazione, Giuffrè, Milano 1974; E. Simonetto, Il bilancio d’esercizio, Cedam, Padova 1976; C. Masini, Lavoro e risparmio, Utet, Torino 1979; A. Matacena, Introduzione allo studio del bilancio d’esercizio, Clueb, Bologna 1979; S. Terzani, Introduzione al bilancio d’esercizio, Cedam, Padova 1985; V.Coda-G.Frattini, Valutazioni di bilancio, Luev, Venezia 1986; F. Superti Furga, Reddito e capitale nel bilancio d’esercizio, Giuffrè, Milano 1991; M. Cattaneo-P. Manzonetto, Il bilancio d’esercizio, Etas, Milano 1997; C.
1
Mario Nicoliello
Frutto precipuo di queste sintesi sono il capitale e il reddito, poi rappresentati nel plesso noto dei relativi prospetti di bilancio. La via tramite cui si perviene a determinare tali valori economici complessi è antitetica nei sistemi reddituali rispetto, ad esempio, al sistema anglosassone: nei primi, soprattutto se strettamente zappiani, si definisce in via previa il reddito di esercizio (quantità-flusso) e in via derivata il capitale di funzionamento (quantità-fondo); nel secondo viceversa – per il quale il capitale assume primigenia rilevanza rispetto al reddito – il bilancio determina dapprima la quantità stock e in via derivata il flusso reddituale.
I prospetti in parola rappresentano un documento nel quale si riflette il comportamento dell’impresa in termini quantitativi, sebbene mediato da processi di valutazione (e nondimeno di calcolo e di classificazione). I valori economici così accolti dai bilanci – espressione di forme quali-quantitative prescelte dai redattori – risultano quindi prima ancora dalle scelte attuate dai responsabili del governo aziendale.
Noti sono i limiti – oggettivi e, pure, soggettivi, vuoi per l’intervento dei redattori vuoi rispetto alle aspettative dei terzi – che il bilancio possiede quale documento complesso. Alcuni fra quelli sono venuti riducendosi negli anni, pur nel diffuso incremento delle aspettative informative dei terzi. Tuttavia, sebbene tali premesse, il bilancio d’esercizio costituisce lo strumento di sintesi più efficace per offrire elaborate informazioni riguardanti la gestione dell’impresa esaminata nell’aspetto economico (ossia reddituale, patrimoniale e, indirettamente, finanziario).
Il bilancio d’esercizio destinato a pubblicazione, nello stato attuale della normativa, si compone di tre documenti (Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa) nonché di un allegato (Relazione sulla gestione) avente tuttavia valore di completamento sostanziale. Questi documenti, unitamente intesi, formano un tutto inscindibile e congiuntamente concorrono alla rappresentazione della situazione economica dell’impresa in funzionamento.
Il bilancio ha un ruolo informativo poiché offre, a posteriori, informazioni sull’andamento economico della gestione e sugli elementi che compongono il capitale di funzionamento.
Tali informazioni sono messe a disposizione dei soggetti portatori di interessi convergenti dell’impresa5, i quali rappresentano diverse categorie,
Caramiello, Capitale e reddito, Giuffrè, Milano 1993; G. Savioli, Verità e falsità nel bilancio d’esercizio, Giappichelli, Torino, 1998; G. Catturi, La redazione del bilancio d’esercizio, Cedam, Padova 1999; A. Bandettini, Il bilancio d’esercizio, Cedam, Padova 1999; AA.VV. (a cura di A. Palma), Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, Giuffrè, Milano 1999.
5 Sono i cosiddetti stakeholders, cioè il complesso dei soggetti che sviluppano interessi di vario genere nei confronti dell’impresa e che, riponendo in essa precise aspettative,
2
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
detentrici di obiettivi conoscitivi anche divergenti e dagli interessi talora conflittuali.
Al fine di contemperare queste diverse finalità informative del bilancio, si è negli ultimi decenni sviluppata la standardizzazione delle modalità espositive dei dati in esso contenuti. Ciò ha portato all’emanazione di diversi atti legislativi che hanno imposto alle società l’adozione di rigidi schemi di rappresentazione dei dati, al fine di poter presentare un documento quanto più neutrale possibile.
Operazione, quest’ultima, ardua e difficilmente raggiungibile considerando che, nonostante i tentativi effettuati dal Legislatore di convogliare in unità le diverse attese informative riposte sul bilancio – in particolare per il contesto italiano riconducendo a sintesi la natura economica del documento, il suo necessario stampo giuridico e gli effetti, preminentemente di ordine tributario, da esso scaturenti –, il tentativo di standardizzare il documento al fine di renderlo neutrale nei confronti dei terzi risulta forse non del tutto riuscito, in quanto la discrezionalità concessa ai redattori è risultata preminente nell’indirizzare i risultati presentati nel prospetto di sintesi talora verso una categoria particolare di stakeholders, talaltra verso una diversa collezione di soggetti interessati al bilancio.
Occorre rimarcare, poi, che quantunque il bilancio d’esercizio sia sempre stato al centro di studi economico-aziendali di sempre maggiore approfondimento, per lungo tempo la normativa civilistica si è rivelata non sempre adeguata rispetto alle impostazioni via via elaborate dalla dottrina.
Poste tali premesse, in questa sede si vuole sottolineare come l’attuale apparato normativo in materia di bilancio sia il risultato di un percorso evolutivo compiuto nel corso del tempo6:
1. il punto di partenza può essere ravvisato nel 1942 con la promulgazione
dell’attuale Codice civile, che nella sua forma primaria disciplina il
perseguono i propri obiettivi cercando di condizionare quelli dell’impresa, o qualora si presentino le condizioni, adoperandosi per influenzarne i comportamenti. Si confronti A. Codini, L’impresa e il suo governo, in M. Martellini (a cura di), L’impresa: Economia e gestione, Giappichelli, Torino 2003.
6 “L’evoluzione della normativa civilistica prende atto della necessità di una diversa rappresentazione delle realtà aziendali più conformi alle mutate esigenze d’ambiente e maggiormente in grado di compararsi con realtà di aree geografiche destinate ad operare nell’ambito di un mercato unitario. La dottrina contabile, che ha contribuito in misura determinante all’elaborazione e formalizzazione di tali esigenze, deve valutare se le metodologie e le tecniche proposte siano tuttora valide”. F. Pezzani, L’economia d’azienda e le determinazioni quantitative. L’evoluzione dell’informativa di bilancio, in F. Pezzani (a cura di), Il bilancio di esercizio nell’informativa esterna d’impresa, Giuffrè, Milano 1993, p. 33.
3
Mario Nicoliello
contenuto dello Stato patrimoniale e i criteri di valutazione delle classi di valore di bilancio;
2. si prosegue nel 1974 con l’emanazione della Legge 216, che introduce nel Codice la disciplina del contenuto del Conto profitti e perdite (l’attuale Conto economico) e della Relazione degli amministratori;
3. nel 1991 viene poi emanato il Decreto legislativo 127, che recepisce nel nostro ordinamento la IV direttiva Cee (25 luglio 1978) sui conti annuali delle società; la novella prevede schemi precisi e dettagliati sia di Stato patrimoniale sia di Conto economico e, in luogo della Relazione degli amministratori, introduce due nuovi prospetti: la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione.
Tale apparato legislativo è, nella sostanza, ancora in vigore attualmente, anche se dal 1991 ad oggi vi sono stati anche ulteriori interventi legislativi che hanno mutato alcune regole in tema di bilancio. 4. In particolare occorre citare il Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6,
con il quale è stato riformato il diritto societario. In tale sede, la principale novità introdotta in tema di bilancio è consistita in una rigorosa separazione delle esigenze civilistiche dalle tributarie, con la disposizione, attraverso l’eliminazione di qualsiasi riferimento altro, che i rendiconti economici e patrimoniali siano redatti in ottemperanza alle sole disposizioni del Codice civile.
5. Gli ultimi interventi normativi, in ordine cronologico, sono stati apportati:
a. con il Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394 che, recependo parzialmente la direttiva comunitaria 65/2001, amplia l’informativa di bilancio, introducendo nuove disposizioni nel Codice inerenti l’obbligo di fornire in Nota integrativa informazioni sugli strumenti finanziari derivati e di inserire nella Relazione sulla gestione informazioni sui rischi associati agli strumenti finanziari posseduti dall’impresa;
b. con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che disciplina la transizione ai principî contabili internazionali.
c. da ultimo, con il Decreto approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 25 gennaio 2007 che integra il contenuto della Relazione sulla gestione (richiedendo “un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente” della situazione della società) e della Relazione dell’organo di controllo contabile.
Obiettivo del presente lavoro è analizzare le modalità con cui le diverse
riforme legislative succedutesi nel tempo (1942, 1974, 1991 e 2003)
4
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
abbiano tradotto in norme positive la natura economica del bilancio d’esercizio depositato; infatti, il bilancio, prima di essere un documento pubblico, è un atto interno di gestione e la sua redazione, oltre che uniformarsi alle norme di legge, deve seguire i corretti criteri ragioneristici.
Pertanto, prima di analizzare i singoli interventi di riforma della disciplina bilancistica, nel prossimo paragrafo sarà delineata – per quanto in maniera sintetica e certamente non esaustiva – la logica prettamente economica del bilancio, che qualifica la natura intrinseca del documento destinato a pubblicazione.
Successivamente, nel paragrafo terzo, si delineeranno gli aspetti peculiari della disciplina civilistica del bilancio nella sua forma originaria del 1942 e in quella successiva alle modifiche del 1974.
Il paragrafo quarto, invece, affronterà l’argomento legato alla IV direttiva Cee sui conti annuali delle società e al suo recepimento nell’ordinamento italiano.
Il paragrafo quinto, poi, da un lato evidenzierà i riflessi sul bilancio della riforma del diritto societario del 2003, dall’altro allargherà la prospettiva dell’analisi indirizzandola sulle conseguenze connesse all’adozione dei principî contabili internazionali.
L’ultimo paragrafo, infine, conterrà alcune considerazioni conclusive.
2. La natura economica del bilancio d’esercizio
2.1. I presupposti per la redazione nel sistema del reddito
Molteplici sono i presupposti per la redazione – e l’esistenza medesima – del bilancio d‘esercizio, e noti in letteratura. Fra quelli, riferendosi in generale al sistema del reddito, principalmente i seguenti:
1. la continuità nel tempo dell’attività aziendale; soltanto assumendo
questa prospettiva, infatti, il ragionamento logico di valutazione può condurre al calcolo di un reddito – che in realtà fluisce nel tempo – e del derivato capitale di funzionamento in un istante, e assegnarli all’esercizio e al suo momento di chiusura;
2. la costruzione dell’esercizio quale unità economica relativa, mediante: a. l’assegnazione allo stesso delle operazioni che, pur non
essendosi manifestate dal punto di vista monetario, gli competono nel profilo reddituale;
b. la rettifica delle operazioni manifestatesi dal punto di vista monetario ma non di sua competenza;
5
Mario Nicoliello
c. l’assegnazione all’esercizio, secondo processi di stima-congettura, di valori non-monetari derivanti in primis dal processo di ammortamento delle immobilizzazioni e di valorizzazione delle rimanenze finali7.
Tali presupposti si incardinano poi negli altri – così preesistenti da non venire normalmente menzionati – e che consistono tuttavia, con rilievo anche tecnico e valoriale: - nella definizione della moneta di conto e delle tecniche necessarie al
variare del suo valore; ne derivano gli scenari e i bilanci di rivalutazione (che conducono alla determinazione del capitale strumento della futura gestione di funzionamento)8;
- nella natura non-originaria del bilancio d’esercizio; tale documento infatti deriva, e conseguentemente trae fondamento, da due elementi che cronologicamente precedono la sua formazione: la contabilità generale e il processo logico-contabile di chiusura dei conti.
Il bilancio, invero, è di stretta derivazione contabile9; perciò alla stessa
stregua della contabilità generale: si fonda sul metodo della partita doppia e sulle sue procedure tecniche, dipende come struttura di base dagli obiettivi della contabilità medesima e dalle convenzioni in essa accolte, porta con sé gli errori, le incertezze e le indeterminazioni tipiche della contabilità sistematica10.
7 Per approfondimenti su questa tre prospettive si rimanda ai lavori noti di: P. Onida, Il
bilancio d’esercizio, cit., 1951; C. Masini, L’economia delle imprese industriali di medie dimensioni nelle rilevazioni d’azienda, Giuffrè, Milano 1963; Aldo Amaduzzi, L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, Utet, Torino 1963; A. Provasoli, Il bilancio d’esercizio destinato a pubblicazione, cit., 1974; V. Coda-G. Frattini, Valutazioni di bilancio, cit., 1986; F. Superti Furga, Reddito e capitale nel bilancio d’esercizio, cit., 1991.
8 Si confronti C. Masini, La dinamica economica nei sistemi dei valori d’azienda: valutazioni e rivalutazioni, Giuffrè, Milano 1960.
9 Cfr. P. Onida, La logica e il sistema, cit., 1970 e R. Camodeca, L’iter formativo del bilancio d’esercizio, Cedam, Padova 2000.
10 Gli errori (asserzioni false non conformi alla realtà) derivano da una non corretta: classificazione dei dati; misurazione delle grandezze monetarie e non monetarie; formazione delle serie di valori di conto; imposizione e controllo delle ipotesi di lavoro.
Le incertezze (cioè dei limiti di conoscenze) derivano: dalla determinazione della durata del periodo tipico da analizzare; dalla determinazione di valori relativi a processi di produzione in corso al termine del periodo amministrativo.
Le indeterminazioni (legate all’impossibilità logica di attribuire un’unica misura agli aspetti quantitativi di un fenomeno) derivano dalla presenza di stime e congetture. La differenza tra questi due ultimi termini consiste nel fatto che i caratteri ipotizzati nelle stime
6
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
La corretta tenuta della contabilità rappresenta, dunque, la prima fase del complesso ragionamento economico-tecnico che conduce alla formazione del bilancio d’esercizio.
Siffatto documento, inoltre, viene redatto da persone e, in quanto tale, può essere visto come uno “strumento di comportamento nelle mani dei compilatori per favorire reazioni favorevoli dei terzi nei confronti dell’impresa”11. In questa logica non esiste un bilancio oggettivo, in quanto esso esprimerà sempre i giudizi di valore di chi governa l’impresa e sarà temprato dalle modalità comportamentali del soggetto economico.
Torna di conseguenza il tema antico delle “politiche di bilancio” che pare ineliminabile dalla scena economico-tecnica del bilancio destinato a pubblicazione, non fosse che per ragioni tributarie nonché degli “atti di disposizione” che possono conseguirne12.
2.2. Grandezze, metodi e strumenti della contabilità generale Prima di analizzare la normativa civilistica occorre dunque considerare la
“logica economico-ragioneristica” che sottintende la redazione del bilancio frutto diretto della contabilità generale: strumento informativo da un lato, e atto di gestione dall’altro.
Le rilevazioni di contabilità generale prendono forma da processi di osservazione della realtà, intesa come operazioni che si svolgono nel continuo divenire della gestione d’impresa. Oggetto di rilevazione sono solo le operazioni esterne di gestione13 e non le operazioni interne, quelle attraverso le quali si effettua la trasformazione fisico-tecnica dei beni. È
saranno verificabili in futuro, quelli ipotizzati nelle congetture, invece, non sono verificabili ex-post singolarmente. Sul punto si confronti M. Cattaneo-P. Golia-P. Manzonetto, Il bilancio d’esercizio nelle imprese: finalità e struttura, Etas, Milano 1989.
11 M. Cattaneo-P. Manzonetto, Il bilancio d’esercizio, cit., p. 27. In particolare gli autori ricordano che i compilatori sono espressione del soggetto economico, cioè l’insieme delle “persone o enti cui di fatto fanno capo gli interessi pro tempore prevalenti nell’impresa”. Il riferimento è quindi ai portatori del capitale di comando ed ai manager che compongono l’alta direzione aziendale. Nel prosieguo dell’opera si afferma che “l’utilizzo del bilancio come strumento di comportamento tende a ridursi quanto più rigida è la regolamentazione pubblica in materia ed anche quanto più vasta, col tempo, diventa la gamma degli interessi umani che entrano a comporre il soggetto economico dell’impresa”.
12 Per un approfondimento sul tema delle politiche di bilancio si rimanda a M. Pini, Politiche di bilancio e direzione aziendale, Etas Libri, Milano 1991.
13 Tipiche operazioni esterne sono quelle di investimento (acquisto di fattori produttivi), disinvestimento (vendita di beni e servizi) e finanziamento (a titolo di capitale proprio o di terzi).
7
Mario Nicoliello
questo un profilo caratteristico della contabilità, che si riflette inevitabilmente anche nel bilancio14.
Dalle operazioni esterne si ricavano diverse quantità monetarie, le quali a seconda della loro misurabilità più o meno diretta e certa, possono distinguersi in quantità economiche, stime e congetture.
Le quantità economiche sono determinabili mediante misurazione effettiva, attuata tramite l’unità di misura che definisce la grandezza stessa15. Le stime sono invece quantità determinabili mediante processi di previsione fondati su ipotesi verificabili ex-post16. Le congetture sono infine quantità determinabili solo tramite processi di calcolo basati su finzioni che non saranno verificabili nel concreto17.
Una volta determinate le diverse quantità, in due fasi successive i valori vengono classificati. In primo luogo, essi si suddividono in relazione alla propria natura in numerari o non numerari18, successivamente si classificano in relazione alla spiegazione che forniscono dell’evento rappresentato. Tale suddivisione consente di rappresentare con chiarezza e trasparenza i valori che connotano l’assetto economico (reddituale, patrimoniale, finanziario) dell’impresa e la conseguente dinamica delle sue operazioni di gestione. Il
14 “Il limite informativo del bilancio non risiede tanto nei vincoli posti alla contabilità
generale che funziona con rilevazioni a consuntivo dei fatti amministrativi, quanto nella necessità di reinterpretare tali risultati alla luce delle eventuali modifiche sopraggiunte nell’ambiente esterno e nelle condizioni di gestione aziendale dal momento in cui le decisioni hanno avuto luogo al momento della presentazione pubblica”. F. Pezzani, op.cit., p. 32.
15 Le quantità economiche costituiscono l’immediata espressione quantitativa di accadimenti economici, di azienda o di mercato, misurati direttamente per il tramite del metro monetario di riferimento. Esse danno origine a valori oggettivi, per i quali il concetto di verità esprime una corrispondenza effettiva tra realtà e espressione quantitativa della realtà. Quantità economiche sono: le rimanenze di valori numerari certi, i valori nominali di debiti e crediti, le variazioni numerarie certe e assimilate, i costi e i ricavi d’esercizio, i costi comuni a più di due esercizi se formati con scambi monetari con altre aziende. Si confronti C. Masini, op.cit., 1963 ed altri fra cui V. Coda-G. Frattini, op.cit., 1986.
16 I valori stimati presentano un grado di approssimazione al vero tanto più elevato quanto più risultano verificate a posteriori le premesse logiche alla base delle previsioni effettuate. Sono stime i valori numerari presunti e i correlativi valori non numerari rilevati durante o al termine del periodo amministrativo. Cfr. V. Coda-G. Frattini, op.cit., 1986, pp. 33 e seguenti.
17 I valori congetturati non possono trovare riscontro nella dinamica degli accadimenti cui si riferiscono, non essendo possibile la verifica delle ipotesi adottate. Al riguardo può soltanto esprimersi un giudizio di coerenza delle ipotesi-finzione adoperate rispetto ai caratteri e al divenire delle combinazioni produttive. Sono congetture le quantità scaturenti dalla ripartizione di valori comuni a diversi esercizi. Ibidem.
18 I valori numerari sono il denaro e i crediti e debiti di regolamento. I valori non numerari si suddividono a loro volta in: finanziari (crediti e debiti di finanziamento e valori attinenti al capitale proprio) e reddituali (costi – a fecondità semplice o ripetuta – e ricavi).
8
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
tema è peraltro nella prassi meno ovvio, e largamente dipende i) dalla struttura del piano dei conti, nonché ii) dalle procedure del medesimo.
Dopo l’individuazione e la classificazione dei valori, per effettuare le rilevazioni di contabilità generale occorrono strumenti, metodi e regole operative.
Lo strumento della rilevazione è il conto19; l’insieme dei conti formano il piano dei conti, che è la risultanza del processo di classificazione dei valori aziendali20.
Il metodo usato nella rilevazione è quello della partita doppia, che racchiude tre peculiarità: ogni accadimento viene misurato in due aspetti, uno originario, l’altro derivato; viene utilizzata una sola unità di conto; ad una o più variazioni di segno “Dare” corrisponde sempre una o più variazioni di segno “Avere”.
Infine, le regole operative concernono il funzionamento dei conti, il momento in cui scatta l’obbligo di rilevazione21 e i supporti22 su cui essa viene effettuata.
Il processo di selezione dei conti, di assegnazione di un codice del piano dei conti a un evento rilevato e la conseguente scrittura di rilevazione sono momenti che condizionano le modalità di rappresentazione dei valori che formano l’esercizio. Queste fasi incidono quindi i) sulla prima fisionomia che il bilancio assume, ii) sull’attendibilità del documento nel suo complesso, iii) sulla capacità del medesimo di rappresentare le coordinazioni lucrative d’impresa, e indirettamente le sue combinazioni produttive.
19 Secondo Zappa il conto è lo strumento che rappresenta “una serie ordinata di scritture
riflettenti un determinato oggetto, ed aventi per scopo di porne in evidenza la variabile e commensurabile grandezza”. G. Zappa, Il reddito, cit., 1950, p. 103.
20 Il piano dei conti possiede due caratteristiche importanti: la variabilità, in quanto muta in relazione del tipo di azienda in cui viene impiegato; la flessibilità: perché si costruisce via via che l’attività dell’azienda prosegue nel tempo. Cfr. R. Camodeca, op.cit., capitolo terzo.
21 La rilevazione contabile per convenzione si effettua nel momento di variazione della moneta o del credito risultante dai documenti originari. Quindi viene posta in essere quando si emette la fattura o un documento equipollente (ad es. il cedolino paga) oppure quando si incassano delle somme o si effettuano dei pagamenti. Ibidem.
22 Ogni rilevazione avviene su due supporti: il libro mastro – l’insieme dei conti utilizzati dall’azienda, dove i valori vengono registrati in maniera sistematica in base all’oggetto e in relazione alla classificazione effettuata – e il libro giornale, ove si registrano giorno per giorno tutte le operazioni effettuate in modo cronologico. Cfr. P.Onida, La logica e il sistema, cit., 1970.
9
Mario Nicoliello
2.3. Dalla contabilità generale al bilancio d’esercizio
Il bilancio d’esercizio è frutto di un complesso di valutazioni interdipendenti fra loro, e inoltre nel tempo (fra due esercizi nel caso ad esempio delle rimanenze, o più di due esercizi per i valori pluriennali, fra i quali anche i lavori in corso).
Ciascuna offre cioè elementi per altre, in maniera da non imputare utili all’esercizio se non si accerta – secondo Onida – i) che nel complesso della gestione la totalità dei costi sarà coperta dai ricavi, ii) che il reddito attribuibile all’esercizio non eccederà quello corrispondente alla capacità di reddito dell’impresa nel lungo andare23.
In termini più realistici (Masini) pare opportuno concorrere alla determinazione di risultati: i) spingendosi ex ante a stimare valori nel solo futuro prevedibile, ii) contemperando i valori prescelti con le condizioni di settore e di mercato (dunque di concorrenza) anche previste future24.
Il capitale di bilancio è, dunque, un sistema di valori la cui attendibilità è condizionata dall’avverarsi degli sviluppi aziendali previsti ed è limitata dallo specifico scopo, ossia la determinazione del reddito d’esercizio, per cui l’intero complesso valutativo (esprimibile mediante la formulazione di previsioni, stime e congetture) viene posto in essere. In altre parole, quindi, il capitale di bilancio è la risultante di un definito giudizio sul futuro sviluppo economico dell’azienda, sviluppo cui sono vincolati i beni oggetto di valutazione; ne consegue che ai relativi valori può essere riconosciuta una autonomia assai limitata.
Se si eccettuano infatti i fondi liquidi (e assimilati), il capitale di bilancio di un’azienda risulta da un accostamento di valori determinati mediante stime e congetture. La varietà di queste è motivo di rilevante eterogeneità tra i valori componenti il capitale medesimo, eterogeneità di cui occorre dare conto, chiarendo la specie di valori non liquidi componenti il capitale di bilancio25.
23 P.Onida, Il bilancio,cit., 1951. 24 C. Masini, La dinamica, cit.; I bilanci d’impresa. Principi e concetti, Giuffré, Milano
1957; L’ipotesi e l’economia di azienda, id., ib., 1961. 25 “Grande rilievo ha anche la classificazione dei valori del capitale, i cui criteri non
dovrebbero risiedere nelle caratteristiche tecniche o nella specie giuridica dei beni da valutare ma nella specie di operazione o gruppo di operazioni cui si riferiscono, in maniera che dal bilancio risultino la grandezza e la specie di valori non liquidi e delle operazioni in corso, il cui esito determina il reddito d’esercizio e la grandezza del capitale di funzionamento. Lo stesso dicasi per la formazione della tavola del reddito d’esercizio, che è problema oltre che di valutazione anche di corretta classificazione dei molteplici valori analitici determinati, concorrenti alla formazione del reddito”. AA.VV., Il bilancio di esercizio d’impresa, cit., p. XI.
10
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
L’attendibilità delle determinazioni del reddito di periodo e del correlato capitale di funzionamento26 dipendono: • dalla proporzione esistente tra le quantità economiche rispetto alle stime
e alle congetture; maggiore sarà il numero delle prime, maggiore risulterà l’attendibilità del bilancio;
• dall’ampiezza delle previsioni future verso le quali deve spingersi chi redige il bilancio d’esercizio, che possono essere diverse a seconda della specie, dell’entità e della durata delle operazioni in corso di svolgimento correlate alla specifica realtà d’azienda27.
Come sottolineato da Zappa, reddito e capitale non sono espressione di
fenomeni distinti, ma di due fasi in cui i valori d’impresa possono essere considerati, o di due modi per rappresentare uno stesso fenomeno. Il reddito esprime la visione dinamica di un complesso investimento nell’attività d’impresa, di cui il capitale rappresenta l’aspetto stazionario in un istante 28.
26 Scrive Zappa: “La chiarita natura economica del capitale e del reddito, che ci fa
apparire il reddito come valore originario ed il capitale come valore derivato, non sembra nota a coloro che, non adusati all’analisi dei fenomeni economici, vedono in essi unicamente il substrato tecnico, materiale, sovente espresso necessariamente in quantità non monetarie. (..) La nozione del capitale come complesso economico si oppone specialmente alla credenza che nel reddito vede un flusso di ricchezza che si diparte dal capitale. Il reddito quasi apparirebbe come il necessario frutto materiale di una forza produttiva preesistente, il capitale, che a sua volta non sarebbe che uno strumento materiale di produzione. (..) In senso economico, dunque, il capitale è prodotto dal reddito, se così è lecito dire; non il reddito dal capitale”. G. Zappa, op.cit., pp. 82-83.
27 Tanto più ampie sono le previsioni sottostanti alla redazione del bilancio d’esercizio, tanto più problematica è l’attendibilità dei valori stimati e congetturati che lo compongono. “Secondo l’entità, la natura e la durata delle operazioni in corso, varia evidentemente l’ampiezza delle previsioni richieste dalla formazione del bilancio. È noto, infatti, che, a parità di altre condizioni, l’attendibilità dei bilanci d’esercizio può risultare ben diversa dall’una all’altra azienda e da tempo a tempo, in una medesima azienda, a motivo appunto della ineguale ampiezza delle previsioni che la composizione di quei bilanci richiede. Quanto più lungo è il tempo che intercorre tra il sostenimento dei costi ed il sostenimento dei ricavi direttamente o indirettamente correlativi ai primi, tanto più vaste sogliono essere le previsioni sulle quali deve fondarsi la determinazione del capitale per la rilevazione del reddito d’esercizio”. P. Onida, Il bilancio d’esercizio, cit., p. 66.
28 “Se attentamente si considera la formazione contabile del reddito e del capitale, si scorge che tali voci non si usano per designare distinti fenomeni connessi, e concetti correlativi, ma invece, come anche l’economia concreta insegna, due modi di apparire di uno stesso fenomeno, o piuttosto due fasi nelle quali i valori aziendali possono essere considerati. Il capitale esprime lo stato complessivo delle attività e delle passività che, conferite nell’investimento di impresa, concorreranno alla formazione dei redditi venturi; il reddito invece manifesta il divenire di componenti attribuiti ad un dato periodo di tempo. Del reddito potrebbe affermarsi ch’esso dà la visione dinamica di quel complesso
11
Mario Nicoliello
Seguendo l’impostazione di Onida, il reddito d’esercizio è un risultato economico astrattamente attribuito al periodo amministrativo. La gestione aziendale, infatti, è destinata a fluire ininterrottamente nel tempo dal momento della costituzione fino a quello della messa in liquidazione. Il calcolo del reddito, conseguentemente, può essere svolto scegliendo due alternative come tempo di riferimento: l’intera vita aziendale o il periodo amministrativo (arco temporale di solito di durata annuale). Nel primo caso si calcola il reddito totale, nel secondo il reddito d’esercizio29.
Riassumendo quanto esposto sino a questo punto, si può quindi ricordare che a) i valori accolti tra le attività e le passività dello Stato Patrimoniale sono espressione economica di processi in corso di svolgimento, riferiti alla data di chiusura ma valutati e integrati successivamente anche in forza di legge; b) la determinazione di tali valori è suscettibile di stime e/o congetture, queste pertanto funzionali all’attribuzione del reddito all’esercizio30.
Nell’impostazione teorica presentata da Gino Zappa e dai suoi allievi diretti e indiretti, il valore del capitale di bilancio non può avere significato autonomo, ma è effetto della determinazione dinamica dei redditi d’impresa31. Ora, essendo il reddito d’esercizio una quantità configurabile in funzione delle ipotesi soggettive che conducono alla sua determinazione,
investimento, del quale il capitale esprime l’aspetto statico. Per usare la apodittica terminologia invalsa in recenti dottrine economiche, si può dire che il reddito esprime il movimento, o la corrente, o il flusso di valori, accertato in relazione al tempo che intercorre tra due rilevazioni della grandezza di quel fondo, o stock di valori, che è il capitale”. G. Zappa, op.cit., p.279.
29 Il reddito totale è una quantità economica certa (cioè calcolata in modo oggettivo), realizzata (ovvero la risultanza reddituale coincide con quella monetario-finanziaria in quanto la gestione è ultimata) e ipotetica (perché non trova riscontro nella realtà).
Il reddito d’esercizio, invece, è una grandezza soggettiva (che risente delle ipotesi-finzioni e delle scelte fatte da chi l’ha calcolata), non realizzata (perché non trova riscontro in forma monetaria) e concreta (perché è riscontrabile nella realtà).
30 Cfr. P. Onida, Il bilancio, cit. 31 Infatti, al fine di permettere la rilevazione di redditi di esercizio che non abbiano a
rivelarsi come misurazioni monetarie prive di fondamento in periodi successivi, il criterio generale di valutazione degli elementi attivi e passivi del capitale di funzionamento dovrebbe essere ispirato dalla previsione del possibile esito che le operazioni in corso di svolgimento avranno nei futuri esercizi. Nel caso in cui si effettuassero previsioni errate circa la futura manifestazione economica dei processi in corso, si correrebbe il rischio di giungere alla determinazione ed, eventualmente, alla distribuzione di utili di esercizio puramente nominali, con l’immediata conseguenza di possibili erosioni del capitale; si potrebbe incorrere nella distribuzione di capitale in luogo di redditi conseguiti, intaccando le possibilità di economico perdurare dell’azienda. Cfr. P. Andrei, La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio, in AA.VV., Il bilancio di esercizio d’impresa, cit, p. 16.
12
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
ne consegue che pure il capitale di bilancio assume i connotati di quantità astratta.
In sintesi quindi il bilancio non è il risultato di pure e semplici operazioni aritmetiche su grandezze quantitative sempre oggettivamente misurabili, ma è soprattutto la sintesi di un “complesso ragionamento” sullo stato economico-finanziario dell’impresa e sulle sue prospettive, che si fonda in parte su fatti già verificati ma anche su circostanze ancora non manifestate, nonché su accadimenti futuri che sovente costituiscono solo semplici attese.
Il punto risulta meno ovvio di quanto non paia giacché su di esso si scontrano, fra gli altri, i convincimenti in tema di: 1) unicità-pluralità di bilanci; 2) opposizione-sovrapposizione eventuale fra verità e prudenza.
Ai due temi saranno dedicate brevi righe nel seguito. I) Da una lettura della dottrina aziendalistica che nel corso degli anni ha
prodotto riflessioni critiche sul tema del bilancio, emerge come la determinazione e la rappresentazione dei valori e delle complementari informazioni che formano le sintesi di esercizio debbano costituire espressione fedele del fine che ne ha sollecitato la formazione: affinché ciò avvenga gli strumenti utilizzati (principî, criteri e regole di valutazione) devono essere coerenti al fine stesso32.
In relazione al bilancio pubblico, oggi, la dottrina concorda nel ritenere inammissibile la coesistenza di una molteplicità di bilanci ufficiali riferiti ad uno stesso periodo e ad un medesimo oggetto di rilevazione. Si nega, dunque la possibilità di redigere tanti bilanci quanti sono i soggetti ai quali è destinato tale documento33. È da rilevare, invece, come in passato questa tesi non fosse unanimemente accettata dagli accademici in quanto alcuni studiosi ritenevano non solo ammissibile, ma addirittura auspicabile, la redazione di più bilanci differenziati34. Per la quasi totalità degli studiosi
32 A.M. Fellegara, Le valutazioni di bilancio nella logica civilistica, in AA.VV., Il
bilancio di esercizio d’impresa, cit., p. 110. Sul punto Onida osserva come in relazione al fine della determinazione del reddito d’esercizio, inteso come “risultato valevole agli effetti dell’eventuale distribuzione o consumo di utili” vadano ricercati i razionali principi di formazione del bilancio e dai principi si debbano desumere norme particolari di valutazione. L’Autore sottolinea, inoltre, come “considerata questa mutevole molteplicità di scopi che l’esperienza dimostra variamente operanti sulla determinazione, classificazione e formale rappresentazione dei valori di bilancio, la teoria non può che ammettere, per ipotesi, l’assegnazione al bilancio, di uno o più scopi fra loro compatibili e dedurre da essi, razionalmente, i criteri di formazione del bilancio medesimo”. P. Onida, Il bilancio, cit., p. 109.
33 Cfr. M.S. Avi, Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, Cedam, Padova, 1990, pp. 12 e segg.
34 Tra i diversi esponenti di questa corrente di pensiero si cita il Pantaleoni, che all’inizio del Novecento scriveva: “il bilancio è un sistema di simboli che hanno un significato convenzionale implicito nel fine del bilancio. (..) Se si prescinde da ogni fine in
13
Mario Nicoliello
odierni invece il bilancio deve essere unico e conseguentemente, viste le diverse esigenze informative dei potenziali utenti, questo prospetto non può che essere considerato il risultato di un “compromesso” fra una serie di interessi contrastanti35.
II) In tema di principio di prudenza occorre in primo luogo domandarsi se il concetto di true and fair view la escluda integralmente.
Occorre cioè chiedersi se il concetto classico della stessa – valutare le attività al minor valore di realizzo, le passività al maggior valore di estinzione, imputare all’esercizio i costi anche se presunti, i ricavi solo se realizzati36 – possa, e in taluni casi debba, coesistere con correttezza e verità. Per i valori stimati e congetturati infatti, correttezza e verità sono – e non possono non essere – convenzionali; donde la possibile esistenza di correttezze più o meno prudenti.
2.4. Il bilancio nelle sue forme giuridiche Chiarita quella che è, nella dottrina prevalente, la logica economica
sottostante la redazione del documento di sintesi periodica dell’attività gestionale, si passerà ora ad analizzare l’evoluzione temporale della
vista del quale un bilancio è redatto, attribuzioni di valore non possono più farsi, e quelle che come atto meccanico si facessero, non avrebbero alcun significato; se un senso viene loro dato da chi legge il bilancio, questi ha introdotto esplicitamente o surrettiziamente una qualche finalità del bilancio nella loro interpretazione. (..) Esistono una pluralità di bilanci sia quando il fine del bilancio è uno solo, sia quando si devono realizzare col bilancio fini diversi, cioè ottenere risposte a quesiti differenti”. M. Pantaleoni, Alcune osservazioni sull’attribuzione di valori in assenza di formazione di prezzi di mercato, in «Erotemi di economia», vol. secondo, Laterza, Bari 1925.
35 L’oggetto del bilancio d’esercizio è secondo Cattaneo ”l’espressione per la totalità delle classi d’interessi convergenti nell’azienda di produzione, della misura del risultato della gestione di un periodo amministrativo e del patrimonio di funzionamento, tenuto conto dell’attitudine dell’impresa a durare in condizioni economiche e finanziarie soddisfacenti per le classi d’interessi medesime, avuto riguardo al mantenimento della consistenza del patrimonio e alla destinazione del risultato d’esercizio. (..) Il bilancio d’esercizio è unico in quanto si riferisce alla ricerca di una conoscenza di base per la totalità degli interessi nell’impresa, riguardante l’attitudine a svolgersi in condizioni di equilibrio dinamico”. M. Cattaneo-P. Golia-P. Manzonetto, op.cit. Coda, invece, sostiene che “i diversi fini operativi perseguiti col bilancio non giustificano affatto una differenziazione e quindi una pluralità di bilanci, sempreché il bilancio d’esercizio venga concepito come strumento per conoscere il reddito d’esercizio e il capitale di bilancio. Gli scopi operativi influiscono sulla rilevazione solo nel senso che concorrono a delimitarne l’oggetto, ossia a precisare le esigenze conoscitive, ma non possono incidere sulla logica di formazione degli elementi di giudizio. I diversi scopi operativi possono quindi solo influire, in sede di interpretazione del bilancio, sul grado di approfondimento della conoscenza dei fenomeni che in bilancio sono sinteticamente rappresentati”. V. Coda-G. Frattini, op.cit.
36 F. Superti Furga, Il bilancio d’esercizio secondo la normativa europea, terza ediz., Giuffrè, Milano 1997, pp. 17-18.
14
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
disciplina giuridica concernente il bilancio d’esercizio, affrontando in particolare i seguenti aspetti:
la disciplina del bilancio d’esercizio nel Codice civile del 1942; la mini-riforma della società del 1974; il recepimento della IV direttiva Cee con il D.Lgs. 9 aprile 1991, n.
127; la riforma del diritto societario del 2003; l’introduzione dei principî contabili internazionali.
Nei paragrafi successivi l’attenzione sarà posta nell’analizzare se il
Legislatore abbia tradotto in norme di legge le indicazioni fornite dalla dottrina aziendalistica prevalente oppure se nel legiferare in materia bilancistica sia andato oltre le risultanti dottrinali, innovando quindi a proprio modo la disciplina, e proponendo così nuove sfide e nuovi spunti di riflessione alla ragioneria e all’economia aziendale.
L’analisi verterà più specificamente:
• sulla derivazione contabile del bilancio (e quindi sulla traduzione nel diritto positivo dell’impalcatura teorica – patrimonialista o reddituale – che sottintende la sua redazione);
• sulle finalità ad esso attribuite; • sui destinatari cui è diretto (cercando di comprendere se nello spirito
delle diverse riforme ci sia stata o meno la volontà di privilegiare una categoria particolare di stakeholders).
Si cercherà di osservare, inoltre, se il cambiamento dell’orientamento
legislativo osservabile in sessant’anni di riforme si accompagni a quello della dottrina aziendalistica, oppure se le due evoluzioni procedano in direzioni diverse.
3. Il Codice civile del 1942 e la mini-riforma del 1974
3.1. Introduzione
La dottrina aziendalistica e la ragioneria hanno prodotto regole e precetti per la determinazione del reddito di esercizio e del patrimonio di funzionamento; tuttavia le società, quando si apprestano alla redazione del bilancio annuale, sono tenute all’osservanza di quanto stabilito dalle norme
15
Mario Nicoliello
del Codice civile, che forma la principale fonte di riferimento in materia bilancistica37.
La disciplina giuridica sul bilancio d’esercizio risale, generalmente, al Code Napoléon. Tralasciando tuttavia per brevità le adozioni nazionali dello stesso, in Italia la disciplina post-unitaria risale al Codice di commercio del Regno, promulgato nel 1882. Precedentemente in materia di bilancio dettavano criteri gli statuti sociali delle imprese38.
Il Legislatore del 1882 aveva ritenuto che le esigenze informative sull’impresa potessero essere esaudite semplicemente con il disposto secondo il quale «il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili
37 Ai fini della redazione del bilancio le norme del Codice civile sono integrate dai
principî contabili emanati dalla dottrina ragioneristica e dalla prassi professionale. “Poiché i principi giuridici sono scarsamente flessibili per la lentezza con la quale mutano e, data la loro necessaria generalità, non sempre sono in grado di configurare la specificità degli oggetti di rilevazione, si rende necessaria la loro integrazione con un complesso di principi che colgano l’evoluzione dell’economia delle imprese e il suo riflesso nella pratica professionale. Sono questi i principi contabili che vengono elaborati dagli organismi professionali o comunque da enti investiti della necessaria autorità a promulgarli. Si tratta di generalizzazioni che si pongono contemporaneamente in una direzione induttiva nei confronti dell’esperienza, mentre procedono deduttivamente rispetto alla teoria economico-aziendale. Spetta ai principi contabili la funzione di rendere concretamente operanti le finalità di chiarezza, precisione e neutralità nella redazione del bilancio pubblico. Infatti essi limitano la discrezionalità degli amministratori, sia in ambito di rilevazione, sia relativamente al bilancio in ordine alla classificazione e alla valutazione delle voci. (..) Le regole prescritte dai principi contabili dovrebbero anche assicurare un certo grado di neutralità nella composizione del bilancio, in quanto stabilita con il preciso scopo di non privilegiare tra i destinatari del bilancio nessun particolare settore di interessi. F. Superti Furga, Passato e presente del bilancio di esercizio: verso un bilancio intellegibile, in «Rivista dei dottori commercialisti», n. 6, 1988, p.1035. Al riguardo scrive Pezzani: “non deve esistere, necessariamente, una coincidenza tra normativa civilistica ed i principi contabili in quanto i disposti di legge non vanno intesi come un manuale di contabilità, ma rispondono a precise esigenze di definizione di schemi di rappresentazione delle differenti realtà aziendali secondo modalità più conformi alle mutate condizioni di evoluzione dell’ambiente socio-economico. Lo schema deve potere essere in grado di rappresentare differenti realtà economiche (pur con dovuti aggiustamenti, specie per quanto riguarda ad esempio imprese operanti nei settori del credito, delle assicurazioni, dei servizi finanziari) in modo tale da permettere anche un sufficiente grado di comparabilità spaziale e temporale delle medesime realtà”. F. Pezzani, op.cit., p. 27.
38 Una disciplina sul bilancio d’esercizio non è, infatti, riscontrabile nel codice di commercio del 1865. Colombo sottolinea come “la regola del bilancio d’esercizio non fosse ancora, a quell’epoca, del tutto chiara nella mente del legislatore”. G.E. Colombo, Il bilancio d’esercizio nelle Spa, Cedam, Padova 1965. Sul punto si confronti inoltre A. Canziani, Il bilancio delle società di capitali fra ragioneria e diritto. Note sull’evoluzione dal code Napoléon ai codici reali del 1942, in M. Martini-L. Zan (a cura di), Computisti, ragionieri, aziendalisti. La costruzione di una professione e di una disciplina tra Otto e Novecento, Cleup, Padova 2001.
16
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
realmente conseguiti e le perdite sofferte»39. La disciplina non conteneva alcuna indicazione sul contenuto minimo del bilancio e sui criteri di valutazione40. L’articolo 89 dello stesso Codice di commercio prescriveva che fossero l’atto costitutivo e lo statuto ad indicare «le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti».
L’assenza di una normativa organica riguardante in modo specifico il bilancio favorì la redazione, da parte delle società, di prospetti compilati in modo estremamente sommario, i quali, conseguentemente, non potevano venire considerati validi strumenti d’informazione verso l’esterno e, anzi, sollevavano dubbi interpretativi sull’esatto significato economico delle poste contabili.
3.2. La novella codicistica del 1942 Nel 1942 la normativa sulle società viene inserita nel Codice civile. Il
Legislatore di allora, accogliendo le sempre maggiori esigenze di informazione dettate dall’evoluzione del mondo economico, disciplina anzi appositamente lo Stato patrimoniale (art. 2424) nel suo contenuto minimo, e detta una serie di criteri per la valutazione del patrimonio (art. 2425 e seguenti). Inoltre nell’art. 2423 viene sancito che «dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte».
Come già evidenziato nel paragrafo precedente, i prospetti che compongono il bilancio d’esercizio sono l’espressione della sintesi periodica di rilevazioni contabili sistematiche. Esiste quindi un ineliminabile
39 Si confronti l’articolo 176 del codice di commercio del Regno d’Italia emanato nel
1882. 40 Il Legislatore del 1882 si affidava, “in omaggio alla propria ispirazione liberista, al
senso di responsabilità degli amministratori e dei sindaci nella «giusta valutazione». Si operava per tal via un illimitato quanto pericoloso rinvio in bianco ai principi della contabilità motivandosi la scelta con la giustificazione che ogni regola tassativa sarebbe stata di necessità incompleta e perciò dannosa. L’unico precetto ragionieristico si ridusse, dunque, al divieto di distribuire utili fittizi. (..) La verità è che il sistema trova la sua giustificazione, da un canto nell’ideologia liberista che rendeva inconcepibile ogni sindacato esterno sull’andamento della gestione sociale, dall’altro nel fatto che il fenomeno della Spa, all’epoca della promulgazione del codice, era veramente nuovo, in quanto le prime leggi sulla Spa non risalgono a molto tempo prima del 1882 e sembrò pertanto pericoloso avventurarsi nel campo della contabile rilevazione dell’impresa, in ordine al quale la stessa scienza contabile del tempo non era in grado di assumere posizioni precise”. E. Bocchini, La chiarezza e la precisione dei bilanci delle società per azioni nell’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza, in «Rivista delle società», n. 2, 1972, pp. 374-375.
17
Mario Nicoliello
nesso logico tra sistema di contabilità generale e sistema di bilancio41, anzi una effettiva co-essenzialità.
La normativa in tema di bilancio del 1942 è ancora di stretta derivazione patrimonialista42. Il Codice, infatti, denomina bilancio lo Stato patrimoniale e considera il Conto profitti e perdite come aggiunto al bilancio, essendo tale prospetto nel sistema patrimoniale destinato ad accogliere le variazioni degli elementi del patrimonio. Vi è quindi una prevalenza dell’impostazione patrimonialista rispetto alla reddituale43, benché la teoria economico-
41 Cfr. R. Camodeca, op.cit, p.150. 42 I sistemi patrimoniali sono finalizzati in via previa alla rilevazione e alla valutazione
del patrimonio aziendale e, in via susseguente, del reddito conseguito. Secondo l’elaborazione di Fabio Besta oggetto delle rilevazioni contabili è il patrimonio aziendale, di cui le scritture devono seguire ogni movimento dei diversi elementi componenti. Per Besta esiste una correlazione diretta fra rilevazioni dei fatti amministrativi e variazioni dei valori del patrimonio. In particolare, ogni fatto di gestione determina una variazione, attiva o passiva, nel valore di uno o più elementi del patrimonio aziendale; tali variazioni, poi, possono tra loro compensarsi oppure essere differenti. Sulla base di ciò, i fatti di gestione vengono definiti permutativi, qualora si verifichino due o più variazioni elementare di segno opposto che si compensano tra loro; modificativi, nel caso in cui si rilevino due o più variazioni elementari del medesimo segno (da cui consegue una mutazione del patrimonio netto); infine, misti, se le variazioni elementari, per quanto di segno opposto, siano di importo non equivalente. Ne deriva che, secondo Besta, costituiscono componenti di reddito esclusivamente le variazioni patrimoniali nette e quindi il Conto profitti e perdite evidenzia singoli risultati lordi riferiti a specifici elementi patrimoniali. Si veda F. Besta, La Ragioneria, Vallardi, Milano 1922, 3 volumi. Sul pensiero di Besta cfr. A. Monorchio, Fabio Besta, il Maestro della moderna ragioneria, in «Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale», n.7-8, 1996, pp. 338-345; G. Bruni, La ragioneria scientifica nel pensiero di Fabio Besta e nelle successive tendenze ed evoluzioni, in «Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale», n.9-10, 1996, pp. 538-543. I sistemi reddituali, invece, sono volti in primo luogo al calcolo del reddito attribuibile ad un esercizio e, in maniera derivata, alla determinazione del capitale di funzionamento. Nell’elaborazione di Zappa, l’obiettivo è l’analisi delle operazioni aziendali che, nel loro insieme, definiscono la gestione d’impresa, dalla quale scaturisce il reddito che a sua volta determina il patrimonio. Il reddito, quindi, deriva dalle operazioni di gestione, osservabili nei profili numerario – generatore di variazioni numerarie attive e passive – ed economico – causa dell’insorgere di componenti positivi e negativi di reddito –. Secondo tale impostazione il Conto profitti e perdite assume la struttura a “costi, ricavi e rimanenze”, intese queste ultime come costi e ricavi sospesi ai fini della costruzione dell’esercizio. Si consulti G.Zappa, op.cit. Sul pensiero di Zappa cfr. AA.VV., La determinazione del reddito nelle imprese del nostro tempo alla luce del pensiero di Gino Zappa, Atti della giornata di studio nel centenario della nascita di G. Zappa (Ca’ Foscari, 4 aprile 1981), Cedam, Padova 1982; A. Canziani, Sulle premesse metodologiche della rivoluzione zappiana, in Scritti in onore di Lino Azzini, Giuffrè, Milano 1989.
43 “Forse la circostanza che siano stati prevalentemente i giuristi ad occuparsi di problemi valutativi ha influito sulla maggiore importanza attribuita al sistema patrimoniale rispetto al sistema del reddito, privilegiando come fine del bilancio, la rappresentazione del supposto effettivo stato del patrimonio. Tale impostazione è stata accolta dal nostro
18
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
aziendale avesse già sottolineato a partire dagli anni Dieci del Novecento con Eugen Schmalenbach in Germania e Gino Zappa in Italia, come la funzione primaria del bilancio consistesse nella determinazione del reddito44. Ciò è avvalorato anche dal fatto che la norma nulla prevede in merito alla composizione del Conto profitti e perdite45, il quale ai fini conoscitivi non assume importanza rilevante, in quanto l’informazione circa lo stato del patrimonio a fine periodo ancora prevale su quella riferita alle cause di variazione del medesimo.
Nella logica patrimoniale l’obiettivo principale delle valutazioni era ancora, all’epoca, la configurazione secondo principî di prudenza del patrimonio aziendale, piuttosto che la determinazione del reddito d’esercizio.
Su questa logica si fondano sia il contenuto dell’art. 2425 del c.c. e degli altri ad esso collegati, sia la regola della realizzazione dei profitti di cui all’art. 2433. Inoltre, secondo quella impostazione, la rilevazione dei valori – sia degli elementi patrimoniali, sia delle variazioni nette del patrimonio – avviene prevalentemente per destinazione, anziché per natura46.
Si assiste così all’adesione del Legislatore alle dottrine ragioneristiche all’epoca tuttora prevalenti in Italia, dunque ancora di logica patrimoniale, in quanto non ancora soppiantate – come avverrà poi verso gli anni ’50 e ’60 – dalle reddituali.
Il Codice del 1942 stabilisce inoltre che, assieme al bilancio, gli amministratori debbano stilare anche una relazione47, e impone che l’uno e l’altra – accompagnati anche dalla relazione dei sindaci – siano depositati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell’assemblea affinché i soci
legislatore ancora nella promulgazione del codice civile del 1942”. F. Superti Furga, op.cit., 1988.
44 Si vedano E.Schmalenbach, Dynamische Bilanz, Colonia 1919 e G. Zappa, La determinazione del reddito delle imprese commerciali, Roma 1920-1929.
45 Altro aspetto che farebbe propendere per una visione dell’impresa eminentemente patrimonialista nell’azione del Legislatore del 1942 è il mancato obbligo di presentazione del bilancio da parte delle società di persone e delle imprese individuali. Essendo tali forme giuridiche “caratterizzate dalla responsabilità personale illimitata dell’imprenditore, si è forse ritenuto sufficiente questa garanzia sussidiaria nei confronti dei terzi per giustificare un regime semplificato”. Cfr. P. Andrei, op.cit., p. 16.
46 Cfr. F. Superti Furga, Reddito e capitale, cit., 1991, p. 56. 47 Di tale relazione, però, non viene precisato il contenuto. Scrive Viganò “la Relazione
degli amministratori altro non era che una più o meno vaga esposizione di dati di carattere generale di nessuna o scarsa utilità per il destinatario del bilancio, dal momento che molto spesso quelle notizie non erano neanche inquadrate nel settore produttivo specifico dell’azienda cui il bilancio si riferiva o addirittura costituivano trattazioni avulse dal contesto proprio del bilancio” E. Viganò, Relazione sulla gestione, in AA.VV., La contabilità delle imprese e la IV direttiva Cee, Etas, Milano 1980, p. 307.
19
Mario Nicoliello
possano prenderne visione. Il bilancio e le relazioni vanno poi depositate entro 20 giorni dall’approvazione presso l’ufficio del registro delle imprese.
L’accoglimento del concetto che il bilancio rappresenti un mezzo di conoscenza per i terzi, fa sì che il principio informatore di tutta la disciplina normativa di tale documento sia la tutela degli interessi dei soggetti esterni all’impresa48. Il Legislatore su questo aspetto anticipa quindi, in un certo senso, l’orientamento dottrinale solo in seguito prevalente, cioè la visione del bilancio come uno strumento di conoscenza per i soggetti terzi rispetto alla realtà aziendale.
Tuttavia, trascurando la definizione puntuale delle linee guida alle quali il compilatore del bilancio di esercizio avrebbe dovuto ispirarsi in sede di formazione dei valori da iscrivere, il Legislatore si limita a fissare direttamente i criteri di valutazione49, stabilendo all’art. 2425 una disciplina delle valutazioni di bilancio per l’epoca sufficientemente analitica, fondata sull’imposizione di regole valutative distinte per ogni classe di valori. Non ritiene però, il Legislatore, di dover dettare regole totalmente rigide: si limita a porre limiti massimi non superabili, stabilendo che – ove speciali ragioni lo avessero richiesto – gli amministratori avrebbero potuto derogarvi50.
L’esclusiva disciplina delle poste dello Stato patrimoniale – del quale viene sancito il contenuto minimo senza imporre una struttura predefinita, cioè un modello da seguire nella rappresentazione dei valori iscritti51 – pur mettendo in evidenza un dato importante quale la composizione del patrimonio, non diffonde informazioni sull’andamento economico della gestione, le quali debbono di forza venire desunte dal Conto profitti e perdite. La mancanza di norme disciplinanti analiticamente la struttura di
48 M.S. Avi, op.cit., p. 31. 49 “Il Legislatore, dunque, non considera che i criteri di valutazione avulsi dai principi ai
quali, invece, avrebbero dovuto essere correttamente informati sarebbero apparsi mere regole di facile applicazione, ma prive di significato economico-aziendale”. A. Broglia Guiggi, La funzione del bilancio d’esercizio tra evoluzione e tendenziale mutazione, Giappichelli, Torino 2004, p.65.
50 Sul punto Ceccherelli osserva le deficienze e le insufficienze della normativa del 1942 sottolineando come esse “dipendono in gran parte dalla natura stessa della materia trattata e dalla difficoltà spesso insuperabile di poterla codificare. Il complesso delle disposizioni rivela senza dubbio le buone intenzioni dei compilatori del Codice e il lodevole sforzo per tradurle in pratica a traverso un diligente lavoro di sintesi delle più note formule della pratica contabile. Ma dimostra anche come sia vana presunzione quella di credere possibile la generalizzazione in pochi articoli di legge delle cosiddette buone regole della contabilità”. A. Ceccherelli, op. cit., p. 281.
51 L’unica indicazione di carattere strutturale riguardava la forma espositiva che doveva essere a “sezioni divise e contrapposte”, così da evidenziare nella sezione di sinistra le attività e nella sezione di destra le passività e le parti ideali del patrimonio netto.
20
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
tale conto consente poi il radicarsi di prassi di “ermetismo” anche estremo dei conti economici pubblicati52.
Osservando i comportamenti di fatto degli amministratori, si può notare come i bilanci pubblicati delle imprese italiane fossero all’epoca scarni di informazioni: negli anni Cinquanta e Sessanta molteplici imprese depositavano conti profitti e perdite evidenzianti soltanto il risultato lordo della gestione, le spese generali, le imposte e il reddito netto.
Scrive Luigi Guatri nel 1972: “le forme del Conto profitti e perdite largamente invalse nel nostro Paese, con
riguardo beninteso ai bilanci destinati a pubblicazione, sono spesso caratterizzate da massicce compensazioni di valori, che hanno la loro espressione tipica nel «risultato lordo» (sintesi, ad esempio, di ricavi di vendita, dei costi industriali e delle rimanenze iniziali e finali). Bisogna, in proposito, francamente ammettere che tale modo di agire è per lo più dettato proprio dall’intento di togliere chiarezza al conto economico, per impedire la diffusione di notizie giudicate riservate o per altri motivi per nulla raccomandabili. È ben vero che il Legislatore non ha stabilito, per il Conto profitti e perdite, quali siano le classi di valore da indicare distintamente. Ma ciò non significa necessariamente che sia ammissibile un qualsiasi modo di comporre la elencazione dei componenti positivi e negativi del reddito: ad esempio un modo che si proponga proprio di non fare risultare con chiarezza i risultati economici d’esercizio.”53
L’assenza di una disciplina analitica della struttura del Conto economico
rendeva quasi impossibile l’interpretazione del bilancio poiché, così strutturato, questo documento tendeva a presentare informazioni non sempre componibili a sistema in tema di andamento economico della gestione sociale. Tale lacuna era ulteriormente aggravata dalla circostanza che, in mancanza di una disciplina specifica riguardante il contenuto della Relazione degli amministratori, si instaurava presso le società la prassi di redigere relazioni che tendevano a tacere le informazioni rilevanti in tema di andamento gestionale dell’impresa.
Si deve tuttavia rilevare che, proprio dalla seconda metà degli anni Sessanta, quando la prassi dell’ermetismo informativo d’impresa si era ormai consolidata non solo gli economisti aziendali – i quali, peraltro, già da tempo avevano manifestato insoddisfazione per la normativa civilistica e
52 M.S. Avi, op.cit., p. 40. 53 “Non è, ad esempio, pensabile che un minimo di chiarezza sia ottenibile con poche
cifre frutto di molte compensazioni e senza l’esplicita indicazione di alcuni valori di stima la cui conoscenza è indispensabile per attribuire un definito significato al risultato d’esercizio”. L’autore conclude, poi, che “la pratica dei Conti economici ermetici, oltre che illegittima, è molto spesso del tutto inutile”. L. Guatri, Illiceità ed inopportunità del conto profitti e perdite sintetico, in «Rivista dei dottori commercialisti», n. 5, 1972, pp. 881-882.
21
Mario Nicoliello
disapprovazione per le modalità, e in definitiva gli abusi che essa sembrava consentire – ma anche i giuristi e la magistratura cominciarono ad avvertirne la sostanziale illiceità54.
Le molteplici critiche mosse alla originaria stesura della normativa civilistica concernente la redazione del bilancio d’esercizio delle imprese retta da società di capitali da un lato, e l’accennato orientamento giurisprudenziale dall’altro, sollecitano così il Legislatore a intervenire nuovamente in tale materia, integrando le disposizioni maggiormente contestate al fine di colmarne le più evidenti lacune55.
3.3. La mini-riforma del 1974 Nel 1974, pertanto, con la Legge n. 216 del 7 giugno56, e inoltre
sull’onda della riforma tributaria, si effettua un restyling della parte del Codice civile inerente il bilancio, i) ampliando il contenuto dello Stato patrimoniale (con la prescrizione che le classi da iscriversi nell’attivo e nel passivo dovessero essere indicate distintamente), ii) definendo analiticamente il contenuto minimo del Conto profitti e perdite, infine iii) stabilendo le regole cui ottemperare per la compilazione della Relazione degli amministratori.
La nuova versione del Codice, prevedendo all’art. 2425-bis il Conto profitti e perdite “a costi, ricavi e rimanenze”57, accoglie come sistema contabile di riferimento quello reddituale di impostazione zappiana, ponendo in secondo piano l’altra impostazione elaborata dalla dottrina italiana, la precedente patrimonialista. In questo cambiamento si ritrova
54 Risalgono, infatti, a quel periodo le prime sentenze sfavorevoli a tale riprovevole
prassi che, per violazione dei postulati della chiarezza e della verità, dichiarano nulle le delibere di approvazione di tali bilanci. Sull’evoluzione della giurisprudenza in merito al bilancio d’esercizio delle imprese rette da società di capitali si rimanda a E. Bocchini, op.cit. e a M.S. Avi, op. cit.
55 A. Broglia Guiggi, op.cit., p. 75. 56 Tale Legge, rubricata “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto legge
8/4/74 n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari”, diviene successivamente nota come “mini-riforma delle società per azioni” a causa dei numerosi emendamenti apportati dal Parlamento nel corso del suo iter di approvazione che modificano ed innovano sotto differenti aspetti la disciplina delle società per azioni.
57 “I componenti del reddito d’impresa possono trovare loro caratteristica configurazione, specialmente appropriata, in quel Conto profitti e perdite che, per designarne il tipico contenuto, esplicitamente espresso, noi diremo composto a costi, ricavi e rimanenze”. G. Zappa, op. cit., p. 605.
22
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
piena concordanza di opinioni tra l’operato del Legislatore e la letteratura nazionale allora prevalente58.
Nella prospettiva reddituale gli elementi del patrimonio sono espressione di cicli di processi produttivi che non hanno avuto termine nel periodo amministrativo denominato “esercizio”, e che sono destinati a concludersi in futuro. Assume preminenza la sintesi dei valori che configura il risultato d’esercizio come contrapposizione tra rimanenze iniziali e costi d’esercizio da un lato, ricavi e rimanenze finali dall’altro. La struttura a sezioni contrapposte pone in luce la generale correlazione tra i valori. La teoria, e implicitamente la norma che vi si rifaceva, prevedevano inoltre una classificazione per natura delle componenti sia del reddito sia del capitale di funzionamento.
Il nuovo art. 2525-bis C.c. richiede soltanto il contenuto minimo obbligatorio del Conto profitti e perdite e non una struttura rigida: esso prevede dunque, per la rappresentazione dei valori, uno schema aperto, suscettibile delle integrazioni opportune in funzione della realtà da rappresentarsi, e inoltre al fine di meglio comunicarla a terzi59.
In sintesi, quindi, la struttura civilistica di Conto profitti e perdite a sezioni contrapposte, con valori classificati per natura, consente al lettore del bilancio di percepire la generale correlazione economica tra costi e ricavi e di apprezzare il grado di attendibilità del reddito d’esercizio. La dottrina economico-aziendale, tuttavia, aveva sottolineato l’utilità dell’indagine relativa anche alle correlazioni parziali, purché effettuate nell’ambito della generale correlazione d’esercizio60.
58 A ben vedere il Legislatore civilistico del 1974 è stato preceduto ed influenzato dal
Legislatore fiscale del 1973 che, per la necessità di determinare il reddito imponibile, privilegia il sistema del reddito.
59 Dal punto di vista pratico, tuttavia, non si è mai riscontrata l’applicazione assoluta del sistema del reddito di Zappa, la quale presupporrebbe una struttura di Conto economico con i) in “Dare” i valori relativi alle acquisizioni di tutti i fattori produttivi (compresi quelli a fecondità ripetuta), ii) in “Avere”, oltre ai ricavi riferiti all’esercizio, anche la quota sospesa dei fattori pluriennali. La mancata applicazione della configurazione ideale del rendiconto reddituale deriva probabilmente dall’esigenza – dettata dalla legge – di “ricostruire contabilmente il processo di ammortamento; per tale ragione tra i componenti negativi di reddito vengono contabilizzate soltanto le quote di ammortamento delle immobilizzazioni, mentre il valore di contropartita si iscrive nel fondo ammortamento posto a diretta rettifica del valore iscritto nell’attivo patrimoniale”. R. Camodeca, op.cit., p. 158. Sul punto si confronti inoltre E. Zigiotti, Sulla natura dei valori del capitale di bilancio nel sistema del reddito, in AA.VV., Studi in onore di U. De Dominicis, Lint, Trieste 1991, tomo I, pp. 347-370.
60 “Le correlazioni fondamentali tra i valori positivi e negativi del reddito sono quelle generali di esercizio; le correlazioni parziali, tanto utili, debbono potersi ricondurre alle prime”. C. Masini, Lavoro e risparmio, cit., p. 149.
23
Mario Nicoliello
L’altra grande novità introdotta con la L. 216/1974 è la prescrizione del contenuto minimale della Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione sociale, disciplinata dall’art. 2429-bis c.c. Tale relazione deve illustrare l’andamento della gestione nei vari settori in cui l’impresa ha operato, anche attraverso società controllate, con particolare riferimento ai prezzi, ai costi e agli investimenti. In particolare, poi, la nuova norma elenca nove punti che in ogni caso devono risultare dalla Relazione, cosicché essa possa costituire una fonte informativa complementare, ma significativa.
Ove dunque la Relazione venga stesa in modo non più elusivo, essa predispone informazioni probanti sull’andamento della gestione, palesandosi quale documento con funzione sia illustrativa sia integrativa dei dati di bilancio61.
Se la mini-riforma del 1974 per quanto attiene gli aspetti formali del bilancio (cioè le modalità di rappresentazione dei valori iscritti nei prospetti contabili) contribuiva ad arricchirne la funzione informativa – rendendola più chiara e analitica, benché bisognosa di ulteriori affinamenti – dal punto di vista degli aspetti sostanziali invece la disciplina predisposta per l’espletamento del processo estimativo di fine periodo risultava ancora carente. Le norme per le valutazioni erano ancora regole da applicarsi in modo atomistico alle fattispecie contemplate, dunque avulse dal sistema dei valori giacché prive di un principio unitario, capace di orientare le valutazioni in coerenza con le finalità proposte per il bilancio d’esercizio62.
Con la medesima Legge 216, il Legislatore del 1974, oltre a disciplinare il grado di analiticità del bilancio, introduceva anche alcune norme sul controllo pubblico delle società quotate in Borsa ai fini di accrescere la trasparenza informativa.
Nonostante l’ampliamento del contenuto minimo obbligatorio dei prospetti contabili, le prevalenti preoccupazioni verso l’Erario e verso le imprese concorrenti condizionavano – e condizionano tuttora – l’analiticità dell’informazione. Essa risultava non di rado velata dal desiderio di riservatezza, nonché dalla preoccupazione delle imposte, che induceva a “inquinare” il bilancio, cioè a inserire nel documento valori derivanti da valutazioni di matrice tributaria. Raramente i bilanci erano corredati – come oggi del resto – da prospetti ulteriormente informativi quali il Rendiconto
61 Scrive Viganò: “Non c’è dubbio che la Relazione degli amministratori acquista una
singolare importanza autonoma come strumento di informazione a corredo del bilancio d’esercizio pubblico. Al contrario dei documenti contabili che costituiscono il cuore del bilancio e che sono simbolici e sintetici, la Relazione degli amministratori non ha limiti di estensione, ha un linguaggio narrativo proprio e quindi esclude tendenzialmente ogni simbolismo e sintesi”. E. Viganò, op.cit., p. 307.
62 Cfr. A. Broglia Guiggi, op.cit., pp. 80-81.
24
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
finanziario; e non di rado le stesse relazioni degli organi amministrativo e di controllo erano scarsamente trasparenti, anzi ridotte all’essenziale63.
4. La IV direttiva Cee e il Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127
Con il Decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 sono state recepite in Italia la Quarta direttiva comunitaria sul bilancio d’esercizio e la Settima sui conti consolidati delle imprese costituite in gruppo64.
La Quarta Direttiva si pone con principî che, per quanto concerne l’Italia, risultano di non semplice attuazione sul piano empirico e comunque non pienamente conformi alla tradizione giuridica e ragioneristica del nostro Paese65. Nonostante ciò, l’intervento normativo del 1991 determina l’evoluzione verso una maggiore trasparenza dell’informazione e risulta di fondamentale importanza ai fini della lettura del documento di sintesi, in quanto introduce per la prima volta, all’interno del Codice civile, un corpus articolato di norme concernenti la redazione del bilancio, al cui vertice si pone la clausola generale (art. 2423) secondo cui «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto66 la
63 Cfr. G. Frattini, Contabilità e bilancio. Il bilancio pubblico, volume secondo, Giuffrè,
Milano 2006, p. 4. L’autore aggiunge “già allora le imprese risultavano distinte in due gruppi: le imprese che producevano utili e quelle con conti economici negativi o sul punto di pareggio. Le prime davano corretta applicazione alla normativa fiscale al solo fine di difendersi dalla esosità dell’Erario; le altre si preoccupavano soltanto di far quadrare i conti”.
64 A ben vedere il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie è avvenuto in ritardo rispetto agli altri Paesi comunitari, i quali hanno adottato le direttive Cee con i seguenti provvedimenti: Danimarca, L. 10 giugno 1981; Gran Bretagna, Company act del 30 ottobre 1981; Francia, L. 30 aprile 1983; Belgio, L. 12 settembre 1983; Olanda, L. 7 dicembre 1983; Lussemburgo, L. 4 maggio 1984; Germania, L. 19 dicembre 1985; Irlanda, Statutary Instrument 18 luglio 1986; Grecia, L. 28 novembre 1986; Spagna, L. 25 luglio 1989; Portogallo, D.L., 21 novembre 1989. Per approfondimenti si rimanda a M. Lacchini, Modelli teorico-contabili e principî di redazione del bilancio. Riflessioni economico-aziendali sull’innovato codice civile, Giappichelli, Torino 1994, p. 2.
65 Cfr. A. Canziani, Critica alla true and fair view quale pseudo-concetto empirico, in AA.VV., Studi in onore di Ubaldo De Dominicis, Lint, Trieste 1991.
66 “Il bilancio appartiene alla categoria dei messaggi; il messaggio, per assolvere la sua funzione, non può non essere chiaro, veritiero e corretto; il bilancio, dunque, in quanto messaggio, non può non presentare tali attributi. (..) Chiarezza significa capacità di esprimere in modo intellegibile l’oggetto rappresentato in tutte le sue principali caratteristiche; capacità, cioè, di farsi comprendere dai destinatari nel modo migliore possibile. (..) La verità deve essere intesa nel senso della corrispondenza tra l’enunciato e la realtà. La correttezza deve essere intesa nel senso del riferimento a criteri razionali di redazione”. C. Caramiello, Il bilancio di esercizio, ieri ed oggi. Brevi note per un confronto, Giuffrè, Milano 1994, pp. 3 e seg. È evidente, comunque, che il postulato della verità non può essere preso alla lettera: “la verità in senso assoluto non è un requisito
25
Mario Nicoliello
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio»67.
Tale fine – derivante dalla nozione britannica di true and fair view68– condiziona in misura notevole le scelte tecnico-contabili operate dagli amministratori in sede di redazione delle sintesi di esercizio, e costituisce il fulcro su cui poggia l’intera disciplina in tema di bilancio69.
La nuova materia giuridica sul bilancio è caratterizzata da norme: i) generali, esprimenti le linee-guida dell’intero processo di formazione, ii) particolari, disciplinanti le modalità di rappresentazione delle strutture e i criteri di valutazione delle classi di valore.
Tali serie di norme vanno viste in sequenza gerarchica discendente, nel senso che le prescrizioni sui requisiti fondamentali del bilancio hanno prevalenza sugli schemi e sulle valutazioni70.
Oltre alla clausola generale – che costituisce, di fatto, la principale finalità che la legge attribuisce al bilancio delle imprese71 – viene introdotta
fondamentale e ragionevolmente assegnabile al bilancio di esercizio in quanto i valori in esso riportati derivano, com’è noto, da un complesso processo estimativo avente per oggetto l’economia di un’impresa in normale funzionamento”. A. Broglia Guiggi, op.cit., p. 110.
67 “Per certo la nuova formulazione è molto più ampia della precedente. Imporre ai redattori del bilancio l’ossequio ai principi di veridicità e correttezza significa attribuire alla comunicazione valori ed effetti giuridici diversi e più ampi di quelli contenuti nella pregressa normativa. E ciò in quanto la chiarezza e la precisione riguardano la forma in cui sono presentati i conti, mentre la correttezza attiene alla sostanza delle voci e del bilancio nel suo complesso”. G. Frattini, op.cit., p. 2.
68 Scrive Fiori: “l’interpretazione più corretta del principio della rappresentazione veritiera e corretta deve essere la seguente: a) per quanto riguarda le valutazioni di bilancio, la rappresentazione veritiera e corretta si ottiene mediante l’applicazione dei principi contabili di generale applicazione; b) per quanto riguarda le informazioni supplementari, il principio della rappresentazione veritiera e corretta rappresenta uno stimolo per integrare e rendere sempre più esaustiva l’informativa di bilancio. G. Fiori, Il principio della “rappresentazione veritiera e corretta” nella redazione del bilancio d’esercizio. Considerazioni critiche e profili evolutivi dell’informazione societaria, Giuffrè, Milano 1999, p. 125.
69 “Gli attributi riconosciuti all’informazione di bilancio possono essere sintetizzati nei concetti di attendibilità e di intelligibilità dell’informazione stessa: sia pure nell’ambito della discrezionalità che pervade l’intera costruzione del bilancio, infatti, la rappresentazione che dovrebbe scaturire dall’azione esperta degli amministratori dovrebbe essere ispirata dall’applicazione di corretti principi di ragioneria (attendibilità) e orientata a fornire un quadro di sintesi chiaro e comprensibile per tutti i destinatari dell’informazione (intelligibilità)”. P. Andrei, op.cit., p.8.
70 A. Consorti, L’evoluzione della funzione informativa del bilancio d’esercizio. Dal conto del patrimonio al sistema delle informazioni, Giappichelli, Torino 2001, p. 205.
71 Ciò risulta evidente anche dal fatto che, nello stesso art. 2423, è previsto che «se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari
26
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
una ampia regolamentazione delle sintesi d’esercizio nei seguenti nuovi articoli del Codice civile:
− art. 2423-bis, relativo ai principî generali di redazione del bilancio; − art. 2423-ter, che riguarda la struttura dello Stato patrimoniale e del
Conto economico (nuova denominazione del precedente Conto profitti e perdite72), i cui schemi sono dettati dai successivi articoli 2424 e 2425;
− art. 2424-bis, inerente le singole voci dello Stato patrimoniale; − art. 2425-bis, disciplinante l’iscrizione dei proventi e degli oneri; − art. 2426, sui criteri di valutazione delle singole voci di bilancio; − art. 2427, che specifica il contenuto minimo obbligatorio della Nota
integrativa; − art. 2428, sulla Relazione sulla gestione predisposta dagli
amministratori a corredo del bilancio d’esercizio. La nuova norma indica poi cinque principî – prudenza, competenza,
continuazione dell’attività, valutazione separata e coerenza valutativa – da osservare nella redazione del bilancio, principî che hanno funzione normativa generale rispetto ai criteri particolari che entrano in gioco nelle operazioni di valutazione73.
L’applicazione dei citati principî di redazione non è scevra da profili discutibili, ove inquadrati nella logica economico-aziendale delle valutazioni di bilancio. La prudenza, ad esempio, mentre rimane canone valutativo prioritario (coerente con l’obiettivo civilistico della tutela dei terzi, in particolare creditori e azionisti di minoranza, le due categorie di stakeholders che assumono ora ruolo preminente), non di rado si scontra sul piano concreto con la logica stessa della trasparenza e della rappresentazione veritiera e corretta, atteso che l’adozione di criteri
necessarie allo scopo». Inoltre, sempre nello stesso articolo si prevede che «se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata».
72 L’innovazione terminologica pone l’enfasi sul reddito d’esercizio e non più sui componenti positivi e negativi di reddito da cui esso ha origine. Le altre innovazioni relative al Conto economico consistono nel passaggio dalla forma a sezioni contrapposte a quella scalare e da un contenuto minimale ad un contenuto rigido in termini relativi. Cfr. F. Pezzani, op.cit., p. 125.
73 La nuova regolamentazione, inoltre, tiene conto della complessità e della problematicità connesse alle specificità delle realtà economiche da rappresentare, prevedendo la possibilità di derogare, sia pure in casi eccezionali, alle norme particolari, quando l’applicazione di esse non consenta una rappresentazione veritiera e corretta delle singole situazioni aziendali. Cfr. F. Superti Furga, Reddito e capitale, p. 59.
27
Mario Nicoliello
prudenziali postula (inevitabilmente) il formarsi di riserve latenti, talvolta determinabili e rappresentabili almeno in Nota integrativa, in altri casi però non quantificabili in modo oggettivo o univoco e dunque non descrivibili in termini quantitativi negli allegati di bilancio74.
L’articolo 2423-ter prospetta schemi strettamente obbligatori per Stato patrimoniale e Conto economico; strutturati e precisi, essi sono ben lontani dai semplici elenchi che la disciplina precedente proponeva75. Mentre per lo Stato patrimoniale non paiono peraltro venire alla luce sostanziali elementi di contrasto con la teoria reddituale, una diversa considerazione si impone viceversa per il Conto economico, il quale – oltre a presentarsi in forma scalare76 – espone le classi di valore riferite alle rimanenze di magazzino in termini di variazioni e non mediante la contrapposizione fra rimanenze iniziali e finali.
L’articolo 2426 è dedicato alle valutazioni, il cui criterio base è il costo storico, specificato nelle varie sue configurazioni applicabili alle singole categorie di beni77.
Il Legislatore nazionale non accoglie modalità alcuna di valutazione alternativa al costo, tra quelle previste dall’art. 33 della IV direttiva Cee.
Tale articolo offriva infatti agli Stati membri l’opportunità, in deroga all’articolo 32 nel quale veniva sancito il criterio del costo quale regola
74 Cfr. R. Camodeca, Il bilancio dell’impresa nel diritto positivo italiano dai codici reali
(1942) al D.Lgs. 127/91, in M. Martini-L. Zan (a cura di), Computisti, ragionieri, aziendalisti. La costruzione di una professione e di una disciplina tra Otto e Novecento, Cleup, Padova 2001.
75 R. D’Oriano, I conti del nuovo bilancio d’esercizio, Cedam, Padova 1995, p. 3. 76 “Nessuna procedura contabile consente di ottenere automaticamente una struttura
scalare. Questa, di necessità, consegue da opportune riclassificazioni dei saldi dei conti del sistema”. F.Superti Furga, Reddito e capitale, p. 62. A ben vedere la IV Direttiva Cee prevedeva quattro strutture di Conto economico: a sezioni contrapposte o in forma scalare e con i costi classificati per natura o per destinazione. L’Italia decide di adottare soltanto una forma di Conto economico: quello in forma scalare e con i costi classificati per natura. Mentre la forma a sezioni contrapposte presenta una spiccata attitudine per illustrare la correlazione generale di tutti i componenti di reddito, la forma scalare si propone di spiegare la formazione del reddito d’esercizio in relazione alla scomposizione dell’unità economica relativa in sottoinsiemi di ordine inferiore. Tuttavia si deve evitare di interpretare la forma scalare della formazione del reddito come espressione di fasi gestionali autonome caratterizzate da una redditività specifica. La forma scalare “chiarisce dunque non distinte fasi di gestione, ma distinti momenti nei quali talora si considera la determinazione del reddito”. G. Zappa, op.cit., p. 610.
77 Le particolari configurazioni di costo sono costituite dal costo di acquisto e dal costo di produzione, il primo dato dall’importo della fattura di acquisto comprensiva degli oneri accessori, il secondo dall’insieme degli oneri sostenuti per la costruzione in economia del bene.
28
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
generale di valutazione, di autorizzare o imporre, per tutte o per talune categorie di società:
1. di valutare in base al valore di sostituzione a) le immobilizzazioni
materiali la cui utilizzazione fosse limitata nel tempo, b) le scorte; 2. di valutare in base a metodi destinati a tener conto dell’inflazione le voci
dei conti annuali, compreso il patrimonio netto; 3. di rivalutare le immobilizzazioni materiali e finanziarie.
La normativa italiana ha optato per una fedele e rigorosa accettazione del criterio del costo e della prudenza, escludendo sia ipotesi di contabilità a valori correnti o per l’inflazione, sia di rivalutazioni volontarie.
Si deve positivamente sottolineare l’ampio spazio dedicato dalla norma, rispetto al passato, al tema delle valutazioni, che inoltre non paiono così lontane dai principî contabili nazionali. Tale relativa affinità pare opportuna, soprattutto alla luce dell’evoluzione normativa intercorsa, talché le due fonti devono da allora venire tra loro integrate per esprimere compiutamente il processo valutativo.
Uno degli elementi di maggiore novità nella configurazione del 1991 risiede nella tendenza verso un bilancio più intellegibile, non solo attraverso l’esplicitazione dei criteri seguiti per le valutazioni, ma anche attraverso la dichiarazione e la giustificazione delle ipotesi operanti nel passato e nel futuro della gestione78.
Il Legislatore del 1991 sostituisce inoltre la preesistente Relazione degli amministratori con a) la Nota integrativa e b) la Relazione sulla gestione. La Nota integrativa – parte integrante del bilancio – deve contenere i criteri di valutazione adottati e specificare analiticamente i contenuti sintetizzati nelle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico. La Relazione sulla gestione ha, come principale funzione, di porre in luce le relazioni dei risultati d’esercizio con la gestione passata e con i programmi della futura.
L’arricchimento della parte descrittivo-esplicativa del bilancio è finalizzato ad aumentarne la chiarezza e l’intelligibilità, risultato che non sarebbe altrimenti conseguibile, vista l’ineliminabile dimensione soggettiva presente nelle valutazioni accolte nella parte quantitativa del bilancio79.
78 Cfr. F. Superti Furga, Reddito e capitale, p. 198. L’autore conclude l’opera
affermando che “poiché da quanto si è visto il bilancio non sembra poter mai raggiungere un livello di verità secondo il paradigma delle scienze esatte e nemmeno secondo quello delle scienze naturali sperimentali, in esso vale principalmente il criterio dell’intelligibilità razionale dal quale discende in sede epistemologica la possibilità di una progressiva, anche se mai completamente conclusa, perfettibilità nell’approssimazione al vero delle raffigurazioni di bilancio”.
79 Ivi, p.194.
29
Mario Nicoliello
Una delle innovazioni introdotte con il principio della rappresentazione veritiera e corretta consiste nell’obbligo di esporre informazioni supplementari, quando quelle previste dalla legge non siano sufficienti. Tale novità avrebbe dovuto rappresentare uno stimolo nella ricerca delle modalità migliori per arricchire l’informazione esterna alle imprese, al fine della citata rappresentazione veritiera e corretta; occorre tuttavia interrogarsi, sul punto, in tema di adesione al dettato normativo da parte delle società80. Rimane viceversa assodato che, dal deposito, i molteplici soggetti interessati alla lettura del bilancio di esercizio attingono informazioni molto maggiori rispetto alle forme antecedenti di pubblicità.
5. La riforma del diritto societario del 2003 e l’introduzione dei principî contabili internazionali
5.1. Il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 Il corpus di norme in materia di bilancio in vigore a partire dal 1991
rimane, nella sostanza, inalterato fino alla riforma del diritto societario81, attuata con il Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, il quale, pur introducendo modifiche, non muta la sistematica della disciplina civilistica del bilancio d’esercizio.
La logica della riforma societaria è stata di consentire alle imprese – considerate come centri propulsori dell’economia, come luoghi deputati alla creazione o alla distruzione della ricchezza – di operare e competere in ambienti complessi con un sistema di regole e di vincoli essenziali, sulla base di modelli che consentano il massimo di autonomia, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e con i diritti degli altri attori dell’economia82.
80 Per approfondimenti si rimanda a G. Meriggioli-M. Masoni, Il nuovo bilancio alla
prova dei fatti. Un’indagine empirica, in «Amministrazione e finanza», n.6, 1996, pp. 3-23 e a M. Montanini, Società quotate. Un’indagine sulle immobilizzazioni immateriali nell’informativa di bilancio, in «Amministrazione e finanza», n. 17, 2000, pp. 5-14.
81 “La globalizzazione dei mercati ha una diretta influenza sulla legislazione degli Stati. Essi diventano consapevoli che gli investimenti tendono a dirigersi laddove si trovano le condizioni giuridiche più favorevoli, così scatenando una concorrenza tra gli ordinamenti. Questi ultimi ricercano dei modelli societari organizzati prevalentemente in base all’autonomia negoziale; ma debbono altresì garantire norme sostanziali e processuali un grado di assicurare la certezza del diritto, la prevedibilità dei contenuti e la tempestività delle decisioni giudiziarie. Tale tendenza all’omogeneizzazione è, naturalmente, accentuata per effetto dell’appartenenza all’Unione europea. La riforma del diritto societario è frutto dell’evoluzione sopra descritta”. R. Bauer, Gli effetti della riforma societaria su bilancio e governo d’impresa. Novità, modifiche e prospettive, Ipsoa, Milano 2003.
82 E. Cavalieri, Appunti in margine alla riforma del diritto societario, in «Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale», n. 1-2, 2005, p. 6.
30
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
Le innovazioni principali alla materia bilancistica introdotte dalla riforma c.d. Vietti83 sono state:
− l’introduzione nel Codice civile di un esplicito rinvio al principio
anglosassone di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica (substance over form);
− l’eliminazione delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio d’esercizio, mediante l’abrogazione del secondo comma dell’art. 2426 che consentiva al redattore del bilancio di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti in applicazione di norme tributarie84;
− la modifica degli schemi di bilancio con l’introduzione di classi maggiormente analitiche rispetto allo schema precedente (i crediti tributari, le imposte anticipate, i debiti verso soci per finanziamenti e gli utili e le perdite su cambi);
− la richiesta di evidenziare nella Nota integrativa l’effetto della contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario, ossia l’iscrizione dei beni locati nell’attivo del locatario in contropartita con il debito verso il locatore;
− l’introduzione nella Nota integrativa di uno schema riepilogativo delle variazioni del patrimonio netto e di un prospetto descrittivo della natura delle voci che lo compongono, con specificazione dell’origine, della possibilità di utilizzazione e della distribuibilità delle diverse riserve e indicazione dell’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
Seguendo la logica prioritariamente economica evidenziata nel § 2, il
bilancio già rappresenta in modo veritiero e corretto gli eventi della gestione aziendale nel suo divenire; ma a tal fine occorre necessariamente determinare e comprendere a) gli aspetti sostanziali (né solo formali) di ognuno di tali eventi, b) la coordinazione degli stessi in sistema. La sostanza dal punto di vista economico-aziendale è l’essenza primaria di ogni fatto o evento, cioè la sua vera natura. Il Legislatore, uniformandosi quindi all’orientamento economico-aziendale, inserisce all’uopo il seguente nuovo comma all’art. 2423-bis del Codice: «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità, nonché tenendo
83 Tale nome deriva da Michele Vietti, sottosegretario al ministero della Giustizia e
presidente della commissione per la riforma del diritto societario che ha curato i lavori preliminari alla Legge delega e al successivo Decreto legislativo.
84 Per approfondimenti sul punto si rimanda fra gli altri a F. Dezzani-L. Dezzani, Il “disinquinamento” del bilancio d’esercizio, in «Diritto e pratica tributaria», n. 5, 2003, pp. 865-874 e a A. Stesuri, Il “disinquinamento” del bilancio, in «Amministrazione e finanza», n. 4, 2004, pp. 7-10.
31
Mario Nicoliello
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato».
La riforma in oggetto innova inoltre la disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni, quali la locazione finanziaria, i “pronti contro termine” e gli strumenti finanziari derivati. Tali operazioni infatti erano in precedenza contabilizzate secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti. La moderna dottrina aziendalistica85 e la prassi internazionale prevedono invece che la rappresentazione in bilancio di tali accadimenti economici venga effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali, e alla stessa pare ispirarsi l’attuale normativa.
Nella riforma del 2003 non si riscontrano la sistematicità e l’organicità espositiva presenti invece nell’intervento del 1991. Mentre allora infatti vi era stato un ridisegno completo dell’impianto del bilancio, questa volta si realizzano soltanto una serie di interventi che non modificano le linee direttrici del contenuto informativo del bilancio stesso86.
In linea generale è dunque possibile ritenere che le variazioni apportate dalla riforma Vietti agli schemi di bilancio – con riferimento sia allo Stato patrimoniale sia al Conto economico – siano di portata limitata, assumendo natura sostanzialmente incrementale rispetto al disposto precedente. Risultano invece di vasta portata le variazioni previste nella disciplina del contenuto minimo obbligatorio della Nota integrativa.
L’approccio seguito dal Legislatore può quindi costituire specifica scelta di non modificare nella sostanza gli schemi di bilancio, in attesa della prossima riforma del documento connessa all’approvazione del Regolamento UE 19 luglio 2002, n. 1606, e del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, entrambi in tema di principî contabili internazionali (Ias/Ifrs)87.
85 “La centralità della misurazione del reddito nel modello contabile sviluppato dalla
Scuola reddituale, oltre a risolvere a priori il problema della contrapposizione tra la sostanza e la forma delle operazioni di gestione, ove la sostanza economica prevale sulla forma giuridica, fornisce un elemento essenziale per comprendere il significato del capitale di funzionamento i cui elementi prescindono sia dai diritti e dagli obblighi giuridici derivanti dalla legislazione vigente sia dai probabili benefici economici futuri conseguenti ad eventi passati. Aderendo, quindi, all’approccio tradizionale si può affermare che non esiste alcuna contrapposizione tra forma e sostanza, poiché quest’ultima prevale nettamente sulla forma giuridica”. N. Agnoli, Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in «Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale», n. 9-10, 2005, p. 597.
86 Cfr. M.T. Bianchi, Alcune riflessioni sulla nuova disciplina del bilancio, in «Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale», n. 1-2, 2005, p. 29.
87 In data 6 giugno 2002 il Consiglio Europeo ha approvato il Regolamento relativo all’applicazione dei principî contabili internazionali per le società europee quotate, muovendo dai conti annuali chiusi al 31 dicembre 2005. Ciò con l’obiettivo di armonizzare l’informazione finanziaria pubblicata e garantire un elevato grado di trasparenza e di comparabilità dei bilanci, e di conseguenza un efficiente funzionamento del mercato dei capitali dei singoli mercati nazionali ma soprattutto del mercato interno UE
32
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
5.2. I principî contabili internazionali Il Regolamento dell’Unione Europea 19 luglio 2002, n. 1606, stabilisce
che – muovendo dai conti annuali chiusi al 31 dicembre 2005 – le società soggette al diritto di uno Stato-membro, con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato-membro, debbano redigere il bilancio consolidato utilizzando i principî contabili internazionali (art. 4).
Poiché il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati dell’Unione (cioè senza bisogno di alcun atto di recepimento) i principî contabili assumono valore cogente analogo alle norme del Codice civile e delle leggi speciali di ciascuno Stato.
Nello stesso regolamento è stata poi inserita un’opzione – che per essere attuata richiede l’intervento del Legislatore nazionale – la quale prevede la possibilità che gli Stati-membri consentano o prescrivano alle società di cui all’art. 4 di redigere i propri conti annuali (bilancio d’esercizio) in conformità ai principî contabili internazionali. Inoltre, sempre su iniziativa degli organi competenti a livello nazionale, anche alle società diverse da quelle di cui all’art. 4 può essere consentito o imposto di redigere il bilancio d’esercizio e/o il consolidato in ossequio ai principî citati.
In Italia, il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, ha stabilito che i principî contabili internazionali debbano venire utilizzati a partire dall’esercizio 2005 per il consolidato e 2006 per il bilancio d’esercizio:
− dalle società quotate, diverse dalle imprese di assicurazione, per la
redazione del bilancio d’esercizio; − dalle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, per il
bilancio d’esercizio e consolidato; − dalle banche italiane e dagli intermediari finanziari sottoposti alla
vigilanza della Banca d’Italia, per il bilancio d’esercizio e consolidato; − dalle imprese di assicurazione per la redazione del bilancio consolidato.
Hanno invece facoltà di utilizzare nel consolidato e nell’individuale gli Ifrs tutte le società non quotate diverse dalle precedenti, tranne quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.
Ne deriva quindi che la comparabilità integrale dei bilanci con riferimento alle società soggette al diritto italiano non sarà più garantita, in quanto vi saranno bilanci conformi agli Ifrs e bilanci, invece, redatti in ossequio alla normativa interna.
33
Mario Nicoliello
Attualmente lo Iasb88 sta lavorando a un progetto di redazione di principî contabili internazionali semplificati per le small and medium sized entities (SME), progetto che dovrebbe essere pronto verso la seconda metà del 200889.
Per quanto concerne invece la normativa interna, l’Organismo italiano di contabilità (Oic90) ha da poco formulato proposte di modifica al Codice civile con esclusivo riferimento ai bilanci d’esercizio delle società a oggi non sottoposte all’applicazione dei principî contabili internazionali. In futuro, quindi, la scelta delle imprese sarà tra Codice civile adeguato dall’Oic e principî contabili internazionali per le piccole e medie imprese91.
Il contesto economico e normativo in cui si inquadra la disciplina del bilancio è quindi in continua e intensa evoluzione92, tanto che all’Oic sono state affidate funzioni che travalicano la mera revisione o l’approntamento di nuovi principî nazionali93.
Sul punto si crede di poter evidenziare i seguenti profili eventualmente problematici.
a) La futura riforma del Codice potrebbe ammettere nel bilancio anche
criteri di redazione meno prudenti ma, sicuramente, più rispettosi di un
88 L’International accounting standard board (Iasb) è l’ente che emana i principî
contabili internazionali. 89 Nel febbraio 2007 lo Iasb ha emesso l’exposure draft degli Ifrs for Sme’s, una bozza
redatta al fine di raccogliere i commenti da parte di tutti i soggetti interessati. I commenti finora giunti hanno, nella stragrande maggioranza, un comune denominatore: l’eccessiva complessità del documento e la sostanziale inapplicabilità alle piccole e micro imprese. Per approfondimenti si rimanda a U. Cacciamani, Il principio Ifrs per le Pmi tarato su entità troppo grandi, in «Il Sole 24 Ore del Lunedì», 22/10/07, p. 53 e F. Distefano, L’applicazione facoltativa è una possibile via d’uscita, in «Il Sole 24 Ore del Lunedì», 22/10/07, p. 53.
90 Tale organismo ha sostituto la commissione congiunta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri nel predisporre principî contabili per i soggetti non tenuti all’adozione dei principî contabili internazionali.
91 Cfr. F. Roscini Vitali, L’Oic avvicina il Codice civile ai principî Ias, in «Il Sole 24 Ore», 22/06/07, p. 31.
92 Sul punto si confrontino i contributi di R. Bauer, Il bilancio fa spazio al fair value, in «Amministrazione e finanza», n. 2, 2004, pp. 17-20 e G. Rossi, L’applicabilità del fair value all’interno del modello di bilancio europeo, in «Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale», n. 9-10, 2005, p. 552; ma anche A. Provasoli, Adeguamento monetario e valori correnti nelle determinazioni di bilancio, in «Rivista dei dottori commercialisti», n. 4, 1975, p. 657.
93 L’Oic è chiamato a svolgere, tra l’altro, un ruolo di impulso, propositivo e collaborativo nei confronti dello Iasb da un lato, e un ruolo coadiuvante per il Legislatore italiano dall’altro, al fine di promuovere l’armonizzazione contabile in Italia e di contribuire all’affermarsi della stessa a livello internazionale. Cfr. A. Provasoli-A. Viganò (a cura di), Bilancio. Valutazioni, lettura, analisi, Egea, Milano 2007, p. X.
34
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
“quadro fedele” del documento che, conseguentemente, meglio rifletterebbe l’effettiva situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell’impresa. Ciò potrebbe portare a includere nella disciplina bilancistica nuovi criteri di valutazione, tra cui il fair value, e il nuovo concetto portante di “perdite permanenti di valore” quali canoni per l’allibramento delle attività.
L’aspetto appare delicato anche alla luce di quanto precedentemente esposto in tema di evoluzione del pensiero dottrinale in merito alle tematiche bilancistiche. È indubbio infatti che la tradizione aziendalistica italiana, prima ancora della giuridica, affidasse, e affidi tuttora, al criterio del costo storico (di acquisizione o di produzione) la valutazione delle attività nello Stato patrimoniale. Tuttavia, nell’attuale contesto intellettuale l’influsso anglosassone ritiene “inadeguata” la logica di bilancio fondata sull’appostazione del valore storico delle immobilizzazioni e la convinzione, da parte soprattutto della prassi professionale internazionale – principale attore coinvolto nella statuizione degli Ifrs – che il valore corrente, soprattutto per i beni intangibili (rettificato con quote di ammortamento non necessariamente costanti) sia i) più espressivo della realtà economico-finanziaria d’impresa, ii) più idoneo a rappresentare il concorso dei beni immateriali alla produzione del reddito.
Nell’impostazione dei principî contabili internazionali, dunque, il costo storico è soltanto uno dei parametri utilizzabili per misurare il capitale aziendale e non, come nel caso italiano, il parametro di riferimento. Gli Ifrs sono poi molto più restrittivi rispetto a quanto previsto nel nostro Paese sull’iscrivibilità tra le immobilizzazioni immateriali di talune classi di costo, tra cui di impianto e ampliamento, di ricerca e di pubblicità.
b) Più ampiamente, il passaggio dalla normativa interna ai principî
contabili internazionali rappresenta probabilmente, anche per quanto riguarda la definizione delle finalità del bilancio, un momento di rottura con la tradizione contabile continentale in favore del modello anglosassone.
L’enfasi sulla true and fair view rimane senz’altro, tuttavia con il passaggio da un “garantismo collettivo” (tutti i terzi) al sostanziale privilegio di una categoria di essi, gli azionisti (shareholders). Questi rappresentano pertanto il gruppo di interessi privilegiato in termini di informativa di bilancio, che ha ora il fine di sostenere e facilitare il finanziamento con capitali propri delle scelte di investimento, dunque anche il processo decisionale94.
94 Cfr. M. Poselli, L’evoluzione del sistema informativo di bilancio. Osservazioni
critiche, Giappichelli, Torino 2005, p. 41.
35
Mario Nicoliello
c) In particolare, occorre poi rammentare che, tra Ifrs e normativa italiana, sussistono comunque differenze, le quali investono le stesse nozioni di capitale e di reddito poste alla base del bilancio95. Il Codice civile considera infatti il bilancio come strumento volto a garantire l’affidamento dei terzi, per cui il principio di prudenza risulta finora sovraordinato agli altri. Secondo i principî contabili internazionali il bilancio può venire viceversa considerato come strumento grazie al quale i terzi assumono decisioni in campo economico, nel quale il principio di competenza economica (accanto a quello del going concern) costituisce l’ipotesi-base per la redazione. Se nella nozione civilistica il capitale viene visto come insieme di risorse e di obblighi facenti capo giuridicamente all’impresa, secondo gli Ifrs, invece, il capitale è un insieme di risorse economiche gestite dall’impresa96.
d) Per quanto poi concerne gli schemi di bilancio lo Ias 1 afferma che il
documento deve comprendere: Stato patrimoniale, Conto economico, Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, Rendiconto finanziario, Note esplicative al bilancio. La disciplina internazionale non prevede però schemi fissi obbligatori per le tavole di sintesi, ma detta soltanto norme generali, ossia linee-guida per la struttura dei documenti, disponendo il loro contenuto minimo obbligatorio. Sotto questo profilo per l’Italia si delinea un
95 Scrive Bandettini, “tali differenze sono di ordine particolare, generale e concettuale.
Le prime riguardano singoli aspetti o poste del bilancio d’esercizio, come, ad esempio, i conti d’ordine e il risultato di periodo. Le seconde, invece, investono il bilancio nella sua interezza e nella sua funzione. In questo senso, si abbandona l’informazione di tipo «garantista», per privilegiare conoscenze che agevolino l’assunzione di decisioni in campo economico. Infine, per quel che concerne le differenze di tipo concettuale viene introdotto un radicale cambiamento del significato di azienda. Questa, infatti, viene identificata come un investimento finanziario e, di conseguenza, diventa prioritario dimostrare la performance da essa conseguita nel periodo amministrativo. Così, ad esempio, il reddito, non è considerato come un’entità distribuibile, ma come un’entità prodotta, collegata, come tale, a tutte le grandezze economiche, ancorché non realizzate”. L. Bandettini, Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo gli Ias/Ifrs, Cedam, Padova 2006, pp. VII-VIII.
96 Il modello nazionale privilegia, dunque, la preminenza del principio di prudenza e la centralità del ruolo del reddito, a scapito della gestione finanziaria e monetaria. “Il più delle volte appare che l’attivo patrimoniale e il patrimonio netto tendono ad essere sottostimati, comportando un’alterazione nella relativa informazione, dovuta alla volontà di tutelare gli interessi dei fornitori e degli altri creditori commerciali dell’azienda, a scapito di quelli degli investitori. E la mancata obbligatorietà di compilazione del rendiconto finanziario conferma tale assunto”. Di contro il modello Ias/Ifrs implica un diverso concetto di prudenza e la centralità delle informazioni di natura finanziaria, relative ai flussi di cassa, rispetto a quelle sul reddito. “Tutto ciò nasce dalla volontà di favorire e tutelare gli interessi degli investitori e degli operatori del mercato mobiliare, come azionisti, obbligazionisti e intermediari finanziari”; ivi, pp. 120-121.
36
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
ritorno al passato, in quanto prima del 1991 nel nostro Paese non era presente una previsione di rigidi schemi di presentazione dei dati.
Lo Ias 1 invita infine le imprese a corredare il bilancio con una Relazione degli amministratori la quale illustri la genesi del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa, e inoltre i principali rischi potenziali.
e) Con l’avvento dei principî contabili internazionali si apre perciò una
diversa prospettiva culturale per redattori e lettori del bilancio pubblicato, il quale sarà sempre più considerato strumento conoscitivo della gestione passata necessario per lo svolgimento della futura97.
Se per le società quotate – connotate dall’appartenenza a gruppi di notevoli dimensioni – l’adozione dei principî contabili internazionali rappresenta un passaggio delicato, complesso e oneroso, per le piccole e medie imprese il problema si acuisce in quanto esse si trovano non di rado in condizioni di notevole svantaggio culturale, strutturale e funzionale. Ciò naturalmente vale non soltanto per la nostra nazione ma anche per il contesto europeo, ove la frequenza di piccole e medie imprese è molto elevata.
Si sottolinea inoltre come nell’applicazione degli Ifrs si assista a una conversione coinvolgente tutto il sistema gestionale-amministrativo dell’impresa, in quanto la transizione in oggetto non comporta soltanto una variazione dei principî contabili, ma determina la modifica di processi e procedure che, soltanto in presenza di una piena condivisione del management, potranno rappresentare condizioni di pieno e soddisfacente recepimento dei nuovi principî.
Allo stato attuale appare però evidente come buona parte delle piccole e medie imprese non si trovi nelle condizioni di affrontare questo cambiamento investendovi le risorse adeguate, sia per le concrete condizioni interne, sia a causa della ridotta apertura verso un’evoluzione culturale, dovuta principalmente ad assetti patrimoniali (familiari o di ristrette
97 Sempre più i principî contabili internazionali influenzeranno le scelte strategiche
degli operatori economici. “Cosi sarà: a) per l’introduzione del fair value, che comporterà una più veritiera rappresentazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e una diversa valutazione della situazione patrimoniale delle imprese; b) per la valutazione dell’avviamento che non sarà più ammortizzato e che potrebbe comportare un miglioramento dei risultati economici e una spinta alla crescita e allo sviluppo delle imprese attraverso operazioni di acquisizione e di concentrazione; c) per la contabilizzazione dei prodotti derivati e dei contratti di leasing, che influenzerà in misura rilevante la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società”. G. Frattini, op.cit., p. XV.
37
Mario Nicoliello
compagini sociali) tendenti a mantenere la gestione nelle sue espressioni più tradizionali e conservatrici.
6. Considerazioni conclusive
Il bilancio d’esercizio, qui affrontato dal punto di vista del suo significato economico e dell’evoluzione nella disciplina giuridica, costituisce il documento informativo più rilevante per le comunità economico-finanziarie odierne.
Esso riflette le dinamiche gestionali passate, presenti e previste future nell’integrarsi di quantità economiche, stime e congetture. Un bilancio true and fair costituisce dunque il primo momento informativo per apprezzare e comparare nel corso del tempo il grado di successo reddituale e competitivo di una realtà imprenditoriale. Grazie al bilancio si può poi interpretare la varia composizione nel tempo delle attese economiche dei portatori di interessi istituzionali nell’impresa.
L’informativa veritiera e corretta, scaturente da un bilancio trasparente, contribuisce nel tempo – in unione alla redditività di lungo periodo – ad incrementare i consensi, le collaborazioni e la fiducia di cui ogni impresa necessita per continuare la propria attività secondo economicità.
Tale funzione informativa – si è sostenuto – nel corso del XX secolo ha subito evoluzioni che, muovendo da una visione centrata sul controllo del patrimonio attraverso determinazioni di valore (paradigma bestano), ha trovato un momento di cesura nell’accettazione del paradigma zappiano. In questo, l’attenzione è tutta rivolta alle ragioni del reddito, e in tale ambito essa ha subito significativi sviluppi, fino a intrecciarsi ai giorni nostri con la “rivoluzione pratica” dei principî contabili internazionali.
Tale evoluzione-rivoluzione non poteva tuttavia rimanere racchiusa nelle semplici ragioni della dottrina aziendalistica. Il bilancio d’esercizio infatti, esistente sin dal tempo degli Assiro-Babilonesi, è giuridicamente normato dal tempo del Code Napoléon, dunque da ben prima dell’una e dell’altra delle rivoluzioni citate. L’interessamento giuridico è poi progressivamente aumentato negli ultimi decenni, a motivo di una serie di concause ricollegabili sia ai nuovi scenari politici e all’evoluzione socio-giuridica che li ha accompagnati, sia all’estendersi dei processi di globalizzazione dei mercati, anche finanziari, e al correlato originarsi di una cultura economico-finanziaria transnazionale a base anglosassone98.
La crescente attenzione delle discipline giuridiche al bilancio d’esercizio non era tuttavia proceduta – almeno fino agli anni Sessanta-Settanta del secolo XX – oltre la definizione di regole generali, la cui pratica
98 Cfr. A. Provasoli-A. Viganò (a cura di), op.cit., p. 17.
38
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
applicazione ha necessitato di un rinvio a norme tecniche aventi natura economico-aziendale, vale a dire alla ragioneria classica secondo alcuni, ai principî contabili secondo altri.
Peraltro, proprio i motivi generali detti prima, e nel contempo la rapida evoluzione della dottrina giuridica sul punto (G.E. Colombo, 196599; P. G. Jaeger, 1980; G.E. Colombo-R. Portale, 1994; L. A. Bianchi, 2001), hanno portato a interpretare diversamente nel tempo a) la finalità informativa assegnata al bilancio (il cui scopo principale è oggi quello conoscitivo dell’andamento e degli esiti della gestione); b) il più idoneo soddisfacimento delle esigenze terze (che oggi si ritiene possa essere raggiunto attraverso “il” bilancio d’esercizio, documento unitario); c) l’intelligibilità (canone che racchiude e sintetizza i concetti di chiarezza, verità e correttezza, costituenti norme-presupposto per la redazione del bilancio).
Il Legislatore ha variamente recepito, nel corso dell’ultimo mezzo secolo, i problemi economici legati all’esigenza di una corretta rappresentazione dei valori dei risultati aziendali, ma soprattutto li ha sempre più normati100, traendo forse profitto, nel contempo, dalla multiforme evoluzione, in quei medesimi anni, della dottrina italiana in tema di bilancio d’esercizio, tendente a) da un lato a radicarsi sulle posizioni esposte già negli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta, forse però senza apportare contributi tecnici analiticamente adeguati, b) dall’altro a orientarsi verso posizioni anglosassoni, sposando così il dettato teorico alla base degli Ias/Ifrs.
Il bilancio societario ha dunque subito nel tempo profonde modificazioni, transitando da documento sintetico e in certa misura inattendibile, che soggiaceva a criteri altamente soggettivi di redazione e di presentazione, a
99 “Col contributo di G.E. Colombo la dottrina giuridica prevalente transita da posizioni
sostanzialmente aderenti alle impostazioni della Ragioneria degli anni Cinquanta a posizioni radicalmente opposte, con riflessi fondamentali in merito alla stessa concezione del bilancio e alle funzioni di esso nel quadro dell’informativa economica delle società”. R. Camodeca, op.cit., in M. Martini-L. Zan, op.cit., p. 212.
100 “Se si osserva in termini temporali l’evoluzione delle dottrine in tema di bilancio d’esercizio e le indicazioni operative espresse si può rilevare un ritardo da parte del Legislatore nel recepire quei generali orientamenti dottrinali che nella pratica si andavano progressivamente diffondendo. Lo sfasamento temporale tra l’evoluzione delle dottrine economico-aziendali e la normativa civilistica dipende in parte dal differente approccio scientifico alla conoscenza del fenomeno aziendale. Infatti, la giurisprudenza ha interpretato nel tempo il fenomeno aziendale in modo autonomo, secondo gli schemi dl diritto non mediando, oppure solo parzialmente, i principi che progressivamente l’Economia aziendale andava elaborando per studiare e misurare il comportamento economico delle imprese. Tuttavia si nota un progressivo avvicinamento tra le due discipline, il legislatore infatti passa progressivamente da una visione più statica e patrimonialista dell’impresa ad una visione dinamica, dove il reddito viene non solo visto come risultato unitario ma anche nelle sue componenti”. F. Pezzani, op.cit., pp. 22-23.
39
Mario Nicoliello
documento analitico e articolato, che espone una ampia gamma obbligata di informazioni dirette e indirette, forse esaustive ma sempre più complesse, destinate agli utilizzatori finali101. Sono questi gli estremi di un’evoluzione nota, riassunta di seguito per conclusione.
Nel Codice civile del 1942 il bilancio era espressione delle voci dello Stato patrimoniale, il reddito veniva visto come risultato di sintesi, e si privilegiava una visione statica e patrimonialista dell’impresa.
Con la riforma del 1974, il bilancio d’esercizio veniva ad essere strutturato in due parti collegate aventi lo stesso peso in termini di esposizione delle voci, che andavano ad esprimere per confronto i risultati di sintesi. Si passava, in sostanza, ad una visione dinamica ed unitaria dell’azienda destinata a perdurare nel tempo mediante il prevalere della visione reddituale.
Con il D.Lgs. n. 127 del 1991, il bilancio presenta schemi progrediti integrati da note chiarificatrici e relazioni accompagnatorie evidenzianti aspetti qualitativi della gestione aziendale. Si accentua il concetto di economicità prospettica, alla quale sono ispirate le valutazioni delle classi di valore contenute nel documento di sintesi.
Con la riforma del 2003, viene poi migliorata l’informativa di bilancio attraverso una rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
L’emanazione da ultimo dei principî contabili internazionali, in grado di integrare e chiarire le disposizioni legislative disciplinanti la materia del bilancio, rappresenta un ulteriore contributo al miglioramento dell’informativa societaria, che deve essere vista come un’opportunità per l’impresa di apertura verso l’esterno. Tale introduzione più che un’evoluzione dal punto di vista legislativo, si profila come una “rivoluzione dal punto di vista pratico”, che risulta però forse priva di valore euristico per essere considerata alla stregua di una rivoluzione scientifica.
Dal punto di vista della derivazione contabile del bilancio si è probabilmente tornati al passato, in quanto l’impalcatura del documento secondo gli Ifrs muove dall’impostazione anglosassone di stampo patrimonialista: il medesimo che caratterizzava il Codice del 1942. Siamo quindi di fronte ad un cambiamento di impostazione con l’abbandono della teoresi reddituale? È ancora troppo presto per rispondere al quesito, visto che tutte le evoluzioni devono venire prima sperimentate nella pratica per poter essere definitivamente vagliate e quindi affermarsi. Occorrerà quindi osservare, tramite un’analisi minuziosa dei bilanci, il comportamento tenuto dalle imprese nell’applicazione dei nuovi standard e le divergenze più
101 Cfr. A. Consorti, op.cit., p. 187.
40
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
evidenti tra i valori calcolati con l’applicazione delle regole nazionali e quelli derivanti dai principî internazionali.
Indagini, queste ultime, che esulano dagli obiettivi del presente lavoro, che si desidera concludere sottolineando come l’efficacia informativa del bilancio non migliori automaticamente all’aumentare della quantità delle informazioni presentate. Se infatti le notizie esposte non risultano strettamente necessarie, esse finiscono per confondere il destinatario, il quale, subissato dall’abbondanza delle informazioni rese, potrebbe smarrirsi nella selva, spesso criptica, di voci e di valori102. Affinché il bilancio possa dunque esprimere tutta la sua potenziale attitudine segnaletica occorre quindi migliorare la qualità delle informazioni e non aumentarne la quantità, contemperando due opposti eccessi, entrambi nocivi: a) da un lato, una pedante e prolissa analiticità, dispersiva e poco incisiva; b) dall’altro, una estrema sintesi, sovente degenerante in un irragionevole, oscuro e controproducente ermetismo103.
Pertanto, sia la carenza sia l’esasperata ricchezza di notizie sono fattori di alterazione informativa laddove i) nel primo caso si omettano informazioni o non si faccia nulla per presentare i dovuti chiarimenti, mentre ii) nel secondo caso si realizzi un affollamento di informazioni talvolta inutili o addirittura appositamente fuorvianti. Oppure, peggio ancora, informazioni auto-referenziali rivolte ad sottolineare aspetti positivi della gestione e dei risultati, trascurando invece situazioni critiche, a volte perfino incombenti sulla continuità aziendale104.
102 Cfr. A. Broglia Guiggi, op.cit., p. 155. 103 Ivi, p. 156. 104 Cfr. M. Poselli, op.cit., p. 11.
41
Mario Nicoliello
Bibliografia
AA.VV., La determinazione del reddito nelle imprese del nostro tempo alla luce del pensiero di Gino Zappa, Atti della giornata di studio nel centenario della nascita di G. Zappa (Ca’ Foscari, 4 aprile 1981), Cedam, Padova 1982.
AA.VV. (a cura di Palma A.), Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, Giuffrè, Milano 1999.
AA.VV., Il bilancio di esercizio d’impresa, Giuffrè, Milano 2000. Agnoli N., Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in «Rivista
italiana di ragioneria e di economia aziendale», n. 9-10/2005. Airoldi G.-Brunetti G.-Coda V., Corso di economia aziendale, Il Mulino, Bologna
2005. Amaduzzi A., L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, Utet,
Torino 1963. Andrei P., La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio, in AA.VV., Il
bilancio di esercizio d’impresa, Giuffrè, Milano 2000. Avi M.S., Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, Cedam,
Padova, 1990. Bandettini A., Il bilancio d’esercizio, Cedam, Padova 1999. Bandettini L., Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo gli Ias/Ifrs,
Cedam, Padova 2006. Bauer R., Gli effetti della riforma societaria su bilancio e governo d’impresa.
Novità, modifiche e prospettive, Ipsoa, Milano 2003. Bauer R., Il bilancio fa spazio al fair value, in «Amministrazione e finanza», n. 2,
2004. Bianchi M.T., Alcune riflessioni sulla nuova disciplina del bilancio, in «Rivista
italiana di ragioneria e di economia aziendale», n. 1-2, 2005. Bocchini E., La chiarezza e la precisione dei bilanci delle società per azioni
nell’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza, in «Rivista delle società», n. 2, 1972.
Broglia Guiggi A., La funzione del bilancio d’esercizio tra evoluzione e tendenziale mutazione, Giappichelli, Torino 2004.
Bruni G., La ragioneria scientifica nel pensiero di Fabio Besta e nelle successive tendenze ed evoluzioni, in «Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale», n.9-10, 1996.
Cacciamani U., Il principio Ifrs per le Pmi tarato su entità troppo grandi, in «Il Sole 24 Ore del Lunedì», 22/10/07.
42
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
Camodeca R., L’iter formativo del bilancio d’esercizio, seconda edizione, Cedam, Padova 2000.
Camodeca R., Il bilancio dell’impresa nel diritto positivo italiano dai codici reali (1942) al D.Lgs. 127/91, in Martini M.-Zan L. (a cura di), Computisti, ragionieri, aziendalisti. La costruzione di una professione e di una disciplina tra Otto e Novecento, Cleup, Padova 2001.
Canziani A., Sulle premesse metodologiche della rivoluzione zappiana, in Scritti in onore di Lino Azzini, Giuffrè, Milano 1989.
Canziani A., Critica alla true and fair view quale pseudo-concetto empirico, in AA.VV., Studi in onore di Ubaldo De Dominicis, Lint, Trieste 1991.
Canziani A., Il bilancio delle società di capitali fra ragioneria e diritto. Note sull’evoluzione dal code Napoléon ai codici reali del 1942, in Martini M.-Zan L. (a cura di), Computisti, ragionieri, aziendalisti. La costruzione di una professione e di una disciplina tra Otto e Novecento, Cleup, Padova 2001.
Caramiello C., Capitale e reddito, Giuffrè, Milano 1993. Caramiello C., Il bilancio di esercizio, ieri ed oggi. Brevi note per un confronto,
Giuffrè, Milano 1994. Cattaneo M.-Golia P.-Manzonetto P., Il bilancio d’esercizio nelle imprese: finalità
e struttura, Etas, Milano 1989. Cattaneo M.-Manzonetto P., Il bilancio d’esercizio: profili teorici ed istituzionali,
seconda ediz., Etas, Milano 1997. Catturi G., La redazione del bilancio d’esercizio, Cedam, Padova 1999. Cavalieri E., Appunti in margine alla riforma del diritto societario, in «Rivista
italiana di ragioneria e di economia aziendale», n. 1-2, 2005. Ceccherelli A., Il linguaggio dei bilanci: formazione e interpretazione dei bilanci
commerciali, quarta edizione, Le Monnier, Firenze 1947. Coda V.-Frattini G., Valutazioni di bilancio. Principi economici, norme civili,
norme fiscali e direttive comunitarie, terza edizione, Libreria universitaria editrice Venezia, Venezia 1986.
Codini A., L’impresa e il suo governo, in Martellini M. (a cura di), L’impresa: Economia e gestione, Giappichelli, Torino 2003.
Colombo G.E., Il bilancio d’esercizio nelle Spa, Cedam, Padova 1965. Consorti A., L’evoluzione della funzione informativa del bilancio d’esercizio. Dal
conto del patrimonio al sistema delle informazioni, Giappichelli, Torino 2001.
Dezzani F.-Dezzani L., Il “disinquinamento” del bilancio d’esercizio, in «Diritto e pratica tributaria», n. 5, 2003.
D’Oriano R., I conti del nuovo bilancio d’esercizio, Cedam, Padova 1995.
43
Mario Nicoliello
Distefano F., L’applicazione facoltativa è una possibile via d’uscita, in «Il Sole 24 Ore del Lunedì», 22/10/07.
Fellegara A.M., Le valutazioni di bilancio nella logica civilistica, in AA.VV., Il bilancio di esercizio d’impresa, Giuffrè, Milano 2000.
Fiori G., Il principio della “rappresentazione veritiera e corretta” nella redazione del bilancio d’esercizio. Considerazioni critiche e profili evolutivi dell’informazione societaria, Giuffrè, Milano 1999.
Frattini G., Contabilità e bilancio. Il bilancio pubblico, volume secondo, Giuffrè, Milano 2006.
Guatri L., Illiceità ed inopportunità del conto profitti e perdite sintetico, in «Rivista dei dottori commercialisti», n. 5, 1972.
Lacchini M., Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio. Riflessioni economico-aziendali sull’innovato codice civile, Giappichelli, Torino 1994.
Masini C., I bilanci d’impresa. Principi e concetti, Giuffrè, Milano 1957. Masini C., La dinamica economica nei sistemi dei valori d’azienda: valutazioni e
rivalutazioni, Giuffrè, Milano 1960. Masini C., L’ipotesi e l’economia di azienda, Giuffrè, Milano 1961. Masini C., L’economia delle imprese industriali di medie dimensioni nelle
rilevazioni d’azienda, seconda ediz. riveduta, Giuffrè, Milano 1963. Masini C., Lavoro e risparmio, Utet, Torino 1979. Matacena A., Introduzione allo studio del bilancio d’esercizio, Clueb, Bologna
1979. Meriggioli G.-Masoni M., Il nuovo bilancio alla prova dei fatti. Un'indagine
empirica, in «Amministrazione e finanza», n.6, 1996. Monorchio A., Fabio Besta, il Maestro della moderna ragioneria, in «Rivista
italiana di ragioneria e di economia aziendale», n.7-8, 1996. Montanini M., Società quotate. Un'indagine sulle immobilizzazioni immateriali
nell'informativa di bilancio, in «Amministrazione e finanza», n. 17, 2000. Onida P., Il bilancio d’esercizio nelle imprese. Significato economico del bilancio e
problemi di valutazione, quarta ediz. emendata, Giuffrè, Milano 1951. Onida P., La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d’azienda, seconda
ediz. accresciuta, Giuffrè, Milano 1970. Onida P., Economia d’azienda, Utet, Torino 1971. Pantaleoni M., Alcune osservazioni sull’attribuzione di valori in assenza di
formazione di prezzi di mercato, in «Erotemi di economia», vol. secondo, Laterza, Bari 1925.
44
La natura economica del bilancio d’esercizio
nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003
Pezzani F., L’economia d’azienda e le determinazioni quantitative. L’evoluzione dell’informativa di bilancio, in Pezzani F. (a cura di), Il bilancio di esercizio nell’informativa esterna d’impresa, Giuffrè, Milano 1993.
Pini M., Politiche di bilancio e direzione aziendale, Etas Libri, Milano 1991. Poselli M., L’evoluzione del sistema informativo di bilancio. Osservazioni critiche,
Giappichelli, Torino 2005. Provasoli A., Il bilancio d’esercizio destinato a pubblicazione, Giuffrè, Milano
1974. Provasoli A., Adeguamento monetario e valori correnti nelle determinazioni di
bilancio, in «Rivista dei dottori commercialisti», n. 4, 1975. Provasoli A.-Viganò A. (a cura di), Bilancio. Valutazioni, lettura, analisi, Egea,
Milano 2007. Roscini Vitali F., L’Oic avvicina il Codice civile ai principi Ias, in «Il Sole 24
Ore», 22/06/07. Rossi G., L’applicabilità del fair value all’interno del modello di bilancio europeo,
in «Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale», n. 9-10, 2005. Savioli G., Verità e falsità nel bilancio d’esercizio. Interpretazione del concetto di
falso in bilancio alla luce dei principi dell’economia aziendale, Giappichelli, Torino 1998.
Simonetto E., Il bilancio d’esercizio, Cedam, Padova 1976. Stesuri A., Il “disinquinamento” del bilancio, in «Amministrazione e finanza», n.
4, 2004. Superti Furga F., Passato e presente del bilancio di esercizio: verso un bilancio
intellegibile, in «Rivista dei dottori commercialisti», n. 6, 1988. Superti Furga F., Reddito e capitale nel bilancio d’esercizio, seconda edizione
emendata, Giuffrè, Milano 1991. Superti Furga F., Il bilancio d’esercizio italiano secondo la normativa europea,
terza edizione, Giuffrè, Milano 1997. Terzani S., Introduzione al bilancio d’esercizio, Cedam, Padova 1985. Viganò E., Relazione sulla gestione, in AA.VV., La contabilità delle imprese e la
IV direttiva Cee, Etas, Milano 1980. Zappa G., Il reddito d’impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende
commerciali, seconda edizione, Giuffrè, Milano 1950. Zigiotti E., Sulla natura dei valori del capitale di bilancio nel sistema del reddito,
in AA.VV., Studi in onore di U. De Dominicis, Lint, Trieste 1991.
45
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE PAPERS PUBBLICATI DAL 2003 AL 2007∗:
24- Francesco AVALLONE, Monica VENEZIANI, Models of financial disclosure on the Internet: a survey of Italian companies, gennaio 2003.
25- Anna CODINI, Strutture organizzative e assetti di governance del non profit, ottobre 2003.
26- Annalisa BALDISSERA, L’origine del capitale nella dottrina marxiana, ottobre 2003. 27- Annalisa BALDISSERA, Valore e plusvalore nella speculazione marxiana, ottobre
2003. 28- Sergio ALBERTINI, Enrico MARELLI, Esportazione di posti di lavoro ed
importazione di lavoratori:implicazioni per il mercato locale del lavoro e ricadute sul cambiamento organizzativo e sulla gestione delle risorse umane, dicembre 2003.
29- Federico MANFRIN, Sulla natura del controllo legale dei conti e la responsabilità dei revisori esterni, dicembre 2003.
30- Rino FERRATA, Le variabili critiche nella misurazione del valore di una tecnologia, aprile 2004.
31- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Co-branding e valore della marca, aprile 2004. 32- Arnaldo CANZIANI, La natura economica dell’impresa, giugno 2004. 33- Angelo MINAFRA, Verso un nuovo paradigma per le Banche Centrali agli inizi del
XXI secolo?, luglio 2004. 34- Yuri BIONDI, Equilibrio e dinamica economica nell’impresa di Maffeo Pantaleoni,
agosto 2004. 35- Yuri BIONDI, Gino Zappa lettore degli Erotemi di Maffeo Pantaleoni, agosto 2004. 36- Mario MAZZOLENI, Co-operatives in the Digital Era, settembre 2004. 37- Claudio TEODORI, La comunicazione via WEB delle imprese italiane quotate: un
quadro d’insieme, dicembre 2004. 38- Elisabetta CORVI, Michelle BONERA, La comunicazione on line nel settore della
distribuzione dell’energia elettrica, dicembre 2004. 39- Yuri BIONDI, Zappa, Veblen, Commons: azienda e istituzioni nel formarsi
dell’Economia Aziendale, dicembre 2004. 40- Federico MANFRIN, La revisione del bilancio di esercizio e l’uso erroneo degli
strumenti statistici, dicembre 2004. 41- Monica VENEZIANI, Effects of the IFRS on Financial Communication in Italy:
Impact on the Consolidated Financial Statement, gennaio 2005. 42- Anna Maria TARANTOLA RONCHI, Domenico CERVADORO, L’industria
vitivinicola di Franciacorta: un caso di successo, marzo 2005. 43- Paolo BOGARELLI, Strumenti economico aziendali per il governo delle aziende
familiari, marzo 2005. 44- Anna CODINI, I codici etici nelle cooperative sociali, luglio 2005. 45- Francesca GENNARI, Corporate Governance e controllo della Brand Equity
nell’attuale scenario competitivo, luglio 2005. 46- Yuri BIONDI, The Firm as an Entity: Management, Organisation, Accounting, agosto
2005. 47- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Luca MOLTENI, Consumatore, marca ed
“effetto made in”: evidenze dall’Italia e dagli Stati Uniti, novembre 2005.
∗ Serie depositata a norma di legge. L’elenco completo dei paper è disponibile al
seguente indirizzo internet http://www.deaz.unibs.it
47
48- Pier-Luca BUBBI, I metodi basati sui flussi: condizioni e limiti di applicazione ai fini della valutazione delle imprese aeroportuali, novembre 2005.
49- Simona FRANZONI, Le relazioni con gli stakeholder e la responsabilità d’impresa, dicembre 2005.
50- Francesco BOLDIZZONI, Arnaldo CANZIANI, Mathematics and Economics: Use, Misuse, or Abuse?, dicembre 2005.
51- Elisabetta CORVI, Michelle BONERA, Web Orientation and Value Chain Evolution in the Tourism Industry, dicembre 2005.
52- Cinzia DABRASSI PRANDI, Relationship e Transactional Banking models, marzo 2006.
53- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Federica LEVATO, Brand Extension & Brand Loyalty, aprile 2006.
54- Mario MAZZOLENI, Marco BERTOCCHI, La rendicontazione sociale negli enti locali quale strumento a supporto delle relazioni con gli Stakeholder: una riflessione critica, aprile 2006
55- Marco PAIOLA, Eventi culturali e marketing territoriale: un modello relazionale applicato al caso di Brescia, luglio 2006
56- Maria MARTELLINI, Intervento pubblico ed economia delle imprese, agosto 2006 57- Arnaldo CANZIANI, Between Politics and Double Entry, dicembre 2006 58- Marco BERGAMASCHI, Note sul principio di indeterminazione nelle scienze sociali,
dicembre 2006 59- Arnaldo CANZIANI, Renato CAMODECA, Il debito pubblico italiano 1971-2005 nel-
l'apprezzamento economico-aziendale, dicembre 2006 60- Giuseppina GANDINI, L’evoluzione della Governance nel processo di trasformazione
delle IPAB, dicembre 2006 61- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Ottavia PELLONI, Brand Extension:
l’impatto della qualità relazionale della marca e delle scelte di denominazione, marzo 2007
62- Francesca GENNARI, Responsabilità globale d’impresa e bilancio integrato, marzo 2007
63- Arnaldo CANZIANI, La ragioneria italiana 1841-1922 da tecnica a scienza, luglio 2007
64- Giuseppina GANDINI, Simona FRANZONI, La responsabilità e la rendicontazione sociale e di genere nelle aziende ospedaliere, luglio 2007
65- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Ottavia PELLONI, La valutazione di un’estensione di marca: consonanza percettiva e fattori Brand-Related, luglio 2007
66- Marco BERGAMASCHI, Crisi d’impresa e tecnica legislativa: l’istituto giuridico della moratoria, dicembre 2007.
67- Giuseppe PROVENZANO, Risparmio…. Consumo….questi sconosciuti !!! , dicembre 2007.
68- Elisabetta CORVI, Alessandro BIGI, Gabrielle NG, The European Millennials versus the US Millennials: similarities and differences, dicembre 2007.
69- Anna CODINI, Governo della concorrenza e ruolo delle Authorities nell’Unione Europea, dicembre 2007.
70- Anna CODINI, Gestione strategica degli approvvigionamenti e servizio al cliente nel settore della meccanica varia, dicembre 2007.
71- Monica VENEZIANI, Laura BOSIO, I principi contabili internazionali e le imprese non quotate: opportunità, vincoli, effetti economici, dicembre 2007.
48
Università degli Studi Dipartimento didi Brescia Economia Aziendale
Dicembre 2007
Paper numero 72
Mario NICOLIELLO
LA NATURA ECONOMICADEL BILANCIO D’ESERCIZIO
NELLA DISCIPLINA GIURIDICADEGLI ANNI 1942, 1974, 1991, 2003
Università degli Studi di BresciaDipartimento di Economia AziendaleContrada Santa Chiara, 50 - 25122 Bresciatel. 030.2988.551-552-553-554 - fax 030.295814e-mail: [email protected]
AR
TI G
RA
FIC
HE
AP
OLL
ON
IO