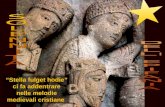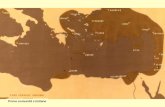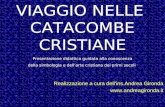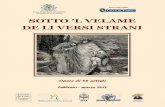LA MINISTERIALITA NELLA CHIESA - diocesipozzuoli.org · 6 Nelle prime comunità cristiane vi era...
-
Upload
trinhtuyen -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of LA MINISTERIALITA NELLA CHIESA - diocesipozzuoli.org · 6 Nelle prime comunità cristiane vi era...

1
LA MINISTERIALITÀ NELLA CHIESA
introduzione
Nella Chiesa-comunione, mirabilmente tratteggiata dal
Concilio, ogni “pietra vivente” concorre con il suo “specifico” alla
costruzione del Regno di Dio già a partire da questa terra. Il “fedele
cristiano laico”, in particolare, concorre a questa costruzione con la
sua specificità, che è quella di rimanere “nel secolo” e “nel
terrestre”, per orientare proprio il temporale ed il terrestre a Dio e
contribuire per la sua parte, al ritorno di ogni cosa al Padre in
Cristo. Ne deriva per i laici una spiritualità peculiare che non può
scimmiottare, né imitare la spiritualità propria delle altre figure
ecclesiali, cioè quella dei presbiteri, dei diaconi e quella delle
persone di vita consacrata.
La Chiesa del Concilio ha avvertito la necessità e l'urgenza di
riscoprire il pluralismo delle forme ministeriali, di cui era ricca e che
per vari motivi erano cadute in oblìo. La Chiesa si riscopre tutta
ministeriale, popolo sacerdotale, che esercita i ministeri in forza del
sacerdozio battesimale-cresimale (cfr. Lumen Gentium 10).
A più riprese il Vaticano II ha parlato del sacerdozio comune dei
fedeli, che è partecipazione radicale al sacerdozio di Cristo per il
battesimo e il dono dello Spirito Santo nella confermazione. Il
sacerdozio comune dei fedeli è esistenziale e liturgico in quanto il
battezzato-cresimato è messo in grado di offrire a Dio sacrifici
spirituali partecipando al culto della Chiesa.
L'esortazione apostolica Christifideles laici del 1988 afferma: «I
pastori, pertanto, devono riconoscere e promuovere i ministeri, gli
uffici e le funzioni dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento

2
sacramentale nel battesimo e nella confermazione, nonché, per
molti di loro, nel matrimonio [...].
In seguito al rinnovamento liturgico promosso dal Concilio, gli
stessi fedeli laici hanno acquisito più viva coscienza dei loro compiti
nell'assemblea liturgica e nella sua preparazione, e si sono resi
ampiamente disponibili a svolgerli: la celebrazione liturgica, infatti,
è un'azione sacra non soltanto del clero, ma di tutta l'assemblea
[...].
Durante i lavori del Sinodo, i Padri hanno dedicato non poca
attenzione al lettorato e all'accolitato. Mentre in passato
esistevano nella Chiesa latina soltanto come tappe spirituali
dell'itinerario verso i ministeri ordinati, con il Motu proprio di Paolo
VI Ministeria quaedam (15 agosto 1972), essi hanno ricevuto una loro
autonomia e stabilità, come pure una loro possibile destinazione
agli stessi fedeli laici, sia pure soltanto uomini» (Christifideles laici, n. 23).
Sulla base di questo insegnamento del Concilio, si può
vedere l'assemblea liturgica come tutta ministeriale. In essa lo
Spirito del Risorto suscita una straordinaria ricchezza di ministeri
e di servizi, richiesti e valorizzati dalla riforma liturgica post-
conciliare, che riscoprendo questa ricchezza vitale della Chiesa,
ha meglio mostrato la sua vocazione alla diaconia, al servizio
sull'esempio dello Sposo che si è fatto servo (cfr. Lc 22, 27).
Dal Concilio Vaticano II a Ministeria quaedam e Ad pascendum
Il Concilio si era limitato ad una indicazione assai generica
riguardo ai ministeri: «Il Rito delle Ordinazioni sia riveduto quanto
alla cerimonia e quanto ai testi» (Sacrosanctum Concilium 76). Si rendeva

3
necessario e urgente il lavoro di revisione riguardante l'esercizio dei
ministeri che apparivano come reperti archeologici e pertanto poco
rispondenti. all'ecclesiologia inaugurata dal Vaticano II.
Una commissione di esperti propose l'abolizione degli ordini mi-
nori, valorizzando i ministeri del lettorato e dell'accolitato. Questi
orientamenti diverranno norme per tutta la Chiesa con la pubblica-
zione dei due motu proprio di Paolo VI: Ministeria quaedam e Ad pa-
scendum del 1972, l'uno per regolare la nuova disciplina della
Chiesa latina per i ministeri e l'altro per il diaconato.
Con i due motu proprio, Paolo VI adempie il desiderio del
Concilio di rivedere i riti delle ordinazioni. La riforma voluta dal
Papa, pur risolvendo alcuni problemi urgenti inerenti alla
questione degli ordini minori, non si esaurisce in un presente
immediato ma nella capacità che avrà ogni Chiesa locale di
scoprirsi comunità tutta ministeriale.
Interessante è il fatto che il documento non parla più di ordini
ma di ministeri; pertanto al termine ordinazione si sostituisce il
termine istituzione. In pratica nei riti delle istituzioni non si ha una
esplicitazione del sacramento dell'Ordine, ma semplicemente una
deputazione ecclesiale per esercitare un ministero a favore della
comunità.
In realtà i ministeri sono dei sacramentali. Ne deriva, come
conseguenza, la possibilità di conferire questi ministeri ad ogni
battezzato. Infine, Paolo VI conserva solo quei ministeri che
hanno effettivamente una funzione ecclesiale. Naturalmente nella
scelta hanno giocato non solo considerazioni storiche, ma anche
valori ecumenici.

4
I ministeri, dunque, non vengono più qualificati come “ordini
minori”: e non si tratta solo di una variazione terminologica! La
nuova dizione segna il tramonto di una visione ministeriale
eccessivamente ed esclusivamente clericale. I ministeri, pertanto,
non sono più considerati soltanto tappe verso il presbiterato;
difatti, oramai sono accessibili anche ai laici. Sono “istituiti” o “di
fatto”: istituiti quando sono conferiti mediante un atto liturgico; di
fatto quando sono esercitati con un mandato temporaneo, ad
actum.

5
Il ministero del lettore Il lettorato è il primo dei ministeri istituiti. Afferma il motu proprio
di Paolo VI: «Esso ha radici molto remote e il suo esercizio apre
prospettive nuove all'impegno di annuncio del Vangelo, che la
Chiesa del nostro tempo riscopre come prioritario ed essenziale
nella sua missione di servizio al mondo». Conviene ripercorrerne
brevemente la storia.
Nel mondo greco-romano le scuole erano molto diffuse ma le
classi più povere della società ne rimanevano escluse. Molti
dovevano essere quindi gli analfabeti (agràmmatoi), quelli cioè che
non sapevano né leggere né scrivere. Ma come vi erano gli scrivani
di professione, così dovevano esserci dei lettori di professione.
Per gli ebrei la lettura della Sacra Scrittura era uno dei requisiti
alla base della loro religione. Il servizio sinagogale comportava la
lettura della legge mosaica e dei profeti (cfr. At 13,27; 15,21; 2Cor 3,15).
Emblematico è l’episodio narrato da Luca 4,16-22 che descrive con
molti particolari un servizio liturgico del sabato. Gesù è presentato
nella funzione di lettore e predicatore. Luca annota anche le
posizioni assunte da Gesù: «in piedi» per la lettura, «seduto» per il
commento. Viene anche menzionato un inserviente, a cui Gesù
consegna il rotolo biblico dopo la lettura. Non c’erano lettori ufficiali;
anche i visitatori occasionali potevano essere invitati dal capo della
sinagoga a fare una lettura e a prendere la parola (cfr. At 13,15).
In Ap 1,3 è espressa quella che potrebbe chiamarsi la
“beatitudine del lettore”, formulata assieme a quella degli ascoltatori
della parola profetica: «Beato chi legge e beati coloro che ascoltano
le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono
scritte. Perché il tempo è vicino».

6
Nelle prime comunità cristiane vi era dunque l’esigenza che ci
fossero persone capaci di leggere nelle riunioni comunitarie sia le
Scritture dell’Antico Testamento, sia le nuove Scritture, come le
lettere degli apostoli (cfr 1Ts 5,27; Col 4,16) e i vangeli. Probabilmente
questo compito all’inizio fu svolto dai didàskaloi, i dottori o maestri, i
quali leggevano e poi anche esortavano o spiegavano il testo,
attualizzandolo alla luce dei nuovi eventi. Gli stessi apostoli,
presentati in At 4,13 come uomini senza istruzione e quindi incapaci
di leggere e scrivere, dovevano ricorrere ad amanuensi (per
scrivere) e a lettori (per leggere). Anche chi, come Paolo, era in
grado di farlo, ricorreva ugualmente ad un segretario scrivano, a cui
dettava il testo.
Una traccia sicura dell'esercizio di questo ministero la si trova
nella I Apologia di Giustino (II secolo - verso il 150) che descrivendo
l'assemblea liturgica domenicale dice: «Si fa la lettura delle memorie
degli apostoli e degli scritti dei profeti sin che il tempo lo consente.
Quando il lettore (anaginóskon = colui che legge) ha terminato, colui
che presiede tiene un discorso per ammonire ed esortare
all'imitazione di questi buoni esempi». In Giustino il lettore appare
quindi come una figura distinta da chi presiede e fa l’esortazione;
ma è sempre una espressione generica che non fa essere sicuri che
quello del lettore fosse un ufficio vero e proprio.
La prima menzione letteraria sicura del lector è verso l'anno
200 in Tertulliano, il quale parla del lettore come di un ministero
proprio e stabile, così come ufficio proprio e determinato hanno il
vescovo, il presbitero e il diacono.
Un'altra esplicita testimonianza del lettore ci viene fornita dalla
Traditio Apostolica attribuita a Ippolito Romano, nella quale il

7
lettorato viene considerato una funzione permanente; vi si afferma
che «il lettore è costituito nell’atto in cui il vescovo gli consegna il
libro, infatti non gli sono imposte le mani (cioè egli non è ordinato)».
Verso la metà del secolo III, a Cartagine e a Roma, l'ufficio di
lettore è diventato ordine del lettorato. A Cartagine è il vescovo e
martire Cipriano (249-258) a testimoniare l'esistenza dell'ordine del
lettore nella sua Chiesa.
Esistevano due gradi di lettore: i lectores doctorum audientium,
cioè i lettori che coadiuvavano i presbiteri-catechisti nella
preparazione dei catecumeni; e i lectores veri e propri, che erano
istituiti dal vescovo con il parere di tutta la comunità e quindi
facevano parte del clero e ricevevano il sostentamento della Chiesa.
Alcuni lettori venivano istituiti però con l’intenzione di un futuro
passaggio al grado di presbiteri.
Altra testimonianza è quella di papa Cornelio, che in una lettera
del 351 a Fabio, vescovo di Antiochia, scrive: «A Roma, vi sono
quarantasei presbiteri, sette diaconi, sette suddiaconi, quarantadue
accoliti e cinquantadue esorcisti, lettori e ostiarii». È una rapida
radiografia, alla metà del sec. III, dell'ordinamento ministeriale a
Roma, comprendente anche il lettorato.
I lettori, dunque, ricevono una speciale ordinazione, riferita
anche dai libri liturgici del tempo di Gregorio Magno (sec. VII-VIII) che di
certo riferiscono tradizioni liturgiche più antiche.
L'Ordo romanus 35 (XI sec.) ci riporta la benedizione con la
quale il papa benedice un fanciullo per conferirgli il ministero di
lettore. Per il compimento del loro ufficio i lettori spesso
conoscevano a memoria tutta la Bibbia, erano custodi dei libri sacri
e degli archivi in cui erano conservati; spesso erano gli scrittori del

8
vescovo e insegnavano ai catecumeni. «I lettori possono essere
(considerati) pastori, perché nutrono il popolo che ascolta»: è il loro
più alto elogio.
Una causa di decadenza di questo ministero è dovuta proprio al
fatto dell’immissione di bambini tra i lettori e della riduzione del
lettorato a semplice tappa per il presbiterato. Infatti col procedere
del tempo molte delle funzioni del lettore furono attribuite o assorbite
da altri ministri della celebrazione; ad esempio il vangelo, dapprima
proclamato anche dal lettore, viene riservato al presbitero e al
diacono, mentre le altre letture sono fatte dal suddiacono.
Quando, a partire dall’alto Medioevo, la celebrazione della
messa cosiddetta “privata” si generalizza, il sacerdote celebrante
assomma tutte le funzioni e “recita” tutte le parti, comprese le
letture.
Il lettorato rimane come una funzione nominale e un “grado
inferiore” della gerarchia, riservato ai candidati al presbiterato e
conferito come una tappa per accedere al sacerdozio ministeriale,
tappa che poteva durare anche pochi giorni, se non addirittura pochi
minuti. Conseguenza di ciò è la svalutazione completa del lettorato
come ordine a se stante, anzi il suo annientamento come ordine
reale al quale corrisponde una funzione specifica nella pratica
concreta della liturgia.
La figura del lettore fu volentieri vista come la porta di ingresso
nel clero e quindi la via di accesso a ulteriori gradi, in particolare
quello del presbiterato. Anche se vi furono lettori che probabilmente
rimasero tali per tutta la vita, tuttavia era normale che, quando nel
presbiterio si aveva un posto vacante, il candidato a occuparlo fosse

9
scelto tra i lettori, ben conosciuti dalla comunità e dotati di una
buona conoscenza delle Scritture, derivante dal loro stesso ufficio.
Questa comprensione del lettorato come tappa verso il
presbiterato si è mantenuta fino al ricordato motu proprio di Paolo VI
Ministeria quaedam che lo configurai come un “ministero”
permanente ed istituzionalizzato che può essere conferito anche ai
fedeli laici in un’apposita celebrazione ecclesiale che li “istituisce” al
servizio della parola di Dio da proclamare nella liturgia, ma anche da
annunciare nella catechesi e in altre forme di annuncio.
In altri termini, il lettore è a servizio della Parola, chiamato a
dare voce alla Scrittura nell'azione liturgica. L'annuncio è essenziale
alla fede, è il mezzo di cui si serve Dio per dire al suo popolo
“Ascolta!”. L'annunzio è quindi un servizio preziosissimo, un
ministero indispensabile perché la Parola di Dio giunga a tutti e da
tutti venga accolta qual è veramente Parola che salva e santifica.
Per la sua importanza non può essere affidata «a un membro
qualsiasi dell'assemblea e, soprattutto, non all'ultimo momento. Non
si può improvvisare una lettura così impegnativa». Il lettore
attraverso il suo ministero dà corpo alla Parola scritta
trasformandola in Parola viva; difatti quando essa risuona nella divi-
na liturgia è Cristo stesso che parla (Sacrosanctum Concilium 7).
Il ministro si fa icona della Chiesa che annunzia ancora e
sempre la Parola. Dunque, il lettore presta la sua voce al Signore e
annunzia all'assemblea l'oggi della Parola di Dio, perché è Parola
efficace e vitale in quanto trova nella divina liturgia la sua piena
attualizzazione. La presenza del Signore nella Parola è sottolineata
dagli onori che nella celebrazione vengono resi all'Evangeliario:

10
acclamazione, processione, luci, incenso, bacio, ostensione e
benedizione.
Il ministero del lettore, perciò, non può prescindere da una
teologia della liturgia della Parola. Diversamente si corre il rischio di
considerare il lettore solo a livello tecnico e funzionale, il che
avviene puntualmente quando si isola il lettore dal contesto
teologico-celebrativo della Parola.
Il ministero del lettore si comprende pienamente quando si
considera l'importanza della Parola di Dio nella vita della Chiesa e la
sua riscoperta operata dal Vaticano II, tanto da parlare di primato
della Parola.
La Costituzione Sacrosanctum Concilium 51 riconosce che
«massima è l'importanza della Sacra Scrittura nella celebrazione
liturgica» ed esorta ad aprire «con maggiore abbondanza i tesori
della Bibbia». La Chiesa ha la primarietà del ministero della Parola
(cfr. At 6, 2-4), anzi la sua predicazione è «la prima carità» (cfr. Lumen
Gentium 27; 41).
Anche il nuovo Ordo Missae e l'Ordo Lectionum Missae
hanno ampiamente sottolineato il primato della Parola nella
celebrazione liturgica. La liturgia, difatti, è impregnata di Sacra
Scrittura: biblico è il contenuto, il linguaggio delle preci, delle
orazioni e degli inni liturgici (cfr. Sacrosanctum Concilium 24) .
Tale primato è culminante nella vita della Chiesa. La Parola dà
vita, suscita la fede e nutre la Chiesa. Pertanto la proclamazione
della Parola nella liturgia si fa evento di salvezza, realizza e
comunica quanto viene proclamato. La Parola celebrata e procla-
mata apre la Chiesa alle infinite ricchezze del mistero nascosto da
secoli (Ef 3, 5) e rivelato in Cristo (cfr. Presbiterorum Ordinis 13). A Dio che

11
parla «il popolo a sua volta risponde con il canto e con la preghiera» (Sacrosanctum Concilium 33).
La risposta dell'assemblea liturgica, rivela la struttura dialogica
della liturgia della Parola, si sviluppa e si amplifica in diversi
elementi rituali: innanzitutto la contemplazione silenziosa e
adorante, il salmo responsoriale, la professione di fede e la
preghiera universale.
Ciò vuol dire, in concreto, che la liturgia della Parola, in ogni
celebrazione sacramentale, non è soltanto un elemento didattico o
una preparazione a ciò che avviene più tardi, ma entra come costi-
tutivo nell'atto di culto e quindi partecipa delle finalità di esso: è glo-
rificazione di Dio e sorgente di salvezza e di santità per gli uomini.
Questo dato, che appartiene alla fede della Chiesa, ha delle con-
seguenze pastorali notevoli.
Vale la pena ricordarne almeno due: anzitutto la necessità per
la comunità cristiana di recuperare una viva esperienza della
presenza del Signore nella sua Parola, anche attraverso
l'importanza e lo spazio da restituire all'ascolto-adesione del
messaggio che essa reca; e poi l'attenzione che occorre attribuire
alla sua proclamazione da parte di coloro che se ne fanno portavoce
nell’assemblea liturgica.
Ciò che qualifica il lettore è, dunque, l’essere mediatore, non
protagonista. Egli è semplicemente un mediatore tra Dio, che rivolge
la sua Parola, e la comunità cristiana che l’ascolta e la fa propria. E
questo non è poco. Non trasmette ai fratelli una parola sua e
neppure della Chiesa, ma la parola di Dio. Il lettore non legge per
sé: compie un servizio per tutta la comunità, ma da parte di Dio. Dio
si comunica oggi, non per mezzo di rivelazioni o di angeli, ma

12
attraverso il ministero concreto di chi si fa annunciatore della sua
parola. Nei Principi e norme per l’uso del Messale Romano al n. 34 si
dice che «secondo la tradizione l’ufficio di proclamare le letture non
spetta al presidente ma ad uno dei ministri». In linea di principio non
deve essere il presidente a proclamare le letture nella celebrazione,
eccettuati i casi in cui nessun altro lo possa fare. Sempre secondo la
tradizione, la proclamazione del vangelo è riservata ai ministri
ordinati per la loro configurazione speciale a Cristo nel sacramento
dell’ordine. Le altre letture vengono proclamate dai laici.
Ogni comunità cristiana, nella sua articolazione ministeriale,
deve avere un gruppo di lettori istituiti, capaci di adempiere questo
ministero a servizio della comunità.
Conviene approfondire brevemente il significato del compito
proprio del lettore che è quello di proclamare la Parola di Dio. Cosa
vuol dire proclamare? Non significa solo leggere ad alta voce, pur
avendo questo significato, ma certamente il significato è più ampio e
preciso. Significa e comporta più aspetti: rendere pubblico, cioè far
conoscere ai presenti ciò che si legge; acclamare, in quanto le
parole pronunziate sono Parole di Dio; rivelare, perché ogni volta
che la Parola viene proclamata è una nuova rivelazione;
proclamazione misterica, cioè efficace, in quanto rende presente
ciò che proclama; memoria, perché presenza di ciò che viene
ricordato; annunzio gioioso, in quanto ha in sé una forza di
salvezza.
Il lettore chiamato a proclamare la Parola deve far vivere il
testo, diventa profeta, e questo richiede la fede non solo
dell'assemblea che ascolta ma anche del lettore che proclama.

13
Unitamente alla fede, necessita la preghiera e la preparazione
tecnica.
Nel proclamare la Parola, il lettore, diviene strumento di Cristo
nell'attualizzazione della sua Parola. Allora non si tratta tanto di
leggere, quanto di proclamare cioè promulgare in maniera solenne
la Parola di Dio dinanzi all’assemblea liturgica in ascolto di Dio che
parla. Dunque un servizio per tutta la comunità compiuto da parte di
Dio, che oggi vuole parlare attraverso il ministero dei lettori.
Il lettore è l'ultimo anello in una catena di trasmissione: il profeta
o l'apostolo parlavano molti secoli fa, le loro parole furono fissate nel
libro ispirato, altri le hanno tradotte e preparate per la celebrazione,
e ora un determinato lettore le proclama alla comunità. Per quanto
sia sublime la teologia di Isaia o di Giovanni o di Paolo, se il lettore
non la comunica in modo efficace o se il microfono non funziona,
sarà difficile che si stabilisca un dialogo pieno di vita tra Dio e la sua
comunità.
In conseguenza di quanto finora detto, il campo di azione del
lettore istituito è molto vasto: va dalla proclamazione della parola
alla catechesi; dalla preparazione degli stessi lettori a quella del
luogo della proclamazione della parola. I suoi compiti vengono precisati nello stesso documento di
Paolo VI Ministeria quaedam in questi termini: «Il lettore è
costituito per l’ufficio, a lui proprio, di leggere la parola di Dio
nell’assemblea liturgica. Pertanto, nella Messa e nelle altre
azioni sacre proclami dalla sacra Scrittura le letture (ma non il
vangelo); in mancanza del salmista legga il salmo interlezionale;
quando non è disponibile il diacono o il cantore proponga le
intenzioni della preghiera universale (o preghiera dei fedeli);

14
diriga il canto e guidi la partecipazione dei fedeli; istruisca i
fedeli a ricevere degnamente i sacramenti. Egli potrà anche – se
necessario – curare la preparazione degli altri fedeli, i quali
abbiano ricevuto temporaneamente l’incarico di leggere la sacra
scrittura nelle azioni liturgiche».
Il documento emanato dall’episcopato italiano nel 1977,
Evangelizzazione e ministeri, dà ancora grande risalto al tema dei
ministeri istituiti, ribadendo quanto già detto nei documenti già citati,
ma affrontando anche alcune questioni circa i ministeri: nozione di
ministero non ordinato; ministeri e religiosi; ministeri e laici; ministeri
e famiglie; ministeri e donne; ministeri e movimenti apostolici.
Volendo quindi esplicitare, in forma più organica, i compiti del
lettore, si possono delineare i suoi “spazi” d’intervento ministeriale:
innanzitutto la proclamazione della parola di Dio nell’assemblea
liturgica (è questa la sua funzione primaria e originale, come ho già
cercato di evidenziare); e poi, fuori del contesto cultuale-celebrativo,
anche il compito di catechista ed educatore nella fede dei suoi
fratelli. In forza del ministero ricevuto il lettore diventa il promotore e
l’animatore di centri di ascolto della parola di Dio, di gruppi del
vangelo o di iniziative analoghe all’interno della comunità
parrocchiale.
Per compiere queste funzioni si richiedono al lettore determina-
te qualità: acquistare una sempre maggiore conoscenza della
Scrittura con l'ausilio di sussidi idonei; meditare la Sacra Scrittura;
dedicare tempo alla preghiera; impegnarsi in una coerente
testimonianza di vita; assicurare continuità e disponibilità
nell'esercizio del ministero.

15
Significative, in proposito, le espressioni dell'omelia per la
istituzione dei lettori: «è necessario che, mentre annunzia agli altri la
Parola di Dio, (il lettore) sappia accoglierla con piena docilità allo
Spirito Santo; meditarla ogni giorno per acquistare una conoscenza
sempre più viva e penetrante, ma soprattutto renda testimonianza
con la sua vita al nostro Salvatore Gesù Cristo».
Per completezza di trattazione non si possono non citare due
altri documenti normativi in campo liturgico: l’Ordo Lectionum
Missae, ossia l’Ordinamento Generale delle Letture della Messa,
promulgato dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei
sacramenti nel 1981, e l’Institutio Generalis Missalis Romani.
Nell’Ordo Lectionum Missae al capitolo III si parla degli Uffici e
ministeri nella celebrazione della liturgia della Parola intra missam.
Dopo aver trattato sui compiti di colui che presiede, dai numeri 44 a
57 si parla del compito dei fedeli, e tra questi quelli del lettore. Così
è detto al n. 51: «il lettore ha nella celebrazione eucaristica un suo
ufficio proprio, che deve esercitare lui stesso, anche se sono
presenti ministri di ordine superiore. Il ministero del lettore vien
conferito con rito liturgico: deve quindi essere tenuto in onore. I
lettori istituiti, se presenti, compiano il loro ufficio almeno nelle
domeniche e nelle feste, specialmente durante la celebrazione
principale. Si potrà affidar loro anche il compito di dare un aiuto nel
predisporre la liturgia della parola, e, se necessario, di preparare gli
eventuali altri fedeli che per incarico temporaneo dovessero
proclamare le letture nella celebrazione della messa». Il lettore ha,
dunque, una fisionomia ministeriale ben precisa che non è lecito
ignorare e trascurare; al lettore bisogna assicurare una certa dignità
e stabilità ministeriale.

16
E tale fisionomia impone che il lettore abbia alcuni requisiti.
L’Ordo Lectionum Missae al n. 52 recita: «L’assemblea liturgica non
può fare a meno dei lettori, anche se non istituiti per il loro compito
specifico. Si cerchi dunque di avere a disposizione alcuni laici, che
siano particolarmente idonei e preparati a compiere questo
ministero». E al n. 55: «Perché i fedeli, con l’ascolto delle divine
letture, maturino nel loro cuore un soave e vivo amore della Sacra
Scrittura, è necessario che i lettori incaricati di tale ministero, anche
se non ne hanno ricevuto l’istituzione, siano veramente idonei e
seriamente preparati».
Si insiste, dunque, sulla “idoneità” e preparazione dei lettori.
Questa preparazione è spessissimo disattesa (dagli stessi pastori
delle comunità), sia per frettolosità, sia per un voler rendere
partecipi tutti di questo servizio. È invece uno dei rischi peggiori.
Sembra si segua a volte un criterio democratico e familiare nelle
parrocchie quando si invita a leggere un volontario o uno qualunque
a recarsi all’ambone: non è segno di rispetto né verso la parola di
Dio né verso la comunità che vuole incontrare Dio nella sua parola.
La delicatezza del ministero del lettore deve scoraggiare ogni im-
provvisazione e tendere invece ad una formazione attenta e
accurata, che si articola su un duplice registro: quello spirituale e
quello tecnico.
La preparazione spirituale comprende la dimensione biblica e
quella liturgica. La formazione biblica deve portare i lettori a
familiarizzare con il linguaggio della Bibbia, a saper inquadrare le
letture nel loro contesto e a cogliere il centro dell'annunzio rivelato
alla luce della fede.

17
Dal momento che i libri della Bibbia sono diversi tra loro e che
in uno stesso libro esistono generi letterari diversi: storia, lettere,
profezia, poesia... esistono diversi modi di esprimersi: affermazioni,
professioni di fede, racconti, parabole. Conoscere i generi letterari,
l'autore e l'epoca di composizione, il luogo e la situazione socio-
religiosa in cui è stato redatto il testo biblico favorisce la
comunicazione e facilita la comprensione del testo proclamato.
Perciò conoscere e rispettare il genere letterario dei testi biblici è il
modo migliore per mettersi al servizio della Parola.
E la formazione liturgica deve introdurre il lettore a percepire il
senso e la struttura della liturgia della Parola e anche la risonanza
che una determinata pagina biblica può avere nella festa e nel
tempo dell’anno liturgico in cui è proclamata; Naturalmente il lettore
deve conoscere bene, o almeno averne un’idea chiara,
l'ordinamento delle letture e dei lezionari e la struttura del Messale.
Si deve anche curare la preparazione tecnica: educare la voce,
saperla impostare rettamente; fare un buon uso dei mezzi di
amplificazione, conoscere le eventuali difficoltà testuali (nomi e
vocaboli prettamente biblici). E qui dovrei inoltrarmi in un campo
assai utile ma molto vasto e tecnico, per cui mi limito solo a qualche
rapida osservazione.
Ad esempio bisogna curare l'accesso all'ambone, che deve
essere sempre dignitoso: è bene non avviarsi prima che il sacerdote
abbia terminato la colletta, nel caso della prima lettura, o che sia
concluso il salmo responsoriale nel caso della seconda. Bisogna
anche prestare la debita attenzione all'atteggiamento del corpo, che
deve evitare ogni forma di teatralità, come anche l’eccessiva
timidezza o l’incerto incedere.

18
L’assemblea “sente” il lettore, ma lo “vede” anche. Prima di
iniziare la proclamazione, il lettore attende che tutti seggano e si
crei il clima di silenzio e di ascolto. Durante la proclamazione, il
busto sia eretto e il volto non piegato sul libro.
E vorrei aggiungere alcuni suggerimenti per una buona
proclamazione. Bisogna imparare a dominare il respiro per
"generare" una voce ricca di suono e sostenere una buona dizione.
La materia prima per un buon servizio alla Parola di Dio è la voce.
Si tratta di parlare ad alta voce, spingendo in avanti la voce, cioè
non si deve trattenere il suono in fondo alla gola, ma proiettarlo
lontano, davanti a sé, come quando si chiama qualcuno distante da
noi.
Va curata, inoltre, l'articolazione del testo: per una lettura che
faciliti la comunicazione, che realizzi, cioè, il duplice movimento di
andata e di ritorno, occorre parlare con molta chiarezza,
pronunciare con precisione e distintamente ogni sillaba e ogni
parola. Il movimento può essere riassunto in tre immagini: cuore,
labbra, orecchio, che sono i luoghi attraverso cui passa la parola e
si genera la comunicazione.
E non va trascurata l’attenzione al fraseggio, cioè al modo di
articolare in maniera espressiva le frasi di un brano. Questo
richiede di prestare attenzione: alle frasi che hanno un movimento
di crescita o di discesa; alle frasi secondarie; alla frase
interrogativa (evitare quel ridicolo e infantile caricamento della voce
nella parte finale della frase interrogativa); alla frase esclamativa; e
in particolare alla punteggiatura (stacchi, pause, allungamenti,
contrazioni... ).

19
A questo aiuta molto il formato e l’uso del libro da cui si legge il
testo sacro che non può essere in nessun modo il foglietto. Un
lezionario ben stampato, a caratteri sufficientemente grandi e,
soprattutto, con una buona punteggiatura e disposizione sintattica
delle frasi (distinguendo, per esempio, con esattezza i dialoghi e i
racconti), favorisce una proclamazione migliore.
Ma favorisce un tale risultato anche e specialmente una buona
capacità del lettore a “interpretare” il testo. E per acquisire questa
capacità bisogna preparare la lettura, leggendo prima attentamente il
testo per recepirne il significato e il messaggio, cogliendone la
struttura e l'articolazione delle parti, individuandone i passaggi-
chiave e le parole-chiave per metterli in risalto nella proclamazione,
e infine determinandone il genere per regolare e modulare la voce,
la proiezione, il ritmo. Mi permetto suggerire di evitare alcuni scogli:
un tono cantilenante; un tono monocorde; la caduta della voce alla
fine della frase; la sveltezza.
Forse non è male aggiungere qualche osservazione sul modo
di usare il sistema di amplificazione. Ormai tutte le chiese sono
dotate di impianti di amplificazione: microfono unità di potenza,
diffusori. È necessario effettuare la registrazione dei volumi e dei
toni, operazione che richiede l’aula liturgica piena, in modo da
valutare l'assorbimento delle onde sonore da parte dell'assemblea.
Per regolare il volume bisogna tener conto dell'edificio; della
dimensione dell'assemblea e della potenza vocale di chi userà il
microfono. Il microfono più idoneo per la proclamazione della Parola
è quello direzionale che ha la capacità di accogliere solo i suoni
emessi davanti alla capsula. Sono da evitare i microfoni
omnidirezionali, più adatti per il coro e per un gruppo di persone.

20
Comunque per una buona resa occorrono strumenti di qualità per un
suono pulito e gradevole.
Infine, mi si consenta di dire qualcosa sull’abito del lettore.
L’Ordo Lectium Misse al n. 54 dice: «Il sacerdote, il diacono e il
lettore istituito, allorché salgono all’ambone per proclamare la Parola
di Dio nella celebrazione della Messa con il popolo, devono
indossare la veste sacra propria del loro ufficio».
Per il lettore non istituito, uomo o donna, non c'è bisogno di una
veste speciale, «essi possono salire all'ambone in abito comune».
Quello della veste è un aspetto su cui spesso si preferisce
sorvolare, forse per paura di clericalizzazione dei laici; ma un buon
lettore lo si riconosce anche dal modo in cui si presenta
all’assemblea, specie se pensiamo che a volte si vedono lettori e
lettrici non sempre vestiti dignitosamente.
Lo Ordo Lectionum Misse al n. 52 parla della possibilità di
distribuire le letture a più lettori, evitando di far proclamare ad
un’unica persona sia la prima lettura, sia il salmo, sia la seconda
lettura.
È poi auspicabile che il salmista non sia la stessa persona che
ha proclamato la prima lettura, sia perché il salmista è un altro
ministero, sia perché l’indole propria del salmo ne richiede il canto e
quindi è più indicato che a cantare il salmo sia un cantore esperto
nell’arte del salmeggiare. Il lettore, poi, non deve dire «prima
lettura», «salmo responsoriale» e neppure leggere la frase
riassuntiva che precede il testo.

21
Il ministero dell’accolito Questo ministero, nel suo concreto esercizio, è destinato a
mettere in risalto l'intimo legame che esiste tra la liturgia e la carità.
La celebrazione eucaristica, infatti, non solo presuppone la carità
verso i fratelli, come impegno di donazione e come volontà di
riconciliazione (cfr. Mt 5,23-24;1Cor 11,17 ss), ma implica, nell'atto in cui si
compie, un atteggiamento di amore che si esprime nei molteplici e
diversi compiti di accoglienza (cfr. Gc 2,1 ss), di solidarietà (cfr. 1Cor 11,29),
di comunione e di servizio con tutti, ma soprattutto con i più deboli
e con i più poveri.
La testimonianza di carità, offerta ai fratelli durante l'Eucaristia,
deve estendersi e prolungarsi dopo la celebrazione e diventare
sollecitudine verso i lontani, gli assenti, i malati, coloro che sono
nella difficoltà o nel bisogno. Solo così la partecipazione al
sacramento della carità diventa piena e autentica. Il ministero
dell'accolito acquista pienezza di significato e importanza notevole
proprio nel contesto di una Chiesa che vive il mistero della carità ed
è chiamata a svolgere nel mondo il ministero della carità.
Forse conviene anche per il ministero dell’accolito, dare
qualche breve informazione storica. Il termine «accolito» deriva da
un verbo greco che significa «seguire» o anche «servire». L'accolito
quindi è il ministero affidato a coloro che, nella Chiesa, sono
chiamati a seguire i pastori, cioè a collaborare strettamente con loro
nella specifica missione ad essi affidata e a offrire ai fratelli un
servizio ispirato ad una sincera carità, soprattutto nel momento in
cui questa carità si manifesta e si celebra, cioè durante la
celebrazione eucaristica.

22
Da una notizia che si trova nel Liber pontificalis, pubblicato dal
Duchesse, sembra che l'istituzione di questo particolare ministero,
che non è conosciuto in Oriente, debba esser fatta risalire a papa
Vittore (+ 197); comunque risulta che al tempo di papa Cornelio gli
accoliti erano già in numero di 42, divisi secondo le sette regioni di
Roma.
Gli accoliti, chiamati dapprima «sequentes», sono anche
denominati «ceroferarii», in quanto avevano come funzione quella di
scortare con i ceri la processione d'ingresso del papa, durante la
messa, e quella del diacono al momento della proclamazione del
vangelo.
A partire dal IV secolo, infatti, e precisamente dopo la pace di
Costantino, il culto della Chiesa romana conosce uno sviluppo gran-
dioso: molti riti in uso presso la corte imperiale sono trasferiti nelle
azioni liturgiche presiedute dal papa. Si solennizzano cosi le
processioni, il papa viene accompagnato in segno di onore da 7
candelabri, rappresentanti le corrispondenti regioni della città di
Roma, mentre il popolo acclama e canta e il profumo dell'incenso
inonda la basilica. I sette candelabri, portati appunto dagli accoliti,
una volta che si è giunti all'altare vengono deposti sulla mensa o nei
pressi di essa. Uso, questo, che è rimasto in vigore, nella messa del
vescovo, fino alla riforma liturgica.
Nel secolo VI gli accoliti acquistarono a Roma un'importanza
ancora maggiore: aiutavano all'altare i diaconi e il presidente
dell'assemblea; portavano le offerte e i vasi sacri ed erano a loro
disposizione per il compimento dei servizi da prestare al popolo.
Oltre questi compiti, che si svolgevano nella celebrazione, gli accoliti
avevano anche altri compiti: accompagnavano il vescovo nelle sue

23
visite, erano al suo servizio per compiere ambasciate e portare
ordini e avevano talora anche l'impegno di assicurare una certa
disciplina tra il popolo cristiano.
Finalmente, in forma straordinaria e come aiuto ai diaconi e ai
presbiteri, gli accoliti avevano anche il ministero della distribuzione
dell'Eucaristia. Erano loro, ad esempio, che portavano il fermentum,
una piccola parte cioè del pane consacrato dal papa nella sua
messa, alle varie chiese di Roma, quale segno di comunione tra il
vescovo di Roma e i presbiteri che celebravano i santi ministeri nelle
chiese succursali, chiamate tituli.
Come il lettorato, anche l'accolitato acquistò ben presto la
fisionomia di un grado inferiore della gerarchia. Sono noti i riti
dell'«ordinazione» degli accoliti dagli antichi documenti liturgici che
sono giunti fino a noi. Questa si svolgeva durante la messa: i
candidati erano rivestiti dell'abito loro proprio e veniva loro
consegnato un sacchetto di lino che era usato per portare
l'Eucaristia sia ai presbiteri, durante la concelebrazione, sia ai fratelli
assenti, una volta che la messa era terminata.
Col passar del tempo, e precisamente dall'alto medioevo, egli
diventò un semplice «inserviente» del prete che ormai celebrava da
solo, mentre nella celebrazione solenne mantenne l'incombenza di
portare i ceri e servire all'altare.
L'accolitato si è sempre conservato, analogamente al lettorato,
come un «ordine minore», cioè come un gradino previo, necessario
per accedere all'ordinazione sacerdotale, ma di fatto poco rilevante
come «ministero ecclesiale». Anch'esso è stato restituito alla Chiesa
come un servizio stabile dal motu proprio Ministeria quaedam e può

24
quindi essere conferito anche a laici, con precise e significative
funzioni miranti all'edificazione del popolo di Dio. Tali funzioni sono descritte nel cap. VI di Ministeria quaedam in
questi termini: «L'accolito è costituito per aiutare il diacono e servire
il sacerdote. Pertanto è suo compito curare il servizio dell'altare,
aiutare il diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche, specialmente
nella celebrazione della messa; inoltre, distribuire, come ministro
straordinario, la santa comunione tutte le volte che i ministri
(ordinari)... non vi sono o non possono farlo, per malattia, per l'età
avanzata o perché impediti da altro ministero pastorale, oppure tutte
le volte che il numero dei fedeli, i quali si accostano alla sacra
mensa, è tanto elevato che la celebrazione della messa si
protrarrebbe troppo a lungo. Nelle medesime circostanze
straordinarie potrà essere incaricato di esporre pubblicamente la
Santissima Eucaristia e poi riporla; ma non di benedire il popolo.
Potrà anche, in quanto sia necessario, provvedere all'istruzione
degli altri fedeli che, per incarico temporaneo, aiutano il diacono e il
sacerdote nelle azioni liturgiche».
A questi compiti, quasi esclusivamente cultuali, i vescovi italiani,
nel documento già ricordato, I ministeri nella Chiesa, ne aggiungono
un altro che ha pure un retroterra nella storia e nell'esperienza della
Chiesa antica, quello precisamente di aver cura dei deboli e degli
infermi. Compito che va “letto” all'interno del significato e della
portata della celebrazione eucaristica, memoriale della carità di
Cristo.
Tenendo dunque presenti queste indicazioni magisteriali si
possono individuare, in maniera più completa e ampia, gli ambiti e le
funzioni specifiche dell'accolito. Innanzitutto egli è chiamato ad

25
essere il promotore della vita liturgica di una comunità, non solo
prestando il suo servizio nella celebrazione, in modo che essa risulti
veramente un'azione comunitaria e partecipata, significativa dal
punto di vista dei diversi servizi che si compiono e pedagogicamente
efficace, ma anche prendendosi cura di quanti, in essa, svolgono
compiti liturgici: ministranti, cantori, lettori, ecc. Egli è quindi il
naturale animatore del “gruppo liturgico” della comunità e per questo
deve curare la formazione liturgica e biblica dei vari componenti,
preparare le celebrazioni, e guidarne lo svolgimento.
Come ministro straordinario dell'Eucaristia egli si affiancherà al
sacerdote e al diacono nella promozione e nell'animazione della
pastorale liturgico-eucaristica, non solo portando la santa comu-
nione ai malati, ma curando l'incremento e l'organizzazione del culto
eucaristico fuori della messa secondo le indicazioni del magistero e i
bisogni della comunità in cui vive ed esercita il suo ministero.
Emerge poi un altro compito dell'accolito: quello di un più vasto
e profondo esercizio della carità verso i poveri, i sofferenti, i malati,
gli emarginati. Dovrà essere l'accolito a suscitare e a curare nella
parrocchia o nei gruppi caritativi le molteplici forme di assistenza, di
aiuto, di promozione umana che oggi sono richieste ai credenti che
vivono nel mondo e che la Chiesa mette in cantiere per rispondere
alle numerose e svariate attese che si manifestano nei settori
dell'emarginazione, della povertà, della terza età, della malattia, ecc.
Egli sarà perciò il leader naturale di quelle associazioni o movimenti
che s'interessano di questo settore e, come tale, potrà rendere un
prezioso servizio di collaborazione all'opera caritativa dei pastori.
In conformità a questi compiti, si richiedono all’accolito alcuni
requisiti. Il primo è una robusta spiritualità eucaristica: «L'accolito

26
eserciterà tanto più degnamente questi compiti, se parteciperà alla
ss. Eucaristia con una pietà sempre più ardente, si nutrirà di essa e
ne acquisterà una sempre più viva conoscenza.
L'accolito, destinato in modo speciale al servizio dell'altare,
apprenda tutte quelle conoscenze che riguardano il culto pubblico
divino e si sforzi di comprenderne l'intimo e spirituale significato: in
tal modo, ogni giorno potrà offrire interamente se stesso a Dio, nel
tempio essere di esempio a tutti per il suo comportamento serio e
rispettoso, e, inoltre, avere un sincero amore per il Corpo mistico di
Cristo, cioè il popolo di Dio, e specialmente per i deboli e i malati» (Ministeria quaedam VI).
L'esortazione che il vescovo rivolge agli accoliti, mentre
conferisce loro il ministero, è nella medesima linea: «L'esercizio di
questo ministero vi stimoli ad attingere dal sacrificio del Signore
una vita spirituale sempre più intensa, e a conformarvi sempre più
perfettamente a questo stesso sacrificio; procurate anche di
penetrare il senso intimo e profondo delle mansioni a voi affidate,
in modo da offrire ogni giorno voi stessi a Dio in sacrificio spirituale
a lui gradito, per Cristo Gesù. Questi vostri compiti vi ricordino che
dovete formare con i fratelli un solo corpo, come partecipare con
essi all'unico pane dell'Eucaristia. Amate di sincero amore il popolo
di Dio che è il Corpo mistico di Cristo, amate specialmente i deboli
e gli infermi: attuerete così il comando dato dal Signore agli
apostoli nell'ultima cena: amatevi l'un l'altro, come io ho amato
voi».
Da ciò che è stato detto fin qui scaturisce anzitutto che anche
agli accoliti è domandata una solida formazione liturgica e
spirituale. Essa deve essere ottenuta attraverso lo studio

27
approfondito della genuina natura della liturgia, non come un puro
e semplice insieme di riti e di cerimonie, ma come il complesso dei
santi segni con cui Cristo risorto continua, nella Chiesa e attraverso
la Chiesa, il suo servizio sacerdotale per la gloria del Padre e la
santificazione dei fratelli: ma lo studio non basta: ad esso si dovrà
accompagnare una opportuna «iniziazione» al mistero liturgico.
Come potrà l'accolito inculcare nei suoi fratelli il gusto della
partecipazione alla liturgia se non vive egli stesso per primo quel
«mistero» che serve?
Per questo gli accoliti istituiti dovranno unire allo studio una
seria riflessione e meditazione della parola di Dio e dei testi
liturgici; dovranno fare ogni giorno una ricca esperienza della
preghiera liturgica, con la celebrazione almeno delle ore principali
dell'Ufficio divino, la partecipazione frequente ai sacramenti, ecc.
Sarà assai opportuno, poi, che essi studino attentamente le
Premesse dei nuovi libri liturgici, in modo da essere attenti alle
indicazioni e norme che questi forniscono per una celebrazione
degna e rispettosa sia degli orientamenti e delle direttive del
magistero sia anche delle attese e delle concrete possibilità
dell'assemblea.
Conclusione I ministeri del lettorato e dell'accolitato, anche se
profondamente radicati nell'esperienza più antica della Chiesa,
acquistano oggi dimensioni e prospettive nuove in una comunità
ecclesiale chiamata ad essere «serva» del Signore e degli uomini. Il
loro corretto e fedele esercizio suppone, pertanto, sempre una vita
di comunità molto dinamica. Anche se si integrano a vicenda, questi

28
due ministeri sono distinti: il lettorato fa direttamente riferimento
all'annuncio della parola di Dio, mentre l'accolitato è più
specificamente orientato alla celebrazione liturgico-sacramentale e
all'impegno di carità e di promozione umana.
Ciò spiega, tra l'altro, l'inopportunità che vengano conferiti
insieme alla stessa persona. La Chiesa è comunità ministeriale,
nella quale lo stesso Spirito conferisce ai fedeli doni diversi per mini-
steri diversificati; non è opportuno quindi che una stessa persona
assommi più compiti, anche perché ciascuno richiede anche doti
umane particolari che non sempre sono simultaneamente presenti
nello stesso individuo; e poi anche perché, altrimenti, si ricadrebbe
in una nuova forma di “monopolio” del ministero che non è certo
rispettosa di una corretta ecclesiologia e che si risolverebbe a svan-
taggio di una pastorale articolata. Questi due ministeri sono però
espressione di carità ecclesiale e sono finalizzati all'edificazione
dell'unico Corpo di Cristo.
Preghiera finale O Padre che in Cristo tuo Figlio, hai dato all’uomo la verità che lo
illumina, la via che indica il cammino, la vita che continuamente lo
rinnova, sostienici con la forza del tuo Spirito, perché cresciamo
ogni giorno nella conoscenza della nostra missione di collaboratori
di Dio nel suo amore e nella speranza del Regno. Per Cristo nostro
Signore.

29
BIBLIOGRAFIA:
CONCILIO VATICANO II, Costituzione Sacrosanctum Concilium
PAOLO VI, Motiu proprio Ministeria quaedam
PAOLO VI, Motiu proprio Ad pascendum
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Christifideles laici
PRINCIPI E NORME DEL MESSALE ROMANO
DIOCESI DI POZZUOLI, Direttorio pastorale
DIOCESI DI POZZUOLI, Il Libro del Sinodo