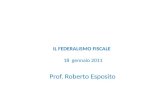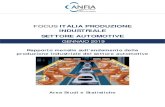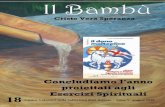Il Polietico 18
-
Upload
it-impresa-srl -
Category
Documents
-
view
227 -
download
9
description
Transcript of Il Polietico 18

Periodico di informazioneRiservato ai medici e agli operatori sanitari
Febbraio 2010, Anno 7 - N 18
In questo numero:Elettrofisiologiain Piemonte 2Una strategia diprevenzione per i pazientidi cardiologia 4
Chirurgia colorettale 7ISFAI: nuove frontierenella formazione 10Citologia: quinta giornatanovarese di studio 12
Disturbi flebopatici:un diario per laprevenzione 14Dalla neuropatologiaalla filosofia 16
PREVENZIONEE FORMAZIONE
La primavera è alle porte e con essa sonotante anche le novità che come semprepresenta il Gruppo Policlinico di Mon-za. Novità che non si manifestano nelsolo campo delle cure mediche, ma an-
che in quello della prevenzione. Ed è proprio in que-st'ottica che nasce il progetto del dottor Antonio Ra-vazzi della Clinica Salus di Alessandria che mira pro-prio a prevenire in maniera efficace quelle che sono lepatologie cardiologiche partendo da una prospettiva dicollaborazione tra il settore pubblico e il settore privatoche possa portare ad un'azione efficace sul territorio.Una realtà di continue sinergie che non è nuova alla fi-losofia del gruppo.A dimostrarlo è anche il primo an-niversario del dipartimento di elettrofisiologia dellecliniche piemontesi, diretto dal dottor Paolo Diotalle-vi. E di prevenzione si parla anche nel campo della fle-bologia. Oltre all’attività clinico medica all’interno delGruppo sta assumendo sempre maggiore importanzauna cultura di formazione ed aggiornamento conti-nuo. Con l’Istituto Superiore di Formazione perAziende e Imprese (I.S.F.A.I.) Policlinico di Monzavuole dare l’opportunità non solo ai propri collabora-tori di formarsi ed aggiornare le proprie conoscenze,bensì anche a tutti gli operatori sanitari del territoriolombardo e piemontese. Così in questo numero nonmancherà una ricca panoramica sulle novità didatticheofferte dal I.S.F.A.I..
Il PresidenteGianPaoloVergani

2
IL DIPARTIMENTO PIEMONTESEDI ELETTROFISIOLOGIA:UN VERO CENTRO DI ECCELLENZA
Natodaunprogetto volto a creareun polo che coordinasse l’atti-vità di aritmologia nelle Strut-ture piemontesi del GruppoPoliclinico diMonza, Il Dipar-
timento di Elettrofisiologia e Cardiostimola-zione, diretto dal Dott Paolo Diotallevi, as-sicura una attività, di interventistica e di vi-site ambulatoriali, alla cliniche Nuova Casadi Cura Città di Alessandria, San Gaudenziodi Novara e LaVialarda di Biella.Lo staff è composto dal Dott Diotallevi, dalDott Enrico Gostoli e dal Dott AlessandroElicio oltre che dal coordinatore infermieri-stico Ivan Baretta.In stretta collaborazione con i Cardiologi delGruppo il Servizio ha iniziato la propria atti-vità a metà del 2008 e nel corso del 2009 havissuto la prima stagione a organico comple-to previsto nel Progetto originale; nel corsodel 2009 sui 3 centri di Alessandria, Novarae Biella sono state eseguite oltre 750 proce-dure: un risultato che colloca la Struttura alvertice assoluto nel panorama della sanitàpiemontese e ai primissimi po-sti a livello nazionale.Il Servizio assicura l’impiantodi pacemaker, sistemi ECGHolter impiantabili fino aipiù sofisticati pacemaker edefibrillatori biventricolari,sistemi questi ultimi, ingrado sia di funzionareda salvavita, interrom-pendo aritmie che al-trimenti sarebbero le-tali, sia capaci di mi-gliorare la qualità stes-sa della vita nel pa-ziente con insufficien-za cardiaca.A riguardo di tali dis-
positivi, nel novembre 2009 presso la Casa diCura Città di Alessandria, è stato eseguitouno dei primi impianti in Italia di un innova-tivo Defibrillatore Cardiaco Impiantabile(ICD). Il dispositivo che si chiama PromoteAccel è uno degli ultimi innovativi Defibril-latori Cardiaci Impiantabili (ICD) prodottidalla St. Jude Medical; l’innovazione tecno-logica del defibrillatore Promote Accel con-siste nell’essere dotato di un sistema di con-nessione di ultima generazione (SJ4) che hala peculiarità di ridurre notevolmente il nu-mero delle connessioni tra il dispositivo e glielettrocateteri che inviano gli impulsi elettri-ci al cuore, con conseguente riduzione delvolume del dispositivo impiantato e maggio-re confort del paziente, rendendo tra l’altro laprocedura di impianto più rapida.Oltre alle procedure di impianto di pacema-ker e defibrillatori l’attività del Dipartimentosi è inoltre rivolta alle tecniche di estrazionedei sistemi di stimolazione disfunzionanti: sitratta di una metodica eseguita solo in Cen-tri di eccellenza in Italia per la mortalità e
morbidità non trascurabile connessaall’atto operatorio ed è stata svol-ta in stretta collaborazione con icolleghi cardiochirurghi dellaClinica città di Alessandria chehanno assicurato un puntualestandby interventistico; sonostati trattati con successo
numerosi pazienti com-plessi, affetti da gravi co-morbidità ottenendoun brillante tasso dicomplicanze dello 0%.Sul versante pretta-mente aritmologicosono stati eseguitistudi elettrofisiologiciintracavitari ed abla-zioni transcatetere del-
le aritmie, compresaquella della fibrillazione
atriale grazie al sistema di
IL DOTTOR PAOLO DIOTALLEVI,DIRETTORE DEL DIPARTIMENTODI ELETTROFISIOLOGIAE CARDIOSTIMOLAZIONEATTIVO NELLE CLINICHEDI ALESSANDRIA,BIELLA E NOVARA
IL DEFIBRILLATORE CARDIACO PROMOTE ACCELCON SISTEMA DI CONNESSIONE SJ4 DELLA ST.JUDE MEDICAL
IL POLO CHE COORDINA TUTTELE ATTIVITÀDI ARITMOLOGIA

3
no trattato l’argomento. Sono inoltre ga-rantite consulenze aritmologiche per i pa-zienti delle Cliniche Salus di Alessandria eSanta Rita di Vercelli. Oltre al servizio divisite ambulatoriali assicurato in sede sullediverse strutture, l’equipe si occupa dellarefertazione degli elettrocardiogrammi se-condo Holter registrati dagli apparecchi inuso sulle strutture della Clinica Città diAlessandria, della Clinica Salus, Santa Ri-ta di Vercelli e San Gaudenzio di Novaraottenendo, grazie alla centralizzazione delsistema di refertazione, una standardizza-zione dei processi valutativi e la conse-guente possibilità di garantire al pazienteuna pronta e mirata gestione della condi-zione clinica. Una recente iniziativa è statal’attivazione del sito web: www.loscompensocardiaco.net/ nccalessandria che sipropone di fornire, nell’ottica di un sem-pre più diretto rapporto con la popolazio-ne e gli operatori sanitari, utili informa-zioni sul tema dello scompenso cardiaco euna flow chart delle opzioni terapeuticheche la moderna cardiologia offre in ambi-to polidisciplinale al paziente affetto dainsufficienza cardiaca. Il servizio si pro-pone di garantire una risposta rapida e ri-solutiva alle necessità del paziente, utiliz-zando quanto di meglio la tecnologia at-tuale in campo elettrofisiologico possaoffrire.
LO STAFF DEL DIPARTIMENTOÈ COMPOSTODAL DOTTOR DIOTALLEVI,DAL DOTT ENRICO GOSTOLIE DAL DOTT ALESSANDROELICIO OLTRE CHEDAL COORDINATOREINFERMIERISTICOIVAN BARETTA
mappaggio con fluoroscopio NAVx utiliz-zato presso la Clinica Città di Alessan-dria.Proprio il trattamento della tachiarit-mia da fibrillazione atriale ha rappresenta-to un obiettivo ritenuto strategico forte-mente voluto, in stretto accordo con la Di-rezione, in quanto l’esigua offerta dellestrutture cardiologiche piemontesi mal siconcilia con l’elevata prevalenza dell’arit-mia nella popolazione locale: ne fanno fe-de gli oltre 150 casi trattati in questo pri-mo periodo con un tasso di complicanzeben al di sotto del dato pubblicato nellepiù recenti Survey internazionali che han-
ATTIVITÀDELDIPARTIMENTODIELETTROFISIOLOGIADELPIEMONTENELL’ANNO2009
Tipologia di intervento N.casiRevisione di Pace Maker cardiaco escl. sostituzione 65Sostituzione di PM cardiaco 27Insufficienza cardiaca e shock 71Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca senza CC 183Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco 73Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea senza inserz. stent in arteri 190Impianto di defibr. card. con catet. card. con IMA, insuff. cardiaca o shock 1Impianto di defibr. card. con catet. card. senza IMA, insuff. cardiaca o shock 22Impianto pacemaker perman. con diagn. cardiovasc.magg. o AICD o gener. impulsi 45Altro impianto di PM card. permanente senza diagn. cardiovasc.maggiore 166
TOTALE 843

4
QUANDO IL MINISTERO CHIAMAIL GRUPPO POLICLINICO RISPONDE
Ogni anno in Italia si contanocirca 300.000 attacchi car-diaci divisi tra episodi di in-farto acuto del miocardio,sindromi coronariche acute
(infarti Q e non Q ed episodi di angina pec-toris) e morti improvvise Questi dati fannodelle malattie cardio-vascolari una delle pa-tologie a più elevata incidenza nei Paesi Oc-cidentali e largamente la prima causa di mor-te nel nostro Paese. A conferma di ciò, nondiversa appare la situazione in Europa ove sicontano un totale di circa 6.500.000 di car-diopatici cronici con un incremento di580.000 nuovi pazienti all’anno. Sono datiimpressionanti, una vera e propria epidemia,nonostante siano stati compiuti grandi pro-gressi nella conoscenza e nel trattamento del-la malattia a partire dagli anni 70. Grazie al-l’utilizzo di nuovi farmaci e di nuove strategiedi approccio alla patologia, si è riusciti a rea-lizzare un miglioramento significativo dellaprognosi delle malattie cardiache acute inquasi tutti i paesi, Italia compresa.Accanto a queste note indiscutibilmente po-sitive bisogna però prendere atto del con-temporaneo progressivo aumento di inci-denza delle cardiopatie cronico-degenerativelegate a varie cause, in particolare al progres-sivo invecchiamento della nostra popolazio-ne e al danno residuo dovuto alle patologieacute nei soggetti sopravvissuti all’eventoacuto della malattia. Pertanto un semprecrescente numero di soggetti va incontro asequele di malattie cardiache e presenta segnidi disfunzione cardiaca e frequentemente direale insufficienza contrattile. Il paziente condisfunzione contrattile, dopo il primo episo-dio conclamato di scompenso cardiaco è de-
stinato ad andare incontro a recidive sinto-matiche, con la necessità di ricoveri ripetuti edi passaggi imprevisti e frequenti in prontosoccorso. Di conseguenza si può innescareun meccanismo (remodelling negativo car-diaco) di grave e progressivo deterioramentod’organo con conseguente peggioramentodella qualità di vita. Il ricorso frequente aiservizi sanitari (ricoveri ospedalieri in pri-mis), spesso accompagnati da interventi,complessi, anche invasivi e sofisticati, deter-mina un incremento di costo tra i più gravo-si per il Sistema Sanitario Nazionale. Laprognosi della malattia infine resta tutt’oraestremamente severa con una sopravvivenzamedia non superiore ai cinque anni dopo lacomparsa dei primi sintomi. Ciò è dovutoalla mancanza di strumenti terapeutici ingrado di modificare realmente la prognosidei malati a lungo termine, ma anche e forsesoprattutto per la carenza di strategie di in-tervento efficaci. Sembra pertanto che ci tro-viamo a fronteggiare una nuova stagione del-la patologia cardio-vascolare cui oggi possia-mo rispondere prevalentemente con nuovimodelli di intervento.Si tratta di una patologia cronica, subdola, adevoluzione quasi sempre silente o paucisinto-matica, almeno nelle sue prime fasi di svilup-po, che sta mettendo in grave difficoltà il no-stro modello organizzativo sanitario, basatoper la massima parte sulla rete ospedaliera perpatologie acute, creando nel contempo inso-stenibili costi diretti ed indiretti alla società.Per questa patologia, peraltro in rapida cre-scita, da alcuni anni si stanno pensando nuo-ve strategie di approccio, tutte facenti riferi-mento ad un migliore utilizzo della rete deiservizi territoriali cui trasferire la gestionedella malattia. Questa strategia perciò si basae sempre più dovrà vedere protagonisti sulterritorio, i Medici di Medicina Generale(MMG), accanto ai quali si dovranno creareo far crescere nuovi capillari servizi sanitari,quali le farmacie, individuate come punti disalute ( allo scopo è stato emanato nel Giu-gno 2009 un apposito disegno di legge), leCase di riposo (RSA) a partire dalle strutture
IL DOTTOR ANTONIO RAVAZZI,RESPONSABILEDEL DIPARTIMENTODI CARDIOLOGIADELLA CLINICA SALUSDI ALESSANDRIA
SPERIMENTAZIONE SUL RAPPORTO PAZIENTE E STRUTTURE
LE STRUTTURE OSPEDALIERE DI ALESSANDRIASONO IMPEGNATE NELLA SPERIMENTAZIONEDI UN MODELLO DI GESTIONE SANITARIAPER VERIFICARNE L’APPLICABILITÀ A TUTTE LECLINICHE DEL GRUPPO POLICLINICO DI MONZA

5
bulatori ospedalieri specialistici, che debbonointervenire come strutture esperte, con fun-zioni consulenziali di secondo livello, realiz-zando l’obiettivo di unificare e razionalizzarele strategie di intervento, per migliorare, pri-ma di tutto la qualità di vita dei pazienti, diprevenire le recidive di ricovero ed alleggerireil ricorso ai servizi di emergenza ospedalierie territoriali.Questa proposta ha preso corpo in uno studiosperimentale osservazionale policentrico fi-nanziato dal Ministero, che vede impegnatetre ASL della Regione Toscana, con riferi-mento ospedaliero nel Dipartimento cardio-logico Universitario di Careggi che ha il ruolodi coordinamento centrale e di raccolta dati el’ASL di Alessandria con riferimento ospe-daliero di secondo livello, nelle Case di Curadel Gruppo Policlinico di Monza, ClinicaSalus e Città di Alessandria.In termini operativi l’esperienza che prendel’avvio nella Provincia di Alessandria haprovveduto a prendere contatto e ha arruolatotrentacinque MMG, punto di riferimentoper oltre 40.000 cittadini, che hanno aderitovolontariamente al progetto, sottoscrivendoil protocollo dello studio. Ha modificato l’or-ganizzazione ambulatoriale della Clinica Sa-lus, con la creazione di un ambulatorio dedi-cato allo scompenso cardiaco, cui affidare ilcompito di applicare i protocolli operativi,garantendo una corretta applicazione dellelinee guida internazionali di trattamento e hareso disponibili i posti letto necessari nellaClinica Città di Alessandria, per garantiretempestivamente gli interventi diagnosticipiù sofisticati e gli intereventi di elettrofisio-logia, di emodinamica e di cardiochirurgianecessari ed opportuni. E’ stato creato unprotocollo di intervento condiviso e verificatoda parte di un coordinamento cardiologicocentrale.Sono state acquisite risorse professionali fina-lizzate esclusivamente allo studio, ( finanziatenell’ambito del progetto Nazionale Ministe-riale) che dovranno operare sul territorio, inparticolare garantendo funzioni di coordina-mento controllo gestionale e di qualità, l’ assi-stenza infermieristica domiciliare per i pazientinon autosufficienti, con funzioni anche di col-legamento tra i MMG e i professionisti dellaClinica, la gestione informatica e di telemedici-na da parte di tecnici informatici in appoggio,che dovranno garantire l’archiviazione, il con-trollo di qualità e la trasmissione dei dati rac-
a più elevato contenuto sanitario, trasformatein case della salute.Questa nuova strategia, accanto al trasferi-mento di risorse alla medicina del territoriocon la costituzione dei Distretti Sanitari terri-toriali, sta compiendo, almeno in alcune Re-gioni del nostro paese, i primi timidi passi, ca-ratterizzati, come da solida tradizione nostra-na, dall’ improvvisazione, dalla mancanza as-soluta di una seria programmazione o peggiodallo sfruttamento contingente, a fini esclusi-vamente di lucro, delle carenze esistenti.In questo panorama non particolarmenteconfortante ha preso avvio, su richiesta delMinistero della Salute, recepita dalla RegioneToscana che lo ha affidato al Policlinico Uni-versitario Careggi di Firenze, un disegnosperimentale che prevede di applicare unnuovo modello gestionale delle patologie car-dio-vascolari croniche, basato sulla continui-tà assistenziale ospedale territorio. In questomodello un campione di MMG debbonooperare in sintonia con gli ospedali e gli am-
LO SPORT ASSUMEUN RUOLO STRUMENTALENELLA PREVENZIONEDELLE PATOLOGIECARDIOVASCOLARI
IL POLICLINICO DI MONZA È L’UNICA STRUTTURAPRIVATA ITALIANA A TESTARE QUESTO PROGETTO.UN’INIZIATIVA CHE GODE DEL RICONOSCIMENTODEL MINISTERO DELLA SALUTE.QUEST’ULTIMO LO RITIENE STRATEGICO PERCHÉSEGUE QUELLE CHE SONO LE INDICAZIONIINTERNAZIONALI DI SPOSTARE GLI STRUMENTIINTERVENTISTICI DALLA GESTIONE OSPEDALIERAAD UNA GESTIONE CONTINUATIVA DEL TERRITORIO

6
aspetti più innovativi del progetto sono tutta-via rappresentati dalla nuova organizzazionedel territorio chiamata ad operare in modoconsapevole ed in stretto collegamento econtinuità con i diversi specialisti ospedalieri.Allo scopo è stata predisposta una capillarerete di servizi territoriali costituita da 10 far-macie della provincia sulle 39 esistenti, dota-te di strumenti diagnostici semplici ( elettro-cardiografi a trasmissione remota, Holterpressori), che dovranno, operare direttamentecon i MMG, in collegamento telematico, ac-quisendo anche la possibilità di effettuareesami in telemedicina, in grado di trasferirele informazioni raccolte ad una banca datiunica e disponibile ai diversi servizi operantinella rete sanitaria.Con l’esclusione della fase iperacuta dellecardiopatie, affidata alle unità coronarichepubbliche, questo modello dovrà garantireuna gestione unitaria, seguendo il pazientedurante le diverse fasi di ricovero, seguendo imalati anche in tutti i diversi interventi dia-gnostici e terapeutici di secondo livello effet-tuati, quali esami coronarografici, Ptca, dia-gnostica e terapia delle aritmie e dei blocchicardiaci sino all’impianto di devices CRT einfine gli interventi di cardiochirurgia coro-narica e valvolare. Il paziente quindi, secondoprotocollo, transiterà nel servizio di riabilita-zione e una volta dimesso e tornato al domi-cilio sarà seguito cronicamente dal MMG edutilizzerà, su richiesta del Curante, i sevizidell’ambulatorio della clinica e, per le presta-zioni più semplici, delle farmacie Questomodo di procedere può garantire una conti-nuità assistenziale ospedale-territorio, a par-tire dall’evento acuto e una gestione unitariae consapevole da parte dei diversi professio-nisti ospedalieri e del territorio coinvolti.Questo modello gestionale una volta speri-mentato per tutto l’anno in corso, in base airisultati ottenuti in termini di miglioramentodella qualità di vita dei pazienti, di riduzionedei ricoveri ospedalieri e dell’utilizzo dei ser-vizi di emergenza e pronto soccorso territo-riali ed ospedalieri, potrà essere gradualmen-te esteso a tutte le cliniche del gruppo “Poli-clinico di Monza”, in modo da arricchire ecaratterizzare i rapporti con la rete dei serviziterritoriali, decongestionare gli ospedali e inprimo luogo i Pronto soccorso, determinandoanche una riduzione significativa dei costidella sanità e un migliore e più tempestivoservizio ai cittadini.
colti negli appositi siti e schede informatiche.Nella nostra realtà però, partendo dall’appli-cazione di questo progetto sperimentale,prende l’avvio un progetto più ambizioso,volto a creare un nuovo modello gestionalesanitario cardiologico, da utilizzare nella pra-tica clinica quotidiana, che caratterizzi il mo-do di operare delle nostre cliniche in Pie-monte. Il progetto dovrebbe occupare il vuo-to di intervento oggi esistente in questo am-bito. Con questa iniziativa si prevede di ren-dere stabili e strutturali i collegamenti tra idiversi servizi cardiologici disponibili, a par-tire dalla gestione della fase acuta della ma-lattia, utilizzando in particolare i laboratori diemodinamica e di elettrofisiologia, centri dieccellenza delle nostre cliniche, coordinatidalla Cardiochirurgia, garantendo unitarietàe continuità assistenziale. Questi Presidi ope-rano da anni nella Clinica Città di Alessan-dria, in maniera unitaria e fortemente strut-turata. Si sono dimostrati capaci di risolvereefficacemente i problemi emergenti dei ma-lati, sino alla loro stabilizzazione clinica. Perproseguire il recupero funzionale dei malati èstata costituita, del tutto recentemente, un’u-nità di riabilitazione, operante nella ClinicaSalus, allo scopo di completare il processo distabilizzazione clinica e facilitare il reinseri-mento nella vita quotidiana dei pazienti car-diopatici. Per garantire un’assistenza adegua-ta anche nella fase post-acuta dei pazienti èstata trasformata la tradizionale attività am-bulatoriale in un servizio specializzato nellagestione delle malattie degenerative cardia-che, all’interno della Clinica Salus, collegan-dola strutturalmente alla rete dei servizi terri-toriali, in primo luogo con i MMG. Gli
LE FARMACIESVOLGERANNO UN RUOLODI PRIMO PIANOALL’INTERNODEL PROGRAMMADI PREVENZIONE

7
È A VERCELLI LA CHIRURGIACOLORETTALE DEL FUTURO
Sono passati poco più di vent’annidalla prima colecistectomia laparo-scopica eseguita in Francia da PaulMouret nel 1987 e nessuno si chie-de più se si sia trattato di una rivo-
luzione etica. L’innovazione è parte dello svi-luppo e della storia della chirurgia, l’innovazio-ne è stata resa possibile da pionieri che si sonoassunti dei rischi, aprendo nuove strade e allar-gando l’orizzonte scientifico. Un traguardoambizioso nella chirurgia laparoscopia è statoil trattamento delle malattie del colon, che ri-sale al 1991 con la prima procedura di colecto-mia eseguita da Dennis Fowler. I vantaggi abreve termine della laparoscopia sono ormaiben conosciuti: riduzione del dolore post-ope-ratorio, della durata della degenza, dell’ileopost-operatorio, del fabbisogno di analgesici emigliore aspetto cosmetico.Le procedure laparoscopiche per il trattamen-to di patologie benigne e maligne del colon-retto sono classificate come procedure chirur-giche avanzate. Le caratteristiche peculiari diquesti interventi, il lungo training specifico ne-cessario per l’esecuzione di procedure tecnica-mente complesse, la necessità di apparecchia-ture e strumentazioni sofisticate, limitano in-fatti l’approccio laparoscopico a centri conesperienza specifica in procedure laparoscopi-che maggiori e consolidata esperienza in chi-rurgia colorettale di base.Dopo i dubbi inizialiper l’uso della laparoscopia nel trattamento del
cancro colorettale numerosistudi hanno dimostrato ivantaggi e la sicurezza dellachirurgia colorettale laparo-scopica, rendendola ora ilmetodo preferito nel tratta-mento chirurgico di moltemalattie colorettali.Tuttavia, è solo dopo la pub-blicazione dei risultati clinicidel Clinical Outcomes ofSurgical Therapy (COST)Study nel 2004 che la chirur-gia laparoscopica è diventatauna pratica accettata nel trat-tamento del cancro coloret-
tale ed è stato evidente che la colectomia lapa-roscopica è equivalente alla colectomia apertain termini di sicurezza oncologica per tutte glistadi dei tumori del colonretto. I margini di re-sezione, il numero dei linfonodi raccolti, i tassidi sopravvivenza cancro-relativi ed i tassi dicomplicazioni e la mortalità sono gli stessi siache l’operazione sia effettuata aperta o laparo-scopicamente.La laparoscopia si pone come approccio chi-rurgico alternativo alla chirurgia tradizionale,proponendo con una chirurgia gentile, menoinvasiva e meno traumatica per il paziente, diquanto già codificato e standardizzato in chi-rurgia oncologica colo-rettale tradizionale.Mediante procedure ed accessi addominalidifferenti è possibile eseguire in laparoscopia iclassici interventi di resezione parziale o totaledel colonEmicolectomia destra.Parte o tutto il colonascendente ed il cieco sono rimossi. Il colon èpoi ricollegato al piccolo intestino.Emicolectomia sinistra.Parte o tutto il colondiscendente è rimossa. Il colon trasverso vienepoi ricollegato al retto.Colectomia sigmoidea.Parte o tutto il colonsigmoideo è rimossa. Il colon discendente vie-ne ricollegato al retto.Colectomia totale.Tutto il colon viene rimos-so. Il piccolo intestino viene ricollegato al ret-to.Resezione anteriore. Il colon sigmoideo e unaparte o tutto il retto vengono rimossi. Il colondiscendente viene ricollegato al retto restante oal canale anale.Resezione addomino perineale. Parte o tuttoil colon sigmoideo e l’intero retto ed ano ven-gono rimossi.Viene confezionata una colosto-mia. Una colostomia crea un’apertura nella pa-rete addominale in modo da far passare le feci.In più, si possono eseguire semplici procedurediagnostiche che, indipendentemente dalla fat-tibilità dell’intervento, sono estrememente utiliper una corretta stadiazione in caso di patolo-gia maligna. Grazie alla visione ingrandita èpossibile eseguire infatti prelievi bioptici, cito-logici ed ecografie intraoperatorie in modo al-tamente specifico.
IL DOTTOR EZIO GANIO,RESPONSABILE DEL CENTRODI CHIRURGIA COLORETTALEDELLA CLINICA SANTA RITADI VERCELLI
LATECNICA ÈMENO INVASIVA ETRAUMATICA PER I PAZIENTI
LA LAPAROSCOPIA È UNATECNICA OPERATORIAIN ANESTESIA TOTALE PREVIADISTENSIONE DELL’ADDOMECON ANIDRIDE CARBONICAE CONSISTE NELL’INTRODURRENELLA CAVITÀ ADDOMINALEATTRAVERSO 3 O 4 FORELLINI,DEGLI STRUMENTI DETTITROCARS CHE FUNGONODA PORTA D’INGRESSOPER FIBRE OTTICHE ESTRUMENTI OPERATIVIDI CUI IL CHIRURGO SI SERVEPER VEDERE MEGLIOIL TESSUTO ENDOMETRIOSICOE SE OCCORREPER RIMUOVERLO INSIEMEAD EVENTUALI ADERENZE

8
nel ripristino della funzione del viscere.Anchese il recupero è più rapido dopo una chirurgialaparoscopica, la differenza è nell’ordine diuno o due giorni, ma anche la completa riali-mentazione può essere anticipata con unaconseguente riduzione di durata della degenzain ospedale.Anche se i benefici a lungo termine sonoequivalenti fra le tecniche aperte e laparosco-piche, i benefici immediati sono vantaggi realiper i pazienti. In pratica, il metodo laparosco-pico è associato con minor dolore, un recuperopiù veloce, un ritorno più rapido della funzio-ne intestinale, una più breve degenza in ospe-dale e cicatrici più piccole, rendendolo il me-todo preferito per la resezione intestinale.
ILFUTURODELLACHIRURGIALAPAROSCOPICALe tecniche laparoscopiche sono attualmenteutilizzate nel trattamento chirurgico della di-verticolite, della malattia di Crohn e nella co-lite ulcerosa, della poliposi familiare, nel pro-lasso rettale e nella neoplasia colorettali beni-gne e maligne. Con i miglioramenti della tec-nologia, anche la chirurgia mininvasiva conti-nua ad evolversi. I metodi endoluminali sistanno esplorando come un’alternativa o tec-nica chirurgica complementare.Le procedure laparoscopiche e colonscopicheassociate possono aprire la strada a sviluppifuturi nella chirurgia endoluminale. In passa-to, una laparoscopia simultaneo alla colon-scopia era tecnicamente difficile perché per lacolonscopia usa aria dell’ambiente come gasper insufflare, portando a significativa disten-sione del viscere che oscura la visione laparo-scopica. Con la colonscopia a CO2, le proce-dure laparoscopiche ed endoscopiche posso-no essere effettuate simultaneamente e pos-sono avere molte applicazioni potenziali,compreso il trattamento dei polipi colici be-nigni che non sono asportabili mediante tec-niche endoscopiche tradizionali. Questi poli-pi richiedono spesso una colectomia a causadel rischio di avere un cancro al loro interno,come pure il rischio futuro di sviluppare ilcancro. Tuttavia, un metodo alternativo inquesta situazione può essere un polipectomiacolonscopica a CO2 associata alla laparosco-pia. Quando queste procedure sono associate,un polipo può essere rimosso senza una rese-zione convenzionale del viscere. Questa pro-cedura associata permette una manipolazionesia extra che intraluminale del colon per age-
Indicazioni, vantaggi e svantaggi della colec-tomia laparoscopicaLa maggior parte dei pazienti che necessita-no di un intervento sul colon retto sono can-didati per un metodo laparoscopico, sia per itumori benigni che maligni che per le pato-logie funzionali di stipsi, prolasso rettale, di-verticolosi, malattie infiammatorie. Se il chi-rurgo ha esperienza, persino i pazienti conuna storia di chirurgia addominale pregressasono candidati.Questa tecnica si avvale di una telecamera e distrumenti miniaturizzati che vengono inseritiattraverso quattro piccole incisioni (11 milli-metri) sulla parete addominale. Rispetto allachirurgia tradizionale, detta “open”, si evital’ampia incisione dell’addome, il relativo trau-ma e dolore, ma anche l’inestetica cicatrice,importante soprattutto per le donne.Benché ci siano chiari benefici, questi non so-no così evidenti se paragonati coi vantaggi as-sociati con altre procedure laparoscopiche. Ilmotivo principale è che una colectomia, siaaperta che laparoscopica, provoca un ritardo
L’ÉQUIPE DEICOLOPROCTOLOGIDELLA CLINICASANTA RITA DI VERCELLI.DA SINISTRAIL DOTT. MARIO TROMPETTO,IL DOTT. EZIO GANIO,IL PROF. RALPHJOHN NICHOLLS(COORDINATORESCIENTIFICO),IL DOTT. GIUSEPPE CLERICOED IL DOTT. ALBERTOLUC REALIS
IL METODO LAPAROSCOPICO GARANTISCEMENO DOLORE, UN RECUPERO PIÙ VELOCE,UN RITORNO PIÙ RAPIDO DELLA FUNZIONEINTESTINALE, UNA PIÙ BREVE DEGENZAIN OSPEDALE E CICATRICI PIÙ PICCOLE,RENDENDOLO IL METODO PREFERITOPER LA RESEZIONE INTESTINALE

9
UN MODERNO STRUMENTOTECNOLOGICO UTILIZZATOPER GLI INTERVENTI DI TEM(TRANSANAL ENDOSCOPICMICROSURGERY)
La dilatazione del retto avviene mediante uninsufflatore - aspiratore che mantiene unapressione di dilatazione con CO2 di 10-12mm Hg. L’intervento inizia con mappaturadei margini liberi da malattia usando punti dicoagulazione sulla mucosa, la distanza dalmargine macroscopico della lesione deve esse-re di 5 mm per i polipi ma di almeno un centi-metro per i tumori. Per gli adenomi (polipi)localizzati nella parte intra-peritoneale delretto viene eseguita una delicata dissezionedella mucosa dallo strato circolare della mu-scolaris propria, per lesioni localizzate nel ret-to extraperitoneale o per i tumori si esegue in-vece un’exeresi a tutto spessore, che consistenell’asportazione della parete rettale a tuttospessore, compresa quindi la parete muscolareed il grasso peri-rettale aderente al retto cheviene asportato per permettere la valutazionedi eventuali linfonodi presenti. Dopo l’aspor-tazione la breccia nella parete rettale può esse-re suturata usando delle suture convenzionali.Quali le indicazioni? I polipi anche con dis-plasia grave del retto, soprattutto i grossi po-lipi villosi, ed i tumori precoci del retto. Lacorretta definizione delle lesioni tumori ag-gredibili con questa tecnica tiene conto, oltreche dei dati della biopsia (prelievo duranteendoscopia), del grado di infiltrazione dellalesione nella parete rettale, ben definibile conuna ecografia endoanale. In particolare han-no indicazione alla TEM quelle lesioni pre-coci confinate alla mucosa rettale (T1) ed inparticoalre nei 2\3 più superficiali della mu-cosa. Con l’aumentare del grado di infiltra-zione aumenta invece il rischio di recidiva equindi vengono meno indicazioni e vantaggidell’approccio.Quali i vantaggi?Il minor trauma (non sono necessarie inci-sioni o distensioni addominali) comportainnanzitutto un minor dolore nel post ope-ratorio, la possibilità di una precoce riali-mentazione, una degenza post operatoriabreve, il paziente viene dimesso in 3°- 4°giornata. La conservazione del retto per-mette una conservazione più ottimale dellemodalità di evacuazione e continenza. L’ot-timale controllo visivo durante la resezionesi traduce in una riduzione dell’incidenzadelle recidive locali. Ovviamente soloun’attenta valutazione permette di selezio-nare quei pazienti che possono beneficiaredi questa alternativa per i loro problemi delretto.
volare la rimozione endoscopica del polipo.Se all’esame estemporaneo al congelatore lalesione risulta essere benigna, la procedura èterminata ma se risulta essere un cancro, unacolectomia laparoscopica convenzionale puòessere effettuata. Inoltre ogni possibile lesionea tutto spessore alla parete del colon durantela rimozione endoscopica del polipo può es-sere visualizzata durante l’esecuzione e puòessere trattata laparoscopicamente.
CONCLUSIONEL’uso della laparoscopia nel trattamento dellemalattie colorettali continua ad aumentarepopolarità ed indicazioni. La laparoscopiapresenta indubbi vantaggi liberi e può essereofferta alla maggioranza dei pazienti nei cen-tri attrezzati e con chirurghi di esperienza.
TRANSANALENDOSCOPICMICROSURGERYPer i tumori iniziali del retto e soprattutto peri grossi polipi rettali non asportabili endosco-picamente un’alternativa alla resezione delretto può essere rappresentata dalla TEM,
una metodica sviluppata apartire dagli anni 80 da Ger-hard Buess. Utilizza uno spe-ciale anoscopio operatore ingrado di permettere una dila-tazione pneumatica del retto,una visione steroscopica edun’operatività simile a quellausata in laparoscopia all’in-terno del retto stesso. Si trat-ta di una micro chirurgia en-doscopica, meno invasiva epiù precisa nei dettagli ri-spetto alle alternative trans-anali usate in passato.
LE PROCEDURE LAPAROSCOPICHE ECOLONSCOPICHE ASSOCIATE POSSONO APRIRELA STRADA A SVILUPPI FUTURI NELLA CHIRURGIAENDOLUMINALE. CON LA COLONSCOPIA A CO2LE PROCEDURE LAPAROSCOPICHE EDENDOSCOPICHE POSSONO ESSERE EFFETTUATESIMULTANEAMENTE E POSSONO AVEREAPPLICAZIONI POTENZIALI COME IL TRATTAMENTODI POLIPI COLICI BENIGNI NON ASPORTABILI CONTECNICHE TRADIZIONALI

18 marzo 201020 ottobre 2010Esposizione degli operatorisanitari a rischio biologicospecifico: HIV, HBV, AH1N1 -Comportamento postesposizioneFormare gli operatori sanitaricirca i rischi connessiall’esposizione a rischiobiologico;aumentare la consapevolezzadegli stessi circa l’importanzadella prevenzione del rischio ditrasmissione del virus in ambitosanitario;conoscere le normecomportamentali da adottare incaso di esposizione.8 crediti ECM
20 marzo 2010Percorsi diagnostico-terapeutici in senologiaIl presente percorso formativo èfinalizzato all’acquisizione daparte dei partecipanti delleseguenti competenze:
-conoscere il meccanismo del“percorso” che la struttura delPoliclinico può offrire e che lapaziente deve percorrere dalmomento in cui si presenta conun qualsiasi sintomo relativo alseno sino al completamentodella terapia e il mantenimentodel follow-up.- Acquisire competenzegestionali/relazionali su pazientiaffette da patologie al seno alfine di educarle e confortarle inmomenti di difficoltà.
23-24 marzo 2010Educazione alla salute ededucazione terapeuticaAnalizzare i riferimenti teorici deiprocessi educativi checonsentono alle persone diapprendere ed assumereconsapevolmente decisioni utilial mantenimento ed almiglioramento della propriasalute.Acquisire competenze teorico-applicative per collaborare
alla realizzazione di interventidi educazione alla salutee di educazione terapeutica.16 crediti ECM
26 marzo 201011 maggio 20109 giugno 20104 ottobre 201013 novembre 2010Basic Life Support with earlyDefibrillation - BLS-DFornire nozioni per l’esecuzionedi manovre rianimatorie di base,anche con l’ausiliodi un defibrillatoresemiautomatico esterno.8 crediti ECM
30 aprile 2010D.Lgs 196/2003 "Codice inmateria di protezione dei datipersonali"L’obiettivo è informare ipartecipanti dei contenuti, degliintendimenti e, soprattutto dellericadute nella vita lavorativa ditutti i giorni del Decreto
Legislativo 196/2003 - “Codicein materia di protezione dei datipersonali” al fine di prevenirecomportamenti pregiudizievoliper il paziente/utente, per sée per l’azienda.8 crediti ECM
29 maggio 201019 novembre 2010Impianti protesicicardiovascolari, ortopedici,neurochirurgici: complicanzeinfettive post operatorieAcquisire maggiori conoscenzeteoriche sull’utilizzo di unacorretta terapia antibiotica nellegravi infezioni chirurgiche postoperatorie.8 crediti ECM
15 giugno 2010Prevenzione in oncologiaIl corso è finalizzato adintrodurre i partecipanti aiprincipali argomenti diprevenzione in oncologia conparticolare riferimento agliaspetti epidemiologici ed aiprincipali fattori e condizioni dirischio per lo sviluppo deitumori maligni.8 crediti ECM
25 giugno 201001 ottobre 2010Accanimento terapeutico: curedi fine vita e rifiuto delle cure –aspetti medico-deontologiciApprofondire e distinguere iconcetti di accanimentoterapeutico, di testamentobiologico, di diritto al rifiuto dellecure e di eutanasianell’ordinamento legislativo,giuridico e deontologico italiano.8 crediti ECM
Calendario Sede di Verano Brianza
10
Tutti i corsi sono in fase di accreditamento presso il sistema ECM di Regione Lombardia
Per informazioni e iscrizioni: I.S.F.A.I. via Petrarca 51 – Verano Brianza (MB) – tel. 0362 824221 – fax 0362 824403 – [email protected]

23-24 marzo 2010Educazione alla salute ededucazione terapeuticaAnalizzare i riferimenti teorici deiprocessi educativi checonsentono alle persone diapprendereed assumere consapevolmentedecisioni utili al mantenimentoed al miglioramento della propriasalute.Acquisire competenzeteorico-applicative per collaborarealla realizzazione di interventi dieducazione alla salute e dieducazione terapeutica.16 crediti ECM
24 aprile 201014 giugno 201017 luglio 201005 novembre 201030 novembre 2010Basic Life Support with earlyDefibrillation - BLS-DFornire nozioni per l’esecuzionedi manovre rianimatorie di base,anche con l’ausilio di un
defibrillatore semiautomaticoesterno. 8 crediti ECM
30 aprile 2010D.Lgs 196/2003 "Codice inmateria di protezione dei datipersonali"L’obiettivo è informare ipartecipanti dei contenuti, degliintendimenti e, soprattutto dellericadute nella vita lavorativa di tuttii giorni del Decreto Legislativo196/2003 - “Codice in materia diprotezione dei dati personali” alfine di prevenire comportamentipregiudizievoli per ilpaziente/utente, per sé e perl’azienda. 8 crediti ECM
29maggio 201019 novembre 2010Impianti protesicicardiovascolari, ortopedici,neurochirurgici: complicanzeinfettive post operatorie.Acquisire maggiori conoscenzeteoriche sull’utilizzo di una correttaterapia antibiotica nelle gravi
infezioni chirurgiche postoperatorie. 8 crediti ECM
15 giugno 2010Prevenzione in oncologiaIl corso è finalizzato ad introdurre ipartecipanti ai principaliargomenti di prevenzione inoncologia con particolareriferimento agli aspettiepidemiologici ed ai principalifattori e condizioni di rischio per losviluppo dei tumori maligni.8 crediti ECM
25 giugno 201001 ottobre 2010Accanimento terapeutico: cure difine vita e rifiuto delle cure –aspetti medico-deontologiciApprofondire e distinguere iconcetti di accanimentoterapeutico, di testamentobiologico, di diritto al rifiuto dellecure e di eutanasianell’ordinamento legislativo,giuridico e deontologico italiano.8 crediti ECM
13-14 luglio 201026-27 ottobre 2010Prevenzione di malattiecardiovascolariIl corso è finalizzato ad introdurre ipartecipanti ai principaliargomenti di prevenzione incardiologia, con particolareriferimento agli aspettiepidemiologici ed ai principalifattori legati agli stili di vitapersonali modificabili e nonmodificabili.Inoltre ci si propone di faracquisire ai partecipanticonoscenze specifiche suideterminanti di salutecardiovascolare in modo dapianificare interventi di educazionesanitaria mirati su una stima delrischio cardiovascolare globale delsoggetto/paziente.16 crediti ECM
23-24 settembre 2010Prevenzione di malattie infettiveIndividuare i determinanti disalute e di malattia e i fattori dirischio, sia in ambitocomunitario (ospedale, case diriposo, RSA) che territoriale.Identificare gli aspetti chenell’esercizio della professionepossono costituire fattori dirischio per l’operatore stesso.Utilizzare strumenti teorici pervalutare il ruolo dell’ambiente edegli stili di vita sulla saluteumana.Descrivere le caratteristiche delruolo educativo per la prevenzionee diffusione delle malattie infettive.Conoscere gli strumenti diprevenzione più idonei per latutela della salute nelle diverserealtà operative assistenziali.16 crediti ECM
Calendario Sede di Novarello
11
Tutti i corsi sono in fase di accreditamento presso il sistema ECM nazionale
[email protected] – www.policlinicodimonza.it, sezione ECM

12
MALATTIE DEL RENE E VIE URINARIELA QUINTA GIORNATA DI STUDIO
Anche quest’anno, per la quintavolta, la “GiornataNovarese diStudio” per medici, biologi etecnici, tenterà di offrire un pa-norama aggiornato su una te-
matica fortemente attuale, quale è quella le-gata a “Malattie delle vie urinarie e del renenell’uomo e nella donna”programmata per il 15 mag-gio 2010 a Santa MargheritaLigure.Tale Corso, per cui sono statirichiesti crediti ECM, tente-rà di ripetere il successo deiquattro precedenti, ed in par-ticolare del terzo, “Il Pap testall’epoca dei vaccini” (Nova-ra, 19 aprile 2008) e del quar-to, “Il carcinoma ovarico”(Santa Margherita, 18 aprile2009), che avevano visto unafolta partecipazione di di-scenti e docenti, provenienti da tutta Italia edanche dall’estero. La scelta della Liguria èmotivata dalla crescente partecipazione di
docenti liguri, Universitari ed Ospedalieri,nonchè dell’Istituto Tumori di Genova, concui esistono anche collaborazioni istituzionalisu filoni di ricerca legati alla cancerogenesied alla ploidia dei tumori.La tematica di questa quinta giornata è parti-colarmente importante, vista la frequenza
odierna delle malattie dellevie urinarie in entrambi i ses-si (anche per l’aumento del-l’età media della popolazio-ne) e la difficoltà di una dia-gnosi precoce in patologie in-validanti e troppo spesso an-cora letali. Molte speranzesono riposte nelle nuove tera-pie chirurgiche e mediche,che ci verranno illustrate daurologi, ginecologi e farma-cologi, particolarmenteesperti in questo settore.Il presupposto a cui fa riferi-
mento anche questa giornata, come le quattroprecedenti e gli otto incontri a tema organiz-zati dal Servizio di Citopatologia Diagnosti-ca della Clinica San Gaudenzio di Novara,gruppo Policlinico di Monza, è la collabora-zione tra pubblico e privato, nell’ottica di unapari dignità, utile per migliorare la sanità inItalia.Dal 1997 il Servizio di Citopatologia ha or-ganizzato le Giornate e gli incontri con riferi-mento alla propria casistica (oltre 20.000 esa-mi citologici all’anno) ed alla collaborazionecon la Facoltà di Medicina dell’Università delPiemonte Orientale Amedeo Avogadro, delleUniversità di Genova e diTorino, dell’IstitutoMario Negri e dell’Institut Jules Bordet diBruxelles. Lo scopo di questi incontri, effet-tuati sempre con il patrocinio della SocietàItaliana di Anatomia Patologica e Citopato-logiaDiagnostica-Divisione Italiana dell’In-ternational Academy of Pthology, è semprestato quello di portare a conoscenza dei di-scenti lo Stato dell’Arte delle varie patologieesaminate, confrontando aspetti epidemiolo-gici, diagnostici e terapeutici in modomulti-disciplinare.
IL PROFESSORROBERTO NAVONEDELL’UNIVERSITÀDI TORINO
PREVISTAPERSABATO15MAGGIOASANTAMARGHERITALIGURE
L'INCONTRO È STATOORGANIZZATO DAL SERVIZIODI CITOPATOLOGIA DIAGNOSTICADELLA CLINICASAN GAUDENZIO DI NOVARA,IN UN'OTTICADI COLLABORAZIONETRA PUBBLICO E PRIVATO

13
ORE 9.00:Presentazione V Giornata novaresedi studio: R.Navone (Torino)
Saluto Autorità
ORE 9.15:Introduzione scientifica ai lavori:L. SANTI (ROMA)
ORE 9.30-10.50PRIMASESSIONE:LADIAGNOSICITO–ISTOLOGICAModeratoriG.ANGELI (Vercelli)G.MONGA (Novara)
ORE 9.30- 9.50:Ruolo della citologia nella diagnosi dei tu-mori e delle infezioni del rene e delle vie uri-narie: tecniche a confrontoP.Dalla Palma (Trento)
ORE 9.50-10.10:Il significato della citologia e dell’istologianella diagnosi post-trattamento chirurgico eterapeuticoO.Nappi (Napoli)
ORE 10.10-10.30:Citologia urinaria: importanza delle notiziecliniche e strumentali nella fase diagnostica.A. Bondi (Bologna)
ORE 10.30-10.50:Utilità della citologia ago-aspirativa nei tu-mori del reneM. Spinelli (Milano)
ORE 10.50-11.10:Discussione
ORE 11.10-11.30:Coffee Break
ORE 11.30-13.00SECONDA SESSIONE:LADIAGNOSICONALTRETECNOLOGIEModeratoriG.CARMIGNANI (Genova)F. FEOLI (Bruxelles)
ORE 11.30-11.50:FISH: ruolo nella diagnosi e nella prognosidei tumori delle vie urinarie: metodiche aconfrontoG.L.Taddei (Firenze)
ORE 11.50-12.20:PCA3, PSA ed altri test utilizzati nella dia-gnosi del tumore della prostata: esperienzapersonaleE.Bollito (Orbassano -To)
ORE 12.20-12.40:Nuove tecnologie in diagnostica per imma-gine dei tumori delle vie urinarie e del reneA.Carriero (Novara)
ORE 12.40-13.00:Discussione
ORE: 13.00-14.00:Lunch
ORE 14.00-15.40TERZASESSIONE:CLINICA,CHIRURGIA,TERAPIAModeratoriE.FULCHERI (Genova)C.MARTINENGO (Borgomanero - No)
ORE 14.00-14.20:Endometriosi della vescica e delle vie urinarieN. Surico (Novara)
ORE 14.20-14.40:Cistite interstiziale: aspetti clinici e correlatiginecologiciA. Spinillo (Pavia)
ORE 14.40-15.00:Aspetti e trattamenti chirurgici nei tumoridel reneC.Terrone (Novara)
ORE 15.00-15.30:LETTURA MAGISTRALE: La chirurgiaoggi nelle patologie delle vie urinarie e del rene(P.Rigatti - Milano)
ORE 15.30-15.50:Il trattamento chirurgico di tipo conservati-vo nelle patologie delle vie urinarieM.Maffezzini (Genova)
ORE 15.50-16.10:Discussione
ORE 16.10-17.30QUARTASESSIONE:RICERCAEPROSPETTIVEFUTUREModeratoriM.TRUINI (Genova)M. SIDERI (Milano)
ORE 16.10-16.30:La ricerca sui farmaci in rapporto ai tratta-menti terapeutici: stato dell’arte sullo studiodel genoma in rapporto alle terapie mirateG.Apolone (Milano)
ORE 16.30-16.50:Update nel trattamento medico dei tumoridel tratto uro-genitale.O.Alabiso (Novara)
ORE 16.50-17.05:News in PathologyA.Marsico (Vercelli)
ORE 17.05-17.20:News in Urology (Titolo provvisorio)M.Tasso (Torino)
ORE 17.20-17.35:Aggiornamenti nella prevenzione e Vaccina-zione anti - HPVG.Gabutti (Ferrara)
ORE 17.35-18.00:Conclusioni e chiusura dei lavori della VGiornata novarese di studioR.Navone (Torino)
IL PROGRAMMADELCONGRESSO

14
DISTURBI FLEBOPATICI: UN DIARIOPER COMBATTERE LA MALATTIA
La primavera si avvicina e per chi èsoggetto a disturbi flebopatici èopportuno adottare comporta-menti idonei per prevenire e at-tenuare le problematiche ineren-
ti alla malattia. Ce lo spiega il Dottor Gian-francoGiffoni, del dipartimento di chirurgiagenerale dellaClinica Salus diAlessandria.“E’ bene ricordare innanzitutto che l’informa-zione al paziente in flebologia è fondamenta-le. L’insufficienza venosa è una patologia cro-nica ed evolutiva, ingravescente. E’ doverosoquindi non solo essere a conoscenza delle pra-tiche più adatte per alleviarne i problemi, maanche rimanere sotto controllo medico perpoter monitorare la situazione”.I consigli su cosa evitare, insieme ai compor-tamenti da adottare, sono riassunti nel Dia-rio clinico di flebologia, l’utile strumento dilavoro che il Dottor Giffoni utilizza nellaquotidiana pratica lavorativa. Partiamo daiconsigli.“Bisogna evitare le posizioni immobili pro-lungate, le poltrone profonde o con bordiduri. E poi evitare di stare in piedi nella stes-sa posizione per lungo tempo. Infatti chisvolge un’attività professionale che lo co-stringe a una posizione eretta prolungata, co-me chirurghi, parrucchieri, bancari o cuochi
è dunque più predisposto ad incorrere nellamalattia rispetto a chi invece conduce una vi-ta dinamica. E’ necessario evitare anche ichili superflui e vestiti troppo stretti comejeans attillati, calze e calzoni. Evitare le cal-zature basse e i tacchi superiori a 5 centime-tri, nonché i bagni caldi, le saune, le cerette acaldo e ogni tipo di calore intenso a livellodelle gambe. Inoltre si deve resistere alla ten-tazione di prolungate esposizioni al sole edevitare tennis, squash, aerobica, equitazione esci. Infine è bene evitare anche pillole con-traccettive ad elevati dosaggi”.Ora i suggerimenti su cosa invece è doverosofare.“1) Durante posizioni stazionarie prolungate,effettuate episodicamente piccoli movimentidelle gambe. 2) In caso di situazioni di im-mobilismo prolungato, sollevatevi sulla puntadei piedi. 3) Indossate abiti ampi. Chiedete alvostro medico il grado di contenimento adat-to alla vostra insufficienza venosa. 4) Preferitecalzature con tacco compreso tra i 3 ed i 5centimetri. Fate correggere ogni tipo di de-formazione della pianta del piede. 5) Termi-nate il bagno con una doccia alle gambe conacqua fredda, dal basso verso l’alto. 6) Tenetele gambe sollevate durante la notte. 7) Prati-cate nuoto, ciclismo, danza, acquagym. 8)Adottate tutte le misure possibili contro lastipsi”.Anche le vacanze sono oggetto di suggeri-menti da adottare.“E’ un dato certo che la maggioranza dei dis-turbi venosi trovano miglioramento tra gli800 e i 1.200 metri. I luoghi boscosi sonomolto raccomandabili nel periodo caldo, poi-ché assorbono le radiazioni a grande lunghez-za d’onda, cioè quelle maggiormente vasodila-tatrici. Per quanto riguarda il mare invece èbene camminare nell’acqua fino al bacino, inmodo tale da avere un idromassaggio naturaleper via della differenza di pressione esistentetra l’acqua alta e quella bassa. Nuotare a lungoporterà sicuramente giovamento, ma atten-zione all’esposizione solare: vietata se le varicisono gravi, se la vostra flebite è recente, se ave-te un grosso adema o un’ulcera alla gamba. Se
IL DOTTOR GIANFRANCOGIFFONI, FLEBOLOGO DELDIPARTIMENTO DI CHIRURGIAGENERALE DELLA CLINICASALUS DI ALESSANDRIA
SIAVVICINALAPRIMAVERAEAUMENTANOIRISCHIPERIPAZIENTI
LA POSTURA È FONDAMENTALENELLA LOTTA AI DISTURBIFLEBOPATICI. SEDERSI MALE,ACCAVALLARE LE GAMBESONO AZIONI CHE POSSONOPORTARE ANCHEA CONSEGUENZE SPIACEVOLI

15
I SINTOMIDAMONITORARETra i sintomi soggettivi della flebopatia è benericordare le flebectasie, il dolore, le flebodinie,l’edema, la flogosi, il prurito, il senso di peso, icrampi notturni, il formicolio, le parestesie e ilsensodi irrequietezza.“Soprattutto quest’ultimo è un sintomo dav-vero importante di cui si parla molto negli ul-timi tempi. E’ un elemento di cui si occupaanche la neurologia moderna e viene trattatocon farmaci antiparkinsoniani, oltre che confarmaci flebotropi. Per quanto riguarda invecei fattori predisponenti troviamo i contraccetti-vi orali, le gravidanze, gli aborti, l’obesità, ilpiede piatto e cavo, l’attività lavorativa, le ma-lattie pregresse e l’ereditarietà, che gioca unruolo importantissimo”.Passiamo dunque alla visita del paziente e allaterapia.“L’esame obiettivo viene condotto con il pa-ziente visitato in posizione eretta, su una scalain piedi.Durante l’esame ispettivo si notano levarici, si vede il colore della pelle, quindi le pig-mentazioni, la presenza o meno di ulcerazioni,di eczemi, di cellulite, la presenza di teleangec-tasie, di distrofie cutanee.A ciò si aggiunge unesame fondamentale che è quello dell’ecoco-lordoppler, che ci dà la possibilità di vedere seci sono situazioni gravi, superficiali, o profon-de. Poi questo punto si stabilisce la terapia daattuare. Le terapie possono essere mediche,quindi con la prescrizione di farmaci flebotropise ci troviamo di fronte a una patologia mini-ma. Inoltre abbiamo a disposizione la terapiaelastocompressiva e la terapia contenitiva, incui si fa uso di bende o bendaggi oppure calzeelastiche terapeutiche o preventive. Infine ab-biamo l’intervento chirurgico che può essere lostripping corto o lungo, oppure la terapia en-dovascolare con il laser o con la radiofrequenzache però hanno un’indicazione molto precisa:dipendono molto dal calibro delle vene e dallaloro tortuosità delle vene (in questo caso si dis-cute se effettuare o meno la prossectomia). Inpiù ci sono interventi chirurgici che riguarda-no la mini invasività con la famosa S.E.P.S.,che però ormai non utilizza più nessuno.Poi viè la terapia elastocompressiva con bendaggi,che possono essere bendaggi medicati o ben-daggi semplici; la terapia contenitiva con calzeelastiche o terapeutiche e poi ci sono le terapieche riguardano le ulcere vascolari. Infine ab-biamo la terapia sclerosante, tradizionale op-pure con scleromousse o sclerofoam, che èquella più in voga di questo tempo”.
non rientrate in questi casi l’esposizione solareè consentita, a patto però che i bagni di solesiano brevi e progressivi e non da effettuarenelle ore più calde”.La postura è fondamenta-le. “Oggi quasi tutti lavorano col computer emolti si siedono male, accavallano le gambe ohanno le spalle non in posizione eretta: in casicome questi facile avere delle complicanzevascolari periferiche”.
L’ESAME OBIETTIVO VIENE CONDOTTOCON IL PAZIENTE VISITATO IN POSIZIONE ERETTA,SU UNA SCALA IN PIEDI. DURANTE L’ESAMEISPETTIVO SI NOTANO LE VARICI, SI VEDE ILCOLORE DELLA PELLE, QUINDI LE PIGMENTAZIONI,LA PRESENZA O MENO DI ULCERAZIONI, DI ECZEMI,DI CELLULITE, LA PRESENZA DI TELEANGECTASIE,DI DISTROFIE CUTANEE. A CIÒ SI AGGIUNGE UNESAME FONDAMENTALE CHE È QUELLODELL’ECOCOLORDOPPLER, CHE CI DÀLA POSSIBILITÀ DI VEDERE SE CI SONO SITUAZIONIGRAVI, SUPERFICIALI O PROFONDE
IL DOTT GIANFRANCO GIFFONICON ACCANTO LA STRUMENTISTAALESSANDRA DEMARTINIE LA CAPO SALA DI SALAOPERATORIA MIMOSA QARRIDELLA CLINICA SALUSDI ALESSANDRIA.
AL MARE È OPPORTUNONUOTARE CON L’ACQUA FINO ALBACINO, IN MODO DA CREAREUN IDROMASSAGGIO NATURALE

16
IL PROFESSOR DAVIDE SCHIFFER:NEUROPATOLOGIA E FILOSOFIA
Igiorni 24-25 settembre si è tenuto aTorino, presso il Centro Congressidel Lingotto, il Congresso Mondia-le di Medicina Psicosomatica. Pre-sidenti i prof. S. Fassino e G.Fava
Sonino. Il prof. Davide Schiffer é stato invi-tato a tenere una lettura dal titolo: “Psycho-somatic models: subjective experience with ge-ne/protein function in CNS tumors and withthe microscopic world”.Il tema è stato di grande interesse per chi faricerca scientifica o si interessa a problemiepistemologici, perché sostanzialmente in-clude l’obiettività scientifica e l’interpreta-zione delle esperienze scientifiche, nelladiscussione delle quali è sempre tirato inballo il dualismo empirismo/razionalismoche risale alla res cogitans e alla res extensa diCartesio. L’oratore ha illustrato come l’e-sperienza soggettiva si svolga richiamandosiagli “stati mentali” della percezione, proces-sazione e interpretazione con due riferi-menti: uno alla biologia della trasformazio-ne tumorale – e nel caso specifico si è tratta-to di tumori cerebrali in cui è esperto – el’altro alla percezione visiva nell’osservazio-ne al microscopio.I gliomi maligni coinvolgono nel loro svi-luppo e nella loro trasformazione malignaun’enorme quantità di meccanismi e viemolecolari, geni e proteine e processi di at-tivazione e in attivazione, anche se non siconoscono i passi conclusivi nella loro ori-gine. A causa del suo sviluppo progressivonel tempo, a tappe successive, il tumore ma-
ligno appare o come la conclusione di unprogetto biologico o il frutto di eventi sto-castici in successione. Esiste in effetti un’in-terpretazione darwiniana dello sviluppo tu-morale come un processo evolutivo, fruttodi interazioni dei geni con l’ambiente, cen-trato sul vantaggio selettivo associato a cer-te varianti per un dato ambiente. I vantaggidella diversità derivano, come dice Eigen(1992), dalla selezione dei mutanti superiorie dall’adattamento di quelli inferiori. Se loconsidera dal punto di vista cellulare, nellaconcezione neo-darwiniana, il tumore se-condo Vineis (2005) può essere assimilatoalla speciazione o all’adattamento. La que-stione della sua poli- o monoclonalità puòessere risolta accettando la prima per glieventi pre-neoplastici e la seconda per l’e-vento cruciale, corrispondendo la cascatadegli eventi molecolari da un lato ad una se-rie di avvenimenti stocastici e dall’altro, unavolta caduta nelle ferree leggi del DNA, allanecessità in senso filosofico, come ha dettoMonod (1975). E’ vero che bisogna tenereconto degli eventi epigenetici, quali adesempio le metilazioni, l’acetilazione degliistoni e lo splicing alternativo, che limitanol’importanza del DNA, ma la loro apparen-te trasmissione nelle generazioni cellulari ècancellata dopo poche di queste.Dunque, il passaggio dalla normalità allostato tumorale avviene con un crescendo dieventi molecolari: lo stato pre-neoplastico,la soppressione dell’apoptosi e dei tumorsuppressor genes o guardiani del menoma, laderegolazione del ciclo cellulare che si svol-ge attraverso una serie di geni e proteineche regolano le cicline e le loro kinasi, l’atti-vazione dei geni della fase S e della mitosicon le sue complicate modulazioni geniche.Si menziona appena il sistema ubiquitina-proteasoma, il silenziamento dell’mRNA,l’invasione del tessuto normale, le metastasifino alla riparazione del DNA dopo terapiee ai meccanismi di resistenza cellulare. Sututto questo dominano i recettori tirosin-kinasici, EGFR, PTEN, la cascata diAKT/PKB che inducono e mantengono la
DAVIDE SCHIFFER,PROFESSORE EMERITODI NEUROLOGIAALL'UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI TORINO
IL CONGRESSOMONDIALEDIMEDICINA PSICOSOMATICA
L’ORATORE HA ILLUSTRATO COME L’ESPERIENZASOGGETTIVA SI SVOLGA RICHIAMANDOSIAGLI “STATI MENTALI” DELLA PERCEZIONE,PROCESSAZIONE E INTERPRETAZIONECON DUE RIFERIMENTI: UNO ALLA BIOLOGIADELLA TRASFORMAZIONE TUMORALE E L’ALTROALLA PERCEZIONE VISIVA NELL’OSSERVAZIONEALMICROSCOPIO

17
che si sviluppano associati a diverse altera-zioni genetiche.Questi effetti sono prevedibili sulla basedell’esperienza. Un esempio di interpreta-zione neo-evoluzionistica del tumore é laselezione per competizione dei nuovi clonimaligni che sostituiscono i predecessori esono responsabili della trasformazione tu-morale. Questo processo va sotto il nome di“anaplasia”. Tutte le alterazioni di ge-ni/proteine possono essere viste da duepunti di vista. Da quello della nostra espe-rienza scientifica esse cadono sotto la regoladel “caso e la necessità” di Monod. Mecca-nismi di selezione per competizione nelsenso darwiniano producono speciazione eadattamento. Se però si osserva l’intero pro-cesso naïvely e senza pregiudizi scientifici,le cose cambiano. Lo studio di Monod en-fatizza all’inizio la “contraddizione episte-mologica” della biologia i cui oggetti, a par-te la morfogenesi autonoma e l’invarianzariproduttiva, mostrano un’ovvia teleonomiae cioè un apparente disegno nella successio-ne dei loro processi. E’ ovvio che la teleono-mia poi si risolva a livello genetico e micro-scopio con le variazioni stocastiche delDNA, che trasporta “il caso” nelle genera-zioni cellulari.Ad un livello organistico l’aspetto teleono-mico degli eventi biologici è inevitabile,perché questi appaiono nella loro forma fi-nale, cosicché si è portati a considerare iprecedenti eventi molecolari come finaliz-zati ad essi. Questo è un atteggiamento psi-cologico umano che cade nella “fictionalfunction” della mente, secondo la filosofiadel “come se” (Die Philosophie des Als Ob, diHans Vaihinger, 1911). Di fronte ad unevento biologico, è d’obbligo la domanda seesso sia il prodotto di un coinvolgimentostocastico di geni/proteine o se questi sianostati selezionati per il suo compimento. Ov-viamente, la finalizzazione di un evento puòessere indotta da altri eventi e cioè il dise-gno può essere intrinseco alla materia vi-vente, ma non lo si può oggettivare senzastaccarlo dal suo contesto biologico.Il secondo esempio riguarda il patologo ochi cerca di discriminare la realtà al micro-scopio con oggettività e rigore scientifico.Nel linguaggio di tutti i giorni si dice “guar-dare le cose con la lente del microscopio” o“analizzare al microscopio una questione”,significando la volontà di essere precisi e
proliferazione cellulare. Un esempio calzan-te è dato dal modello animale dei tumorisperimentali da derivati della Nitrosoureanel ratto. Una singola dose di 20 mg/Kg i.v.alla ratta al 17° giorno di gravidanza di Etil-nitrosourea provoca tumori cerebrali nel90% della progenie. I tumori, dopo un pe-riodo iniziale di latenza, cominciano ad ap-parire al 3° mese di vita e.u. e continuano acrescere per mesi fino alla morte dell’ani-male. A partire dall’effetto della Nitrosou-rea sulle cellule staminali della matrice, sisvolgono uno dopo l’altro una serie di even-ti biologici in successione temporale.In genere, gli effetti fenotipici delle serie dialterazioni di geni e proteine differiscono aseconda delle cascate molecolari attivati oinattivate. Un esempio di ciò è dato dai duetipi di glioblastoma, primario e secondario,
SECONDO IL PROFESSORSCHIFFER L’OSSERVAZIONEAL MICROSCOPIO DA PARTEDEI PROFESSIONISTIÈ SOGGETTA AI MECCANISMIPSICOLOGICI DERIVANTIDELL’ESPERIENZASOGGETTIVA
L’EQUIPE DEL PROFESSORDAVIDE SCHIFFERALLA CLINICA SANTA RITADI VERCELLI

18
mondo o come una proiezione della mentenel mondo, secondo l’accoppiata empiri-smo/razionalismo, cioè natura senza co-scienza o coscienza senza natura, è superatadal concetto dell’ “Io sono il mio corpo”.In entrambe le concezioni c’è un ampio spa-zio per l’influenza del vissuto sulla percezio-ne, sia nel primo che, soprattutto, nel secon-do stadio dellaGestalt Psychologie. Quello chenoi percepiamo è un prodotto cognitivo incui l’informazione sensoriale è processata inbase al proprio vissuto, scientifico o generale.Il preambolo della Gestalt è che non esisteuna corrispondenza diretta fra le caratteristi-che fisiche della realtà e quelle percepite, poi-ché le prime possono esistere senza le secon-de e viceversa. In questo scambio fra mondoe mente intervengono molti fattori, quali al-cune caratteristiche della realtà o le proprietàfisiche e fisiologiche dell’apparato visivo.Esiste una ricca letteratura sui meccanismiche regolano la distinzione della figura dalfondo.I’interesse é tuttavia focalizzato sul-l’influenza del “vissuto” non solo sulla perce-zione, ma e principalmente sull’interpreta-zione del mondo percepito, nella consapevo-lezza che altre funzioni cognitive interven-gono nel primo e nel secondo o in entrambigli stadi della percezione, come l’attenzione,il linguaggio, la memoria, la coscienza. L’at-tenzione è di grande importanza sia nella suaforma attiva che passiva, anche nei mancati oerronei riconoscimenti, ma soprattutto nelpassaggio dell’informazione alla memoria alungo termine. Molti contributi sperimentalisono stati portati su questo argomento, in-cludendo quelli sulle vie che raggiungonol’ippocampo da altri centri nervosi. Questoargomento rientra nella questione più gene-rale che riguarda la possibilità che l’ideazioneproduca modificazioni organiche, del cervel-lo e si riporta alle grandi idee di Popper, Ec-cles, Kandel.Della massima importanza é l’influenza del“vissuto” sull’interpretazione del mondo per-cepito e, al contrario, la capacità di questa dievocare sentimenti e idee nella mente dell’os-servatore. L’integrazione dello stimolo nell’e-sperienza scientifica può condurre ad inter-pretazioni tanto più utili quanto più in dialet-tica con la corrente interpretazione scientifica.Il ruolo maggiore nel riconoscimento deglioggetti e nella loro interpretazione , così comenel commettere errori, è giocato dalle cosid-dette “immagini mentali” che forzatamente
obiettivi. Questo può essere sbagliato. Dis-criminare la realtà al microscopio implicadue stati mentali che sono la percezione el’interpretazione e in entrambe il peso della“esperienza” è fortissimo, in senso positivodell’identificazione e riconoscimento di “og-getti” nel campo, ma anche in senso negati-vo. Non si può oggi parlare della percezionevisiva senza riferirsi alla Gestalt Psychologie.Questa fin dall’inizio ha considerato il “tut-to” come diverso dalla somma delle e sueparti costituenti. La percezione è un processoinfluenzato dall’esperienza o “vissuto” cherappresenta lo “sfondo” come opposto alla“figura”. Il processo si compone di uno stadioprimario e di uno secondario. Nel primo av-viene la descrizione strutturale dell’oggetto,cioè la distinzione della figura dal fondo, nelsecondario l’oggetto è comparato con la me-moria in una elaborazione cognitiva.Una pietra miliare nella nostra concezionefilosofica della percezione visiva è la teoria diMerleau-Ponty. Questi propugna l’Ontolo-gia della percezione per superare l’opposizio-ne empirismo/razionalismo, concependo lasoggettività come il correlato ontologico del-la corporeità del mondo. La percezione comeindicante qualcosa che entra nella mente dal
NELLE GIORNATEDEL 24 E 25 SETTEMBRESCORSI IL PALAZZODEL LINGOTTO DI TORINOÈ STATO IL TEATRO DELCONGRESSO MONDIALE DIMEDICINA PSICOSOMATICA
I PATOLOGI COMMETTONO ERRORI, COME TUTTI,E AL MICROSCOPIO CERCANO DI DARECORRETTE INTERPRETAZIONI ED ESSERE OBIETTIVI.MA QUI SORGE IL QUESITO: COS’È L’OBIETTIVITÀNELLA SCIENZA?

19
nella scienza? Dovrebbe significare vedere ilmondo reale il più possibile così com’é, ma ègià stato detto che la percezione è un prodottocognitivo in cui il vissuto gioca un grande ruo-lo e che non c’é una corrispondenza diretta frale caratteristiche fisiche della realtà e quellepercepite. Questo significa che l’obiettivitàconsisterebbe nell’usare immagini mentali piùvicine possibili a quelle riconosciute dallascienza corrente come vere, assumendo la ve-rità nel senso di Hanson, Kuhn e Popper econsiderando il fallibismo, la contingenza e latransitorietà dei dati scientifici, che non sonoassoluti e nel lungo periodo risulteranno sba-gliati. Quello che mette il patologo oggi a dis-agio quando fa una diagnosi o conclude unaosservazione sono le conseguenze delle suevalutazioni sulla prognosi e trattamento di pa-zienti e sulla propria produzione scientifica.E’difficile poter dire se le diagnosi e le conclu-sioni delle osservazioni microscopiche sonobasate più sulla patologia o sulle scienze di ba-se che sono oggi anche quelle più finanziate.Oltre all’iter procedurale delle diagnosi clini-che, su cui ha discusso recentemente Fava So-nino, ci si chiede se anche in microscopia lescienze di base abbiano condotto alla distru-zione al fisiopatologico ponte “dal bancone (dilaboratorio) al letto (del malato)”, come vasottolineando Feinstein (1970, 2005). Que-sto non viene discusso nella relazione ad essobisognerebbe aggiungere qualcosa prove-niente dall’interpretazione della “Teoria deiquanta” e dal “Principio di indeterminazio-ne” di Werner Heisenberger. Ma questa èun’altra storia.
devono essere usate, precedentemente co-struite con l’esperienza. Queste devono esserein dialettica con la corrente conoscenza scien-tifica per non commettere errori che possonoarrivare perisino ad mideologie.Il concetto di“immagine mentale” potrebbe essere in favoredel razionalismo, non fosse per la loro originedall’esperienza. I contenuti emotivi dell’espe-rienza, che rientrano nella memoria implicitae in quel mistero chiamato inconscio, che ilrelatore preferisce denominare “meccanismiiponoici e ipobulici (secondo Kretschmer),sottendono ad un doppio gioco: influenzarel’interpretazione ed essere evocati con conse-guente stato emotivo o esplicitati. Il microsco-pista vive così in due mondi: uno reale e quellomicroscopico e passa dall’uno all’altro, nonsenza sofferenza, ma anche non senza piace-vole interesse a causa della generazione di pe-culiari stati mentali. I patologi commettonoerrori, come tutti, e al microscopio cercano didare corrette interpretazioni ed essere obietti-vi. Ma qui sorge il quesito: cos’è l’obiettività
OLTRE ALL’ITER PROCEDURALE DELLE DIAGNOSICLINICHE, SU CUI HA DISCUSSO RECENTEMENTEFAVA SONINO, CI SI CHIEDE SE ANCHEIN MICROSCOPIA LE SCIENZE DI BASEABBIANO CONDOTTO ALLA DISTRUZIONEAL FISIOPATOLOGICO PONTE “DAL BANCONE(DI LABORATORIO) AL LETTO (DEL MALATO)”,COME VA SOTTOLINEANDO FEINSTEIN (1970- 2005)
NON SI PUÒ OGGI PARLAREDELLA PERCEZIONE VISIVASENZA RIFERIRSI ALLAGESTALT PSYCHOLOGIE
IL DIBATTITOSUL DUALISMOEMPIRISMO/RAZIONALISMORISALE ALLA FILOSOFIADI RENATO CARTESIO

20
Clinica SalusAlessandria
Policlinico di Monza - Via Amati, 111 - 20052 Monzawww.policlinicodimonza.itUfficio Stampa e coordinamento redazionale:Tel. 039/2810618www.policlinicodimonza.it
AnnoVII numero 18 - Febbraio 2010Autorizzazione del Tribunale di Monza n. 1724 del 5 marzo 2004Direttore responsabile:Marco PirolaStampa:Novarello Servizi, VercelliProgetto grafico:Marco MicciImmagini: Policlinico di Monza
Via Amati 111 - MonzaTel. 039 28101www.policlinicodimonza.itDir. Sanitario: Prof. Giulio Cesare Papandrea
Via Bottini 3 - NovaraTel. 0321 3831www.clinicasangaudenzio.comDir. Sanitario: Dott. Alfredo Lamastra
Via dell’Aeronautica 14/16 - VercelliTel. 0161 2221www.clinicasrita.itDir. Sanitario: Dott. Manlio Accornero
Via Castiglia 27 - IvreaTel. 0125 645611www.clinicaeporediese.itDir. Sanitario: Dott. Dario Andrea Verani
Via Trotti 21 - AlessandriaTel. 0131 29461www.clinicasalus.itDir. Sanitario: Dott. Clemente Ponzetti
Direttore Scientifico: Prof. Elio Guido Rondanelli
Monza
Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Chirurgia plastica e maxillo facciale, Chirurgia toracica,Chirurgia vascolare, Neurochirurgia, Ortopedia e traumatologia, Urologia, Cardiologia,Medicina generale, Neurologia, Riabilitazione cardiologica, Riabilitazione neuromotoria,Emodinamica, Pronto Soccorso,Terapia intensiva, Unità coronarica
Novara
Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Neurochirurgia, Ortopedia, Oculistica, Cardiologia,Medicina interna, Terapia fisica, Riabilitazione e Fisiokinesiterapia, Emodinamica,Terapia intensiva
Alessandria
Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Oculistica, Ortopedia, Urologia, Cardiologia,Medicina generale, Emodinamica, Terapia intensiva
Vercelli
Chirurgia generale, Ginecologia, Oculistica, Ortopedia, Urologia, Medicina generale,Riabilitazione neuromotoria e bronco-pneumo-cardio respiratoria, Terapia intensiva
Ivrea
Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Neurochirurgia, Ortopedia, Medicina generale,Medicina riabilitativa (1° livello), Emodinamica, Terapia intensiva
BiellaChirurgia generale, Chirurgia vascolare, Ortopedia e Traumatologia, Urologia,Cardiologia, Medicina generale, Nucleo per pazienti in stato vegetativo permanente,Emodinamica, Terapia intensiva
Alessandria
Chirurgia generale, Day Surgery, Ortopedia, Medicina generale, Neurologia,Neuro Riabilitazione III Livello, Riabilitazione neuromotoria II Livello
Via Bruno Buozzi 20 -Alessandria - Tel. 0131 314500www.nccalessandria.itDir. Sanitario: Dott. Roberto Prigione
Via Ramella Germanin 26 - BiellaTel. 015 35931www.lavialarda.itDir. Sanitario: Dott. Roberto Terzi
LO/0200/2008