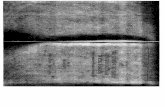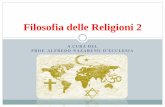Il Metodo Storico-comparativo Nella Scuola Italiana Di Storia Delle Religioni - Gianfranco Bertagni
-
Upload
gianfranco -
Category
Documents
-
view
53 -
download
0
description
Transcript of Il Metodo Storico-comparativo Nella Scuola Italiana Di Storia Delle Religioni - Gianfranco Bertagni

SEZIONE: STORIA DELLE RELIGIONI
di
Gianfranco Bertagni1
Comunemente per storia delle religioni si intende lo studio storiografico di religioni in base alla loro
documentazione storica. Diciamo subito che questa definizione è obsoleta. Ad aggravare questo pregiudizio è da registrare il fatto che la stragrande maggioranza delle enciclopedie, dei manuali e dei dizionari di storia delle religioni sono per lo più delle collezioni delle varie singole storie religiose2. L'idea sottostante a questa metodologia è quella che vede la storia delle religioni equivalente alla storia dell'Induismo più quella del Buddismo più quella dello Shintoismo più quella dell'Ebraismo più quella del Cristianesimo, ecc.
Da Raffaele Pettazzoni3 in poi, in Italia, la storia delle religioni ha visto l'affermarsi del metodo storico-comparativo (non solo comparativo, bensì storico-comparativo); non è tale se non è «storia comparata delle religioni».
1. Sul metodo storico-comparativo Raffaele Pettazzoni si trovò a contrastare le due tendenze ideologiche prevalenti negli anni '20-'30
intorno alle scienze religiose. Da una parte vi era Benedetto Croce, il quale sulla scia di Giambattista Vico, teorizzava quella moderna prospettiva storicistica-storiografica-critica che caratterizzerà la cultura italiana e a cui lo stesso Pettazzoni si abbeverava, ma che dimostrava nei confronti della religione una grave chiusura mentale a causa del suo idealismo. Croce infatti affermava l'autonomia delle quattro categorie dell'estetica, della logica, dell'economia e dell'etica, tralasciando la categoria religiosa. Inoltre egli considerava la storiografia non applicabile all'analisi di una storia particolare distaccata da quella unica e totalizzante dello spirito e quindi escludeva la possibilità di un approccio storico-comparativista ai fatti religiosi, esigenza che si rivelerà, invece, fondamentale per il Pettazzoni. Dobbiamo inoltre dire che Croce rimase sempre tristemente legato a una visione etnocentrica trasmessagli dall'ideologia colonialista europea del suo tempo e dall'influenza della teorizzazione hegeliana.
D'altra parte la figura di Benedetto Croce era influentissima anche grazie al fatto che lo si considerava il più grande antifascista, difensore della libertà politica e religiosa. E così contribuì non poco al ritardo dello sviluppo di una autonoma scienza delle religioni, proprio quando invece l'Europa
1 Ringrazio i proff. Dario M. Cosi e Anselmo Cassani per aver letto la prima stesura di questo aritcolo. 2 Si veda per es. la Storia delle religioni a cura di Tacchi Venturi (prima edizione: 1934, sesta edizione: 1970-1971), o la Historie des religions a cura di C. Puech (1970-1976) o ancora quella più recente di Giovanni Filoramo. 3 Raffaele Pettazzoni, nato a San Giovanni in Persiceto nel 1883, li laureò in lettere all'università di Bologna. Nel 1913 ebbe la libera docenza e insegnò nella stessa università fino al 1922, anno nel quale si trasferì all'università di Roma. Dal 1950 fu presidente dell'Associazione Internazionale per la Storia delle Religioni. Morì nel 1959
IL METODO STORICO-COMPARATIVO NELLA SCUOLA ITALIANA DI STORIA DELLE RELIGIONI

Il metodo storico-comparativo nella scuola italiana di storia delle religioni
2
(si pensi soprattutto alla Francia e alla Germania) era sede di un acceso dibattito e dialogo su questi temi4.
Dall'altro versante, in un certo senso opposto al primo, Pettazzoni si trovò a combattere contro le teorie della Scuola di Vienna, soprattutto nel suo esponente massimo, padre Wilhelm Schmidt. Quest'ultimo era l'assertore della teoria del «monotesimo primordiale» (Urmonotheismus): considerando i Pigmei africani i rappresentanti dello stadio primordiale della civiltà umana, essa afferma che la credenza in un Essere celeste da parte di questo popolo sarebbe la prova del monoteismo originario. Dopo questo stadio dei cacciatori Pigmei vi sarebbe stata una caduta con l'originarsi di una cultologia magica, esito dell'era della coltura e dell'allevamento.
L'influenza di Schmidt fu forte nell'etnologia italiana fra le due guerre. La Chiesa Cattolica considerò la tesi schmidtiana quasi come sesta prova (non più teologica, bensì - appunto - etnologica) dell'esistenza di Dio, presentata nei seminari accanto alle cinque vie tomiste. L'indirizzo schmidtiano penetrò in Italia anche grazie alle opere dei padri Koppers e Pinard de la Boullaye, alle presentazioni delle teorie di Schmidt fatte da padre Schulien sull' «Osservatore Romano» e in riviste scientifiche, e alle opere di Renato Boccassino. Ispirò molte voci dell' «Enciclopedia italiana» e opere divulgative come «Razze e popoli della Terra» a cura di Renato Biasutti.5
Pettazzoni criticò queste tesi teologizzanti soprattutto con due grandi opere: «Dio. Formazione e sviluppo del monoteismo»6 e «L'Onniscienza di Dio»7. Egli, con queste opere e con una serie di articoli, portando come prova una enorme documentazione, interpretava il monoteismo non più come dato originario e primordiale, ma come rivoluzione religiosa. Il punto nodale era che il monoteismo rappresentava un rinnegamento delle altre divinità con l'affermazione del Dio unico. Proprio la Bibbia e il Corano, i testi sacri delle tre religioni monoteiste, lo indicano: è degno di nota per esempio il fatto che nell'Antico Testamento, quando Jhavé parla di altre divinità, non ne nega l'esistenza, ordinando però al suo popolo che il culto venga indirizzato solo a Lui. Per Pettazzoni allora il monoteismo è una conquista di civiltà superiori, dotate di scrittura, ad opera di profeti innovatori (rivoluzionari, si potrebbe dire): Mosè, Gesù, Maometto, i quali agiscono su un terreno di religioni preesistenti politeiste rinnegate.
Consideriamo ora da più vicino il metodo storico-comparativo elaborato dall'autore italiano. Come già accennato, Pettazzoni, «recuperava la dimensione vichiana di interpretabilità delle vicende religiose, intese come realtà storiche e sottoposte a un'analisi filologicamente severa proprio come storia particolare o specializzata, la quale, tuttavia, non restasse radicalmente avulsa dal contesto della storia generale delle culture» (A. di Nola). La prospettiva di Pettazzoni, inserendosi nell'indagine storica dei fatti, escludeva quei due modi di rapportarsi alla religione (quello positivista e quello teologico), i quali erano le vie più battute al suo tempo8. La civiltà ha in sé innumerevoli aspetti, come l'arte, la politica, l'economia, e tra essi troviamo anche la religione. Ovviamente queste forme di vita e di pensiero spesso sono astrazioni mediante le quali indaghiamo la società, e dunque esse non sono affatto slegate
4 Cfr. Benedetto Croce, La storia come pensiero e come azione, Bari, Laterza,1938. Per le sue obiezioni di tipo storicistico e anti-comparatistico vedi in «La Critica» (1924), pp. 312 e ss.; risposta di Pettazzoni in «S.M.S.R.», I (1925), p. 153; replica di Croce in «La Critica» (1925), p. 318. 5 Torino, 1940. 6 Raffaele Pettazzoni, Dio. Formazione e sviluppo del monoteismo nella storia delle religioni, Vol. I, L'Essere celeste nelle credenze dei popoli primitivi, Bologna, Zanichelli, 1922. 7 R. Pettazzoni, L'onniscienza di Dio, Torino, Einaudi, 1955. Le ricerche e i risulrati di questa opera e di quella del '22 sono riassunti nel libro a carattere divulgativo L'Essere supremo nelle religioni primitive, Torino, Einaudi, 1957. 8 Cfr. Religione e cultura, ripubblicato in Religione e società (d'ora in poi RS), a cura di M. Gandini, Bologna, Ponte Nuovo, 1966.

Il metodo storico-comparativo nella scuola italiana di storia delle religioni
3
tra loro, bensì interdipendenti. La civiltà è un «organismo vivente», secondo le stesse parole del nostro studioso; dunque per intenderne un suo aspetto non si può isolarlo da tutti gli altri. Conoscere la religione di un popolo vuol dire anche interpretare la sua storia, la sua arte, la sua visione del mondo,... .
D'altra parte religione è soprattutto storia: se il credente concepisce i miti, i riti, i culti, le preghiere, i personaggi sacri di cui vive come dati, fissi, da sempre identici nelle loro caratteristiche, lo storico sa che dietro a ogni aspetto di una precisa religione c'è una storia: una storia di crescita, caduta, ricrescita, influenze, eliminazioni, interpretazioni, rotture, crisi. «L'uomo costruttore della sua religione» si legge negli ultimi appunti del maestro, a cura di Angelo Brelich9.
Con il metodo storico-comparativo, inoltre, si ricostruisce il dato religioso come facente parte di qualcosa di altro, di più esteso, che non si esaurisce in esso: «un fatto religioso... non è altro che la manifestazione specifica di qualcosa di molto generale e molto più ampio»10. Proprio per questo la comparazione non può partire e concludersi nella considerazione di vicinanza (spesso apparente) di temi religiosi appartenenti a tradizioni diverse: bisogna invece considerarli nella loro ricchezza di legami e presupposti, i quali, uscendo dalla sfera strettamente religiosa, si trovano nel contesto sociale, culturale e storico-dinamico cui appartengono. Questa istanza invece non è sentita da chi considera la religione come fatto interamente autonomo, slegandola dunque da tutto il resto: su questo argomento gli storici delle religioni italiani si pongono criticamente nei confronti delle correnti fenomenologiche e irrazionalistiche11.
2. A cosa serve la comparazione? Seguiamo il pensiero di Pettazzoni nel suo famoso articolo «Il metodo comparativo»12. Certo,
comparare due o più religioni per rivelarne taluni aspetti simili tra loro, serve a ben poco. Nel 1956 H. H. Rowley scrisse «Prophecy and Religion in Ancient China and Israel», in cui confrontò i profeti ebraici con i maestri cinesi Confucio, Meng-tse, Mo-tse: così l'autore concluse che il profetismo ebraico ha alcuni aspetti che concordano e altri che discordano con certi aspetti del pensiero cinese. E dunque? Rimaniamo nel «vestibolo della storia»: mettere due termini a confronto non ci fa conoscere nulla di ciò che non sapevamo su ciascuno di essi prima di compararli. Dunque una comparazione che sia meramente descrittiva non porta a nulla: bisogna superare il momento della registrazione delle somiglianze e delle differenze, per giungere a una scoperta di rapporti nuovi nell'approfondimento storiografico. Il Pettazzoni, quindi, fa una serie di esempi di comparazione orientata verso un vero sviluppo della conoscenza storico-religiosa. Si consideri il Cristianesimo: esso è cosa unica e irripetibile per il credente, ma per lo storico non può non essere comparato con il Buddismo, in quanto entrambe sono religioni supernazionali. Esse attuano il passaggio dalla forma nazionale alla forma supernazionale della religione. Questo passaggio non viene inteso se non lo si inquadra come elemento storico, se lo si concepisce come una necessità interna a una legge operante nel divenire storico: la storia infatti non è equivalente alla natura, non è cioè il mondo della necessità, ma è essenzialmente libertà, varietà, grazie alla quale è possibile la comparazione. La comparazione evidenzia il valore religioso del passaggio a una religione supernazionale, passaggio non necessario e dunque non universale, ma particolare, trovando nelle singole forme e ragioni storiche specifiche, e solo in esse, il 9 «S.M.S.R.» XXXI - 1960. 10 A. Brelich, Storia delle religioni: perchè?, Napoli, Liguori, 1979, p. 168. 11 Come esempio di questa diversa considerazione della storia delle religioni, si veda F. Heiler, Die Religionen der Menschheit in Vergangenheit und Gegenwart, Stuttgart, Reclam-Verlag, 1959, 1962², trad. it. Storia delle religioni, 2 voll., Firenze, Sansoni, 1976. 12 «Numen», VI, 1959.

Il metodo storico-comparativo nella scuola italiana di storia delle religioni
4
suo perché. Tra questi motivi sono presenti, ovviamente, sia esigenze slegate dalla sfera religiosa, sia intrinseche ad essa (per es. l'avvento di una religione supernazionale rappresenta sempre un nuovo e rinvigorito slancio di vita religiosa, intriso di nuovi ideali).
Un altro esempio che Pettazzoni adduce è il monoteismo. Solo uscendo, argomenta, da presupposti dogmatici-religiosi-fideistici o anche naturalistico-evoluzionistici, solo attraverso la comparazione delle sue realizzazioni storiche (Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo), il monoteismo si mostra con il suo significato storico di reazione e rivoluzione contro una forma precedente di religiosità politeistica, essendo questo un carattere ricorrente in ogni religione monoteistica. In tale contesto interpretativo, è stato possibile formulare la nozione di Essere Supremo (che è altra cosa rispetto alla credenza nel Dio unico, ma che è alla base di essa), rintracciandola nel mondo primitivo, variando nella forma a seconda delle tipologie elementari delle civiltà in cui si concretizzava. È questa un'altra testimonianza della necessità di colloquio tra le varie sfere interne a una stessa società, per una reale comprensione dei loro elementi e delle loro funzioni; l'Essere Supremo è chi provvede alle necessità esistenziali dell'uomo: sarà dunque la Madre Terra per le civiltà agricole, il Padre celeste (che manda pioggia per il pascolo) per le civiltà pastorali, e il Signore degli animali (dal quale dipende l'esito della caccia) nelle civiltà della caccia13.
Da queste considerazioni si capisce che il fatto che due storie religiose non abbiano una comune origine non vieta la possibilità di compararle. Per esempio, in due paesi così distanti come l'Egitto e il Messico si constata l'esistenza di quelle peculiari costruzioni che sono le piramidi. Banalmente si potrebbe dedurre che queste due civiltà si sono conosciute; purtroppo però non ci sono prove storiche che avallino questa tesi fantastica (dovrebbe far riflettere che per dimostrare lo spostamento di popolazioni dal continente africano a quello americano molti «studiosi» abbiano scomodato il mito di Atlantide). Lo storico delle religioni invece sa che a monte di ogni credenza, rito, mito e anche costruzione di tipo religioso c'è sempre un bisogno, un'esigenza. Dunque il bisogno di costruire una piramide è frutto di due società affini, sia in Egitto che in Messico, in un determinato momento dell'evoluzione sociale degli uomini.
Nella prefazione al suo libro del 1920 dedicato alla religione di Zarathustra, Pettazzoni si chiede «se quel rinnovamento religioso che si produsse nel giro di pochi secoli tra gli Ebrei con i Profeti, tra gli Irani con Zarathustra, tra i Greci con l'Orfismo, tra gli Indi con Buddha, tra i Cinesi con Lao-Tse [...], sia effetto di altrettante evoluzioni indipendenti e convergenti, oppure di una irradiazione molteplice da un unico centro sconosciuto»14. Ora, secondo le parole di Ambrogio Donini, «è qui che Pettazzoni ha portato un contributo prezioso a quella che è oggi l'interpretazione marxista delle religioni, anche se non è mai stato dal punto di vista storico-critico, un marxista»15 .
Il marxismo risponde a questa domanda segnalando il periodo in cui sono avvenute questa serie di rinnovamenti religiosi come la grande epoca sociale della schiavitù di tutto il mondo, nella quale si formò tra gli uomini la coscienza che tutto fosse perduto sulla terra: da questo presupposto, quindi, la ricerca di una nuova vita, di una salvezza, del regno di Dio dei Profeti, di un mondo futuro che fosse di riscatto. Questa era una reazione alle religioni classiche, in mano ai padroni, in cui le divinità greche o romane erano esclusive dei ricchi, dei patrizi. Queste nuove religioni nascono nello stesso periodo
13 Vedi L'onniscienza di Dio, cit., p. 648. 14 R. Pettazzoni, Gli insegnamenti di Zarathustra nella storia religiosa dell'Iran, Padova, Meb editrice,1997, p. 14 (si tratta di una ristampa del testo del '20 dal titolo La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell'Iran). 15 Raffaele Pettazzoni e gli studi storico-religiosi in Italia, p. 64, in M. Gandini (a cura di), Raffaele Pettazzoni e gli studi storico-religiosi in Italia, Bologna, Forni, 1969.

Il metodo storico-comparativo nella scuola italiana di storia delle religioni
5
perché quella era l'età in cui la vita religiosa si divideva in due, tra il culto delle classi dominanti e quello delle classi dominate16.
Pettazzoni riprende il medesimo tema nella nuova introduzione del '53 a «Storia della religione greca»: il dualismo tra il culto olimpico tradizionale e il dionisismo mistico viene visto non solo in termini religiosi, ma anche culturali, etnici, sociali. Da una parte dunque un'arcaica religione agraria, propria della tradizione contadina - il dionisismo -, dall'altra, la religione olimpica, propria della cultologia gentilizia. E nella democratizzazione dell'Ellenismo, Pettazzoni vede l'uscita del dionisismo dalla sua situazione di marginalità e di segregazione tipica dell'epoca classica, con la diffusione dei culti misterici17.
Angelo Brelich, successore alla cattedra storia delle religioni di Pettazzoni, approfondì questo tema elaborando nuovi argomenti: non vedeva nell'Ellenismo la nascita di una nuova civiltà solo attraverso il conflitto tra gli strati sociali (come era per il suo maestro), ma sottolineava anche in quell'epoca l'avvento di una crisi psicologica e culturale generale. La polis, in cui l'individuo trovava la sua identità, era venuta improvvisamente a mancare; se prima il cittadino aderiva alla religione della polis, con l'unità politica creata da Alessandro, l'indipendenza e l'autonomia delle città viene meno. A questo si aggiunge la convivenza con masse di popolazioni orientali, con la conseguente compenetrazione di diverse culture. Molti greci vivono fuori della loro patria, conoscono nuove religioni, recepiscono l'idea di «regalità sacra», ha inizio il sincretismo religioso. Così si originano i culti misterici e, cadendo i vecchi rapporti tra l'uomo e gli dei della polis, non resta che la via, privata e diretta, del contatto con il sovraumano, privata, diretta18 .
Attraverso la comparazione storica Brelich cerca anche di allontanare i miti greci da quella lettura estetica o poetica che li intende come un unicum nella storia religiosa universale. Egli dimostra nel suo libro come racconti e personaggi mitici, feste greche si debbano rapportare, per certi versi, a caratteri comuni a tante culture primitive di popoli coltivatori (culti agrari per es.) e cacciatori (trickster), mentre per altri versi siano specifici della storia peculiare della civiltà greca.
Ma Brelich confronta la religione greca anche con le religioni superiori dell'India, del vicino-Oriente e con l'Ebraismo. Queste ultime sono accumunate da una caratteristica: hanno una documentazione diretta, fonti redatte da sacerdoti o comunque da personale addetto al culto e alla sua diffusione. Sotto questo profilo, la religione greca è peculiare per la sua mancanza di documentazione diretta, essendo le sue fonti l'arte, la letteratura, la poesia,...: questa sua caratteristica non la si poteva cogliere senza il confronto con altre religioni. Dunque la religione greca «è inestricabilmente legata ad ogni settore dell'esistenza, alla vita quotidiana di ognuno», per cui «non c'era bisogno di trasmetterla in testi sacri redatti da autori specializzati». Per questo anche la religione dell'antica Grecia è confrontabile con le religioni primitive studiate dall'antropologia: come nelle società premoderne, la religione greca non era emanazione di una classe sociale dominante. Come già detto, l'intera situazione cambierà con l'avvento dell'età ellenistica.
Nella constatazione di elementi in comune tra religioni superiori e religioni primitive si è spesso parlato di «sopravvivenze» (Tylor): si tratta di un residuo dell'ottocentesco evoluzionismo a volte
16 Certo queste parole non furono mai usate da Pettazzoni. Un lessico di un certo tipo, che contempla al suo interno concetti come "lotta di classe" o dialettiche "padrone/suddito", fa parte di una ben precisa opzione culturale-politica, la quale sempre meno viene ritenuta vincente, a parte l'eccezione di pochi nostalgici tra cui Amborgio Donini, nella metodologia della ricerca storico-religiosa. 17 Sui misteri greci si veda anche: Raffaele Pettazzoni, I misteri. Saggio di una teoria storico-religiosa, Cosenza, Lionello Giordano, 1997 (ripubblicazione del libro del '24), soprattutto i paragrafi 2.1 e 2.2, sui misteri eleusini, dionisiaci e l'orfismo, e il capitolo 7 sulla teoria dei misteri in generale. 18 Angelo Brelich, I Greci e gli Dei, Napoli, Liguori, 1985, pp. 129-135.

Il metodo storico-comparativo nella scuola italiana di storia delle religioni
6
riemergente nella storia delle religioni. Si è creduto cioè, e alcuni credono ancora oggi, che l'obbiettivo dello storico delle religioni fosse quello di trovare nelle forme religiose «evolute» residui primitivi, «totemici», «animistici» o «magici», a seconda di quello che le varie scuole concepissero come la fase più primitiva dell'evoluzione religiosa (un errore in cui è caduto anche Durkheim quando ha posto come esempio di qualsiasi religione il totemismo inteso come forma religiosa più arcaica).Una storia delle religioni così intesa si trasforma in una archeologia attenta unicamente alla ricerca di fossili, invece di mantenere l'attenzione a quel processo creativo e formativo di nuovi concetti e idee religiose.
Ma in sede metodologica fortunatamente l'evoluzionismo è sorpassato e così anche i concetti di «primitivo» e «superiore» non sottintendono più un giudizio di valore implicito (come se i primitivi fossero a uno stadio preistorico di una presunta evoluzione umana, rimanendo al di fuori della storia), ma solo un senso convenzionale, denotando due tipi di civiltà: uno che ignora la scrittura, certe tecniche agricole, una specializzazione spinta, le abitazioni in materiale duraturo, ecc., e l'altro indicando per l'appunto la cosiddetta «civiltà superiore»19. Tra l'altro, anche per quanto riguarda quei fossili, non si tratta semplicemente di pure sopravvivenze perché, come spesso ripeteva Malinowski, niente sopravvive che non trovi una funzione nuova. Se sopra il mobile di una bella casa sta un grammofono, esso è lì non per suonare i dischi, ma in quanto oggetto di antiquariato. È quindi molto utile esaminare - e ciò è possibile solo grazie alla comparazione - quali retaggi primitivi vengono reinterpretati, funzionando così come trampolino di lancio per nuove idee e istituzioni religiose: anche grazie a questo si comprende la specificità di ogni religione. In questa capacità sta la superiorità della comparazione storica rispetto ad altri metodi comparativi come quello dell'evoluzionismo e quello della fenomenologia: solo grazie al metodo storico-comparativo si può cogliere l'originalità di ciascuna religione, attraverso la comprensione del meccanismo interno alla creazione religiosa.
In conclusione ai suoi «Prolegomeni a una storia delle religioni», Angelo Brelich scrive: «Non è un male che lo storico delle religioni limiti il proprio ambito di ricerca a una sola religione, quella di cui è in grado di conoscere bene l'ambiente culturale, dal punto di vista filologico, archeologico, ecc. Ma quel che è importante è che egli studi una data religione come storico delle religioni e non come storico della civiltà corrispondente; che la sua problematica e il suo metodo siano quelli della storia delle religioni; metodo, abbiamo visto, essenzialmente comparativo, anche se nella comparazione ogni studioso deve affidarsi alle ricerche dei suoi colleghi specializzati in altri settori storici e filologici, ma ugualmente storici delle religioni. Attualmente non siamo ancora a questo punto! Lo studio delle singole religioni si effettua essenzialmente nel quadro dello studio delle singole civiltà».
3. La necessità di una ricerca aperta Raffaele Pettazzoni non credeva che il valore e il significato della religione potessero venire
offuscati a causa del metodo suo e della scuola italiana che a lui si ispira. «La cultura storico-religiosa non solo non contrasta agli interessi della religione, ma li serve»20. Per lui opzione laica non equivaleva a dire ateismo, il suo era un pensiero «che per essere laico non ha bisogno di essere anti-religioso, e nemmeno a-religioso»21. Ma nei suoi ultimi appunti dice anche che «in fondo è sempre l'uomo che crea il suo mondo ideale... è l'uomo... che crea il suo creatore». L'interesse di Pettazzoni nello studio delle religione era, come scrive de Martino, «ricostruire le condizioni esistenziali, le condizioni sociali, le condizioni storiche, per le quali in fondo l'uomo aveva in queste condizioni
19 A. Brelich, Prolegomeni a una storia delle relgioni, in Puech (a cura di), Religione e storia delle religioni, Bari, Laterza, 1988, pp. 40-41. 20 Religione e cultura, p. 171, in RS, cit.. 21 Socialismo e cultura storico-religiosa, p. 176, in RS.

Il metodo storico-comparativo nella scuola italiana di storia delle religioni
7
spaziato nel campo della evasione, ma per tornare, per rendere più tollerabile... il soggiorno terreno. ...La vita religiosa per Pettazzoni doveva essere rimessa in piedi... cioè doveva essere ricostruita la genesi del bisogno religioso nel concreto condizionamento sociale, come prodotto culturale umano... senza lasciare nessun margine a interventi divini... ciò che è compito dello storico è compito essenzialmente, esclusivamente di trovare le ragioni umane delle religioni»22.
Ora, però, è da chiedersi se queste esigenze, tipiche della scuola italiana, siano conciliabili con il rispetto - dichiarato da Pettazzoni - per quello che si potrebbe chiamare il «significato religioso della religione».
Consideriamo per esempio un autore come l'appena citato Ernesto de Martino. Criticando la fenomenologia della religione scrive che ciò che è proprio di una attenta ricerca storiografica e che costituisce invece l'errore dei fenomenologi in campo storico-religioso è «l'esigenza di non ripetere, nell'atto del capire, la limitazione della coscienza che forma oggetto di comprensione»23. L'irrazionalismo pone come fondamento dell'esperienza religiosa il rapporto con il numinoso, ma questa posizione può essere, continua de Martino, quella del credente, mentre ponendola come fondamento per la storia delle religioni si confonderebbero «scienza storica della vita religiosa e vita religiosa in atto». L'esigenza di de Martino - ma si potrebbe dire della maggior parte degli storici delle religioni italiani - è quella di eliminare qualsiasi commistione tra la metodologia e il suo oggetto.
Da un certo punto di vista questo presupposto è importante ed essenziale se non si vuol fare della storia delle religioni una sorta di apologia o una teologia delle religioni. D'altra parte scopriamo però che quel «laicismo» da cui eravamo partiti e che spesso è sbandierato come prova di correttezza e massima espressione di liberalismo culturale, non è poi così spesso esempio di rispetto di tutte le posizioni (quindi anche di quelle religiose), velando dietro questa bella parola democratica quella, forse più antipatica e troppo di parte (come lo è certamente anche il suo opposto) di «ateismo» o «pensiero anti-religioso». Del resto, anche questa posizione, che non sarebbe azzardato definire ideologica, è abbastanza esplicita nei lavori dei nostri studiosi: «conoscenza storica delle religioni significa risolvere senza residuo in ragioni umane ciò che nell'esperienza religiosa in atto apparvero ragioni numinose. [...] Con ciò la storia delle religioni entra in un non componibile dissidio con la teologia, fondata invece sull'opposta persuasione che all'inizio del processo ierogenetico non sia l'uomo storico, ma Dio»24. Naturalmente de Martino con «teologia» non voleva intendere semplicemente ciò che significa strettamente questa parola di stampo tipicamente cristiano, bensì quel che prima chiamammo il «significato religioso della religione».
Nella prospettiva tratteggiata sono orientate le ricerche di autori come Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich, Dario Sabbatucci, Vittorio Lanternari, Ernesto de Martino, Alfonso M. di Nola, Carlo Tullio- Altan, i quali, insieme ad altri, costituiscono la scuola italiana di storia delle religioni e antropologia religiosa25.
Ora, il problema non è optare per una posizione religiosa o una anti-religiosa, ovviamente. Bisogna però cercare di non cadere in quello stesso errore che si imputa all'irrazionalismo e alla fenomenologia. Queste correnti partono da presupposti i quali, se non si possono dire di tipo confessionale (teologici, cioè), sono comunque vagamente spirituali. Nulla contro questa scelta, se vuole mirare a fini altrettanto spirituali e non storico-religiosi; infatti in sede storiografica non si può ammettere ciò che non è provato 22 Commemorazione di Raffaele Pettazzoni di E. de Martino, p. 88, in Raffaele Pettazzoni e.., cit. 23 Ernesto de Martino, Storia e metastoria. I fondamenti di una teoria del sacro, Lecce, Argo, 1995, p. 73. 24 Ibidem, p. 76. Il corsivo è nostro. 25 Lo specialista forse si stupirà di trovare citati insieme autori così diversi tra loro, appartenenti, in certi casi, a discipline non propriamente storico-religiose. Gliene diamo atto. Il nostro scopo è semplicemente quello di sottolineare come una certa interpretazione culturale delle religioni sia stata, ed è di fatto, condivisa tra tanti (forse i più) studiosi italiani.

Il metodo storico-comparativo nella scuola italiana di storia delle religioni
8
storicamente essendo la storia l'inizio, l'oggetto e il limite di una ricerca metodologicamente fondata: «lo storico... cerca, ed esclusivamente, le ragioni storiche, cioè umane, di ogni formazione culturale (e perciò anche religiosa) e abdicherebbe al suo mestiere nel momento stesso in cui ammettesse la sola possibilità di un intervento di fattori sovraumani nella storia»26. Si tratta dunque di costruire una metodologia spoglia di inquinamenti ideologici, privi di possibilità di verificazioni storiografiche. Se è vero che non si può basare una storia delle religioni sulla presunta verità di qualsivoglia rivelazione sovraumana, è nella stessa misura pregiudizievole il ritenere che il «fenomeno religione» sia un puro manufatto umano; pregiudizievole in quanto assunto come assioma fondante un certo tipo di metodo d'indagine, e quindi per definizione indimostrabile oggettivamente.
Eppure ogni disciplina, ogni studio, ogni posizione si basa su principi primi al di là dei quali non possiamo indagare, i quali sono condivisi da tutti o che comunque sembrano i meno azzardati, ma in ogni modo indimostrabili scientificamente. In altre parole, da qualcosa bisognerà pure iniziare: allora cominciamo ad optare per uno storicismo. Perché? La giustificazione la trovo già nella mia scelta: come dice Brelich, questa è la posizione consona allo storico, il quale, avendo scelto così, attribuisce alla sua scelta un valore storico, e quindi «nello stesso poter scegliere trovo la giustificazione della mia posizione: non tutto è determinato da sempre, se io posso ancora scegliere»27. Ma parallelamente bisogna stare attenti a non confondere questa opzione (che realmente sembra la migliore in quanto a oggettività) con un credo.
La storia delle religioni deve rimanere «aperta». Ugo Bianchi28 ci insegnava quanto fosse sbagliato dare una definizione univoca e, come tutte le definizioni, chiusa, al termine «religione»: si tratta invece di avvicinarcisi, come ad un asintoto che mai verrà toccato, attraverso la ricerca in fieri. Sembrerebbe una contraddizione: come cercare ciò che non si sa definire? Ma sbaglia chi confonde un metodo di studio con una sorta di asettico e matematico diagramma di flusso. Conosciamo tante realtà senza che le si sappia definire rigorosamente in relazione a noi stessi: ugualmente accade per i fenomeni religiosi. Anche non avendone una precisa definizione, sappiamo sempre distinguerli. Questa intuizione bisogna valorizzarla in tutta la metodologia storico-religiosa, non solo nel problema di definizione di ciò che è religione. Karl Popper è stato un maestro nell'indicare il pericolo di una disciplina chiusa in sé che fagociti qualsiasi oggetto che le si presenti all'interno del suo sistema in cui non è possibile trovare contraddizione. Egli aveva in mente soprattutto la psicanalisi di Freud e la filosofia della storia marxista. In queste teorie, qualsiasi fenomeno troverà sempre una sua collocazione e gli verrà accollato un significato che risulterà funzionale al sistema che lo ingloba. Ma come si può parlare in questo caso di ricerca, di progresso di comprensione? Diversamente da quello che si potrebbe credere superficialmente, è necessario un metodo che lasci spazio a possibili contraddizioni, quindi a continui miglioramenti, affinamenti e anche espunzioni delle leggi che lo governano.
Bisogna che lo storico delle religioni basi le sue ricerche esclusivamente sui dati che gli dà in mano la storia (con i suoi documenti, i reperti archeologici, le opere d'arte, ...), ma si deve cercare di rimanere lontani non dal tentativo di interpretazione di questi o addirittura di formulazione di una teoria generale (che, sempre e comunque, trascende la storia stessa), bensì dall'errore di ritenere la teoria con priorità ontologicamente superiore ai fatti, considerando così il suo lavoro non altro che trovare una giusta collocazione di questi nel suo sistema. 26 A. Brelich, Perchè storicismo e quale storicismo (nei nostri studi)?, p. 10, in «Religione e civiltà», 1. 1978. 27 "Perchè storicismo....", p. 13. 28 Vedi ad es. Problemi di storia delle religioni, Roma, Studium, 1986² e Saggi di metodologia della storia delle religioni, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1991. Bianchi riesce a superare tanti nodi e problemi che erano e sono presenti in molti storici delle religioni italiani. Purtroppo non abbiamo lo spazio per soffermarci su questo grande autore (che meriterebbe forse un lavoro a parte), ma ci preme sottolineare che nel panorama italiano la sua metodologia è fra le più puntuali ed equilibrate.

Il metodo storico-comparativo nella scuola italiana di storia delle religioni
9
Come esempio di teoria che non si fa guidare dai fatti consideriamo la teoria sul magismo di Ernesto de Martino (il quale sembra considerato, negli studi di interpretazione dei poteri magici, una sorta di santone): per lui il dramma del mondo magico è inseribile nella dialettica del rischio e del riscatto. La presenza non sarebbe un dato eternamente posseduto dall'umanità, ma una formazione storica consolidata in Occidente e non ontologicamente garantita una volta per tutte. La persona magica allora si difende dal rischio «della dissoluzione coinomica nella natura mediante una serie di tecniche che hanno il compito di cosmicizzare il caos e di trattenere la "presenza" al mondo secondo un orizzonte simbolico operativo già pienamente definibile come culturale»29.
Ma se applichiamo questa teoria alla magia di oggi, il sistema non regge più. La magia è veramente «la scienza del concreto» (M. Mauss): la gente va dal mago perché soffre, perché ha un problema, perché cerca l'amante... . Se entra in gruppi esoterici è perché cerca potere, ricchezza, una vita brillante. La demartiniana «destorificazione del divenire» non compare nelle esigenze del magismo odierno (o anche in quello rinascimentale, medioevale e greco-romano). Il problema non è più (o forse non lo è mai stato) la crisi della presenza, ma la realizzazione dei sogni e delle aspirazioni30.
Scopriamo quindi che l'aspetto per cui spesso de Martino affascina studiosi di discipline diverse, come la filosofia, la storia delle religioni e l'antropologia, cioè le sue precomprensioni heideggeriane fondative del suo metodo, è forse anche il suo tallone d'Achille.
E nello stesso errore, anche se sotto diverse spoglie, cadono tante filosofie della religione, che «trascurando di accostarsi allo studio dei fatti con la necessaria mediazione della storia delle religioni e della fenomenologia da questa nascente, [intendessero] subordinare queste ultime alla cosiddetta "precomprensione" e, criticando l'"oggettività" del "fatto", [rivendicassero] a se [stesse] la questione dell'"ermeneutica" e del "significato"»31.
BIBLIOGRAFIA: oltre al materiale bibliografico citato nelle note, si vogliono segnalare: - Raffaele Pettazzoni, Essays on the History of Religions, Leiden, Brill, 1954. - Angelo Brelich, Introduzione alla storia delle religioni, Roma, Ateneo, 1966. - Ugo Bianchi, La storia delle religioni, introduzione alla «Storia delle religioni» fondata da P.
Tacchi-Venturi e diretta da G. Castellani, 6 ed., vol. I., pp 1-171, 1971. - Dario Sabbatucci, La prospettiva storico-religiosa, Bari, Laterza, 1990. - Vittorio Lanternari, Antropologia religiosa, Bari, Dedalo, 1997.
29 P. Chierchi, Il signore del limite, Napoli, Liguori, 1994, p. 47; ma vedi soprattutto, ovviamente, del nostro autore, Il mondo magico, Torino, Bollati Boringhieri, 1973 e Crisi della presenza e reintegrazione religiosa, in «Aut Aut» (Gennaio 1956). Anche M. Franchi, Identità e confini. Ernesto de Martino: costruzione del soggetto e cultura, Ravenna, Essegi, 1988, pp. 19-22; 76-81; 121-124. 30 Vedi il cap. XIV: Evola e de Martino, ovvero "la congiunzione degli opposti" in Cecilia Gatto Trocchi, Il Risorgimento esoterico, Milano, Mondadori, 1996. 31 Ugo Bianchi, Saggi di metodologia..., cit., p.88.