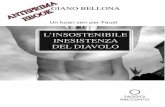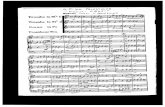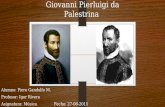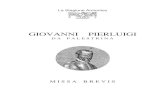Il Diavolo a Palestrina
-
Upload
lucio-damelia -
Category
Documents
-
view
78 -
download
0
description
Transcript of Il Diavolo a Palestrina
-
Giovanni Melosi
IL DIAVOLO A PALESTRINADella ricezione italiana del Doctor Faustus di Thomas Mann
Hieronymus Bosch, Linferno musicale, particolare de Il giardino delle delizie, 1480-1490 ca.
-
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICACorso di Laurea Triennale in Lettere
ELABORATO FINALE
Il Diavolo a PalestrinaDella ricezione italiana del Doctor Faustus di Thomas Mann
CANDIDATO RELATORE Giovanni Melosi Chiar.mo Prof. Luca Crescenzi
ANNO ACCADEMICO 2012/2013
-
INDICE
- Was ist das? I-VIII
- Capitolo I: Prima del Doctor Faustus I.1 LItalia in Mann 1
I.2 Mann in Italia 12
- Capitolo II: Doctor Faustus II.1 Un romanzo complesso 23
II.2 La prima ricezione in Italia (1947-1955) 41
- Capitolo III: Il Doctor Faustus dopo la morte del suo autore III.1 Dallanno della morte al centenario della nascita (1955-1975) 89
III.2 Sviluppi (pi o meno) recenti della critica 176
- Bibliografia 274
- Ringraziamenti 277
-
WAS IST DAS?
Che cos?... Che... cos?... sono le prime, incerte parole pronunciate dalla
piccola Antonie Buddenbrook nel romanzo che rese celebre Thomas Mann e che gli
valse, diversi anni dopo, il premio Nobel, assegnatogli a Stoccolma il 10 dicembre del
1929. La formula che apre I Buddenbrook, ripetendosi, nel corso del racconto, per ben
ventidue volte, non soltanto un esempio del tipico utilizzo manniano del Leitmotiv;
lo scrittore la mutua infatti dal Piccolo catechismo di Martin Lutero, dove essa viene
utilizzata a mo di apertura per introdurre le successive spiegazioni ai Dieci
comandamenti, ai tre articoli del Credo e al Padre Nostro1. In sostanza come se
Lutero si immaginasse le domande dei piccoli bambini tedeschi, le prevenisse
esordendo con esse, e infine vi rispondesse. Noi abbiamo deciso di fare lo stesso, ma
in altro senso, cambiando per cos dire campo e prospettiva, passando da quella
religiosa allaltra, pi consona ai nostri studi, critico-letteraria. Che cos, dunque,
questo elaborato? potremmo dire a questo punto, e la domanda sarebbe completa.
Ebbene, la tesi che seguir a questa breve introduzione intende essere uno studio
riguardo alla ricezione critica italiana di uno dei romanzi pi importanti e conosciuti di
Thomas Mann; con ci non alludiamo, come potrebbe venir fatto di pensare, ai
sopracitati Buddenbrook, bens al Doctor Faustus, il libro della fine, il romanzo-
saggio che lo scrittore tedesco compose negli Stati Uniti durante gli anni della seconda
guerra mondiale e pubblic, sempre a Stoccolma, nellottobre del 1947.
Fatta questa precisazione, non ci stupiremmo affatto se ci venisse posto un altro
interrogativo, vale a dire il seguente: perch proprio il Doctor Faustus? La risposta,
anche in questo caso, abbastanza semplice. Il Faustus va infatti considerato, il
romanzo pi significativo scritto da Mann, cos come Adrian Leverkhn, che ne
protagonista, , fra tutti i personaggi ideati dallo scrittore tedesco, quello cui lautore
per sua stessa ammissione rimarr in assoluto pi legato. Ci significativo, poich
testimonia quanto questopera intensamente sofferta, fortemente pessimista (ma non,
lo vedremo, in tutto e per tutto), e a suo modo modernissima, fosse importante prima
I
1 Cfr. Luca Crescenzi, Notizie sui testi e note di commento. I Buddenbrook, nota 1, in Thomas Mann, Romanzi (vol. 1), Mondadori, collana i Meridiani 2007 (pag. 1269).
-
di tutto per lo stesso Mann, il quale, considerandola come una sorta di voluminoso
epilogo della sua lunga e prolifica carriera di scrittore, ne fece un vero e proprio
testamento poetico, una confessione, se si preferisce, recuperando per essa i temi pi
cari dellintera sua produzione letteraria, ribadendo alcune sue linee di pensiero,
ritrattandone altre, tentando, al tempo stesso, di fornire una propria chiave di lettura ai
terribili eventi che avevano scosso il mondo negli anni immediatamente precedenti,
eventi che lo riguardavano da vicino in quanto scrittore tedesco per antonomasia:
dovera lui, l infatti andava cercata la vera Germania. Perci il Doctor Faustus va
inteso innanzitutto come imponente affresco della Germania stessa, nonch del suo
popolo, un popolo dannato e degenere da cui Mann, al pari del deuteragonista del suo
romanzo, il narratore Serenus Zeitblom, si affretta a prendere le distanze, rimanendovi
tuttavia intimamente legato. Non solo: la proficua collaborazione col filosofo-
musicologo della scuola di Francoforte Theodor Wiesengrund-Adorno, anche lui
esiliato e residente in California, permette allo scrittore tedesco di affrontare, sempre
allinterno del Faustus, la vexata questio relativa allarte moderna, al problema
dellespressione, alla crisi del linguaggio e delle forme tradizionali. Ecco perch il
Doctor Faustus: perch in esso confluiscono temi storici, sociologici, psicoanalitici e
artistici, la Germania, il nazismo, Nietzsche, Schnberg e la dodecafonia, Dio e il
Diavolo, il bene e il male, in una parola: luomo, con tutta la sua irriducibile e atavica
complessit.
naturale che unopera di tale eterogeneit comporti reazioni eterogenee,
interpretazioni diverse e spesso in contrasto fra di loro, giudizi che spaziano dal pi
favorevole al meno lusinghiero. Un grande romanzo anche questo, o, per meglio
dire, un romanzo per essere veramente grande deve sapersi prestare a sempre nuove
chiavi di lettura, fornendo spunti inediti proprio quando si credeva di averli esauriti
tutti. Il Faustus, come vedremo, si dimostrato capace di tutto ci, instaurando una
sorta di dialogo ininterrotto con i tantissimi critici che, dopo averlo letto, sentirono il
bisogno di esprimere il loro personale parere su di esso. Obiettivo del nostro lavoro
mettere in luce proprio tale processo cos tipico di molti classici della letteratura, di
quelli, almeno, che si dimostrano capaci di evolversi nel tempo, che possiedono la
Introduzione
II
-
miracolosa facolt di attualizzarsi, riflessa, questultima, nella diversa percezione che
ne hanno i lettori di periodi storici differenti. Ma visto che non ci pareva il caso di
cominciare lanalisi cos, ex abrupto - partendo cio dal 1947 -, e visto che, per nostra
sfortuna, il Faustus rappresenta una delle ultime tappe della carriera del lubecchese,
abbiamo preferito esordire con un capitolo che potremmo definire introduttivo. Anche
perch, come accennato di sfuggita poco sopra, il panorama critico che prenderemo in
considerazione solamente quello italiano, dove lutilizzo che abbiamo appena fatto
del termine solamente davvero non rende giustizia alla quantit e qualit dei
contributi saggistici stilati dai vari studiosi italiani.
In Prima del Doctor Faustus cercheremo perci di svelare i legami intercorsi tra
Mann e lItalia nei decenni precedenti luscita del romanzo faustiano, acch il lettore
possa grosso modo comprendere quale fosse il rapporto fra lo scrittore tedesco e il
nostro Paese. Nel primo dei due paragrafi, LItalia in Mann, tratteremo di vicende,
luoghi e personaggi italiani presenti nelle opere maggiori e minori di Thomas Mann, e
vedremo brevemente quale idea avesse il lubecchese del nostro popolo e della nostra
terra. Nel secondo paragrafo, Mann in Italia, opereremo il processo inverso,
occupandoci della prima ricezione manniana in Italia e soffermandoci, sempre
brevemente, sui contributi pi importanti (per esempio il saggio di Mittner del 1936),
sui pi discussi e controversi (alludiamo soprattutto alle polemiche sorte intorno a
Mario e il mago e alla strumentalizzazione che la propaganda fascista fece della
novella Sangue velsungo), o ancora su personalit alquanto significative come Lavinia
Mazzucchetti e Benedetto Croce, veri e propri mediatori culturali e divulgatori
quantomai preziosi delle opere del nostro.
Arriveremo cos al secondo capitolo della presente trattazione, cui abbiamo dato il
sobrio titolo Doctor Faustus. Anchesso al pari del precedente suddiviso in due
paragrafi: in II.1, Un romanzo complesso, diremo la nostra su alcuni temi che ci sono
parsi particolarmente importanti per una corretta analisi del romanzo, pronunciandoci
sui personaggi principali della vicenda, sulla particolare tecnica compositiva utilizzata
da Mann (la cosiddetta tecnica del montaggio), sugli imprestiti autobiografici e su
quelli derivati da altre opere letterarie, fossero esse al momento della stesura gi
Introduzione
III
-
consacrate dalla storia, o al contrario ancora da pubblicare (e qui il pensiero va alla
Filosofia della musica moderna di Adorno). Per una pi ampia comprensione dei
nostri intenti riguardo al suddetto paragrafo rimandiamo alla nota a pi di pagina 44,
che il lettore trover posta proprio in coincidenza del titolo del paragrafo stesso. Con il
successivo e ultimo paragrafo, La prima ricezione in Italia (1947-1955), avr invece
inizio il vero e proprio lavoro di ricapitolazione dei contributi critici pubblicati in Italia
nellarco di tempo preso in considerazione, che in questo caso ha come estremi da una
parte la pubblicazione del romanzo grazie alla edizione della Mondadori del 49,
dallaltra lanno della morte di Mann, avvenuta il 12 agosto 1955 a Zurigo. Oltre agli
scritti della Mazzucchetti e agli articoli di Vincenti e Cecchi usciti rispettivamente su
La Nuova Stampa e il Corriere della Sera, ci soffermeremo sui diversi saggi, pi o
meno estesi, di Cambon, Fortini, Caracciolo, Actis Perinetti, Chiarini e Devescovi. A
questultimo in particolare verr dedicato ampio spazio, poich il volume da lui
composto, Il Doktor Faustus di Thomas Mann. Problemi e considerazioni (1955),
risulta essere uno dei pi corposi (per la precisione il secondo) totalmente incentrati
sul romanzo da noi preso in considerazione. Un altro scritto significativo senza
dubbio quello di Fortini, critico la cui voce pu essere a ragione definita fuori dal
coro; nel breve saggio Il Doctor Faustus di Thomas Mann pubblicato sul numero
di marzo-aprile 1950 della rivista Comunit, egli infatti non lesina di certo critiche
nei confronti sia del romanzo, sia di chi il romanzo ha scritto. Giunti a questo punto
non ci pare superfluo avvertire fin da subito il lettore che le nostre analisi non saranno
propriamente oggettive, bens soggettive, nel senso che, riportando il pensiero dei vari
studiosi, esprimeremo via via il nostro giudizio personale, in quello che pu essere
considerato come un dialogo immaginario non pi a due, ma a tre elementi, allinterno
di una sorta di triangolo che ha come vertici il libro stesso, il critico di volta in volta
preso in considerazione e infine noi, che tentiamo di rispondere a tale critico
chiamando in causa il romanzo. un gioco pi complesso a spiegarsi che non a
capirsi. Comunque sia, da questo punto in poi che lestensione dei paragrafi della
nostra tesi subir un processo di dilatazione abbastanza sostanzioso ed evidente.
Introduzione
IV
-
Con lanalisi di Devescovi e la morte dello scrittore terminer il secondo capitolo,
cui naturalmente seguir il terzo, cio lultimo, Il Doctor Faustus dopo la morte del
suo autore. Per amor di simmetria anchesso sar diviso in due paragrafi, dei quali il
primo prosegue lanalisi dei contributi saggistici nel periodo che va - come suggerito
dal titolo - Dallanno della morte al centenario della nascita (1955-1975) dello
scrittore, coprendo cos un ventennio davvero fervido e denso di scritti sul Faustus; il
secondo, Sviluppi (pi o meno) recenti della critica, far riferimento al restante lasso
di tempo che principia nel 1976 e perdura fino ai giorni nostri, senza peraltro potersi
considerare concluso. In III.1 troveranno spazio i lavori di Papi, Tecchi, Mittner,
Cases, Traverso, Checconi, Fornasarig, Tiburzio, Asor-Rosa, Jesi, Perlini, Ferretti e
Oberti. Quale sia a nostro parere il pi importante fra di essi? Cos su due piedi non
sapremmo davvero che cosa rispondere, poich quasi tutti, a loro modo, possiedono
una qualche particolarit che li rende degni di nota. Ci che pu essere detto senza
troppe ambagi che, rispetto ad esempio al vulcanico saggio di Devescovi, si nota col
passare del tempo il profilarsi di un certo distacco emotivo nei confronti del romanzo
oggetto di analisi, distacco ovviamente inteso soprattutto in senso positivo, come spia
cio di un ritrovato rigore critico e analitico. Questo discorso per non pu essere
esteso a tutti gli interventi (quello di Jesi ad esempio risulta a tratti un po
impalpabile), ma riscontrabile in modo abbastanza evidente nelle approfondite
analisi dei vari Fornasarig, Tiburzio e Ferretti (rispettivamente del 1968, 1969 e 1975).
Molto importante poi la lettura del Faustus da parte di Asor-Rosa, che nel suo saggio
del 71 sottolinea lambiguit del romanzo ed esorta il lettore a prediligere il
problematicismo delle opere di Mann, anzich sforzarsi nella ricerca a tutti i costi di
una sintesi fra tendenze opposte che risulterebbe necessariamente posticcia e affettata.
Un caso particolare poi quello di Perlini (1973), il quale nella prima parte del suo
scritto espone in maniera convincente ed efficace molti dei temi principali del
racconto, ma poi, giunto alla fine, esprime dei giudizi critici a nostro avviso poco
condivisibili (giudizi che, come diremo a suo tempo, sembrano quasi scritti da unaltra
persona). Ma, si direbbe, ogni paragrafo deve necessariamente avere almeno un Fortini
che funga da vero detrattore dellopera, cos da riportare in prossimit dello zero la
Introduzione
V
-
somma totale dei pareri positivi e negativi riguardanti il Faustus. Tale ruolo spetta in
questo caso soprattutto a Ladislao Mittner, lo stesso Mittner che nel 36 ebbe il merito
di scrivere la prima, importante monografia sullo scrittore tedesco; peccato che gli
accenni al Doctor Faustus contenuti nei due capitoli del suo volume del 1960 La
letteratura tedesca del Novecento e altri saggi dimostrino una superficialit di analisi
che stupisce in un critico di tale levatura. Il penultimo paragrafo terminer infine con il
breve articolo della Ferretti, che lascer per cos dire campo aperto allultimo
paragrafo, il III.2. In esso il lettore potr trovare un sunto degli importanti scritti di
Porena, Becagli, Schiavoni, Manzoni, Magris, Cases, Isotta e Chiusano, tutti anteriori
al 1985; poi, con un salto temporale che tenteremo di giustificare e rendere meno
brusco attraverso una metafora fluviale che potr apparire a chi ci sta leggendo pi o
meno convincente, balzeremo di colpo negli anni Duemila, soffermandoci sugli scritti
di Freschi, Sandrin, Pascal e Zurletti. Nel suddetto paragrafo notevoli sono
innanzitutto i contributi di Porena, Manzoni e Isotta, in primo luogo perch opera,
rispettivamente, di due compositori e di un musicologo. Nonostante lacutezza di certe
vedute di Porena, sono tuttavia le riflessioni sul Faustus contenute nel volume Il
ventriloquo di Dio di Paolo Isotta a catturare maggiormente la nostra attenzione; il
critico infatti, pur giungendo a conclusioni che spesso non approviamo (come quella
ad esempio che considera lopera di Leverkhn irrimediabilmente fascista), compie
unanalisi davvero sottile e accurata dei principali temi del romanzo, ponendo
laccento su alcuni aspetti precedentemente trascurati. Potremmo dire che anche Isotta
fa parte della schiera dei Fortini, perch il suo giudizio sul romanzo risulta essere nel
complesso negativo, ma va comunque riconosciuta al musicologo una capacit di
penetrare addentro alle problematiche dellopera di certo non comune a tutti i suoi
colleghi. Per quanto riguarda invece Manzoni, possiamo intendere la sua
interpretazione come parzialmente opposta a quella di Isotta: il compositore infatti
vede in Mann una sorta di inconsapevole e recalcitrante profeta del nuovo verbo della
musica davanguardia, poich scorge nelle teorie espresse da Leverkhn e in molte sue
composizioni delle vere e proprie anticipazioni di quel processo di razionalizzazione
del materiale musicale che avr luogo negli anni successivi alla pubblicazione del
Introduzione
VI
-
romanzo. La sua lettura del Faustus tende dunque a esaltare (forse in modo eccessivo)
quei pochi balenii di speranza che sono effettivamente presenti allinterno del
romanzo. Infine lultimo contributo che analizzeremo sar quello di Sara Zurletti. Le
dodici note del Diavolo, pubblicato nel 2011 dalla casa editrice Bibliopolis, un
saggio importante sotto vari aspetti. In primo luogo esso in assoluto il pi esteso
lavoro che sia stato scritto fino a questo momento sul Doctor Faustus, pi esteso pure
di quello, prima di allora insuperato, di Guido Devescovi. Inoltre anche la Zurletti
esperta di musica, il che significa che allinterno del suo saggio trovano ampio spazio
questioni legate ai vari temi musicali che informano il romanzo, prima fra tutte quella
relativa al rapporto fra Mann e Adorno e fra il Faustus e la gi citata Filosofia della
musica moderna. Tuttavia ci che attrae maggiormente la studiosa quella struttura
nascosta che a suo dire governerebbe lintera narrazione, una struttura alquanto
complessa, costituita da diversi livelli di realt, che non riguarderebbe soltanto il
romanzo, ma anche la Genesi del Doctor Faustus, il diario-racconto che Mann
pubblic nel 1949. Tale scritto, secondo la Zurletti, sarebbe nato dalla volont da parte
dellautore di chiarire una volta per tutte i legami tra se stesso e i due protagonisti del
romanzo (soprattutto Adrian), tra il libro e le composizioni di Leverkhn (in primo
luogo la Lamentatio Doctoris Fausti), tra la dodecafonia schnberghiana e quella,
traslata in campo letterario, utilizzata da Mann grazie allinnovativa tecnica del
montaggio. Le riflessioni della Zurletti, la quale prende le mosse dalle precedenti
analisi di altri studiosi italiani e stranieri (Isotta e Bergsten in primis), sono nel
complesso interessanti e convincenti, nonostante pecchino, forse, di un eccessivo
rigore geometrico. Se si considerano unaltra volta i due contributi pi voluminosi
incentrati sul Faustus, vale a dire questo e quello del 55 di Devescovi, si capir al
volo il discorso che facevamo poco sopra riguardo al mutare, col passare degli anni,
dellapproccio critico-analitico degli studiosi: laddove infatti il saggio di Devescovi
tutto incentrato sulla sostanza dellopera e sugli aspetti filosofici e simbolici, quello
della Zurletti opta al contrario per una dissezione quasi chirurgica della struttura
formale del romanzo, concedendo minore spazio ai contenuti propriamente detti.
Inoltre, se da una parte la studiosa esprime la sua ammirazione per labilit tecnica e
Introduzione
VII
-
costruttiva dello scrittore tedesco, daltra parte spesseggiano nel saggio giudizi
negativi riguardo alla riuscita artistica di numerosi episodi della trama, nonch dei
personaggi primari e secondari, che lesperta di musica ritiene nel complesso poco
credibili.
Una volta giunto al termine della sintesi riguardante lanalisi della Zurletti, il lettore
sar a un passo dalla conclusione del nostro lavoro. Non gli rester a quel punto che
leggere la breve conclusione, consultare la successiva bibliografia e soffermarsi per un
attimo, qualora lo volesse, sui ringraziamenti di rito posti in calce alla tesi. Dopodich
non trover pi pagine da voltare e potr pure richiudere il presente volume, non
possiamo di certo dire con quale espressione in volto, ma soltanto limitarci a sperare
che non sia delle pi contrariate.
Introduzione
VIII
-
CAPITOLO I: PRIMA DEL DOCTOR FAUSTUSSanto Dio, mi lasci in pace con lItalia Lisaweta! LItalia mi indifferente fino al disprezzo. passato molto tempo da quando pensavo che quella fosse la mia patria. Larte, non vero? Il cielo azzurro, come di velluto, il vino denso, la dolce sensualit... In poche parole: tutto questo non mi piace, ci rinuncio. Tutta questa famosa bellezza mi rende nervoso. E non posso nemmeno sopportare tutti quegli uomini spaventosamente vivaci con quello sguardo nero animalesco. Quei romani non hanno il minimo segno di coscienza negli occhi...Thomas Mann, Tonio Krger.
I.1 LItalia in Mann
Non occorre di certo essere esperti conoscitori dellopera omnia di Thomas Mann
per accorgersi in breve tempo del filo sottile ma continuo che lega il grande scrittore di
Lubecca allItalia. Pescando a caso fra i suoi numerosi romanzi e novelle, avremo
infatti buone probabilit di imbatterci in un qualche elemento che rimandi al Bel
Paese, consista esso in uno dei tanti personaggi usciti dalla sua fantasia o, pi
frequentemente, in uno scenario magistralmente evocato che faccia da sfondo alla
vicenda di volta in volta narrata. Ebbene, da dove nasce questo interesse da parte di
Mann, scrittore tedesco se mai ve ne furono, per lassolata e distante Italia?
Innanzitutto occorre sottolineare, come del resto si fatto spesso, una caratteristica
peculiare del processo creativo di Mann, ovvero il suo continuo attingere alla vita
vissuta in prima persona, alle esperienze quotidiane, in una parola alla propria
biografia. Anche questo caso non fa eccezione: per rispondere alla domanda dobbiamo
senzaltro rivolgerci alla storia dello scrittore, consapevoli che non ne rimarremo
delusi.
Thomas Mann mette piede per la prima volta in Italia nel 1895 per raggiungere il
fratello Heinrich e passare con lui lestate a Palestrina, al riparo dalle focose
temperature della capitale. Successivamente i due trascorreranno lunghi periodi nella
Penisola, soprattutto a Roma, con un duraturo soggiorno che avr come base un
appartamento in via di Torre Argentina 34. Thomas, dei due fratelli il minore,
allepoca un giovane ventenne inquieto e scontento di s che avverte, non senza una
certa apprensione, di non essere ancora riuscito a imboccare la strada che
1
-
maggiormente gli si addice. Egli ha un impiego a Monaco in una compagnia
assicurativa, ma lavora controvoglia e preferisce dedicarsi alla lettura quasi
compulsiva dei grandi classici della letteratura. Inoltre, nelle molte ore di inattivit che
il lavoro gli concede, si cimenta nella scrittura e compone i suoi primi racconti e
articoli di giornale. Gli studi universitari, anchessi iniziati a Monaco, vengono presto
interrotti. I viaggi in Italia che intraprender in quegli anni, in sostanza, pi che viaggi
verso lItalia risultano essere fughe dalla Germania e da quellambiente monacense
che lo rende inquieto e insoddisfatto. Non a caso lo stesso Mann parler pi volte di
esilio volontario, di ricercata lontananza, di benefico isolamento:
Passammo una lunga e cocente estate italiana a Palestrina [...]. Non avevamo nessuna relazione. Quando sentivamo parlare tedesco prendevamo la fuga. Consideravamo Roma un nascondiglio per la nostra irregolarit, e, quanto a me, ci venivo non per amore del Sud, che in fondo non amavo, ma soltanto perch in patria non cera ancora posto per me2.
Non amore del Sud dunque, ma puro e semplice escapismo, almeno a prima vista. E
in effetti I Buddenbrook (Buddenbrooks), prima grande prova3 delle proprie capacit
che lo scrittore tedesco forn al mondo letterario e non, sembra confermare questa
impressione. Iniziato a Roma nel 18974, il romanzo narra, come suggerito dal
sottotitolo, la lunga decadenza di una ricca famiglia alto-borghese di Lubecca, una
decadenza che si prolunga per quattro generazioni, attraversando di fatto gran parte del
XIX secolo. se non altro singolare, per non dire paradossale, che Mann abbia quasi
sentito il bisogno di distaccarsi dai luoghi e dalle persone della sua citt natale per
poterli poi descrivere e reinventare, si direbbe, da un punto dosservazione pi
tranquillo, pi libero, meno coinvolto. Non dobbiamo infatti dimenticare che la storia
della famiglia Buddenbrook legata a doppio filo a quella degli stessi Mann e che tutti
i personaggi presenti nel racconto riproducono pi o meno fedelmente membri della
LItalia in Mann
2
2 Citato in Marino Freschi, Thomas Mann, il Mulino 2005 (pag. 46).3 Si decide qui di partire da I Buddenbrook essendo questa la prima opera di grande impegno dello scrittore. Tuttavia val bene una nota a pi di pagina il ricordare tre racconti brevi composti da Mann nel biennio 1896-1897, i quali hanno come comune ambientazione lItalia. Alludiamo a Desiderio di felicit (1896), Delusione (1896) e Il pagliaccio (1897).4 Si riporta spesso, negli studi italiani dedicati a Mann, la data che apre la prima pagina del manoscritto del romanzo: Rom, Ende Oktober 1897.
-
famiglia e parenti stretti dello scrittore5, come dimostra anche la lunga e astiosa
polemica che segu la pubblicazione del romanzo. Sembra insomma che Mann,
scrivendo da quel Sud che avverte come profondamente estraneo a s e alla sua
Weltanschauung, riscopra come per contrasto la sua vera identit nordica. Eppure
quella sensualit, quella mollezza che tanto pareva infastidirlo non doveva essergli del
tutto estranea, se vero che in essa riconosceva leredit materna: la madre dei due
fratelli, infatti, si chiamava Jlia da Silva-Bruhns, era nata in Brasile nel 1851 e si era
trasferita a Lubecca dopo la morte del padre. Nel recente saggio di Marino Freschi si
legge che nel cuore della bellissima Jlia, nelle cui vene scorreva sangue creolo,
rimase il culto per i profumi, gli odori, i colori, la libert e la musica del Sud6.
Linfluenza che essa ebbe sui figli, soprattutto riguardo alla comune vocazione
letteraria, dovette essere decisiva e sempre presente alla coscienza di questi ultimi.
LItalia rappresenta dunque per Mann il Sud, con tutti i suoi pregi e ancor pi con
gli inevitabili difetti. Nel grande gioco di contrapposizioni che informa lintera
produzione artistica del Mago7 e che diventa fin da subito una delle sue caratteristiche
principali e immediatamente riconoscibili, lintero meridione, e con esso lItalia, si
trasforma in un simbolo geografico polarmente contrapposto al Nord, che invece
efficienza, rigore, disciplina. Ma questo Sud sar in un modo o nellaltro spesso
presente, probabilmente proprio perch la sopracitata tensione fra elementi opposti,
cos profondamente avvertita dal meticcio Mann, non sarebbe pi tale se uno di essi
venisse a mancare.
Il nostro lascer definitivamente Roma alla fine dellaprile del 1898, ma torner a
pi riprese in Italia per brevi periodi di vacanza insieme alla moglie Katja (al secolo
Katharina Pringsheim), conosciuta a Monaco nel salotto del padre, lillustre
matematico Alfred Pringsheim e successivamente sposata nel 1905. Da ogni viaggio,
come vedremo fra poco, lo scrittore trarr la materia viva di molti suoi racconti, quei
LItalia in Mann
3
5 Si pensi che nelle librerie di Lubecca veniva venduta, insieme al romanzo, una specie di legenda con i nomi dei personaggi decriptati. 6 Marino Freschi, Thomas Mann, il Mulino 2005 (pag.13).7 Zauberer era il soprannome che i figli di Mann dettero al padre.
-
dati effettuali che debbono poi essere trasfigurati e reinventati dal poeta. Ma andiamo
con ordine.
Nel 1903, a due anni dalluscita presso la casa editrice berlinese Fischer de I
Buddenbrook, Mann pubblica il racconto Tonio Krger, altro pezzo di bravura a
carattere fortemente autobiografico. Anche in questo caso infatti lo scrittore prende le
mosse da uno spunto realistico, un soggiorno in Danimarca nel 1899. Tonio,
esattamente come il suo doppio reale, un ragazzo irrequieto in perenne esitazione tra
un Nord e un Sud che non sono e non vogliono essere, lo abbiamo visto,
esclusivamente geografici. In questo caso per il baricentro si sposta, per cos dire,
verso lalto, cosicch a fare le veci del Sud troviamo, anzich Roma o una qualsiasi
localit italiana, quella Monaco dalla quale Mann era evaso pochi anni prima,
riparando poi a Roma. Il Nord invece rappresentato dalla gelida Danimarca, dove lo
scrittore soggiorn per un breve periodo. Eppure nella novella c spazio anche per
lItalia (in questo caso lestremo Sud), a partire proprio dallo strano nome del
protagonista, il quale in un colloquio con i suoi amici si affretta a precisare:
S, un nome stupido, io vorrei chiamarmi Heinrich o Wilhelm, potete credermi. Ma viene dal fatto che mi hanno battezzato col nome di un fratello di mia madre che si chiamava Antonio, perch mia madre straniera...8
Poi, allinizio del capitolo V, quando lo stesso protagonista comunica allamica
Lisaweta Iwanowna la sua imminente partenza e questultima pensa subito che la
destinazione scelta sia lItalia, egli le risponde piccato9 e perentoriamente conclude:
no, vado un po in Danimarca10. Seguendo le orme del suo creatore, Tonio alla fine
opta per il Nord, per lordine e per la norma, mentre lItalia sembra assumere sempre
pi i tratti di una metafora negativa, di ci che lo stesso Mann respinge ed esorcizza in
diversi suoi racconti giovanili.
Passano soltanto due anni e lItalia torna a far capolino nellunico componimento
teatrale uscito dalla penna dello scrittore di Lubecca: Fiorenza. Il dramma,
LItalia in Mann
4
8 Thomas Mann, La morte a Venezia - Tonio Krger - Tristano, Feltrinelli 2006 (pag. 76).9 Cfr. citazione a inizio capitolo.10 Thomas Mann, La morte a Venezia - Tonio Krger - Tristano, Feltrinelli 2006 (pag. 99).
-
rappresentato a Francoforte nel 1907, ambientato nella Firenze dei Medici e vede
come protagonisti Lorenzo de Medici e il suo intransigente oppositore, Girolamo
Savonarola. La Fiorenza del titolo altri non che lamante del Magnifico, vero pomo
della discordia in quanto amata in giovent dallo stesso Savonarola, il quale, dopo aver
ricevuto un netto rifiuto da parte della donna, sceglie per compensazione la vita
monacale, diventando cos il terrore dei patrizi dissoluti e degli artisti fiorentini. Si
tratta dunque di unaltra opera che vive di contrasti e contrapposizioni, ma resta
notevole e insolita la scelta dellambientazione, oltre che della forma narrativa, che di
fatto costituisce un unicum nella lunga e prolifica carriera del lubecchese.
Dobbiamo aspettare il maggio del 1911 perch Thomas, convinto dal fratello
Heinrich, faccia di nuovo ritorno in Italia, stavolta assieme alla moglie: sono queste le
fatidiche settimane trascorse al Lido di Venezia (precedute da una breve tappa presso
le isole Brioni, in Istria) che gli ispireranno il celeberrimo11 romanzo breve La morte a
Venezia (Der Tod in Venedig), scritto al ritorno in Germania e pubblicato lanno
successivo sulla Neue deutsche Rundshau, la rivista diretta dalleditore Samuel
Fischer. La novella, senza dubbio una delle pi italiane fra tutte quelle composte da
Mann, ha come protagonista lo scrittore tedesco Gustav von Aschenbach, figura
dartista austera e compassata, sempre soggetta a un tenace autocontrollo delle proprie
pulsioni. Dapprincipio Aschenbach decide di partire per un viaggio sulle coste della
Dalmazia, ma poi allimprovviso, come folgorato da unepifania, fa ci che non ha
mai fatto in vita sua: segue listinto e devia verso Venezia, pure subodorando in parte,
almeno a livello inconscio, limminente sciagura che lo colpir. Giunto col si
innamora perdutamente del giovane Tadzio, figlio di una distinta famiglia polacca
alloggiata anchessa allHotel des Bains. Per Gustav sar linizio della fine. La
passione pederasta per ladolescente far crollare una volta per tutte il suo fragile
equilibrio psichico, ponendolo di fronte ai pi reconditi e inconfessabili desideri della
sua anima. Alla fine morir sotto una maschera di cerone, in riva al mare, tendendo
pateticamente le braccia verso loggetto del suo amore impossibile. Laltro grande
protagonista della novella senza dubbio Venezia. La citt lagunare, in preda a
LItalia in Mann
5
11 Celeberrimo grazie anche alla trasposizione cinematografica che ne fece Luchino Visconti nel 1971.
-
unepidemia improvvisa di colera, non semplicemente lo sfondo passivo di questa
sorta di catabasi. Al contrario, leggendo il racconto si ha quasi limpressione che essa
partecipi attivamente alla vicenda, come se il destino del grande scrittore fosse
irrimediabilmente segnato fin dallinizio, diremmo quasi fin dalla nascita. E in effetti
Aschenbach avverte questa intima simpatia tra la sua situazione emotiva e il degrado
che regna nella decadente citt, la avverte e segretamente se ne compiace. La storia,
per un verso indecente e scandalosa, si sublima in uno stile di rara eleganza e
raffinatezza, un periodare classico che ben si conf alle grecizzanti elucubrazioni del
protagonista. Proprio riguardo a questultimo sappiamo che Mann si ispir in parte a
Gustav Mahler, il famoso compositore austriaco deceduto nello stesso 1911, ma ancora
una volta decisiva risulta essere la biografia dellautore: vera la scena iniziale del
gondoliere abusivo, vera quella del bagaglio disperso e dello spettacolo dei guitti
allhotel; veri, soprattutto, la famiglia polacca e lefebico fanciullo, che dovette turbare
non poco lo scrittore, a giudicare dalle sventure del suo doppio immaginario. Il breve
romanzo fece una certa impressione allepoca, cos come pure continua a farla ai nostri
giorni, nonostante il concetto stesso di impressionante (meglio ancora:
scandaloso) sia mutato e abbia ristretto di molto i suoi confini. A lungo ci si
interrogati sullomofilia di Mann e sui mezzi che lautore utilizz per frenarla e
controllarla, ma purtroppo non questo il luogo adatto per trattare la questione; il
dovere di essere brevi e concisi ci obbliga nostro malgrado a procedere oltre.
Del 1924 La montagna magica (Der Zauberberg), opera di grande impegno e
complessit a tuttoggi tra le pi lette e apprezzate. La vicenda, come noto, si svolge
interamente in un sanatorio di Davos sulle Alpi svizzere e ha come protagonista Hans
Castorp, un giovane uomo come tanti, seppur accattivante12. Mann in questo caso
prende spunto dal reale soggiorno che la moglie Katja, afflitta da uninfezione
polmonare causata dalle numerose gravidanze, fu costretta a intraprendere nel
sanatorio del dottor Jessen. Il fatto del 1912, dunque quando lautore si appresta alla
stesura del romanzo sono gi passati diversi anni. Mann per dimostra di non essersi
affatto dimenticato di quella particolare esperienza e decide cos di comporre una
LItalia in Mann
6
12 Thomas Mann, La montagna magica, Mondadori, collana I Meridiani 2010 (pag. 3).
-
novella sul tema della malattia che faccia pendant con quella veneziana. Quando per
comincia a scrivere, proprio come gli era capitato tempo prima con I Buddenbrook, la
storia stessa pare accrescersi enormemente sotto la sua penna, e quello che doveva
essere un breve romanzo si trasforma in una vasta opera che supera le mille pagine,
nonostante una trama estremamente parca di eventi e di significativi colpi di scena.
Hans Castorp, partito inizialmente per andare a trovare il cugino Joachim, giunge al
sanatorio Berghof e dopo poco tempo vi si perde, catturato e quasi ipnotizzato
dallatmosfera sospesa e fiabesca delle magiche montagne che lo attorniano. Anche il
viaggio, esattamente come il romanzo, avrebbe dovuto essere breve, ma ben presto il
nostro protagonista (e noi con lui) perde totalmente la cognizione del tempo. Giorni,
mesi, anni, tutto si relativizza per Hans Castorp e quella che doveva essere unascesa
verso le cime aguzze dei monti si trasforma paradossalmente nellennesima descensus
ad inferos manniana. Egli si aggira spettrale per il sanatorio, conosce e conversa con i
malati che vi dimorano, tutti rappresentanti dellalta societ europea, esponenti di un
ceto in netto declino, relitti, fantasmi, eppure in un certo senso eletti in quanto malati e
dunque diversi da coloro che vivono in pianura, i cosiddetti normali, i sani. Fra questi
personaggi attira la nostra partigiana attenzione litaliano Lodovico Settembrini,
massone, ottimista, progressista, carducciano, il quale per buona parte del romanzo
ingaggia unaccanita lotta con il suo acerrimo rivale, il gesuita comunista Naphta. I
due educatori si contenderanno a lungo lanima ancora tutta da plasmare del giovane
Castorp, in un duello che terminer tragicamente con il suicidio del nichilista Naphta.
La figura di Settembrini, che in questa sede quella che pi ci interessa, pare ispirarsi
al Mazzini tratteggiato dallautore stesso in un passo delle Considerazioni di
unimpolitico (Betrachtungen eines Unpolitischen), il saggio del 1918 che caus
vastissime polemiche e che, come vedremo, svolger un ruolo fondamentale nella
diffusione di Mann in Italia:
Trovo in Mazzini, allo stato puro e nel suo rigoglio, il massone latino, il democratico, il letterato della rivoluzione, il retore del progresso; da lui imparo a considerare lo spirito come
LItalia in Mann
7
-
qualcosa di mezzo fra il Grande Oriente e il club giacobino, giusto come oggi, riabilitata ormai la virt, vuole e deve essere nuovamente considerato13.
Quella polemica su Mazzini era in parte rivolta anche al fratello Heinrich, il
democratico, leuropeista che, secondo la concezione di Thomas, tradiva in un certo
senso lessenza della vera Kultur tedesca. Con gli anni le idee politiche di Mann
cambieranno, egli smusser le sue punte pi velenose passando di fatto sempre pi a
sinistra, soprattutto per linfluenza che ebbero su di lui i figli Erika e Klaus. Ma gi
nella Montagna magica la figura di Settembrini ha perso molta della negativit che ci
si sarebbe potuti aspettare, risultando anzi sovente comica e affatto simpatica. Su di
essa non pare pesare la condanna dellautore e anzi a ben guardare fra i due pedagoghi
sar Naphta a uscirne sconfitto, optando per un simbolico suicidio. Daltra parte
litaliano non pu ritenersi il vincitore della lunga disputa, poich Hans, dopo aver
attentamente ascoltato e lungamente riflettuto, non si lascer convincere da nessuno
dei due e sceglier una via tutta sua, appena percepita e afferrata in mezzo a una
tormenta di neve, ma poi quasi subito dimenticata.
Gli anni successivi furono molto movimentati per Mann. La sua fama crebbe
sempre pi, culminando con lassegnazione del Nobel, ufficialmente conferitogli il 10
dicembre 1929 dal re Gustavo V in particolare per il grande romanzo I Buddenbrook,
che nel corso degli anni si solidamente affermato come un classico del presente14.
Nellagosto dello stesso anno, durante un soggiorno a Rauschen sul Mar Baltico,
Mann cominci a scrivere il racconto Mario e il mago (Mario und der Zauberer),
basandosi, secondo le sue stesse parole, su un aneddoto la cui idea risaliva a un altro
viaggio estivo, a un soggiorno a Forte dei Marmi presso Viareggio15. Lo scrittore
infatti aveva passato due settimane in Versilia nellestate del 1926, ma la sua vacanza
era stata alquanto spiacevole, in parte anche per il pesante clima politico che si era
venuto a creare dopo la presa del potere da parte di Mussolini nel 1922. Il lubecchese
si trov faccia a faccia con unItalia diversa e dovette affrontare numerosi contrattempi
LItalia in Mann
8
13 Citato in in Marino Freschi, Thomas Mann, il Mulino 2005 (pag. 130).14 Citato in in Thomas Mann, La montagna magica, Mondadori, collana I Meridiani 2010 (in Cronologia, CXXI).15 Citato in ibidem (in Cronologia, CXXI).
-
che lo infastidirono non poco: innanzitutto fu costretto insieme alla famiglia a
cambiare camera nellalbergo che li ospitava perch la figlia aveva la tosse e
infastidiva gli altri ospiti; poi, e pare che sia stato questo lepisodio che lo irrit di pi,
dovette subire lumiliazione di una denuncia con annessa multa perch laltra figlia,
che allepoca aveva otto anni, si era tolta il costume in spiaggia causando un vero e
proprio scandalo. Nonostante fossero passati diversi anni, Mann si prese la sua
personalissima vendetta componendo per lappunto Mario e il mago. Sarebbe per
sbagliato pensare che la novella consista tutta in un mero sfogo di vecchi rancori e
infatti fin da subito anche in Italia, ivi chiamata in causa da Mann come mai forse
prima di allora, la storia del mago-incantatore Cipolla e del cameriere Mario, che in un
primo momento viene ipnotizzato e ingannato da questi, poi finalmente si ridesta e lo
uccide, venne interpretata principalmente come unallegoria politica, per dirla tutta
anche abbastanza trasparente. Le risposte dei critici italiani non si fecero attendere:
Mann fu polemicamente accusato di essere schiavo di errati pregiudizi e invitato, in
poche parole, a farsi gli affari propri, anzich immischiarsi in questioni che, in quanto
tedesco, non lo riguardavano16. In buona sostanza ci si preoccup di difendere
limmagine dellItalia da quellattacco velato ma abbastanza deciso contro il regime
fascista salito al comando pochi anni prima. Non si tenne di conto che la novella non
era stata scritta a caldo, al rientro dalle vacanze, ma dopo quattro anni, quando ormai
anche in Germania la situazione si faceva sempre pi preoccupante e lascesa del
nazionalsocialismo sempre pi certa. Cos il monito del mago Mann cadde nel vuoto,
mentre laltro mago (lo si chiami Cipolla, Mussolini oppure Hitler) pot continuare
indisturbato a incantare le masse.
Infine, a partire dal maggio del 1943, Mann inizia a lavorare a quello che sar poi
considerato il capolavoro della sua fase senile, il libro della fine17 che chiude
simbolicamente18 il ciclo dei grandi romanzi del lubecchese: Doctor Faustus (Doktor
LItalia in Mann
9
16 Cfr. Arno Schneider, La prima fortuna di Thomas Mann in Italia, tesi di dottorato 2008 (pag. 109-117).17 Tale lo riteneva Mann e tale lo defin Hans Mayer (Thomas Mann, Doctor Faustus, Mondadori 2012; in Introduzione, XV).18 Simbolicamente perch di fatto non sar lultimo: oltre al romanzo breve Linganno (1953), Mann infatti avr ancora tempo di scrivere Leletto (1951) e di riprendere e pubblicare la prima parte delle Confessioni del cavaliere dindustria Felix Krull (1954), romanzo che per rimarr incompiuto per il sopraggiungere della morte dello scrittore.
-
Faustus). Egli si ormai da tempo trasferito negli Stati Uniti e ha appena concluso
limmensa fatica della tetralogia biblica Giuseppe e i suoi fratelli (Joseph und seine
Brder), con la quale si era imposto larduo compito di strappare il mito dalle mani del
nazionalsocialismo. La stesura del romanzo faustiano lo terr occupato per diversi anni
e culminer con la pubblicazione a Stoccolma nel 1947. La vicenda, nonostante il
titolo, non ha come protagonista n un mago, n un dottore, n tantomeno un
negromante di nome Faust, bens un compositore, Adrian Leverkhn, la cui triste
storia, come ci suggerisce il lungo sottotitolo19, viene narrata dallamico Serenus
Zeitblom. Mann, rinunciando per una volta al narratore onnisciente, al cosiddetto
spirito della narrazione, ha la possibilit di sdoppiarsi in due tipi di caratteri del tutto
contrapposti tra loro, contrapposti eppure evidentemente compresenti nella personalit
dellautore stesso. Soprattutto, in questo modo egli pu sviluppare il racconto su due
piani cronologici differenti e intrecciare polifonicamente le esperienze20. La vita di
Adrian infatti ha luogo nella Germania di inizio Novecento, ma Serenus la racconta
durante gli anni finali del secondo conflitto mondiale, a pochi anni dal decesso
dellamico. Il romanzo, la cui importanza simbolica stata pi volte ribadita dallo
stesso Mann, risulta complesso non solo da un punto di vista strutturale, ma anche e
soprattutto sul piano tematico. Vera e propria summa dellintera carriera artistica del
lubecchese, lopera pu essere considerata quasi come un imponente pastiche21 di
elementi eterogenei: alle lunghe e addolorate riflessioni di Serenus sul tragico destino
della Germania ammorbata da Hitler e dal nazismo, si alternano le vicende della vita di
Adrian, la cui storia da un lato segue il canovaccio faustiano del patto col diavolo,
dallaltro ricalca da vicino la biografia di Friedrich Nietzsche, il filosofo che tanta
parte ebbe nellevoluzione del pensiero del nostro. Oltre a ci di fondamentale
importanza il tema della musica, altra grande passione di Mann, cui lautore dedica
intere pagine di digressioni, avvalendosi della consulenza di Theodor Wiesengrund-
Adorno, del direttore dorchestra Bruno Walter e basandosi soprattutto sulle teorie
LItalia in Mann
10
19 Il titolo completo sarebbe infatti: Doctor Faustus. La vita del compositore tedesco Adrian Leverkhn, narrata da un amico.20 Thomas Mann, La genesi del Doctor Faustus, in Romanzo di una vita, il Saggiatore 2012 (pag. 84).21 O montaggio, secondo la definizione che lo stesso Mann utilizza pi volte ne La genesi del Doctor Faustus per descrivere il modus operandi che egli adotta nel romanzo.
-
musicali di Arnold Schnberg, lideatore della tecnica dodecafonica. Ma Mann in
quegli anni, come dimostra la tetralogia biblica e lo studio approfondito di Freud,
anche attratto dal tema del mito, dellarchetipo, della storia che si ripete nei secoli
seguendo gli stessi schemi, ritessendo le stesse trame. Cos, con mirabile grazia, in
questa opera totale e totalizzante, Adrian ripercorre le orme del giovane Thomas in
Italia e il soggiorno a Palestrina prende di nuovo vita:
Il luogo era Palestrina, il paese nativo del compositore, detto anche Preneste, e ricordato da Dante nel ventisettesimo canto dellInferno come Prenestino, roccaforte dei principi Colonna, una cittadina pittoresca appoggiata ai monti [...]22.
Mann, non a caso, cita anche lInferno di Dante, cos come non a caso aveva deciso
di premettere al romanzo un passo del canto II dellInferno stesso. Adrian avr il suo
dostoevskijano colloquio con il Diavolo23 proprio in questo paese rurale, uno spicchio
di campagna nel quale il tempo pare essersi veramente fermato a un medioevo pieno di
demoni e spiriti. Lautore, lo abbiamo detto, rispolvera i suoi ricordi giovanili, ed ecco
dunque che alcune pagine dopo ritroviamo anche Roma, la stessa medesima via nella
quale alloggiava Mann, persino lo stesso piano del palazzo:
[Adrian e Schildknapp] abitavano nella via di Torre Argentina, vicino al Pantheon, a un terzo piano, da una padrona che preparava loro il caffelatte del mattino e la colazione a mezzogiorno24.
Il vecchio Mann, cos affascinato dal tema del mito, del pedissequo ripetersi degli
eventi, chiude il cerchio della propria biografia rievocando il soggiorno romano
proprio in quello che , pur non essendo lultimo, il suo libro della fine. Anche noi,
con questa breve carrellata dei luoghi e dei personaggi italiani presenti nelle sue opere,
abbiamo voluto e dovuto fare lo stesso, partendo da Palestrina e a Palestrina facendo
infine ritorno.
LItalia in Mann
11
22 Thomas Mann, Doctor Faustus, Mondadori 2012 (pag. 245).23 Anchesso descritto secondo un ricordo giovanile, una visione diabolica che Mann confessa di aver avuto mentre sedeva alla scrivania. Da l, infatti, vide un individuo seduto sul divano, una figura piuttosto allampanata dalle ciglia rossastre, il viso cereo, i pantaloni disgustosamente stretti e scarpe gialle, logore (citato in Sara Zurletti, Le dodici note del diavolo, Bibliopolis 2011; p. 276). Individuo dunque molto somigliante alla prima delle tre maschere assunte dal Diavolo durante il colloquio con Adrian a Palestrina.24 Ibidem (pag. 254).
-
I.2 Mann in Italia
Ora che abbiamo esaminato in breve le occasioni in cui lItalia e gli italiani ebbero
la possibilit di ritagliarsi un qualche spazio allinterno delle opere di Thomas Mann,
tocca fare con la stessa rapidit il processo inverso, concentrandoci stavolta
sullaccoglienza che la critica nostrana riserv allo scrittore di Lubecca. In questo
breve paragrafo assumeremo perci allincirca lo stesso punto di partenza del
precedente, quel primo importante soggiorno del giovane Mann in Italia, procedendo
poi passo passo fino agli anni dellesilio. L ci arresteremo, affidando la ricezione del
Doctor Faustus ai capitoli successivi.
Stando alle parole dello stesso Mann, il primo suo libro apparso in Italia sarebbe
nientemeno che Il piccolo signor Friedemann (Der kleine Herr Friedemann). Con
questo titolo non dobbiamo tanto intendere il racconto singolo, apparso per la prima
volta nel maggio 1897 nella rivista di Samuel Fischer, la Neue deutsche Rundschau,
quanto piuttosto la raccolta dei racconti stessi:
Gi durante il soggiorno romano apparve il mio primo libretto, un volume di novelle che recava il titolo di quel racconto. Potei, quindi, vedere me nelle vetrine delle librerie di Roma25.
Se la notizia fosse vera si tratterebbe senzaltro di un caso singolare, vista la
lentezza con la quale lItalia cominci a interessarsi allo scrittore tedesco. Inoltre la
pubblicazione sarebbe stata sicuramente in lingua originale, poich le prime
sporadiche traduzioni avverranno soltanto negli anni Venti. Daltro canto potrebbe
anche essere che Mann nel suo saggio autobiografico abbia in qualche modo
romanzato la sua stessa biografia e che non tutto corrisponda totalmente a realt. Per
quanto dubbia, resta comunque suggestiva lidea che questa raccolta giovanile
circolasse fin da subito nelle librerie della capitale.
I primi significativi contributi da parte della critica italiana risalgono invece agli
anni iniziali del Novecento. Stando alla ricerca bibliografica effettuata da Arno
Schneider, il primo articolo dedicato a Mann dovrebbe essere quello uscito dalla penna
12
25 Thomas Mann, Saggio autobiografico, in Romanzo di una vita, il Saggiatore 2012 (pag. 16).
-
di Gustavo Sacerdote, pubblicato su un numero della Rivista dItalia del 1903.
Lautore, che in seguito sar anche traduttore di Giuseppe e i suoi fratelli, recensisce
nel suo pezzo alcuni nuovi romanzi tedeschi, e fra questi riserva una pagina anche a
Mann, lodandolo per le sue capacit di osservazione dellambiente, ma esprimendo al
contempo un giudizio alquanto negativo sui Buddenbrook, libro chegli giudica troppo
lungo e minuzioso. Sacerdote, pur riconoscendo il grande successo che il romanzo
ebbe in Germania, non condivide affatto gli entusiasmi del pubblico tedesco. Inoltre,
cosa che capit spesso ai primi lavori di Mann, egli afferma che le qualit dello
scrittore tedesco fanno pensare ai migliori rappresentanti del naturalismo26,
inquadrandolo di fatto in una corrente letteraria ben definita e dunque tralasciando,
almeno in apparenza, lintero, fondamentale apparato simbolico della narrazione.
Sei anni pi tardi, nel 1909, Giulio Caprin dedica un articolo ad Altezza reale
(Knigliche Hoheit), il romanzo che Mann aveva appena pubblicato. Lo studioso
triestino si preoccupa principalmente della realt storica della Germania e della
rappresentazione, allinterno del libro, dei piccoli staterelli indipendenti che
continuano a sopravvivere allinterno dellImpero. Ci dovuto, secondo il suo parere,
al vivo sentimento monarchico di tutta la Germania, la quale appunto perch
monarchica ha bisogno di avere molti monarchi27. Caprin pare insomma attribuire
eccessiva importanza a un romanzo che in realt ha molti aspetti fiabeschi, lontani
dalla reale situazione politica, e definisce Mann addirittura il romanziere pi storico
degli storici28. inoltre caratteristico che ancora una volta ci si soffermi pi su
elementi secondari dellopera che non sul suo valore artistico.
Successivamente, nel gennaio del 1915, Alberto Spaini pubblica sulla Nuova
Antologia il primo saggio interamente dedicato a Thomas Mann. Lobiettivo quello
di presentare in Italia le ancor poco conosciute (per non dire sconosciute) opere del
lubecchese, a partire dai Buddenbrook, per procedere poi con Tonio Krger, il dramma
tutto italiano Fiorenza e il romanzo breve anchesso ambientato in Italia La morte a
Venezia. Spaini cita direttamente alcuni passi dei vari testi, soffermandosi talvolta
Mann in Italia
13
26 Arno Schneider, La prima fortuna di Thomas Mann in Italia, tesi di dottorato 2008 (pag. 39).27 Citato in ibidem (pag. 42).28 Citato in ibidem (pag. 43).
-
anche su alcuni contributi in lingua tedesca. Per la prima volta si analizzano con la
dovuta attenzione lo stile e le tematiche tipiche del narrare manniano, riconoscendo,
per quanto riguarda il primo, il Leitmotiv dellironia, per quanto riguarda il secondo, il
conflitto spesso presente tra arte e vita. Spaini conclude con un giudizio molto positivo
su Mann e si dice certo che lo scrittore otterr ben presto il successo che merita.
Questo saggio lultimo contributo critico dedicato a Mann prima dellirrompere
della guerra: durante gli anni del conflitto, cos come in quelli immediatamente
successivi, non sono a noi noti scritti su di lui. Riassumendo possiamo concludere che
fino agli anni Venti la conoscenza in Italia delle opere di Mann fu molto influenzata
dal contesto storico-politico, risultando di fatto scarsa, limitata a quella stretta cerchia
di persone colte ed erudite che avevano una conoscenza del tedesco tale da
permettergli di comprendere la complessa ed elegante prosa del lubecchese.
A partire dagli anni Venti, esattamente nel 1920, la situazione comincia per pian
piano a cambiare, soprattutto per il fondamentale lavoro di mediazione svolto da due
personaggi decisivi, e decisivi non solo per quanto riguarda la fortuna di Mann in
Italia, ma pi in generale per la diffusione della letteratura tedesca nel nostro Paese:
Lavinia Mazzucchetti e Benedetto Croce. Entrambi infatti dedicheranno molte
attenzioni a Mann e instaureranno con lui dei rapporti personali sempre pi intensi,
come dimostrano i vivaci scambi epistolari che intercorsero fra il tedesco e i due
letterati italiani. Lavinia Mazzucchetti, in particolare, scriver una ventina di
contributi, in aggiunta alle numerose traduzioni e introduzioni alle opere del nostro.
Sia Croce sia la Mazzucchetti continueranno inoltre a occuparsi di Mann anche
durante lesilio di costui, cogliendo al volo ogni occasione per promuovere lo scrittore
in Italia e cercando di superare tutte le difficolt di un periodo quantomai ostico e
delicato, quello degli anni precedenti il secondo conflitto mondiale.
Il primo scritto della Mazzucchetti appare il 1 febbraio del 1920 su Il Secolo di
Milano. Fin dal titolo29 lattenzione parrebbe concentrarsi pi che altro sul fratello di
Thomas, Heinrich Mann, conosciuto e apprezzato anche in Italia soprattutto per due
romanzi, Il professor Unrat (Professor Unrat) del 1905 e Il suddito (Der Untertan) del
Mann in Italia
14
29 Il romanziere della rivoluzione e... suo fratello, citato in ibidem (pag. 60).
-
1916. Larticolo parla proprio di questultimo romanzo, il quale era stato tradotto in
italiano appena un anno prima, ma nellultima parte la Mazzucchetti riserva uno spazio
anche a Thomas e alle sue Considerazioni di un impolitico, scritte durante gli anni
della guerra e pubblicate in Germania nel 1918. Secondo la studiosa il lungo e
vulcanico saggio di Mann esprime con forza la posizione dei conservatori, i non-
politici, i non-occidentali, i non-latini, soprattutto i non-democratici30. La
Mazzucchetti critica le vedute fortemente conservatrici del minore dei due fratelli,
parteggiando piuttosto per Heinrich, che lautrice definisce, come da titolo,
romanziere della rivoluzione. In questo scritto dunque sono ancora una volta le
ragioni politiche a farla da padrone. Ci nonostante esso assume unimportanza
particolare, perch Mann lo lesse e rispose divertito allautrice, ringraziandola per aver
visto in lui un conservatore piuttosto che un reazionario. Si tratta, come detto da
Schneider nel suo elaborato, della prima comunicazione scritta che Thomas Mann
spedisce in Italia. Da questo momento in poi lo scrittore tedesco e la Mazzucchetti
cominceranno un proficuo scambio epistolare, cui si aggiungeranno presto alcune
visite della studiosa italiana alla famiglia Mann a Monaco. Sar la stessa
Mazzucchetti, nel 1963, a curare Tutte le opere, la fondamentale edizione Mondadori
dedicata allo scrittore di Lubecca.
Larticolo di Benedetto Croce esce invece sul numero di maggio del 1920 de La
Critica, il periodico letterario da lui fondato nel 1902. Esso interamente dedicato
alle Considerazioni, a dimostrazione di quanto lo zibaldone manniano riusc a far
parlare di s anche in unItalia che dello scrittore tedesco sapeva poco o niente. Croce,
al contrario della Mazzucchetti, loda fin da subito il saggio e riconosce in esso lo
scontro tra lo spirito tedesco rappresentato e difeso da Thomas e quello democratico e
civilizzatore, in sostanza tra il Dichter e il Zivilisationsliterat, il poeta e lintellettuale
illuministico e occidentale, impersonato questultimo, pur senza venir mai
espressamente nominato, dal fratello Heinrich. Il critico osserva che il tema del libro
[...] ritrae in forma simbolica e mitologica (di storico mitologismo) lumana ed eterna
Mann in Italia
15
30 Citato in ibidem (pag. 61).
-
opposizione tra aristocrazia e volgo31. Non sar superfluo ricordare che linfluenza di
Croce in quegli anni era altissima, e che nello stesso 1920 egli era ministro della
Pubblica istruzione nel governo Giolitti. Risulta dunque ancora pi significativa e
importante lattenzione che il filosofo-critico-scrittore abruzzese rivolse al
misconosciuto, almeno in Italia, scrittore tedesco. Come gi abbiamo accennato, i
rapporti tra i due diventeranno pi intimi col passare degli anni, culminando con la
dedica al tedesco anteposta alla Storia dEuropa nel secolo XIX, il saggio che Croce
pubblic nel 1932.
Ad ogni modo entrambi i contributi, quello della Mazzucchetti e quello di Croce,
pur avendo il merito di interessarsi al Mann im-politico e saggista, non concedono
alcuno spazio al Mann romanziere. Essi danno piuttosto inizio a due filoni
interpretativi del pensiero manniano: da una parte ( la lettura che ne d la
Mazzucchetti) si vede nello scrittore tedesco il classico conservatore antidemocratico,
dallaltra (assecondando il punto di vista crociano) si tender ad accentuarne sempre
pi laspetto liberale.
Negli anni seguenti aumenteranno considerevolmente gli scritti dedicati a Mann e,
soprattutto, usciranno le prime traduzioni in lingua italiana. Procedendo con ordine
sono da segnalare innanzitutto gli articoli di Alberto Spaini e Rudolf Kayser, entrambi
del 1923. Ambedue gli autori, parlando della situazione contemporanea della
letteratura tedesca, citano Mann come uno dei rappresentanti pi importanti di essa e
lodano la ricchezza spirituale delle sue opere. Kayser in particolare nomina I
Buddenbrook e successivamente paragona lo scrittore a Theodor Fontane;
effettivamente sappiamo che Mann lesse con molta attenzione i romanzi del suo
connazionale, il quale esercit, almeno nella fase giovanile del lubecchese, un
notevole influsso sulla sua poetica.
Nel 1924 appare invece la prima voce di enciclopedia dedicata al nostro: la palma
spetta in questo caso alla Grande Enciclopedia Popolare Sonzogno. In essa si fa
riferimento non solo ai Buddenbrook, ma anche a Tristan (la seconda raccolta di
novelle pubblicata in Germania nel 1903) e alla Morte a Venezia. Ampio spazio
Mann in Italia
16
31 Citato in ibidem (pag. 65).
-
concesso ancora una volta alle Considerazioni, dunque al Mann saggista piuttosto che
al Mann romanziere. Ci probabilmente dovuto anche alla lunga eco lasciata dai
precedenti interventi del 1920 della Mazzucchetti e di Croce, che come detto ebbero
fin da subito uninfluenza e una diffusione non indifferenti. Nel primo Supplemento
dellenciclopedia la voce dedicata a Mann si amplia ulteriormente, soprattutto grazie a
una trattazione pi approfondita dei romanzi. Anche in questo caso, facendo
riferimento ai Buddenbrook, si tenta di inquadrare lautore in un filone letterario ben
definito: dopo il naturalismo, limpressionismo e il realismo, stavolta tocca al verismo,
corrente, giusto sottolinearlo, del tutto italiana. Il Supplemento si sofferma poi su
Altezza reale e soprattutto cita La montagna magica (Der Zauberberg), o meglio in
questo caso la Montagna del prodigio, romanzo che era appena stato pubblicato in
Germania. Fedele alla definizione che si voluta dare dello scrittore di Lubecca,
lopera viene definita addirittura come una esagerazione della formula veristica32,
opinione oggi davvero poco condivisibile. Sempre riguardo alla Montagna magica, v
da notare come luscita del libro in Germania non passi inosservata in Italia: anche se
le prime traduzione di alcuni estratti del romanzo saranno del 1929, esso viene
comunque presentato al pubblico nostrano grazie agli articoli di Lionello Vincenti e di
Lavinia Mazzucchetti.
Lanno successivo, il 1925, Thomas Mann festeggia il suo cinquantesimo
compleanno; a celebrarlo in Italia ci pensa, puntuale come sempre, Lavinia
Mazzucchetti, cui si aggiunge Aldo Sorani, che in un articolo uscito su La Stampa
definisce Mann il pi grande romanziere tedesco33. Gli anni dal 1926 al 1929 sono
invece particolarmente importanti per le pubblicazioni delle prime traduzioni e per
diversi altri contributi, ad opera, tra gli altri, di Alberto Spaini, Bonaventura Tecchi e
Mario Puccini. Per quanto riguarda le prime, si tratta in principio di brevi estratti
pubblicati su quotidiani o riviste, per poi passare in un secondo momento a traduzioni
integrali in forma di volume. Risalgono al biennio 1923-1924 uno stralcio del Tonio
Krger tradotto su La Stampa e le quattro lettere riguardanti il panorama artistico
Mann in Italia
17
32 Citato in ibidem (pag. 78).33 Citato in ibidem (pag. 79).
-
contemporaneo tedesco composte da Mann e pubblicate in italiano dalla rivista
LEsame. Sempre su LEsame, dopo questi quattro testi di saggistica, viene
tradotto di nuovo un testo narrativo, stavolta peraltro in versione integrale: si tratta del
racconto Larmadio (Der Kleiderschrank), vlto in italiano da Guido Isenburg. La
prima traduzione ad opera di Lavinia Mazzucchetti appare invece nel 1926 sulla rivista
Il Convegno e consiste in un estratto di Disordine e dolore precoce (Unordnung und
frhes Leid).
Il 1926 anche lanno delle prime pubblicazioni editoriali. Ad occuparsene la
Morreale di Milano, che fa uscire in rapida successione il Tonio Krger di Guido
Isenburg e la raccolta Ora greve, Tristano e altri racconti, la cui traduzione affidata a
Rosina Pisaneschi e Alberto Spaini. Tre anni pi tardi, nel 1929, la casa editrice
Sperling & Kupfer d alle stampe il testo integrale di Disordine e dolore precoce, che
comprende anche Cane e padrone (Herr und Hund), il breve idillio composto da Mann
nel 1918. Sulla rivista Il Convegno escono invece due capitoli, i primi tradotti in
italiano, della Montagna magica.
Poi, nel 1929, viene conferito a Mann il premio Nobel e la fama dello scrittore
tedesco in Italia cresce non solo notevolmente, com lecito aspettarsi, ma anche in
maniera piuttosto repentina. Lassegnazione del premio al lubecchese Mann fece pure
un certo scalpore, poich fu lui il primo scrittore tedesco a ricevere quel prezioso
riconoscimento dopo la recente conclusione del conflitto mondiale. In Italia il primo a
riportare la notizia fu Mario Puccini, seguito a ruota dalla solita Mazzucchetti, ma
soltanto a partire dal 1930 che i contributi dedicati a Mann aumentano drasticamente,
concentrandosi finalmente su quella parte della sua produzione fino ad allora
maggiormente trascurata, quella cio relativa ai romanzi. Nello stesso 1930 e negli
anni successivi le grandi opere di Mann, pur con colpevole ritardo, vengono
finalmente tradotte in italiano: la casa editrice Fratelli Treves pubblica in un unico
volume La morte a Venezia e Le confessioni di un cavaliere dindustria, mentre la
Barion si occupa dei Buddenbrook, il romanzo che di fatto valse a Mann il premio
Nobel, ma che in Italia, quando ormai erano passati venti anni dalla prima edizione
tedesca, in pochissimi avevano avuto il privilegio di leggere. Due anni pi tardi sar
Mann in Italia
18
-
invece la volta della Montagna incantata34, pubblicata in due volumi dalla casa
editrice Modernissima. Lopera riscosse fin da subito un discreto successo, successo
destinato non soltanto a consolidarsi, ma a crescere sempre pi col passare del tempo.
Del 1933 sono invece le prime due edizioni in italiano di Altezza reale, uscite presso
Barion e Corbaccio. Negli stessi anni si avvia anche il fondamentale sodalizio tra
Mann e la Mondadori, la quale si occuper della pubblicazione dei quattro libri che
compongono la tetralogia biblica Giuseppe e i suoi fratelli: nel 1933 esce infatti Le
storie di Giacobbe, nel 1935 Il giovane Giuseppe e nel 1937, in due volumi, Giuseppe
in Egitto; per lultimo capitolo della saga, Giuseppe il nutritore, si dovr invece
attendere il 1949.
Negli anni Trenta linteresse verso lo scrittore di Lubecca aument dunque sempre
di pi, e con esso si approfond la conoscenza della sua opera. Tra gli scritti di settore
meritano di essere ricordati i contributi di Bonaventura Tecchi, Lionello Vincenti, Italo
Maione e soprattutto Ladislao Mittner, autore della prima monografia italiana dedicata
interamente al nostro, Lopera di Thomas Mann, pubblicata nel 1936. Il Mittner
analizza sistematicamente le opere del tedesco, prestando attenzione agli aspetti
linguistici e stilistici ed escludendo del tutto la parte saggistica della sua produzione.
Che si tratti di un saggio dimportanza fondamentale lo dimostra ad esempio il fatto
che Claudio Magris, in uno scritto del 198035, lo definisca addirittura insuperato.
Anche se di l a poco la guerra avrebbe complicato ogni cosa, si pu dire insomma
che durante gli anni Trenta, in gran parte grazie al Nobel del 1929, Thomas Mann
diventa anche in Italia un autore affermato, conosciuto e soprattutto - questa la cosa
pi importante - letto. Mai come in questo decennio si assistette infatti a un aumento
cos considerevole degli interventi dedicati al Mago, siano essi traduzioni e successive
pubblicazioni di romanzi, articoli di quotidiani o riviste specializzate, saggi di pi o
meno ampia estensione.
Mann in Italia
19
34 In Italia sar per lungo tempo questo il titolo adottato, sia dalla Mondadori, sia dal Corbaccio, sia dalla Tea. La stessa Mondadori ha per recentemente pubblicato una nuova edizione per la collana I Meridiani, cambiando per loccasione il titolo in La montagna magica. Anche la versione inglese suona in questo modo (The Magic Mountain).35 Cfr. infra, pag. 199.
-
Gli avvenimenti politici successivi cambieranno per drasticamente (e in negativo)
la situazione, soprattutto in unItalia che, con lavvento e il consolidarsi del fascismo,
non era mai stata prima di allora cos al centro dellattenzione mondiale. Facendo un
passo indietro possiamo cogliere le prime avvisaglie del mutato clima politico nella
polemica sorta intorno alla novella tutta italiana Mario e il mago, della quale abbiamo
gi parlato in I.136. Pubblicato in Germania nel 1930, pur non venendo
immediatamente tradotto in italiano37, il racconto fu comunque in grado di catturare
lattenzione di diversi nostri critici, proprio in virt del fatto che in esso parevano
entrare in gioco degli aspetti che trascendevano il lato prettamente narrativo. Fra i
contributi pi originali ricordiamo quelli di Enrico Rocca, Bonaventura Tecchi e
Francesco Bruno, tutti usciti nello stesso 1930.
Rocca definisce la novella come lo stereotipato resoconto di viaggio dello straniero
che non si trova bene in Italia38, affermando che se il suddetto straniero non si
sentito a suo agio soltanto perch s tirato dietro tuttun bagaglio di pregiudizi
vari. La posizione di Tecchi risulta invece pi equilibrata, soprattutto perch lesperto
germanista evita con cautela di alimentare ulteriormente la polemica. Egli apre il suo
articolo citando i vari contrattempi occorsi a Mann durante il soggiorno a Forte dei
Marmi, affermando, daccordo in questo con Rocca, che si poteva certamente evitare
di inserirli nella novella. Poi lascia per da parte i nazionalismi e si dedica allanalisi
del racconto, concentrandosi principalmente sullo stile, in particolare sulla
caratteristica e funzionale lentezza delle descrizioni manniane. Infine, Francesco
Bruno si dichiara al contrario contento che in questo racconto la narrazione proceda
abbastanza rapida, senza inceppi e senza lungaggini descrittive39, ma quando arriva
a parlare della trama e delle tematiche in esso affrontate ribadisce lidea secondo la
quale lo scrittore tedesco, come del resto molti uomini del Nord, sarebbe vittima dei
tanti pregiudizi che offuscano limmagine dellItalia e degli italiani. Per dare unidea
Mann in Italia
20
36 Cfr. supra, pp. 8-9.37 Il libro, edito dalla Libreria Editrice Eclettica, uscir nel 1945 con il titolo Mario e lincantatore. Una tragica avventura di viaggio.38 Citato in ibidem (pag. 111).39 Citato in ibidem (pag. 114).
-
del tono fortemente irritato e polemico dellarticolo di Bruno, basti il citare linvito
che egli rivolge, pur fra parentesi, a Mann e ai suoi colleghi teutonici: ma perch,
benedetti letterati tedeschi, non ve ne state in casa vostra?40
Come gi avevamo detto nel paragrafo precedente, nessuno a quanto pare tent di
andare oltre gli aspetti superficiali della novella, cercando di coglierne il significato
pi profondo e allegorico.
In seguito il panorama politico europeo peggiorer di anno in anno e gi dal 1933
Mann sar costretto allesilio. Egli dapprima si trasferisce in Svizzera, dove trova il
conforto, tra gli altri, dellamico Herman Hesse; poi nel 1938 emigra negli Stati Uniti,
accettando il titolo di Doctor of letters offertogli dallUniversit di Princeton. LItalia
nel frattempo, con il consolidarsi dellAsse Roma-Berlino, si alline sempre pi alla
Germania anche riguardo alle posizioni assunte da questultima in campo culturale,
pur se con minor rigore.
Giungiamo cos al 1938, lanno della promulgazione delle leggi razziali e del breve
estratto di Sangue velsungo (Wlsungenblut) pubblicato sulla rivista di propaganda
fascista La difesa della razza. La novella, che narra la cupa storia di un incesto fra
una ragazza ebrea e il suo fratello gemello, era stata scritta da Mann nel 1906 in
seguito al matrimonio con Katja, in parte prendendo ispirazione proprio dalla famiglia
della sposa, che era di origine ebrea. Dobbiamo innanzitutto ammettere che il testo
risente del diffuso antisemitismo di quegli anni e contiene al suo interno diversi clich
sugli ebrei. Detto ci, difficilmente si potr inferire che il breve racconto sia stato
scritto da Mann con lo scopo precipuo di colpire e denigrare gli ebrei in quanto razza
inferiore; che poi proprio quanto tent di fare la propaganda fascista, traducendo
arbitrariamente il titolo della novella in Sangue riservato ed estrapolandone la parte
finale. Anche questultima peraltro appare manipolata, poich la rivista vi reintroduce
il termine Goy41, che Mann aveva espunto prima della pubblicazione, in seguito alle
proteste ricevute in fase di lettura da parte di amici e conoscenti. Si tratta infatti di una
Mann in Italia
21
40 Citato in ibidem (pag. 115).41 Citato in ibidem (pag. 123). Il racconto si conclude con lincesto, cui segue un breve dialogo tra i due fratelli. Alla domanda della sorella riguardo al futuro marito e al ruolo che esso assume nello scandalo che si appena consumato, il fratello risponde sprezzante: Ebbene credi che glielabbiam fatta, al Goy!
-
parola per certi versi offensiva utilizzata dagli ebrei per indicare i non ebrei, la quale
avrebbe potuto far apparire lincesto come una sorta di meschina vendetta contro il
futuro marito della ragazza, pi in generale contro tutti i non ebrei.
Lestratto, come suggerisce Schneider, serv alla propaganda fascista per giustificare
le leggi razziali appena promulgate, soprattutto quella che vietava i matrimoni misti,
dimostrando come gli stessi ebrei osservassero delle leggi ancora pi severe. In
sostanza, come si legge anche nella breve introduzione, ci si scagli contro il
cosiddetto razzismo dIsraele, rispetto al quale il razzismo praticato dai cristiani nei
riguardi dei giudei diventa un innocuo scherzo42. Come se non bastasse, nella
seconda parte dellintroduzione Thomas Mann viene dichiarato ebreo, un ebreo che
per si scaglia anchesso contro i non ebrei tramite questa novella che descrive cos
bene lostilit ereditaria dellebreo per il cristiano43. Si aggiunga che a quellepoca
lo scrittore tedesco era gi vietato dal regime e la triste vicenda si completa in tutta la
sua imbarazzante paradossalit.
Fu questa di fatto lultima traduzione di Mann che usc in Italia prima e durante la
seconda guerra mondiale. A causa dellAsse Roma-Berlino le sue opere vennero infatti
bandite anche nel nostro Paese, e qui come l, a Roma come a Berlino, fu come se egli
durante quegli anni cessasse di esistere. Invece Mann per fortuna continuava a esistere,
viveva, grazie al cosiddetto Gegenachse (laltro Asse), nelle lettere e nelle attenzioni
di Benedetto Croce, di Lavinia Mazzucchetti e di pochi altri isolati intellettuali, i quali
fortunatamente non furono cos sviati dalla barbarie di quei tempi, e riuscirono sempre
e comunque, almeno loro, a non dimenticarsi di lui.
Mann in Italia
22
42 Citato in ibidem (pag. 125).43 Citato in ibidem (pag. 126).
-
CAPITOLO II: DOCTOR FAUSTUSQuesta sola volta sapevo che cosa volevo e quale compito mi imponevo: nientemeno che di scrivere il romanzo della mia epoca travestito nella storia di una vita di artista, molto precaria e peccaminosa.Thomas Mann, La genesi del Doctor Faustus.
II.1 Un romanzo complesso44
Che il Doctor Faustus sia unopera complessa, sfuggente e per certi versi
irriducibile a una sintesi critica che possa dirsi definitiva, lo si trova scritto nella gran
parte dei saggi, anche in quelli che, nonostante tutto, si pongono pi o meno
scopertamente quello stesso obiettivo, il voler cio giungere a uninterpretazione la
meno problematica e ambigua possibile. Gi negli anni immediatamente successivi
alluscita del romanzo, pubblicato a Stoccolma nel 1947, assistiamo a un vero e
proprio proliferare di contributi critici a esso dedicati, interventi che si
moltiplicheranno vieppi nel tempo e che daranno luogo a un intenso dibattito
culturale spesso assai prossimo alla polemica vera e propria, non solo in Germania, ma
anche, come vedremo, in Italia. Effettivamente di pochi romanzi si discusse cos
spesso e cos a lungo come del Doctor Faustus. Significativa, in questo senso, la
gustosa testimonianza di Italo Alighiero Chiusano, che nel suo breve scritto Il Doctor
Faustus dopo una generazione, annota:
Non vi dico che cosa furono, per alcuni mesi, i salotti letterari, i circoli studenteschi, gli uffici della Rai, le sedute al ristorante o al caff dove intervenissero uomini di cultura. Bastava lasciar cadere la parola Faust, e gi si accendeva una discussione, si arroventava una diatriba, iniziava a planare un monologo esplicativo. Niente di arbitrario. Lo stesso autore, forse, non desiderava di meglio. E allora via con le ipotesi, con le varie chiavi di lettura45.
23
44 La breve analisi del romanzo compiuta in questo paragrafo non ha affatto la presunzione di potersi definire esauriente. Oggetto specifico della nostra tesi la ricezione italiana del Doctor Faustus; non, dunque, linterpretazione diretta e non filtrata del romanzo, ma piuttosto linterpretazione delle interpretazioni e esso collegate. Per questo motivo, anche se la cosa non ci sarebbe affatto dispiaciuta, non abbiamo potuto dedicare pi di tanto spazio alle nostre considerazioni. Ci sembrava tuttavia doveroso introdurre in prima persona alcuni temi fondamentali dellopera, fondamentali o perch tali sono parsi a noi, o perch ricorrono spesse volte negli interventi critici che analizzeremo a partire dal prossimo paragrafo. Il lettore che conosce il Faustus come fosse opera sua vorr dunque scusarci se lamenter nella nostra breve analisi la mancanza di certe problematiche che gli stanno particolarmente a cuore. Del resto, come lo stesso lettore vedr, avremo modo di trattare numerosi altri temi nel prosieguo della tesi, via via che essi saranno tirati in ballo dai vari studiosi. Va aggiunto infine a nostro parziale discarico che la natura stessa del romanzo, vista la sua complessit, non facilit di certo la sintesi.45 Italo Alighiero Chiusano, Il Doctor Faustus dopo una generazione, in Literatur, Rusconi 1984 (pag. 255).
-
Ed probabile in effetti che lautore, con quella lieve civetteria che spesso non
riusciva del tutto a reprimere, davvero non desiderasse di meglio. Eppure leggendo il
romanzo, nonostante anchesso sia, al pari dei precedenti, tutto rinsanguato dal tipico
utilizzo manniano dellironia (ma qui diremmo meglio: parodia), si ha limpressione di
trovarsi di fronte a un qualcosa di molto serio e doloroso, oltre che - naturale -
inquietante. Come i convitati al drammatico rinfresco organizzato da Adrian, anche a
noi lettori inizialmente viene fatto di sorridere; ma poi restiamo in ascolto con aria
sempre pi preoccupata, e arrivati alla fine, proprio come loro, quasi vorremmo
darcela a gambe.
Del resto quanto Mann tenesse al suo libro della fine lo dimostra la
pubblicazione, nel 1949, de La genesi del Doctor Faustus, sapiente resoconto dei
fervidi anni di stesura del romanzo. Tra conferenze, eventi mondani e serate in societ,
emerge bene da questo documento tutta la tribolazione interna che accompagn lo
scrittore in quel periodo, la paura di non riuscire a completare la propria opera, il
timore di essersi impaludato in un progetto che superava le forze di un vecchio
ancorch espertissimo narratore come lui. Cos, scorrendo le pagine del diario-
racconto, vi leggiamo che non , azzardiamo noi, a causa degli inevitabili malanni
dellet se lo scrittore nel 46 viene colpito da una grave affezione polmonare ed
costretto a una complicata e rischiosa operazione nel Billings Hospital di Chicago,
poich in realt la colpa della malattia resa acuta dallinfluenza va ascritta certamente
al terribile romanzo46, il quale, a detta dello stesso Mann, pare non solo
metaforicamente ma letteralmente prosciugargli la quasi totalit delle energie vitali.
Per fortuna il delicato intervento si risolse nella most elegant operation, e i lettori di
tutto il mondo poterono gustarsi, gi a partire dallanno successivo, il loro Faust
moderno. Sono, queste, dichiarazioni che scusiamo volentieri allo scrittore di Lubecca,
perch sappiamo bene che la bonaria ironia con la quale tratt gran parte dei suoi
personaggi, egli la rivolse in primo luogo (come forse in questo caso) verso se stesso.
Oppure: e se non solo di ironia si trattasse? Non pu essere che Mann, soffermandosi
cos a lungo sullepisodio della sua malattia, volesse riportare alla mente del lettore
Un romanzo complesso
24
46 Thomas Mann, La genesi del Doctor Faustus, in Romanzo di una vita, il Saggiatore 2012 (pag. 186).
-
laltra malattia, ben pi grave, del suo protagonista? La malattia come fatto spirituale
accomunerebbe in questo modo Adrian Leverkhn e lo stesso Mann, il Doctor Faustus
ripeterebbe i suoi schemi nella Genesi del Doctor Faustus... Evidentemente tale
diario-racconto, in apparenza scritto ad hoc per studiosi e biografi, ha qualcosa di pi
del racconto che non, piuttosto, della pura e schietta annotazione diaristica.
Ma a parte questo, le pagine che per il momento ci interessano sono le altre,
numerose e molto dettagliate, che Mann dedica, come da titolo, alla genesi del
romanzo, pagine nelle quali vengono citate le sterminate letture preparatorie, che
spaziano dalle opere di Nietzsche a quelle di Shakespeare, dal saggio sulle marionette
di Kleist al James Joyce di Harry Levin, passando per i Gesta romanorum, il Malleus
maleficarum e il Volksbuch del Faust. Questultimo testo in particolare sar di
fondamentale importanza e funger da modello per il Doctor Faustus molto pi di
quanto non facciano le numerose rielaborazioni successive della leggenda47. Mann
lesse anche, com lecito aspettarsi, numerosissime opere di storia e teoria della
musica, ma ben presto dovette rendersi conto che n queste n la sua pluriennale
passione per larte dei suoni sarebbero bastate allopera che andava meditando. Egli
cap che aveva bisogno dei consigli e del supporto di personalit che alla musica
avevano consacrato unintera esistenza, cos decise di rivolgersi a veri esperti in
materia, come il direttore dorchestra Bruno Walter, il compositore russo Stravinskij e,
soprattutto, Arnold Schnberg, lideatore di quella tecnica dodecafonica che tanto peso
avr nel romanzo. Da Schnberg per, Mann sar destinato a separarsi presto: fra i due
mont infatti una velenosa polemica che fece storia e obblig lo scrittore a porre una
nota esplicativa alla fine del romanzo, nella quale dichiara che le parti tecnico-
musicali del libro devono parecchi particolari alla teoria armonica dello Schnberg. I
due giunsero pi tardi a una tregua, ma non ebbero il tempo di riappacificarsi di
persona, poich il compositore mor nel 51.
Un romanzo complesso
25
47 Sono molti i passi del romanzo che dimostrano come Mann si sia ispirato pi al testo del 1587 di Spies che non ai successici drammi di Marlowe, Lessing o Goethe, per dire soltanto dei pi famosi. Il Se sai alcuna cosa, taci che apre il lungo colloquio di Adrian col demonio ad esempio una citazione letterale dalla Historia di Spies. Cos pure la riunione organizzata dal musicista prima di cadere definitivamente preda della demenza, che ricalca lultima cena con gli amici voluta da Faust prima della morte. Mann ricorre anche in questo caso alla citazione parodistica della fonte, resa possibile e in qualche modo credibile dalla pazzia di Leverkhn; questi pu dunque esordire con un solennissimo e iperbolico Commendevoli e molto diletti fratelli e sorelle!, nel quale il lettore attento sapr riconoscere lincipit dellOratio Fausti ad studiosus che conclude il libro di Spies.
-
Il Doctor Faustus non sarebbe per cos come lo leggiamo oggi senza il
preziosissimo supporto di Theodor Wiesengrund-Adorno. Questo il mio uomo48
scrive di lui Mann nella Genesi, e lo scrive giustamente soprattutto perch, almeno per
quanto riguarda laspetto musicale, il contributo che il filosofo della Scuola di
Francoforte forn allo scrittore suo connazionale risulta cos notevole che si potrebbe
addirittura definirlo co-autore49, piuttosto che consigliere segreto (come invece prese
a chiamarlo Mann). Lo scrittore e il musicologo si conobbero probabilmente a casa del
comune amico Max Horkheimer nel marzo del 4350, ma iniziarono a frequentarsi con
continuit soltanto a partire dallestate dello stesso anno. Mann pot mettere mano alla
prima parte della Filosofia della musica moderna (Philosophie der neuen Musik),
saggio che Adorno pubblic nel 1949 e dal quale lo scrittore riprese interi passi,
parafrasandoli e adattandoli allatmosfera del romanzo. Si andava cos ancor pi
affinando la cosiddetta tecnica del montaggio, metodo di architettare la narrazione di
certo non nuovo per il lubecchese51, ma probabilmente mai utilizz