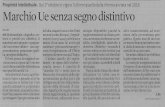GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ - Sassari · tra la municipalità e la Corona, nel XVI seco-lo quando...
Transcript of GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ - Sassari · tra la municipalità e la Corona, nel XVI seco-lo quando...
COMUNE DI SASSARI Assessorato alle Culture
PALAZZO DI CITTÀ
LA GUIDA
CoordinamentoNorma Pelusio
CuratoriPaolo Cau, Cristina Cugia,Mariangela Valentini
Progetto graficoAntonello Spano, Composita
FotografieMarcello Saba
L’ALLESTIMENTO
Studio d’architetturaCenami Simonetti Ticca
Comunicazione graficaMarco Moretti
Installazioni audiovisiveStudio Bianchini Lusiardi
PlasticiA. Marongiu per Domos
LE SEZIONI ESPOSITIVE
Memoria e identitàAntonello Mattone, Elisabetta Alba,Franco Campus, Alessandro Soddu
Forma e immagineMarisa Porcu Gaias
Rappresentanza e rappresentazioneSacro e profanoPaolo Cau
Sassari città e campagnaGianmario Demartis
© Copyrigt 2009 Comune di Sassari
PREMESSA
IDENTITÀ E STORIA DI UNA CITTÀANTONELLO MATTONE - ALESSANDRO SODDU
BREVE STORIA ARCHITETTONICA DEL PALAZZO DI CITTÀOTTOCENTESCO E DEL TEATRO CIVICOMARISA PORCU GAIAS
L’ATTIVITÀ MUSICALE AL TEATRO CIVICO NEL XIX SECOLOANTONIO LIGIOS
IL PALAZZO DI CITTÀTRA RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTAZIONEPAOLO CAU
IL PERCORSO ESPOSITIVOCRISTINA CUGIA - MARIANGELA VALENTINI
ALA OVEST
ALA EST
9
11
19
23
27
35
37
45
SOMMARIO
INTRODUZIONE
Ormai fa parte del comune sentire affermareche l'identità di una città possa essere ricercataoltre che su valori, tradizioni e consuetudinicomuni, anche sui luoghi in cui si sono forma-ti i comportamenti collettivi dei suoi cittadini.In questo senso, il municipio ed il teatro rap-presentavano una parte di questa identità inquanto luoghi dell'amministrazione e dellasocialità: in ambito locale questa nobile funzio-ne è stata esercitata dal Palazzo di Città, chetanto ha rappresentato per lo spirito pubblicodi Sassari. Il nuovo Palazzo Civico con il suoteatro esprimeva l'orgoglio dell'élite urbana inquanto simbolo delle tradizioni di autonomiamunicipale.La pubblicazione della guida del Palazzo diCittà segna una tappa importante della risco-perta di questo insigne edificio, così comeappare nella splendida veste frutto dell'ultimorestauro, che lo ha restituito alla città con nuovispazi espositivi destinati proprio ad illustrarne lafunzione di luogo identificativo dell'intera col-lettività sassarese.
Il SindacoGGiiaannffrraannccoo GGaannaauu
L'Assessore alle CultureAAnnggeellaa MMaammeellii
PREMESSA
Il volume sul Palazzo di Città rappresenta laprima guida finalizzata ad illustrare a un'uten-za sempre più ampia, attraverso una nuovalettura, lo storico palazzo con il suo teatrodopo l'ultimo restauro.Il lettore e il visitatore potranno ritrovare tra lepagine il forte legame tra la città e l’anticacasa comunale e nel percorso espositivo,anche multimediale, suggerimenti interpretati-vi alla sua visita.La guida propone spunti di approfondimentosulla memoria e sull'identità della città, sullaforma architettonica data al palazzo dopo larifondazione ottocentesca, sulla musica di cui èstato a lungo spazio privilegiato, sulla duplicefunzione di luogo della rappresentanza e dellarappresentazione, come sede dellaMunicipalità e come teatro. Si prosegue ancorasu alcuni temi identitari civici: la festa deiCandelieri, i momenti del sacro e del profano,l’abito dei primi decenni della Sassaridell'Ottocento quale espressione delle conta-minazioni socioculturali dell’epoca.La descrizione puntuale delle sezioni espositiveha il compito di orientare il visitatore in un per-corso originale tra le sale del palazzo, accom-pagnato da una ricca documentazione fotogra-fica e da un supporto multimediale interattivoche offrono la prima testimonianza visiva dell’edificio dopo il restauro conservativo.Una doppia lettura, dunque, per volgere unosguardo attento e scoprire ancora una volta,Sassari città regia e il suo patrimonio culturale.
11GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
IDENTITÀ E STORIA DI UNA CITTÀ
Per secoli l’identità sassarese è stata segnatadalla linea della sua cinta muraria che la divide-va dalla campagna circostante. I “villici” del con-tado e del Logudoro per inurbarsi dovevanoacquisire i valori della città in cui andavano adabitare: rispettare le leggi municipali, parlare ildialetto locale, venerare i santi cittadini – in par-ticolare i tre martiri turritani, Gavino, Proto eGianuario –, confrontarsi con le tradizioni artigia-ne e con la vita associativa urbana.
IDENTITÀ STORICA DI SASSARI
Identità è un termine ambiguo. Significa ricono-scersi in una serie di valori e tradizioni talvoltasfuggenti e indeterminati. Per Sassari più che diuna “identità” bisognerebbe parlare di più “iden-tità” che nel corso dei secoli si sono formate.Esse riguardano ambiti diversi sia di carattereeconomico (un’agricoltura fortemente sviluppatanel corso del tempo, dalla viticoltura all’orticoltu-ra, alla olivicoltura), sia di carattere istituzionale(la forte impronta municipale eredità delComune sorto nel XIII secolo), sia di carattereartigianale (dalle botteghe degli argentieri all’in-dustria delle conce, all’organizzazione dei gremi,cioè delle antiche arti e mestieri), sia di caratterelinguistico (il peculiare dialetto sassarese), sia dicarattere culturale e religioso (le confraternite, leistituzioni educative, le processioni, le feste, ecc.).Sassari mantiene ancor oggi una spiccata identi-tà urbana, espressione di lunghe sedimentazio-ni che caratterizzano la sua storia e la sua stessavocazione di capoluogo territoriale dellaSardegna settentrionale. Dal 1355 era infatti lasede della Reale Governazione del Capo diSassari e di Logudoro che verrà trasformata,all’indomani della “fusione” con gli ordinamentipolitici degli Stati sabaudi di Terraferma (1847),nell’omonima Provincia che sino alla nascita diquella di Nuoro nel 1929 comprenderà granparte della Sardegna centro-settentrionale. Dettaglio della mazza civica
12 GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
ampliò verso quattro direttrici di espansione, verie propri quartieri nuovi, corrispondenti ad altret-tante chiese parrocchiali (S. Sisto, S. Donato, S.Apollinare, S. Caterina). All’interno delle mura sicostituirono, come avveniva nelle altre città, iluoghi del mercato (Carra Manna, attuale PiazzaTola), delle attività artigiane e delle istituzioni (laplatha con la sede del Comune).La rete di villaggi che ruotava intorno a Sassari, eche costituiva il territorio di Romangia eFluminargia, venne in gran parte incorporata neldistretto comunale e amministrata da ufficialinominati dal governo civico. Centri comeBosove (oggi Latte Dolce), Enene (Eba Ciara),Innoviu (Li Punti), Eristala (S. Giovanni) e Ottavacontribuirono nel momento dello sviluppo diSassari a popolare la nuova città, che d’altraparte si arricchì della massiccia immigrazione dielementi toscani, liguri, corsi e sardi. Lo stessodialetto sassarese si formò nel corso del tempocome un ibrido di apporti logudoresi, italiani esuccessivamente catalani e castigliani.Gli Statuti trecenteschi danno conto di intenseattività artigiane (muratori, carpentieri, fabbri,conciatori, pellicciai, orafi, ecc.), che, oltre al mer-cato urbano, dovevano soddisfare le esigenzedei villaggi del vasto retroterra rurale delLogudoro, in un periodo di grandi trasformazionieconomiche e sociali.
LE CARATTERISTICHEDELLA CITTÀ COMUNALE
Agli inizi del XIII secolo Sassari conobbe unostraordinario sviluppo, determinato dalla feliceposizione nella Sardegna nord-occidentale. Erainfatti il punto terminale del sistema produttivodel giudicato di Torres – la cui crisi risale allametà del Duecento – basato su un’intensacerealicoltura, sulla pastorizia e sull’allevamentodel bestiame. Sassari poteva contare inoltre sulvicino scalo portuale di Torres, che significativa-mente nelle fonti è talvolta denominato “portodi Sassari”. La cronaca medievale nota comeLibellus Iudicum Turritanorum ci descrive loscalo protetto da una torre con i magazzini distoccaggio delle merci e una forte presenza dioperatori italiani. La posizione collinare della città, lontana dallepianure malariche, grazie anche alla presenza disorgenti naturali aveva favorito lo sviluppo delleattività agricole specializzate (vigneti, orti e frutte-ti) e di quelle molitorie. La costruzione dellacinta muraria negli anni Trenta del Duecento rap-presentò la definitiva affermazione dell’identitàurbana rispetto alla vecchia organizzazione dellavilla, menzionata nel XII secolo come Thatharinel condaghe di S. Pietro di Silki (registro patri-moniale dell’omonimo monastero benedettinofemminile). Anche la struttura urbanistica, primaconcentrata intorno alla pieve di S. Nicola e alpozzo ancor oggi denominato Pozzo di Villa, si
Mazza civica
consultato in ogni evenienza. Oggi questaimportante fonte può essere consultata pres-so l’Archivio Storico del Comune di Sassari.Nel 1323 una delegazione di eminenti citta-dini sassaresi si recò a Barcellona per conse-gnare al re d’Aragona Giacomo II le chiavidella città. In odio ai dominatori genovesi, ilComune si poneva spontaneamente sotto lasovranità della Corona catalano-aragoneseche, in cambio, gli avrebbe riconfermato isuoi Statuti e le sue franchigie. Sassari cosìdiventava “città regia”: nel suo stemma insie-me alle torri sarebbero state inserite le bandecatalane gialle e vermiglie. La nuova domina-zione iberica avrebbe modificato la strutturaamministrativa della municipalità: il podestàsarebbe stato sostituito nel corso degli annida un vicario (veguer), un ufficiale regio pre-posto al controllo della vita cittadina, e da unconsiglio civico ristretto di cinque consellerso iurats, insieme ad un più ampio Consellcon funzioni consultive. Questo regimesarebbe stato riformato, non senza contrastitra la municipalità e la Corona, nel XVI seco-lo quando venne introdotto il sistema dell’e-strazione a sorte dei consiglieri e degli ammi-nistratori civici (clavari, obrer, amostassen) icui nominativi erano inseriti in palline di cera(rodolins) posti dentro un’urna. Tale sistemarimase in vigore sino alla riforma sabauda del1771, quando i consiglieri vennero sceltidirettamente dal sovrano in base a liste dinomi presentati dalle autorità governative.Il Palazzo di Città, sede dell’antico consigliocivico, ubicato al centro della platha, primadella ricostruzione ottocentesca dell’ingegnerGiuseppe Cominotti, era un edificio medieva-le con un’ampia loggia all’interno della qualesi svolgevano le attività commerciali. Il palaz-zo subì gravi danni durante la breve occupa-zione francese nel 1527 e durante i tumultiper la mancanza di pane del 1780. Inentrambi i casi i danni maggiori vennero arre-cati all’archivio civico con la devastazione el’incendio delle carte.
LE ISTITUZIONI MUNICIPALIE IL PALAZZO DI CITTÀ
Il Comune di Sassari nacque nella secondametà del XIII secolo, come Comune “pazio-nato”, cioè sottoposto ad una Dominante –prima Pisa, poi Genova – che inviava il pode-stà col compito di esercitare un controllopolitico sulla vita amministrativa e commer-ciale, lasciando però una relativa autonomiaai ceti dirigenti locali rappresentati dalConsiglio degli Anziani (cui spettava il potereesecutivo) e dal Consiglio Maggiore, un’am-pia assise composta da coloro che godevanodel privilegio di cittadinanza, cioè dal populussassarese.Il Palazzo di Città doveva quindi essere giàcostruito nel 1272, quando il Comune diSassari accolse da Pisa il podestà Arrigo daCaprona e i suoi collaboratori. Conosciamoaltri nomi di podestà pisani: GottifredoSampante nel 1282 e Tano Badia de’Sismondi nel 1283.L’edificio sorgeva al centro della platha deCotinas, l’arteria principale della città (l’odier-no corso Vittorio Emanuele II) che collegaval’attuale Porta Sant’Antonio con la PortaCastello; nei porticati della platha – alcuni deiquali ancor oggi visibili – erano ubicate lebotteghe dei mercanti. Nel 1294 la conven-zione tra il Comune di Sassari e quello diGenova, firmata da sindici e ambasciatoridella comunità locale, confermava l’esistenzadi un corpo statutario definito come “anti-quas consuetudines et constitutiones”.Iniziava allora la dominazione genovese:come Pisa, Genova avrebbe inviato a Sassarii propri podestà. Conosciamo i nomi diOttone Boccanegra (1300 circa), Rolando diCastiglione (1313), Cavallino degli Onesti(1316), Alberano Salvago e Cicala dei Cicala(in anni imprecisati del Trecento).Nel 1316 il podestà Cavallino degli Onestiavrebbe emanato gli Statuti di Sassari in lin-gua sarda logudorese, un codice articolato intre libri: nel primo sono comprese le normerelative al diritto pubblico e a quello agrario;nel secondo le norme di diritto privato e didiritto processuale; nel terzo quelle di dirittocriminale. Il codice pergamenaceo era con-servato nel Palazzo Civico e poteva essere
13GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
14 GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
La testimonianza più rilevante della civiltà comu-nale sassarese è il codice degli Statuti, emanatinel 1316, ma rielaborazione di un precedentecorpus normativo promulgato durante il dominiopisano. I 252 capitoli che compongono i tre Libri,composti originariamente in latino e poi tradotti insardo, regolano ogni aspetto della vita cittadina:dai prezzi delle merci ai luoghi dove si potevavendere, dalle cariche amministrative all’artigiana-to alle disposizioni in materia edilizia, dal dirittoagrario a quello criminale, al governo del contado.Nel Palazzo della Provincia un grande dipinto delpittore catanese Giuseppe Sciuti ricorda la firmadella convenzione con Genova (1294) come ilvero e proprio atto di nascita della tradizione
SASSARI DAL MEDIOEVO AD OGGI
Il nome di Sassari (Thathari) appare per la primavolta, insieme alla chiesa di S. Nicola, nel conda-ghe di San Pietro di Silki, registro patrimonialedel monastero benedettino femminile ubicatonell’odierna periferia della città, redatto nei seco-li XII-XIII. Thathari era allora uno dei tanti villaggidel giudicato di Torres, governato dalla dinastiadei De Laccon, che comprendeva le regioninord-occidentali della Sardegna.Il giudicato entrò in crisi intorno alla metà delDuecento, sia per la sempre maggiore ingerenzadi Pisa e di Genova, con i loro interessi politici ecommerciali, sia per l’inadeguatezza delle anticheistituzioni incapaci di interpretare le nuove istan-ze e le esigenze del nascente mondo urbano.
per sorvegliare con una guarnigione armata l’in-quieta città. Il maniero verrà abbattuto con unadelibera municipale del 1877. Alla fine delTrecento Sassari fu conquistata temporaneamen-te dai giudici di Arborea e rientrò definitivamentein possesso della Corona d’Aragona nel 1410.Nel periodo di massima espansione la città con-tava circa diecimila abitanti, era cinta da mura eda torri, di cui rimangono ancor oggi parzialmen-te le vestigia. Il Quattrocento segna un momen-to di forte sviluppo dell’economia urbana chesuggella una netta egemonia politica ed econo-mica sul territorio feudale circostante, di cui sonotestimonianza le fertili campagne, caratterizzateda orti, vigne ed oliveti.
comunale sassarese. Tuttavia, al di là della cele-brazione tardo-ottocentesca il dominio genove-se doveva pesare non poco, se nel 1323 un’am-basciata di cittadini di Sassari si recò a Barcellonaper sollecitare l’intervento del re d’Aragona inquella Sardegna che papa Bonifacio VIII gli avevaconcesso in feudo nel 1297.Così, quando il corpo di spedizione catalano-ara-gonese sbarcò nel Sulcis nel 1323, i Sassaresifurono i primi a rendere omaggio ai nuovi conqui-statori. Tuttavia il clima di diffuso malcontentoverso i nuovi dominatori iberici portò già negli anni1324-26 ad una serie di rivolte duramente repres-se. Fu allora che i Catalano-Aragonesi costruironoun munito castello nell’attuale omonima piazza,
15GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
Plastico del castello aragonese
16 GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
Collegio che avrebbe preso il suo nome e aprì laprima tipografia.Sassari subì un terribile colpo con la grande pestedel 1652 che, secondo le statistiche del tempo,avrebbe dimezzato addirittura la sua popolazio-ne. Inoltre, il vasto territorio costiero della città,che abbracciava la Nurra, l’isola dell’Asinara e illitorale sabbioso di Platamona era continuamen-te colpito dalle incursioni barbaresche che, adispetto delle numerose torri difensive, riusciva-no a razziare e terrorizzare le popolazioni.Soltanto nella seconda metà del Settecento ilgoverno sabaudo durante l’illuminato ministerodel conte Bogino (1759-1773) varò importantiriforme agricole (Monti Frumentari, diffusione diuna cultura agronomica, incentivi per le coltiva-zioni pregiate, lotta all’usura, ecc.), che favoriro-no la crescita economica e civile di Sassari nellasua vocazione più autentica, quella contadina(soprattutto ortolana). Venne favorita con privile-gi e incentivi la coltivazione degli ulivi che ancoroggi caratterizza il paesaggio dell’agro. Boginoriformò inoltre nel 1765 l’Università, che rinno-vava i corsi di giurisprudenza, di teologia e di
Durante i secoli XVI-XVII Sassari e la Sardegnavengono investite dalle guerre mediterraneecontro i Turchi e i Francesi. Nel 1527 la cittàdovette subire il saccheggio delle truppe del redi Francia comandate da Lorenzo Orsini.Seguirono l’acquartieramento dei fanti dei solda-ti spagnoli con angherie e distruzioni, carestieterribili e due pesti, nel 1528 e nel 1582. Fu pro-babilmente per implorare la cessazione di unapestilenza che nel XVI secolo si affermò l’uso diportare in processione il 14 agosto di ogni anno,come ex voto delle corporazioni degli artigiani(Gremi) e della città, i caratteristici ceri in legnodetti Li Candareri, che rappresentano la FesthaManna dei Sassaresi.Evento importante nella storia cittadina è, nel1562, l’apertura di uno Studio generale deiGesuiti da cui sarebbe nata successivamentel’Università: un’istituzione che attraverso i tempiha funzionato da punto di riferimento dellaSardegna settentrionale e ha formato interegenerazioni di classi dirigenti. All’inizio delSeicento l’arcivescovo di Oristano AntonioCanopolo, sassarese di nascita, creò nella città il
Veduta della città, incisione di Giacinto Maina
risolversi a favore di questi ultimi, che fondaro-no, nel 1891, «La Nuova Sardegna», un quotidia-no destinato a durare a lungo, elessero un lorodeputato, governarono il Consiglio comunalealmeno sino alle soglie della prima GuerraMondiale. Fu un periodo di grande sviluppo eco-nomico, civile e culturale.Nel ventennio fascista la città veniva dotata dialcune importanti infrastrutture (il Ponte diRosello, il Palazzo di Giustizia, grandi edifici sco-lastici, cliniche universitarie) e cominciò, seppu-re lentamente, quello che sarebbe stato unfenomeno imponente nel dopoguerra: la mas-siccia immigrazione dall’hinterland agricolo. Dai44.148 abitanti del 1921 passò ai 51.700 nel1931: nel dicembre del 1966 avrebbe superatoi 100 mila abitanti.Gli anni del dopoguerra sono segnati, come pertutto il resto della Sardegna da un rapido “salto”nella civiltà contemporanea: fenomeni che l’in-dustrializzazione (in particolare l’insediamentodella grande industria petrolchimica nel golfo diPorto Torres) e il turismo di massa (di cuiAlghero fu, come si disse, la “porta d’oro”) sonostati accompagnati, a Sassari, da un processo dirapida terziarizzazione delle attività produttive,con la perdita delle antiche radici contadine cheha provocato non poche contraddizioni nella suaidentità contemporanea.Oggi Sassari è città soprattutto di servizi (ammi-nistrazione pubblica, grandi magazzini, strutturesanitarie, scuole e Università). Può peraltro van-tare di avere dato al Paese, nei primi cinquan-t’anni della Repubblica, due capi di Stato,Antonio Segni (dal 1962 al 1964) e FrancescoCossiga (dal 1985 al 1992) e un grande leaderpolitico come Enrico Berlinguer.
medicina. Fra i più celebri docenti del tempobisogna ricordare l’economista FrancescoGemelli, il naturalista Francesco Cetti e l’anatomi-sta Luigi Rolando. È da questa Università “nuova”che uscirono molti dei patrioti che guidarono, frail 1793 e il 1796, la “sarda rivoluzione”.Nel 1780 la città conobbe una sollevazionepopolare, causata da una terribile carestia, forseaggravata dal comportamento del governatorepiemontese, interessato a speculare sui grani. Lafolla invase forni e case, devastò il palazzo civi-co, bruciò le carte degli archivi; i moti finironocon otto condanne a morte.Nel periodo tumultuoso del triennio rivoluziona-rio (1793-1796) Sassari si schierò a difesa deiprivilegi feudali contro il governo cagliaritanodegli Stamenti che ne chiedeva la mitigazione. Ibaroni sassaresi pensarono addirittura alla seces-sione, chiedendo l’intervento del governo britan-nico che occupava allora la Corsica. Nel dicem-bre del 1795 la città fu assediata e occupata daun esercito contadino e quindi governata dall’in-viato degli Stamenti, l’alternos GiommariaAngioy, l’eroe del moto antifeudale. Il suo trion-fale ingresso a Sassari (28 febbraio 1796) è ilsoggetto dell’altro grande dipinto dello Sciuti nelPalazzo della Provincia.Nell’Ottocento la città crebbe ancora sulla spintadi alcuni importanti interventi del governo pie-montese (la costruzione della grande strada perCagliari, intitolata al re Carlo Felice) e grazie all’at-tività di commercianti, spesso di provenienza ita-liana, ma capaci di inserirsi nel tessuto produtti-vo cittadino e di sfruttare le ricche risorse di un’a-gricoltura progredita (l’olio, il vino, le pelli concia-te, il tabacco). Di fondamentale importanza fu“l’uscita” della città dalla chiusa cerchia dellemura: nel 1837 fu approvato il primo pianoregolatore e si cominciò a costruire in quelle chesi chiamavano “le appendici”. La città perdetterapidamente il suo volto medievale, in seguitoalla terribile epidemia di colera del 1855, peracquistarne uno più nuovo e moderno, da cuideriva direttamente quello attuale: caddero par-zialmente le mura, si edificò la grande Piazzad’Italia, si costruirono grandi palazzi pubblici ebelle case private. La costruzione della ferroviacollegò Sassari direttamente al suo porto natura-le e al resto della Sardegna.Alla fine del secolo la lotta tra i monarchici-con-servatori ed i repubblicani-democratici parve
17GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
BREVE STORIA ARCHITETTONICA DEL PALAZZODI CITTÀ OTTOCENTESCO E DEL TEATRO CIVICO
Il progetto, fortemente condizionato dalle ristret-tezze dell’area, prevedeva al piano terreno unpiccolo teatro, sul modello del Carignano diTorino, l’ufficio postale e il corpo di guardia; alprimo piano, con accesso dallo scalone di rap-presentanza, quattro sale destinate al Consiglio,alla Giunta, al Sindaco e al Tesoriere e, nelle sof-fitte, gli uffici di Segreteria. Il prospetto sul Corso Vittorio Emanuele, che siispira al classicismo purista di impronta palladia-na caro al Cominotti, è diviso in due ordini, scan-dito da quattro paraste ioniche giganti, sormon-tato da un timpano triangolare e con tre distintibalconi, sostituiti in corso d’opera dalla balcona-ta in ferro battuto che corre lungo la facciata, ver-sione moderna dell’antico corredor dal quale siaffacciava il Consiglio.L’ordine inferiore, dalla superficie a bugnatopiano, dipinta in giallo-ocra, ha un portale mar-moreo centinato con l’architrave retto da testeleonine e la lunetta con lo stemma civico, affian-cato da due finestroni anch’essi centinati, men-tre l’ordine superiore ha le pareti lisce, intonaca-te e vivacemente colorate nel caratteristico rossopiemontese, e tre finestre di foggia rinascimen-tale con architrave piano su mensole. Un campaniletto con due campane sovrasta iltimpano di facciata ed è posto quasi in angolocon un grande orologio con volute laterali situa-to sulla cornice superiore della fiancata. Questa,delimitata da due paraste giganti per parte, cheincludono una finestra per piano, ha al centro unportale marmoreo con architrave decorato conemblemi teatrali e timpano piano. La fiancatasviluppa lo schema della facciata ed è ritmatadall’alternanza del bugnato con la superficieliscia delle pareti e dalla sequenza delle apertu-re, centinate al piano terreno, architravate alpiano elevato. Al centro del suo coronamento ècollocata una torretta cilindrica con decorazioniclassicistiche a festoni e ghirlande.
La decisione di ricostruire dalle fondamenta ilpalazzo di città, fatiscente edificio medievalerisalente nel primo impianto al Duecento, piùvolte restaurato e ristrutturato nel corso deisecoli, quindi sgomberato per il pericolo di uncrollo, fu assunta dal Consiglio cittadino nelmarzo del 1825. Come risulta dai disegni recentemente ritrovatinell’Archivio di Stato di Torino1, nel febbraio e nelluglio 1823 l’ingegnere piemontese GiacintoDervieux, inviato in Sardegna al seguito dell’inge-gnere Giovanni Antonio Carbonazzi, incaricato diprogettare e dirigere i lavori della strada di colle-gamento fra Sassari e Cagliari, aveva elaboratoun primo progetto del nuovo edificio comunaleche includeva anche il Teatro. Furono probabilmente quei disegni a persuade-re il sovrano piemontese Carlo Felice ad acco-gliere la richiesta di finanziamento inoltrata dalComune e a concedere un prestito di tremila lireper la realizzazione del nuovo edificio, a condi-zione che si celebrasse in perpetuo una messaquotidiana in memoria del defunto fratello, ilConte di Moriana, morto a Sassari nel 1802. Il progetto definitivo, elaborato dall’ingegnereGiuseppe Cominotti, a Sassari dal 1823, e suc-cessivamente pubblicato fra i disegni che contor-nano la Pianta di Sassari, da lui delineata assie-me all’ingegnere Enrico Marchesi, riprende l’im-postazione del Dervieux e si adegua ai modi cor-renti del neoclassicismo, che caratterizzano l’edi-lizia pubblica e civile del tempo.Il Palazzo di Città, con l’annesso Teatro civico,rappresenta anche la prima opera di edilizia civi-le a Sassari, progettata in linea con la nuova con-cezione urbanistica delineata dal Cominotti,autore del primo piano di espansione della cittàfuori le mura con le nuove Appendici, e la suaedificazione rappresentò un importante occasio-ne di apprendimento delle nuove tecnichecostruttive per le maestranze locali.
19GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
1 Ne ha dato recentemente notizia sulla stampa locale l’architetto Sandro Roggio
20 GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
Duca dell’Asinara, che fu acquistato dalMunicipio trenta anni dopo.Il Palazzo di città venne quindi adibito a sede delTeatro e della scuola civica di Musica. Alla finedel secolo, era diventato inagibile e si resenecessario un importante intervento di restauroe ristrutturazione, fortemente voluto dal sindacoMariotti e concluso nel Millenovecento. In quell’occasione, sotto la direzione del pittoreaccademico torinese Andrea Marchisio, furonorinnovate le scenografie e realizzato sul soffittodella originaria sala consiliare l’attuale affresco
neobarocco che occultò quello classicistico e diispirazione civica, realizzato dal Bossi nel 1851 evenuto alla luce durante l’ultimo restauro. Nel 1947, a causa del cattivo stato di conserva-zione, le strutture lignee originarie e l’apparatoornamentale del teatro realizzato nel primoNovecento furono smantellati e, pur senzaapportare modifiche strutturali che ne alterasse-ro la forma, il Teatro fu allestito secondo unaconcezione moderna.Con l’ultimo restauro, sono state riportato in lucele decorazioni novecentesche nelle sale divenu-te di rappresentanza, e restaurate le soffitte e l’a-diacente edificio, adibiti a spazio museale, riatti-vando l’originario accesso dalla via Satta eattuando un ripristino di strutture, arredi ed ele-menti lignei del Teatro, volto a recuperarne l’ori-ginaria fisionomia ottocentesca.
La fabbrica del palazzo di Città e del Teatro,avviata nel 1826 per opera dell’impresa del bel-linzonese Eugenio Somazzi e dei sassaresi fratel-li Bosinco Fogu, proseguì negli anni successivi.Nell’aprile 1829 giunsero da Genova i due por-tali in marmo e i due busti marmorei raffiguran-ti Goldoni e Alfieri, opera della bottega diFrancesco Orsolini. Nel maggio dello stessoanno, i pittori e scenografi torinesi Pietro Bossi eCesare Vacca, furono incaricati della decorazionedegli interni e delle scene del Teatro. Nel mesedi novembre giunse da Torino il grande lampa-
dario acquistato dal nobile Vittorio Pilo Boyl,deputato alla vigilanza sull’opera. Il collaudo delteatro avvenne nel 1831.Il teatro a ferro di cavallo, cui si accedeva dallavia Satta, era formato da quattro ordini compre-so il loggione, con 50 palchetti cui si aggiungevala piccola platea, e capace di contenere un tota-le di circa 500 spettatori. Nel tempo, palazzo e teatro furono soggetti adiverse riparazioni, ristrutturazioni e ampliamen-ti, compresa l’acquisizione dell’immobile adia-cente nella via Satta, volti a renderli più acco-glienti e funzionali, dato che l’edificio in tempibrevi si rivelò del tutto insufficiente ad espletarela sua doppia funzione, tanto che già nel 1848 iConsiglieri proposero di costruirne uno nuovo! La soluzione fu trovata nel 1879 col trasferi-mento della casa comunale nel palazzo del
Portale del Palazzo di Città, lunetta con lo stemma civico
L’ATTIVITÀ MUSICALEAL TEATRO CIVICO NEL XIX SECOLO
ne di ben quattordici stagioni, e alcuni lavori diGaetano Donizetti e Vincenzo Bellini: Norma,L’elisir d’amore, Lucrezia Borgia e Lucia diLammermoor.Però - almeno sino alla fine degli anni Sessanta- il repertorio compreso nei cartelloni delle sta-gioni del Civico era in gran parte basato su operedonizettiane, cui si associavano prevalentemen-te lavori di Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini,Saverio Mercadante, Giovanni Pacini, GiuseppeVerdi e di quella innumerevole schiera di “mino-ri” di cui non resta quasi traccia nell’attualerepertorio melodrammatico: Luigi Ricci,Valentino Fioravanti, Serafino De Ferrari, NicolaDe Giosa ed altri ancora. Negli anni Settanta fanno poi la loro apparizionele opere più rappresentative di Errico Petrella,Amilcare Ponchielli, Filippo Marchetti e degliautori francesi, in particolare Charles Gounod eJacques Halévy.Il Civico - per ciò che riguarda il teatro musicale- fu attivo essenzialmente nel periodo corrispon-dente alle stagioni di Autunno e di Carnevale.L’ambito temporale nel quale si allestivano glispettacoli della stagione autunnale era moltovariabile, ma solitamente era compreso tra lametà del mese di ottobre e i giorni immediata-mente antecedenti il Natale. La stagione diCarnevale, tradizionalmente, aveva invece inizioil 26 dicembre, giorno di S. Stefano, per conclu-dersi il martedì di Carnevale. Solitamente unastessa compagnia allestiva gli spettacoli delledue stagioni, che di norma prevedevano com-plessivamente sei titoli.In quasi tutti i contratti stipulati negli anniSettanta dell’Ottocento con le imprese teatrali èrichiesto alla compagnia un numero minimo dirappresentazioni che va dalle 50 della stagione1877 - 78 sino alle 80 della stagione 1878 - 79.Quest’ultima stagione costituì peraltro un caso asé, visto che era la prima in cui un’impresa costi-tuita da una società di cittadini di Sassari avevachiesto al musicista sassarese Luigi Canepa
L’apertura del Civico al teatro musicale ebbeluogo nella primavera del 1831, con una primastagione completa affidata alle cure del romanoPietro Ansiglioni, un basso che si era dato all’or-ganizzazione di stagioni teatrali e che aveva otte-nuto l’impresa del Teatro Regio di Cagliari. Ma non si trattava del primo ingresso della musi-ca nel nuovo teatro. Il Civico aveva infatti ospita-to l’esecuzione di due composizioni celebrativescritte dal maestro di cappella del Duomo diSassari Francesco Vegni: un Inno (1829) e unaCantata (1830) composta in onore di MariaCristina di Borbone, entrambe eseguite in formascenica. Inoltre il Civico era stato sede di alcuneaccademie, una delle quali tenuta nel 1830 dalcompositore palermitano Nicolò Oneto, che pro-prio in quell’anno sbarcava in Sardegna per assu-mere l’incarico di maestro di cappella ad Alghero.La compagnia di Ansiglioni ripropose a Sassari -nel mese di aprile - le stesse quattro opere pre-sentate a Cagliari: l’Elisa e Claudio di SaverioMercadante e Il barbiere di Siviglia, la Matilde diShabran e La Cenerentola di Gioacchino Rossini.L’orchestra venne formata in buona parte damusicisti della Cappella musicale del Duomocome Clemente Canobbio, primo violino, e lostesso Francesco Vegni, maestro al cembalo. A partire da questa stagione e sino al 1884 - annodi apertura dell’altro teatro sassarese, il Politeama- il Teatro Civico divenne la sede naturale di quasitutti gli spettacoli melodrammatici dati a Sassari.L’attività del Civico fu pressoché continua: solo intre stagioni Sassari non potè godere della musica,quando il teatro venne chiuso nel 1835 - 36 e nel1852 - 53 per cause di forza maggiore e nel1855 - 56, al tempo della terribile epidemia dicolera che si abbattè sulla città. Secondo Enrico Costa nello spazio di tempocompreso fra il 1831 e il 1884 si diedero alCivico 301 opere in musica, cioè 153 per laprima volta e 148 ripetute. Fra le opere maggior-mente rappresentate figurano Il barbiere diSiviglia di Rossini presente nella programmazio-
23GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
24 GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
(1849 - 1914) di dirigere le sei opere previste:fra queste erano presenti i primi due lavori scrit-ti dal compositore per i teatri milanesi, il DavidRizio e I pezzenti.La composizione dei cartelloni - nel corso dipoco più di mezzo secolo - consente di ricostrui-re i mutamenti del gusto del pubblico e le sueaspettative. Nei primi trent’anni circa di attivitàdel Civico era l’amministrazione comunale adinteressarsi direttamente alla definizione del car-
tellone: se inizialmente la tendenza era volta agarantire la compresenza di opere che avevanogià riscosso successo al Civico con opere maieseguite a Sassari, già nel corso degli anniSessanta si nota un progressivo prevalere deititoli appartenenti al cosiddetto “repertorio”.Anche i generi delle opere rappresentate rifletto-no le trasformazioni del gusto teatrale e musica-le. Nelle stagioni comprese nei primi venti annicirca di attività infatti le opere buffe sono spesso
25GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
1831, proprio l’anno in cui s’inaugurava nel tea-tro nuovo di Sassari la stagione di opera lirica.Il Civico riaprirà grazie all’iniziativa del sindacoMariotti. Dopo un radicale restauro, l’1 gennaiodel 1900 il teatro accolse quella che fu peraltrola sua ultima stagione lirica. Ad inaugurarla fu laBohème di Puccini, cui seguirono la Lucia diLammermoor di Donizetti, la Dinorah diMeyerbeer e il David Rizio di Luigi Canepa, ilquale fu impegnato anche come direttore.
di numero pari a quelle serie, ma durante laseconda metà del secolo queste proporzionisono destinate ad essere progressivamentemodificate a vantaggio dei drammi musicali.L’apertura del Politeama sancì l’inevitabile tra-monto del Civico, che assolse comunque sinoalla fine il suo compito con una stagione che sichiuse - nel febbraio del 1884 - con La sonnam-bula di Bellini, creata dal cigno catanese - anno-ta con una punta di amarezza Enrico Costa - nel
Ingresso sala del teatro
IL PALAZZO DI CITTÀTRA RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTAZIONE
1830 le due anime incarnate dall’edificio cui hadato recente vita, inscindibili pure dal punto divista tecnico oltre che funzionale. Al di là dellemotivazioni che portarono ad una tale decisione,il risultato fu quello di avere in una stessa unitàarchitettonica due funzioni importanti per lasocietà locale: il luogo della “rappresentanza”nella parte destinata al Municipio e il luogo della“rappresentazione” nel Teatro. Lo spazio origina-rio, accresciuto dall’area di una casa attiguaacquistata dal Comune, venne diviso tra la zonadestinata al nuovo teatro e quelle proprie dicompetenza degli organi consiliari e dell'ammi-nistrazione civica. La peculiarità della strutturaarchitettonica sta proprio nella contiguità fisica trai due luoghi deputati alla rappresentanza e allarappresentazione, che porta ad una singolarecommistione di ruoli nello stesso spazio fisico:sembra, anzi, che le queste due “anime” vivanoin una sorta di simbiosi mutualistica, così compe-netrate all’interno del Palazzo di Città che riesceproblematico distinguerne i rispettivi contorni.Il nuovo Palazzo Civico, nonostante avesserispetto al precedente spazi più ristretti a causadell'ingombrante teatro, fu sicuramente motivod’orgoglio per la cittadinanza e motivo di ricono-scenza nei confronti del re Carlo Felice, che perl'avvio dell'opera fece dono «grazioso» di tremilascudi, al posto dei quattromila richiesti dalla Cittàe in cambio delle messe perpetue in suffragiodel fratello Conte di Moriana morto a Sassari nel1802. Già nel 1824 - quando la “riedificazione”del fabbricato era ancora un' idea in progetto -era possibile cogliere quale fosse il grado diaspettativa riposta nell'opera, assurta a testimo-nianza della volontà di Sassari di essere città. Per converso, se c’è un dato che fotografa il dif-ficile e per certi versi deficitario funzionamentodella macchina amministrativa municipale citta-dina ancora nei decenni successivi l’Unità èquello legato all’infelice logistica. Già nel 1856, insede di discussione consiliare del progetto di rior-ganizzazione della Segreteria civica, si erano leva-
La casa comunale è l’edificio che più d’ogni altroha rappresentato nel corso dei secoli il punto diriferimento collettivo per Sassari in quanto“luogo” della vita istituzionale, sociale e culturaledella città. Sin dall’ epoca medievale si è prestata coninconsueta versatilità a ricoprire il ruolo di strut-tura pubblica per così dire “polifunzionale”, cheha saputo sopperire nel corso del tempo allacarenza di edifici in grado di ospitare servizi pub-blici: quindi, non solo luogo della “politica” e dell’“amministrazione” con gli spazi destinati agliorgani deliberativi ma anche posto di guardia,caserma dei pompieri e ufficio postale.All’occorrenza gli ambienti della casa comunalesono serviti per l’esercizio di funzioni forse menonobili ma certamente altrettanto, se non più,vitali per la vita collettiva della Sassari di AnticoRegime, quali quelle connesse alla mera sussi-stenza della popolazione: non sarà prosaicoricordarne l’utilizzo come deposito per le grana-glie e addirittura come ricovero del bestiame chein certe situazioni di emergenza venne ospitatonella Loggia, cioè al pianterreno del palazzo. Ma la casa comunale ha esercitato un’ altrettantoimportante funzione sociale in quanto luogo dell’“effimero” destinato ad ospitare le rappresenta-zioni di compagnie di commedianti e saltimban-chi che approdavano in città: in buona sostanza,funzioni da spazio teatrale ante litteram.
… Collaudare ed estimare il Teatro però riflette-re all’intima connessione del medesimo colPalazzo Civico, quali due edifizi in varie parti s’internano l’uno nell’altro e non formano che uncorpo solo, riesce impossibile di prescriverne iloro limiti e per conseguenza impraticabile ladivisione delle loro perizie di stima ...
Così, Giuseppe Cominotti, progettista e direttoredei lavori del nuovo Palazzo di Città voluto dagliamministratori sassaresi nel luogo e in luogo del-l’antica casa comunale, fotografa nel giugno del
27GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
28 GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
te personale ed uffici cresciuti in conseguenzadei nuovi compiti affidati al Comune faceva dacontraltare l'inidonea capienza del teatro ormaiinsufficiente ad accogliere un pubblico semprepiù numeroso. Nel 1867 il sindaco “acquarelli-sta” don Simone Manca aveva pubblicato unfascicoletto di una ventina di pagine incentratesulla proposta d’ampliamento della casa munici-pale e di costruzione di un nuovo teatro: di quila proposta di destinare il Palazzo di Città allasola funzione di sede dell’amministrazione civica
e di trasferire il teatroaltrove, precisamentenell’area del carcere diSan Leonardo in via didismissione. Questoera un immobile gran-de, centrale e si affac-ciava sulla CarraGrande (l’attualePiazza Tola) tramite ilpalazzo che il Comuneaveva acquistato pocotempo prima dal ducadi Vallombrosa (attual-mente conosciutocome «palazzettod’Usini»).L’Ufficio d’Arte delComune predisposeanche un progetto perla riedificazione delnuovo municipio nell’a-rea occupata dalPalazzo di Città edancor prima dall’antica
casa comunale lungo la ruga de Cothinas men-zionata negli Statuti Sassaresi: progetto poi accan-tonato «a causa della ristrettezza e forma dell’areadisponibile», non rispondente alle esigenze deiservizi comunali. Ma la fame di spazi dell’AmministrazioneComunale rimase. Col trasferimento del ducadell’Asinara a Parigi, la settecentesca dimora difamiglia rimase disabitata e finì per essere affit-tata; essendo uno dei rari immobili di pregiodella città, fu adibita a sede delle più importantiistituzioni: ospitò la Prefettura el’Amministrazione Provinciale. Quando nel 1878,l’Amministrazione Provinciale abbandonòPalazzo Ducale, il Comune di Sassari, ancora alla
te le proteste di quanti ricordavano «come il difet-to di locale si fosse dal Consiglio addotto comecagione degli incagli sperimentati nella spedizio-ne dei lavori e nel disbrigo degli affari tutti concer-nenti il servizio burocratico municipale».L’angustia del Palazzo di Città relegava in soffittagli spazi della Segreteria; faceva eccezione l’uffi-cio di Tesoreria, posto in quello stesso primopiano destinato ad ospitare gli organi deliberativied alla rappresentanza e che si differenziavadagli altri ambienti di lavoro per la ricca dotazio-ne di argenti che loimpreziosivano, a signi-ficare una netta distin-zione di ruoli: parurecomposta di «piatto,due calamai coi rispet-tivi coperti, due porta-penne, un campanelloe una piccola bugia» epoi ancora «una sfera,una pisside, un turibo-lo, una navicella, tuttoin argento». Anche aSassari, come in altrerealtà comunali italianedel periodo, era difficilecircoscrivere l’area delpersonale comunalesia per le moltepliciforme di rapporto dilavoro poste in esseresia per l’ampia gammadi figure gravitanti piùo meno a lateredell’Amministrazione.Nello specifico, dal 1856 la Segreteria civicaviene articolata in tre sezioni con undici impiega-ti che nel 1864 salgono a tredici un segretario,quattro sottosegretari, sette scrivani, un architet-to: tutti in soffitta.L’angustia degli spazi del Palazzo di Città, in cuioltre agli uffici comunali aveva trovato collocazio-ne al piano terra anche il posto di guardia e l'uf-ficio postale, impose alla città l’esigenza di dotar-si di un nuovo palazzo comunale: un obiettivoper così dire “trasversale” di tutte le amministra-zioni succedutesi al governo del Comune diSassari nella seconda metà dell’Ottocento. Alla ristrettezza dei locali della casa municipaleche non era in grado di ospitare adeguatamen-
Ritratto del Sindaco Gaetano Mariotti
Feliciano del 1827 giustificando, così, la persi-stenza dell’antica denominazione di MagistratoCivico i cui giudizi si tengono nel Civico Palazzo.Nel nuovo Palazzo di Città entrano e lavorano gliorgani deliberativi espressione del nuovo ordina-mento ispirato ad una sempre più rigorosa sele-zione delle classi dirigenti locali. Il ConsiglioGenerale, composto di ventiquatttro membri epresieduto dal sindaco, doveva radunarsi almenoquattro volte nel corso dell’anno il 15 di aprile,luglio, ottobre e dicembre; eccezionalmente, inseduta straordinaria, tutte le volte che veniva con-vocato dal Regio Commissario o dal ConsiglioParticolare. Il Consiglio Generale si occupava diamministrare i fondi e i reddti della città; esami-nava il bilancio compilato dal ConsiglioParticolare; esaminava i progetti relativi alle operepubbliche; emanava regolamenti in materia dipersonale, previa autorizzazione viceregia.Il Consiglio Particolare, composto di dieci consi-glieri, aveva l’obbligo di riunirsi almeno una voltaalla settimana. La riforma del 1836 comportòuna più articolata distribuzione delle competen-ze al suo interno: l’ufficio dell’amostassen, anti-co retaggio aragonese, venne soppresso e sosti-
ricerca di una sede che assommasse prestigio efunzionalità, si sostituì come affittuario e vi trasfe-rì la sede di rappresentanza e gli uffici ancorasparsi in diverse sedi «con grave discapito delservizio pubblico». Così, dice Enrico Costa, Sassari ebbe «due palaz-zi di Città: l'uno destinato agli uffici, l'altro a di-sposizione della cittadinanza per conferenze,cinematografo, riunioni ed altri usi».
LUOGO DELLA RAPPRESENTANZA
Forse è non solo frutto di banale casualità lacoincidenza temporale riscontrabile tra l'abbatti-mento dell'antica casa comunale, simbolo dellaSassari di Antico Regime, e la fase conclusivadello sbriciolamento dell’antico ordinamentomunicipale catalano - aragonese attraverso leprogressive modificazioni introdotte dal governosabaudo: solo in ambito giurisdizionale, il pervi-cace attaccamento della municipalità all’istitutodel proomenato - il diritto di giudicare in primaistanza i cittadini sassaresi accusati di reati pena-li - farà sì che questo venga accolto nel Codice
29GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
Ingresso sala del teatro
30 GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
nell’ufficio comunale ... molti si fecero radiareper motivi di salute. Ond’è che si tennero giun-te col solo sindaco ed un solo consigliere». Il passo dell'archivista sassarese lascerebbe tra-pelare un'immagine della classe dirigente cittadi-na poco incline ai doveri di rappresentatività poli-tica propri dello status, tale da farli disertare lesale del Palazzo di Città diventate di colpo trop-po grandi per loro. Ma il nuovo Palazzo di Cittàfu anche teatro di una fase epocale della storiadel Comune: l'insediamento, nel 1848, deiprimi organi deliberativi elettivi - sia pure a suf-fragio molto ristretto - che rappresenta l’atto dinascita del comune moderno in Sardegna dopola trasformazione dello stato sabaudo in monar-chia costituzionale e parallelamente all’emana-zione dello Statuto e all’apertura della cameradei deputati Subalpina. Il Consiglio Generale - ora ribattezzato Comunale- tornò all’antica composizione numerica di qua-
tuito da un organo misto formato dal vicario dipolizia, dal sindaco e da un consigliere, concompetenze in materia annonaria. Alcuni mem-bri curano gli aspetti connessi allo sviluppo urba-nistico - edilizio con la predisposizione del pianod’ornato della città. Un membro del ConsiglioParticolare era indicato come Padre degli Orfanicui era demandata la gestione dell’assistenzaagli esposti. Muta anche la foggia degli abiti con-siliari che i rappresentanti civici chiedono dipoter adeguare al gusto di quelli in uso negliStati Sabaudi in terraferma.In quel tempo, si affermò il principio della gratui-tà delle cariche civiche, punto molto caro aEnrico Costa che così commenta il provvedi-mento: «mentre nel passato i cittadini si racco-mandavano a tutti santi della terra e del paradi-so perché il viceré li comprendesse nellaMatricola, in seguito divennero apatici e riluttan-ti ad ogni invito. Nessuno voleva prestar servizio
Sala dell’Intregu
Non più sede del Comune già dalla secondametà dell’Ottocento, ancora oggi il Palazzo diCittà incarna la sua funzione di luogo - simbolodi tutta Sassari in occasione della festa più amatae sentita dalla popolazione, la discesa deiCandelieri del 14 agosto. Per l'intera giornata ilPalazzo ridiventa idealmente la Casa Comunaledi tutti, al cui balcone sventola dalla mattina lostendardo con l’effige di Nostra Signora delleGrazie, patrona del Gremio dei Massai e ideal-mente della città intera. Il passaggio più significativo è dato dall’arrivodel gremio dei Massai nel salone del Palazzoche nell’Ottocento ospitava le sedute delConsiglio Comunale.La tradizionale sosta all’interno del Palazzo diCittà ristabilisce attraverso il cerimoniale, che haragione di essere solo in quel preciso luogo, illegame viscerale di Sassari con la propria storia,le proprie tradizioni, le proprie istituzioni: vincoloche si rinsalda e si rinnova nella beneaugurantee liberatoria formula a zent’anni del brindisi dichiusura. Qui si consuma il rituale fortementesimbolico dello scambio di insegne traMunicipalità e gremio dei Massai in cui si iden-tifica l’intera popolazione di Sassari, città a fortevocazione agraria: il sindaco consegna la ban-diera del gremio, esposta sin dal mattino al bal-cone del Palazzo di Città, all’obriere maggioreuscente e affida il gonfalone del Comune diSassari al nuovo obriere maggiore.Raggiunta l’uscita del Palazzo di Città, il vecchioobriere maggiore dei Massai saluta con la ban-diera del gremio il Sindaco in segno di deferen-za e rispetto. Poi, insieme ai rappresentanti dellaMunicipalità, ricompongono il corteo per rag-giungere la chiesa S. Maria di Betlem e scioglie-re e rinnovare il Voto alla Vergine Assunta.
LUOGO DELLA RAPPRESENTAZIONE
Dal secolo dei lumi in avanti il teatro è chiama-to a diventare un cardine del processo di abbel-limento delle città in piena espansione econo-mica e demografica; si tratta di un fenomeno diportata europea che interessa grandi realtà urba-ne e periferici capoluoghi di provincia: tutti sen-tono l'esigenza di un “modello” di teatro cheoffra garanzie di dignità e di adeguato inserimen-to nel contesto urbano.
ranta consiglieri, come ai tempi di Aragona eSpagna e dei primi cinquanta anni di governosabaudo, sino alla riforma dei consigli civici del1771. Il Consiglio Delegato (o Giunta) era com-posto da nove consiglieri. Il 1848 sassareseconobbe proprio nel civico teatro uno deimomenti di grande tensione ospitando le arrin-ghe del capopopolo Antonico Satta contro il par-tito dei moderati locali.A Sassari le prime elezioni comunali si tennero il21 dicembre 1848. Per avere un'idea di quanto“smilza” fosse la lista elettorale in una città checontava 20.000 abitanti basterà osservare che ilpiù votato, il commerciante Sebastiano Brusco,riportò 261 voti contro gli 85 dell'ultimo dei con-siglieri eletti, il cav. Simplicio Maffei. Viceversa, ilsindaco - che aveva la doppia qualità di capodell’amministrazione comunale e di ufficiale delgoverno - era ancora di nomina regia.Don Antonio Ledà d'Ittiri fu il primo sindaco dellaSassari “costituzionale” a occupare le sale delPalazzo di Città.
TRA RAPPRESENTANZAE RAPPRESENTAZIONE
Al di là del dato meramente strutturale dell'edifi-cio, il rapporto tra rappresentanza e rappresenta-zione non poteva vivere in un contesto di sepa-ratezza, raccogliendo in seno l'uno elementi del-l'altro. Palazzo di Città, sede della rappresentan-za municipale, è il luogo che, debitamente illu-minato, viene deputato alla celebrazione deifesteggiamenti per matrimoni e lieti eventi deiregnanti e poi per le feste politiche nazionali:una sorta di contraltare laico al Tedeum inCattedrale in cui si consuma la messa in scenadel potere in periferia sotto i simboli di cui i cetidirigenti cittadini sono espressione.Poi, le feste civiche popolari costituivano i conte-sti per così dire naturali i cui il rapporto tra rap-presentanza e rappresentazione aveva modo dideclinarsi anche all'interno delle “cose” più pret-tamente afferenti l'aspetto della rappresentanzaistituzionale con dinamiche che andavano benal di là della formalità del protocollo per toccarel'ambito della più vivida e sentita partecipazione:potremmo dire da “civica rappresentazione”,come nel caso dell’iniziale scambio di insegneda cui prende corpo il lungo rituale dell'intregu.
31GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
nell'orchestra: fatta eccezione per le donne,coristi e orchestrali erano impiegati, studenti eartigiani locali. Eppure, anche se «al Civico tutto era in famiglia»,viene male immaginare che lo spettacolo fosseesente dalle dinamiche funzionali all'attrazioneche lo stesso esercitava non solo tra palcosceni-co e spettatori ma tra gli stessi spettatori: ancheal Teatro Civico di Sassari, ci si compiaceva dimostrarsi in platea o nei vari palchi, a secondadel ceto sociale, stretti nelle convenzioni delleapparenze, della nascita, della carica ricoperta. Dipiù, i consiglieri civici sedevano nel palco delleautorità non da meri spettatori ma da ammini-stratori – impresari del Teatro, responsabili dellerappresentazioni che andavano in scena, attor-niati nei palchi di primo e secondo ordine dairappresentanti delle famiglie cittadine di cuierano l’espressione. Già alla fine degli anni Settanta dell'Ottocento, ilTeatro Civico risulterà troppo piccolo per la“fame” di spettacolo teatrale dimostrata dallacittà alla quale occorreva un locale con unacapienza almeno doppia: esigenza soddisfattadall'apertura del Politeama che coincise con lachiusura del Teatro Civico, piccolo e non in rego-la rispetto alla nuova normativa in materia disicurezza. Il “Civico” riaprirà nel 1900 dopo gliimportanti lavori di restauro fatti realizzare dalsindaco Mariottti.La mai troppo deprecata dispersione che hainteressato i documenti relativi all'attività e alleproduzioni del Teatro Civico, oltre a rendereparziale un'eventuale anche se ormai doverosastoria della più importante emergenza architet-tonica pubblica cittadina, che tanto rappresen-ta ancora per lo spirito civico della città, nonconsente di delinearne con maggior dettaglio ilruolo di luogo “condannato” per così dire sindalla nascita a incarnare le funzioni della rap-presentanza e rappresentazione, fuse in ununicum inscindibile.
L'edificazione del civico teatro di Sassari rientra apieno titolo in questa temperie culturale in cui ilteatro aveva acquisito cittadinanza nell'insiemeurbano: «non esiterei a affermare - dirà EnricoCosta - che la costruzione della nuova casacomunale era servita di pretesto per potercostrurre un nuovo centro di spettacoli tanto carialle dame e cavalieri di quel tempo». Però a differenza della tendenza generale volta,oltre che a definire chiaramente la struttura dellocale destinato al pubblico, a conferire un'i-dentità ben riconoscibile alla sua architetturacosì da renderlo necessariamente ben distintodalle altre emergenze architettoniche cittadine- quali dice Haupt - il mercato coperto o ilmunicipio stesso, il caso sassarese è proprio unesempio di mix irrisolto di municipio e teatro. Del resto, per tradizione il palazzo del Comuneaveva sempre avuto al suo interno gli spazidedicati allo spettacolo: dal Cinque - Seicentofu il cortile della casa comunale ad ospitare lecompagnie itineranti di comediants che appro-davano a Sassari, passando poi per il primoteatro con palchetti, oggetto di contesa tranobildonne sassaresi, distrutto / o smontatodurante i moti rivoluzionari angioini di fineSettecento sino ad arrivare al primo decenniodell'Ottocento col primo teatro stabile inembrione dotato di palchetti e un palcoscenicomunito di attrezzi. Al posto del cortile, nel cuoredel più importante palazzo pubblico cittadinosarebbe sorto il Teatro Civico.L'organizzazione degli spazi interni del civicoteatro sassarese ricalca la tradizione del teatroall'italiana, col sistema dei palchi alveolatisovrapposti in più piani che secondo Cochin,disegnatore delle fabbriche del re di Francia,risultava molto funzionale allo stile di vita impe-rante nella penisola: «i loro palchi sono per essipiccoli appartamenti dove ricevere e stare incompagnia». Anche il civico teatro sassarese fuedificato secondo i criteri strutturali e decorativiallora in voga: pianta a “ferro di cavallo”, serie ditre ordini di palchi più il loggione, palco di rap-presentanza per le autorità.Aldo Cesaraccio fa rilevare come la stessa strut-tura del teatro con molti palchi e un piccolologgione stava a dimostrare che «le distinzionidi classe non dovevano esistere» in quanto ilpubblico era popolo e di estrazione popolareerano quelli che operavano sul palcoscenico e
33GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
35GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
PALAZZO DI CITTÀIL PERCORSO ESPOSITIVO
L’ala est con l’ingresso su via Sebastiano Satta,ospita la sezione dedicata a:
L’abbigliamento nella vita quotidiana tracittà e campagnaIl sacro e il profano
L’ala ovest del palazzo che si affaccia sul corsoVittorio Emanuele è destinata ai temi:
Memoria e identitàForma e immagineRappresentanza e rappresentazioneCandelieri
Il percorso espositivo museale allestito negli spazi del Palazzo di Città si divide in due sezioni distinte.
ALA OVESTINGRESSO CORSO VITTORIO EMANUELE II
città di Sassari col disegno de’ suoi principaliedifizi del 1833 di Giuseppe Cominotti e EnricoMarchesi e la Veduta della città di Sassari nell'i-sola di Sardegna di Giacinto Maina rappresenta-no l’osmosi tra la città e la sua campagna, verosimbolo identitario.Due postazioni multimediali forniscono appro-fondimenti sul tema dell’identità della città.
a - Sassari: memoria e identitàLa sala posta all’ingresso del palazzo sullasinistra, offre un’immediata rappresentazionedei luoghi e dei simboli della memoria e del-l’identità cittadina.
Per secoli l’identità di Sassari è stata segnatadalla linea della sua cinta muraria, eretta nelcorso del Duecento, che divideva la città dallacampagna. Eppure già nel XII secolo, quando erasoltanto un villaggio del giudicato di Torres,Sassari (Thathari) svolgeva un ruolo importantenel territorio, poiché ospitava la pieve di SanNicola, una chiesa dotata cioè dei diritti di batte-simo e sepoltura. La costruzione del castello nella parte più altadella città, tra il 1326 e il 1330, rappresentò ilpassaggio di Sassari dall’autonomia comunalealla condizione di città regia, sottoposta cioè algoverno di un veguer (vicario) nominato dalsovrano d’Aragona. Sede del Tribunaledell’Inquisizione venne demolito nel 1877 esostituito dalla caserma Lamarmora.Se il castello è l’emblema del potere militare, lafontana di Rosello, edificata alla fine delCinquecento, vuole esaltare l’immagine diSassari ricca di acque e immersa nel verde diuna campagna rigogliosa, sposando utilità edestetica. La fontana diventa il simbolo della città,di cui reca le insegne ufficiali sormontate dallastatua equestre di San Gavino.Il percorso espositivo si apre proprio con la pre-sentazione dei simboli dell’identità cittadina: glistemmi; le mazze civiche emblema del poteremunicipale; le immagini della fontana di Rosello;il plastico del castello aragonese. La Pianta della
37GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
Fontana del Rosello, incisione di Giuseppe Cominotti
A sinistra. Venere Bagnante o Estate, statua originale in marmo proveniente dalla Fontana del Rosello, primi anni del XVII secolo.
38 GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
della città, a partire dalla riedificazione delPalazzo Civico con l’annesso teatro. Riprendendo una tendenza invalsa già nei primidecenni dell’Ottocento, che ha avuto interpretidi rilievo come lo stesso Cominotti, ancheGiovanni Pietrasanta si cimenta alla fine delsecolo, in una veduta della vallata del Rosellocon la fontana realizzando uno “schizzo presocorrendo nei giorni 1, 2, 3 maggio 1893”, inmostra nella sezione.Al centro della sala il grande plastico della cittàmurata viene descritto grazie ad una mappainterattiva che evidenzia i più importanti edifici emonumenti della città.Le “vedute” della città nelle cartoline di fineOttocento, esposte nella sala, mostrano il risultatodella trasformazione urbanistica di Sassari da cittàdi matrice spagnola in moderna città piemontese.
b - Sassari: formae immagineLa sala posta di fronteall’ingresso del palazzooffre la ricostruzionegrafica del nucleo urba-no all’interno della cintamuraria, dei suoi princi-pali monumenti e deglielementi costitutiviassunti dalla città neisecoli.
La forma vagamentepentagonale della cittàracchiusa entro la cer-chia delle mura, inter-vallate da torri quadran-golari con l’eccezionedella Turondola, cresciu-ta su sé stessa per sei-cento anni, viene deli-neata per la prima voltanella carta del 1577 del-l’architetto militare cre-monese RoccoCapellino.La più antica rappresen-tazione è quella, con-venzionale e al tempostesso realistica, conte-nuta nel volumetto suiSanti della Sardegna diFrancisco Carmona, del 1631. Sulla massa indi-stinta dell’abitato spiccano gli elementi salientiche lo caratterizzano e assumono valenze sim-boliche: il castello aragonese, la chiesa di SantaCaterina in cima alla Platha, che divide in dueblocchi l’abitato, il campanile e la cupola delDuomo. Al di là della cinta muraria la fontanadi Rosello e il convento francescano di SantaMaria di Betlem, rappresentano il forte legametra la città e questi elementi architettonici.La pianta disegnata dal “primo violino” GiovanniMasetti Raimondi nel 1806, conferma la persi-stenza della forma e la compattezza dell’abitatoinframurario, le cui strette strade e i rari slarghimanifestano l’origine medievale. Sarà Giuseppe Cominotti a ridisegnarla con cri-teri oggettivi, unendovi il primo progetto diampliamento fuori le mura e di “abbellimento”
Pianta della città di Sassari di Giovanni Masetti Raimondi
Ma gli spazi insufficienti per accogliere laMunicipalità e il teatro imposero all’Ammini-strazione Comunale la scelta di una nuova casacomunale: il prestigioso palazzo del Ducadell’Asinara. Perduta la funzione della “rappre-sentanza” il Palazzo venne quindi adibito a sededella sola “rappresentazione”.Il teatro divenne sin dal 1829 la sede di stagio-ni musicali e liriche e di spettacoli melodramma-tici. Accanto a tale attività ospitò altre forme dispettacolo e di intrattenimento tipichedell’Ottocento e nel corso del tempo mantennela funzione di luogo del teatro di prosa.Alla fine del secolo, il Teatro divenuto inagibilerese necessario un importante intervento direstauro e ristrutturazione che ebbe termine nel1900. Tale intervento fu fortemente voluto dalsindaco Mariotti. Nel 1947, a causa del cattivo stato di conserva-zione, le strutture lignee originarie e l’apparatoornamentale del Teatro realizzato nel primoNovecento furono smantellati e, pur senzaapportare modifiche strutturali che ne alterasse-ro la forma, venne realizzato un allestimentoimprontato ad una concezione moderna.
c - Sassari: rappresentanzae rappresentazioneAlla fine dello scalone, al primo piano, la sala èdedicata alle due anime incarnate dal palazzonel corso del tempo: luogo della “rappresentan-za” nella parte destinata al municipio e luogodella “rappresentazione” nel teatro.
Al centro della sala si può ammirare il modelloligneo del Palazzo di Città con il Teatro Civico, rea-lizzato su disegni originali del Cominotti (1827) ei rilievi dell’architetto Vico Mossa. Una postazioneinterattiva descrive l’architettura del palazzo.Nel 1830 Giuseppe Cominotti, divide lo spaziooriginario, accresciuto dall’area di un antico edi-ficio acquistato dal Comune, tra la zona destina-ta al nuovo teatro e quelle ricavate per ospitaregli organi deliberativi municipali nonché gli ufficidel Sindaco e del Tesoriere; e ancora, gli uffici disegreteria in soffitta e gli ambienti per l’ufficio diPosta e il Corpo di Guardia al piano terreno.Il Teatro progettato dal Cominotti riproduceva ilteatro Carignano di Torino. Il Civico era comunquecapace di contenere circa cinquecento spettatori. Il Palazzo fu soggetto a ristrutturazioni e amplia-menti, compresa l’acquisizione dell’immobileadiacente nella via Satta, volti a renderlo piùaccogliente e funzionale.
39GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
Modello ligneo del Palazzo di Città
42 GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
d - sala dei sindaciLa stanza, dedicata ai sindaci della città, proponei ritratti ottocenteschi di Gavino Soro Pirino,Gaetano Mariotti e il busto di Pietro Satta Branca.
e - sala dell’intregu adiacente alla sala dei sinda-ci, ospitava anticamente le sedute del Consigliocomunale. I recenti restauri hanno portato allaluce, nella volta, le decorazioni del pittore-sceno-grafo Pietro Bossi nel 1851 raffiguranti le Virtùciviche, le Arti liberali e il Commercio, copertedalle pitture eseguite dal Marchisio durante laristrutturazione del 1899 - 1900.Le decorazioni del Bossi oggi sono documentatesolo con le immagini riprodotte nel pannellodescrittivo visibile nella sala. Attualmente la sala è il luogo in cui prende avvioil lungo rituale dell’intregu: infatti il palazzo con-serva la sua funzione di luogo simbolo della cittàche si esprime nella cerimonia dell’omaggio chei gremi offrono alle autorità riunite in occasionedella festa più amata e sentita dalla popolazione,la discesa dei Candelieri del 14 agosto.Nel salone si svolge il rituale fortemente simbo-lico dello scambio di insegne: il sindaco conse-gna all’Obriere Maggiore uscente la bandiera delgremio, e affida il gonfalone della città al nuovoObriere Maggiore. Busto del Sindaco Pietro Satta Branca
Sala dei Sindaci
f - la discesa dei CandelieriLo spazio propone i suoni e le azioni sce-niche della festa dei Candelieri che rap-presenta una delle principali ricorrenzereligiose cittadine e uno dei più grandimomenti di identificazione collettiva. Ilsuono del piffero e del tamburo, i tradi-zionali strumenti che accompagnano ladanza dei portatori nella discesa, accolgo-no e sorprendono il visitatore e grandiimmagini proiettate nella sala lo coinvol-gono nella festa.La festa dei Candelieri è di indubbiamatrice pisana: nel XIII secolo Sassarimutua da Pisa il rito dell’offerta deiCandeli di mezz’agosto.In età moderna, la tradizione assume unsignificato più profondo sotto il profiloreligioso: diviene Voto della città in onoredella Vergine Assunta che con la suaintercessione pose termine ad una delleterribili pestilenze che periodicamente siabbattevano sulla città.Conosciuta come “discesa” dal sassarese“faradda”, la processione dei Candelieri èun lungo rituale di grande partecipazionecollettiva in cui gli attori principali sono igremianti vestiti con gli antichi costumidella corporazione, i portatori dei cande-lieri, le autorità civiche.Realizzati in legno i Candelieri pesanocirca quattro quintali e sul fusto alto tremetri sono dipinti l’immagine del Santopatrono e i simboli del Gremio.
g saletta proiezioniAttigua alla sala dei Candelieri, propone ifilmati storici della festa dei Candelieri.
43GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
Discesa dei Candelieri
ALA ESTINGRESSO VIA SEBASTIANO SATTA
Un mondo composito quello di Sassari: un pic-colo appartato crocevia di gente eterogeneache denota diversità di mestieri, di provenienzae di costumanze, una società fortemente divi-sa in ceti. Tale ambiente è colto in modo assaiimmediato da Giuseppe Cominotti, architettopiemontese che eseguì una nota serie diacquarelli (oggi conservati presso la BibliotecaUniversitaria di Cagliari), le cui riproduzionisono in parte esposte nella sezione.
Le sale del primo e del secondo piano accolgo-no l’abbigliamento della vita quotidiana aSassari tra città e campagna.Nel primo quarto del 1800, a Sassari, accantoall’élite dei nobili, degli strati più alti della bor-ghesia e del ceto mercantile ed impiegatizio, sipoteva osservare il colorito mondo popolaredei piccoli proprietari terrieri, dei braccianti, deivenditori ambulanti, del lavoro domestico.L’economia della città, nonostante la presenzadi svariate attività artigiane e commerciali, eraancora fortemente agricola.
45GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
Bottoni d’argento dell’abito maschile
46 GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
Una teca espone i vistosi bottoni d’argentoche ornavano i costumi delle donne apparte-nenti alla classe degli agricoltori proprietari, limassai fedeli a fogge sarde di derivazionesettecentesca.I bottoni, utilizzati per chiudere le manichedei giubbetti e il colletto delle camicie , siamaschili che femminili, erano più elaboratiin numero, dimensioni e peso quando eranodestinati alle occasioni festive, mentre nobili eborghesi completavano i loro abiti civili congioielli ispirati alle mode correnti europee.La carità, olio su tela dell’artista sassareseEnrico Murtula (Sassari 1836 - 1910) espostanella sala, offre un esempio di raffinata rap-presentazione del costume tradizionale sardonelle sue diverse fogge e provenienze. Unapostazione interattiva illustra nel dettaglio l’ab-bigliamento esposto.
l - Sassari: città e campagnaLa sala, al primo piano, propone le riprodu-zioni di alcuni abiti della classe abbiente cit-tadina risalenti agli anni venti dell’Ottocento.
Una complessa realtà sociale ed economicaquella della Sassari di primo Ottocento, doveuna borghesia fortemente omologata a quella“continentale” per condizione economica emodi di vita, spesso accomunata dalla stessa ori-gine anagrafica, è la componente primaria dellasocietà. Elemento portante della popolazione diun grande borgo che in questo periodo accele-ra i ritmi di crescita demografica ed economicae va facendosi città. Anche l’abbigliamento vieneinfluenzato dal gusto europeo e nella sala nesono l’esempio alcuni abiti esposti.I proprietari terrieri che esercitavano attivitàdirettamente collegate all’agricoltura e allapastorizia indossavano invece ancora costumilegati alla tradizione sarda.
Sala Sassari: città e campagna
Il pauperismo espresso nell’abbigliamento deipopolani, nelle case, nella vita di strada si rifletteanche su un altro grande tema ben rappresenta-to dal Cominotti: la cucina e i costumi alimentaridei sassaresi. Alcuni esempi: Pizzinnu a piglià eba, Pizzinnu vin-dendi finociu. Uniforme de’ragazzi del popolo aSassari nell’estate. Agosto 1825; Vendiola dipesciu. Frigitrice di pesci in contrada Rosello.Ottobre 1825; Cucina Sassarese. Ottobre 1826;Imurza (colazione) sassarese. Novembre 1825;Sassaresi alle lattughe. Marzo 1826. A testimo-nianza della rappresentazione della vita rurale sipossono ammirare: il bassorilievo in gesso pati-nato Vita dei campi di Gavino Tilocca (Sassari1911 - 1999), Tra i sugheri, olio su tela diGiuseppe Magnani (San Benedetto Po, 1913 -Sassari 2007).
i - Sassari: città e campagnaLa sala al secondo piano espone alcune foggedell’abbigliamento dei popolani adulti, dei fan-ciulli e delle donne che esercitavano umilimestieri e piccoli commerci.
Tale vestiario dei sassaresi meno abbienti, anco-ra attorno al 1825 restava fedele ai canoni delcostume sardo della Sardegna nord-occidentale.Le donne indossavano generalmente fazzoletticopricapo ed un tipico bustino rigido, allacciato connastri sotto il seno mentre gli uomini portavano lecaratteristiche berrittas, ragas e giacche d’orbace. Negli abiti femminili si riscontra l’ampia utilizza-zione di tessuti economici di importazione offer-ti dalle botteghe cittadine e dai venditori ambu-lanti, che sostituirono progressivamente le stof-fe di produzione locale, come l’orbace e le teledi lino, avviando un processo di trasformazioneche ben presto avrebbe portato all’acquisizionedi fogge “continentali”.
47GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
Sala Sassari: città e campagna
48 GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
dell’Addolorata del Mercoledì Santo; i Sepolcridel Giovedì Santo; il Venerdì Santo con i suoi riti:la Madonna dei sette dolori, l’Iscravamentu odiscendimento del Cristo dalla croce antichissimatestimonianza risalente alla seconda metà del‘500, la processione del Cristo morto.In questa sezione una grande teca contiene laProcessione dei Misteri, gruppo costituito da ven-ticinque pupazzi in legno intagliato e policromatorealizzato nel 1928 da Eugenio Tavolara (Sassari1901 - 1963), una creazione di straordinariamessinscena corale riproducente la variopintasequela dei paraj, dei confratelli, il simulacrodell’Addolorata e il gruppo di donne oranti. Alcuni filmati d’epoca rappresentano momentisalienti della Settimana Santa.Due postazioni multimediali riassumono tutti icontenuti interattivi del museo.Un grande pannello - video e uno schermo sepa-rano i due temi del sacro e del profano ripropo-nendo “il popolo di legno”, la biografia e l’operadi Eugenio Tavolara. Una seconda teca custodi-sce la Mascherata Sassarese realizzata daTavolara nel 1937: trentadue pupazzi in legnointagliato e policromato, un lavoro di grandi pro-
h - Sassari: sacro e profanoLa sala, posta al terzo piano, articolata in duesezioni, accoglie i temi della religiosità cittadinaripresa dai riti della Settimana Santa e del pro-fano attraverso l’espressione tipicamente popo-lare del Carnevale sassarese.
Anche a Sassari i riti della Settimana Santa mutua-no modelli di devozione popolare propri della tra-dizione iberica. Non a caso, il loro sviluppo inSardegna coincise con il momento culminantedell’egemonia spagnola nell’isola in ambito politi-co - amministrativo ma soprattutto culturale.Sono palesi le molte assonanze tra questi duemondi, frutto di stratificate contaminazioni cheinvestono ogni aspetto delle pratiche religiosepopolari interpretate dalle confraternite locali cherichiamavano anche nel nome le cofradrias spa-gnole, associazioni di laici con finalità essenzial-mente religiose, che contribuirono al risvegliodella religiosità popolare soprattutto attraverso lacura e la gestione organizzativa delle processionidella Settimana Santa.Un’ampia documentazione fotografica scandiscele tappe più salienti di tale evento: la processio-ne dei Misteri del Martedì Santo; la processione
“Processione dei Misteri” di Eugenio Tavolara
ne delle caratteristiche proprietà che distinguononettamente il Carnevale sassarese dagli altri delresto dell’isola. Le gobbule sono composizionipoetiche o canzoni popolari, di presumibile discen-denza dall’antichissima tradizione letteraria catala-na delle coblas, nelle quali traspare l’anima satiricae maliziosa ma anche mordace della gente diSassari. Alcune tra le più significative composizionisono riportate in un grande pannello.Una ricca carrellata di immagini fotografichedescrive questo mondo carnevalesco e sottoli-nea i personaggi tradizionali che ricorrono in tuttele manifestazioni, un orso e un re: l’Ussu e Giogli.Entrambe le figure possono essere considerateda un punto di vista simbolico le vittime sacrifica-li nella lotta per il prevalere del bene sul male opiù semplicemente stanno a significare la capaci-tà dell’uomo di addomesticare la natura. Le foto degli strumenti o congegni sonori realiz-zati con materiali originali completano la sezionededicata al Carnevale: il seghede - seghede ozanzarra o serràggia (ricavato dalla vescica dimaiale rigonfia d’aria posta su un fusto di canna),lu bottu (tamburo a frizione), lu trimpanu, (tam-burello con sonagli), lu tamburu, la banda musi-cale degli ottoni. Un filmato degli anni 70 accompagna con imma-gini e suoni il visitatore in alcune scene delCarnevale sassarese.
porzioni sorto da un’appassionata ricerca sulleusanze carnevalesche della tradizione popolarecittadina che introduce al Carnevale.In passato, anche in sede locale il Carnevale, ana-logamente ad altre realtà europee caratterizzateda una società fortemente strutturata e gerarchi-ca, costituiva una fonte primaria di liberazione erinnovamento, grazie al suo ritmo spontaneo eirregolare: un’autentica esperienza di vita liberada gerarchie, contrapposta alle categorie fissedella quotidianità. Enrico Costa archivista, storico e narratore dellaSassari tra Otto e Novecento, ha dedicato impor-tanti pagine della sua fondamentale opera intito-lata Sassari al Carnevale dei suoi tempi e alla fre-nesia gioiosa che supera le differenze sociali.Ad oltre un secolo di distanza dalle annotazionisul Carnevale nella Sassari di fine ‘800, non è dif-ficile riconoscere quanto i mascheramentiimprovvisati e per certi versi improbabili e l’ince-dere sgangherato di persone “armate” di stru-menti musicali o coperchi di pentole siano anco-ra fortemente radicati nelle manifestazioni carne-valesche odierne.Poi, il senso sfrontato dell’ironia, il gusto per la bat-tuta fulminante, le grevi allusioni a sfondo sessua-le, i ritmi sostenuti dei tamburi venati da un sottilesenso di tristezza che decorano le antiche melodiee i versi caustici delle gobbule rappresentano alcu-
49GUIDA DEL PALAZZO DI CITTÀ
“Mascherata sassarese” di Eugenio Tavolara